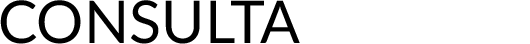Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2005
tenuta in occasione della conferenza stampa del Presidente Annibale Marini del
9 febbraio 2006 (*)
(*) a cura di M. Bellocci e P. Passaglia
N.B. Sono stati omessi i grafici.
Indice sommario
1.1. Il totale delle decisioni
1.2. Il rapporto tra decisioni ed atti di promuovimento
Il giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale
2. I giudici a quibus e la legittimazione a
sollevare questioni di legittimità costituzionale
3. Il nesso di pregiudizialità tra giudizio a quo e giudizio
di legittimità costituzionale
5. La riproposizione delle questioni
6. L’oggetto delle questioni di legittimità
costituzionale
8. La questione di legittimità costituzionale ed i
poteri interpretativi dei giudici comuni
9. Il contraddittorio di fronte alla Corte
10. La trattazione congiunta e la riunione delle cause
11.1. Le decisioni interlocutorie
11.2. Le decisioni processuali
11.4. Le decisioni di accoglimento
12. Sindacato di costituzionalità e discrezionalità
legislativa
2.1. La notifica, il deposito ed i termini per ricorrere
2.2. I rapporti tra il ricorso e la delibera recante la
determinazione all’impugnazione
3. L’oggetto delle questioni di legittimità
costituzionale
4. Il parametro di costituzionalità
6. La riunione e la separazione delle cause
7. Il contraddittorio di fronte alla Corte
8.1. Le decisioni interlocutorie
8.2. L’estinzione del giudizio
8.5. Le decisioni di accoglimento
9. Il controllo degli statuti ordinari ai sensi
dell’art. 123 della Costituzione
Il giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e
Regioni e tra Regioni
3. La deliberazione del ricorso
6. La materia del contendere ed il «tono costituzionale»
del conflitto
8.1. Le decisioni interlocutorie
8.2. L’estinzione del giudizio
8.3. Le decisioni di inammissibilità
Il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato
Il giudizio di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo
2. Il contraddittorio di fronte alla Corte
3.1. La decisione di inammissibilità
3.2. Le decisioni di ammissibilità
4. I rapporti tra giudizio di ammissibilità del referendum e controllo di costituzionalità
1. Il principio personalistico
2. I principî di eguaglianza e di ragionevolezza
2.1. Il principio di eguaglianza
2.2. Il principio di ragionevolezza
3. Il principio di laicità dello Stato
4. La condizione giuridica dello straniero
4.1. Il diritto all’unità familiare
4.2. L’espulsione dello straniero
4.3 La regolarizzazione del lavoratore extracomunitario
4.4. Il diritto alla fruizione dei servizi pubblici
4.5. Questioni non decise nel merito
Diritti e doveri degli individui
3. La libertà di manifestazione del pensiero
4. I principî costituzionali in materia penale
4.1. Il principio di offensività
4.2. La discrezionalità del legislatore nella
determinazione del trattamento sanzionatorio
4.3. I principî di personalità della responsabilità
penale e della funzione rieducativa della pena
5. I principî costituzionali in materia processuale
5.3. La difesa dei non abbienti
5.4. La riparazione per l’ingiusta detenzione
2.1. La tutela del minore e il principio di
«responsabilità genitoriale»
2.2. La tutela del minore nella disciplina dell’adozione
2.3. La tutela dei disabili all’interno della famiglia
2.5. La tutela della famiglia di fatto
3. L’autonomia privata e l’iniziativa economica
1. Le prestazioni patrimoniali
1.1. La disciplina dei tributi
La tutela dei diritti nella giurisdizione
1.2. Introduzione del giudizio e competenza
1.3. Imparzialità e terzietà del giudice
1.4. Il procedimento di esecuzione forzata
1.5. Il giudizio di cassazione
1.6. Le controversie in materia di circolazione stradale
1.7. Le controversie in materia di spese di giustizia
2.4. Le intercettazioni telefoniche
2.6. L’assenza e la contumacia dell’imputato
2.8. Il procedimento di esecuzione
2.9. Il procedimento davanti al giudice di pace
L’ordinamento della Repubblica
1.1. La disciplina dell’elettorato passivo dei
parlamentari
1.2. L’insindacabilità delle opinioni espresse dai
parlamentari
1.3. Le immunità previste dal
secondo comma dell’art. 68: le intercettazioni «indirette»
1.4. Esercizio della giurisdizione e svolgimento dei
lavori parlamentari
2.2. Le leggi di interpretazione autentica e le (altre)
leggi retroattive
2.3. Il referendum
abrogativo (rinvio)
2.4. La delegazione legislativa
2.5. La decretazione d’urgenza
2.7. Le fonti esterne (rinvio)
3. Il Presidente della Repubblica
5. La pubblica amministrazione
5.1. Il principio di buon andamento
5.2. Lo status
dei funzionari pubblici
5.3. L’accesso ai pubblici uffici
5.4. L’amministrazione sanitaria
6.1. Il principio di indipendenza ed autonomia della
funzione giurisdizionale
6.2. Rapporto fra giurisdizioni
2. La legislazione regionale ed i vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario
3. Il riparto di competenze legislative
3.1. Le materie di competenza esclusiva dello Stato
3.1.4. «Tutela della concorrenza»
3.1.5. «Sistema tributario e contabile dello Stato»
3.1.6. «Ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali»
3.1.7. «Ordine pubblico e sicurezza»
3.1.8. «Giurisdizione e norme processuali»
3.1.12. «Norme generali sull’istruzione»
3.1.16. «Tutela dell’ambiente [e] dell’ecosistema»
3.1.17. «Tutela […] dei beni culturali»
3.2. Le materie di competenza concorrente
3.2.1. «Tutela e sicurezza del lavoro»
3.2.5. «Governo del territorio»
3.3. Le materie di competenza residuale delle Regioni
3.3.1. «Formazione professionale»
3.3.3. «Trasporto pubblico locale»
3.4. La «concorrenza di competenze»
3.6. Le materie attratte in sussidiarietà dallo Stato
5. Il potere estero delle Regioni
7.2. La disciplina dei tributi
7.3. Gli interventi finanziari diretti dello Stato
9. I ricorsi decisi sulla base del Titolo V nel testo
anteriore alla riforma del 2001
10. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome
1.1. Il totale delle decisioni
Il totale delle decisioni (numerate)
rese dalla Corte costituzionale nel 2005 è di 482, cui dovrebbero aggiungersi
le ordinanze non numerate (quali, ad esempio, quelle che si pronunciano in
merito all’ammissibilità di interventi di terzo).
Il valore si pone apprezzabilmente al
di sopra delle 446 decisioni registrate nel 2004 (le 36 decisioni segnano un
incremento pari all’8,07%), proseguendo nella tendenza alla crescita di
decisioni riscontrata nel 2004, dopo la netta flessione del 2003 (lo scorso
anno, il tasso di incremento era stato del 16,75%).
Questa tendenza ha fatto sì che il
valore del 2005 si ponesse al di sopra della media degli ultimi dieci anni, che
si attesta a 473,5 decisioni annue. Ad ulteriore testimonianza della mole di
attività svolta, deve poi sottolinearsi che le 482 decisioni del 2005 sono
inferiori, nel periodo a partire dal 1996, soltanto ai dati del 2000 e del 2002
(con, rispettivamente, 592 e 536 decisioni), mentre sono leggermente superiori
a quelli del 1997, del 1998 e del 1999 (in tutti e tre gli anni le decisioni
rese sono state 471) e considerevolmente superiori ai dati del 2001 (447
decisioni), del 2004 (446), del 1996 (437) e del 2003 (382).
Altro dato che merita di essere
analizzato, al fine di cogliere alcune caratteristiche di fondo dell’attività
della Corte, è quello relativo alla suddivisione delle pronunce per tipi di
giudizio.
Le 482 sono così ripartite: 314 nel
giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 101 nel giudizio in
via principale (per la prima volta dal 1988 questo tipo di giudizio supera la
quota simbolica delle cento decisioni in un anno); 16 nel giudizio per conflitto
di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni;
Questi dati confermano la
preponderanza numerica del giudizio in via incidentale, le cui decisioni
coprono il 65,15% del totale; il giudizio in via principale occupa il 20,95%,
mentre i due conflitti si assestano, rispettivamente, a quota 3,32% e 9,54%
(dato, quest’ultimo, che costituisce la somma del 4,78% della fase di
ammissibilità e del 4,78% della fase di merito); il giudizio di ammissibilità
delle richieste referendarie copre, infine, l’1,04% del contenzioso.
Il giudizio in via incidentale conferma, dunque, la propria predominanza numerica, ma conferma anche, nella sostanza, i dati percentuali del 2003 e del 2004, quando le decisioni sul totale avevano rappresentato, rispettivamente, il 65,18% ed il 64,13%. Se è vero che, rispetto al 2004, si è avuto un pur leggero incremento (l’1,02%, pari a 28 decisioni in più), è anche vero che il 2004 aveva rappresentato, in termini percentuali, il minimo storico mai raggiunto. I dati dei venti anni precedenti al 2003, d’altra parte, sono rimasti assai lontani, in essi oscillando il giudizio in via incidentale tra il 75 ed il 90% del totale delle pronunce, ed attestandosi su una media dell’83,64% per il periodo 1983-2002 (quest’ultimo anno presenta un valore assai prossimo alla media: 84,14%).
Discorso analogo, ma inverso. è da
farsi per il giudizio in via principale, il quale, ancorato, per il periodo
1983-2002, ad una media del 7,29% (il 2002 si è posto leggermente al di sotto,
con una percentuale di 5,60), con un picco negativo di 2,76% (nel 1998) ed uno
positivo di 11,14% (nel 1988), ha conosciuto un notevole incremento a partire
dal 2003, giungendo al 14,92% e, nel 2004, addirittura al 21,75%. La lieve
flessione in termini percentuali del 2005 (-0,80%), peraltro corrispondente ad
un aumento del valore assoluto (101 decisioni contro le 97 del 2004), conferma
un dato scarsamente immaginabile sino a pochi anni fa, conseguente,
evidentemente, alla crescita del contenzioso derivante dal nuovo Titolo V della
Parte seconda della Costituzione.
Per quanto attiene al conflitto tra
Stato e Regioni e tra Regioni, il dato del 2005 segna una flessione dello 0,94%
(pari a 3 decisioni in meno) rispetto al 2004 (quando la percentuale sul totale
era stata del 4,26), che già si poneva al di sotto del dato del 2003 (6,02%).
In una valutazione relativa agli
ultimi dieci anni, peraltro, il valore del 2005 si pone, sì, al di sotto della
media (pari al 4%), ma sostanzialmente in linea con essa: prova ne sia il fatto
che, in tre degli ultimi dieci anni (1997, 2000 e 2002), il dato percentuale
del conflitto intersoggettivo è stato inferiore a quello registrato nel 2005.
Il grafico che segue illustra queste risultanze:
Per quanto attiene ai conflitti tra
poteri dello Stato, il dato comprensivo delle decisioni rese nelle due fasi del
giudizio evidenzia un leggero aumento (dello 0,35%) rispetto al 2004, quando le
decisioni erano state
Disaggregando le decisioni della fase
di ammissibilità da quelle della fase di merito, il 4,78% di queste ultime, nel
2005, è nettamente superiore al 2,47% del 2004 (con un incremento di ben 12
decisioni) ed al 2,09% del 2003, nonché alla media dell’ultimo decennio
(2,50%).
La percentuale di decisioni rese in sede di giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo mal si presta ad una valutazione in termini di trend, stante l’estrema volatilità del dato per anno.
1.2. Il
rapporto tra decisioni ed atti di promuovimento
Il dato piuttosto elevato del n. di
decisioni rese nel 2005 cresce notevolmente quando si vada ad esaminare il n.
di giudizi definiti, alla luce del quale sembra di poter dire che è in via di
definitivo «smaltimento» quell’arretrato formatosi essenzialmente nel 2003, e
che nel 2004 era stato solo in minima parte diminuito.
Le ordinanze di rimessione emesse dai
giudici a quibus, che nel 2004 erano
state 1.094 (nel 2003 erano state addirittura 1.196), sono scese drasticamente,
nel
Il parziale smaltimento
dell’arretrato è ben testimoniato dal raffronto tra le cause pendenti al 1°
gennaio e quelle pendenti al 31 dicembre 2005: 1.113 contro 560.
Decisamente positivi sono anche i
dati relativi al giudizio di legittimità costituzionale in via principale. A
fronte delle 101 sopravvenienze,
Anche in questo caso, il confronto
tra le pendenze all’inizio ed alla fine del 2005 segna un dato
inequivocabilmente positivo: 152 contro 120.
Indiscutibilmente positivi sono anche
i dati relativi ai conflitti intersoggettivi, che hanno visto 15 ricorsi promossi
e 22 ricorsi decisi, con un saldo positivo di 7 ricorsi: il dato del 2004 era
pressoché identico, con 16 ricorsi promossi e 22 definiti (saldo positivo di
6), mentre nel 2003 il saldo tra decisioni e sopravvenienze era stato ancor più
elevato (15 ricorsi promossi contro 36 ricorsi decisi). Se al 1° gennaio 2005 i
conflitti pendenti risultavano 44, alla fine dell’anno il dato è dunque sceso a
37.
L’unico ambito nel quale non si è
avuta una diminuzione di pendenze nel corso dell’anno è quello del conflitto
tra poteri dello Stato.
Per quanto attiene alla fase
dell’ammissibilità, le 23 ordinanze rese hanno pareggiato i 23 ricorsi
depositati (nel 2004, invece, ai 20 ricorsi avevano corrisposto 30 ordinanze),
con il che il n. di conflitti ancora da delibare è rimasto invariato, a quota
12, tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2005.
In ordine alla fase di merito, i 24
conflitti definiti non hanno eguagliato le 25 sopravvenienze, segnando così
l’unico saldo negativo, per quanto di assai modesta entità (-1): i 40 conflitti
pendenti all’inizio del 2005 sono così divenuti, alla fine, 41. Nel 2004, i
dati erano stati, peraltro, ben più negativi, se è vero che gli 11 ricorsi
decisi erano rimasti ben al di sotto dei 17 ricorsi promossi, con un saldo di
-6; nel 2003, addirittura, a fronte di 22 ricorsi promossi, erano stati solo 8
i ricorsi decisi, con un saldo di -14.
Le 5 decisioni pronunciate in sede di
giudizio di ammissibilità delle richieste referendarie hanno, ovviamente,
esaurito le pendenze presenti al 1° gennaio 2005. Al 31 dicembre 2005 non
constano richieste di cui giudicare l’ammissibilità.
Delle 482 decisioni, le sentenze sono
state 198 e le ordinanze 284, pari, rispettivamente, al 41,08% ed al 58,92%.
Il dato, che vede una crescita della
percentuale delle sentenze rispetto al 2004 (in cui le 167 sentenze hanno
rappresentato il 37,44% del totale delle decisioni), pare confermare un trend già riscontrato nel confronto tra
il 2004 ed il 2003, che aveva visto una crescita anche più pronunciata (nel
2003, le 134 sentenze ha costituito il 35,08% del totale delle decisioni).
Parrebbe, allora, di potersi argomentare una certa quale inversione di tendenza
rispetto a quella che aveva dominato gli anni novanta ed i primi anni del
secolo in corso. In particolare, negli anni 1994-2002, la percentuale di
sentenze, dall’iniziale 58,01 (picco massimo degli ultimi due decenni), era
costantemente scesa (riducendosi, in un solo anno, dal 51,38% del 1997 al
36,94% del 1998) sino al 25,19%. L’inversione di tendenza è ancora lontana dal
riportare il saldo percentuale delle sentenze sui livelli propri di buona parte
degli anni novanta (tra il 1991 ed il 1997, la percentuale ha oscillato tra il
49,71% ed il 58,01%), assestandosi su livelli assimilabili – ma leggermente più
elevati – a quelli degli anni 1987-1990, largamente coincidenti con la fase
c.d. dello «smaltimento dell’arretrato» (i cui valori sono risultati compresi
tra il 40,50% del 1990 ed il 37,25% del 1989).
Al di là di queste considerazioni di
ordine generale, una particolare attenzione meritano i dati del 2005
disaggregati per tipo di giudizio: nel giudizio di legittimità costituzionale
in via incidentale, 80 sono state le sentenze e 234 le ordinanze (percentuali:
25,48 e 74,52); nel giudizio in via principale, 85 le sentenze e 16 le
ordinanze (percentuali: 84,16 e 15,84); nel conflitto tra enti territoriali, 14
le sentenze e 2 le ordinanze (percentuali: 87,50 e 12,50); nel conflitto tra
poteri dello Stato, con riguardo alla fase di merito, 14 sono state le sentenze
e 9 le ordinanze (percentuali: 60,87 e 39,13).
Più che la comparazione diacronica in
termini percentuali (invero scarsamente significativa, a tal riguardo,
potendosi constatare, con poche eccezioni, una sostanziale omogeneità dei dati
rispetto agli ultimi anni), ciò che rileva è soprattutto il rapporto tra i tipi
di giudizio. Avendo come riferimento le decisioni adottate con la forma della
sentenza, deve sottolinearsi che, alla stessa stregua del 2004, anche nel 2005
il giudizio nell’ambito del quale è stato reso il maggior n. di sentenze non è
stato il giudizio in via incidentale (come era accaduto invariabilmente sino al
2003), bensì il giudizio in via principale (alle 81 sentenze del giudizio in
via principale avevano corrisposto 63 sentenze nel giudizio in via incidentale;
già nel 2003, comunque, la distanza tra i due tipi di giudizi di legittimità
costituzionale si era fortemente assottigliata: 54 sentenze nell’incidentale
contro 48 nel principale).
Peraltro, operando un raffronto tra i
due ultimi anni, può notarsi come, a fronte di una crescita contenuta
(nell’ordine di 4 unità) delle sentenze nel giudizio di legittimità
costituzionale in via di azione, si è verificata una crescita cospicua (di 17
unità) di quelle rese nel giudizio in via incidentale.
In termini percentuali, le sentenze
sono state rese nel 40,40% dei casi in sede di giudizio in via incidentale,
contro il 42,93% del giudizio in via principale (nel 2004, le percentuali
erano, rispettivamente, il 37,72 ed il 48,50); a completare il quadro, le
sentenze nei conflitti si sono assestate sul 7,07% sia per quello tra enti
territoriali che per quello tra poteri, mentre le sentenze in sede di giudizio
sull’ammissibilità delle richieste di referendum
abrogativi coprono il 2,53% del totale.
Con riguardo alle ordinanze, il giudizio in via incidentale ha confermato la sua assoluta centralità, coprendo l’82,39% del totale (nel 2004, era al 79,93%), contro il 5,63% del giudizio in via principale (nel 2004, 5,73%), lo 0,70% del conflitto intersoggettivo (nel 2004, 1,79%), l’8,10% della fase di ammissibilità del conflitto interorganico (nel 2004, 10,75%), il 3,17% della fase di merito (nel 2004, 1,08%).
Nel corso del 2005,
Le decisioni adottate a seguito di
udienza pubblica sono state 186, mentre quelle che hanno definito
congiuntamente giudizi trattati in camera di consiglio 293, con percentuali
pari, rispettivamente, al 38,59 ed al 60,79. A questo dato, debbono aggiungersi
3 decisioni (0,62%) che hanno definito giudizi in parte trattati in udienza
pubblica ed in parte in camera di consiglio (sentenze nn. 437
e 444, ed ordinanza n. 418).
Il dato segna una apprezzabile
crescita della percentuale di decisioni adottate dopo l’udienza pubblica
rispetto al 2004 (quando le 446 pronunzie si erano ripartite tra le 167
adottate dopo una udienza pubblica e 279 dopo una camera di consiglio, con
percentuali rispettive del 37,44 e del 62,56), che era, a sua volta,
decisamente superiore a quello del 2003 (anno nel quale delle 382 pronunce, 126
erano seguite ad una udienza pubblica e 256 ad una camera di consiglio, con
percentuali rispettive del 32,98 e del 67,02).
Pur senza poter instaurare un
parallelismo perfetto, può constatarsi come buona parte delle decisioni
adottate a seguito di udienza pubblica abbiano avuto la forma di sentenza:
delle 186 decisioni, 145 sono infatti sentenze (77,96%), mentre 41 sono le
ordinanze (22,04%). Correlativamente, le ordinanze sono state la grande
maggioranza delle decisioni adottate a seguito di una camera di consiglio: 242
ordinanze (82,59%) contro 51 sentenze (17,41%).
Disaggregando i dati per tipi di
giudizio, è agevole constatare come il procedimento in camera di consiglio
abbia connotato fortemente il giudizio in via incidentale: delle 314 decisioni
rese, 248 lo sono state in camera di consiglio,
Nel giudizio di legittimità
costituzionale in via principale, l’udienza pubblica ha visto – secondo
consuetudine – una netta preponderanza delle decisioni rese a seguito di
udienza pubblica: 94, contro le 7 adottate a seguito di camera di consiglio
(percentuali: 93,07 e 6,93). Dopo una camera di consiglio, si è invariabilmente
avuta una ordinanza, mentre dopo una udienza pubblica si sono pronunciate le 85
sentenze (90,43%) e 9 ordinanze (9,57%).
Dati sostanzialmente analoghi a
quelli del giudizio in via principale si rintracciano per il conflitto tra
Stato e Regioni o tra Regioni, in ordine al quale 15 delle 16 decisioni sono
state pronunciate a seguito di udienza pubblica (93,75%; l’unica decisione
emessa a seguito di camera di consiglio copre il 6,25% del totale). Le 14
sentenze sono state tutte pronunciate a seguito di udienza pubblica (93,33%),
così come una delle due ordinanze (6,67%).
Relativamente al conflitto tra poteri
dello Stato, tralasciando la fase dell’ammissibilità (svolta in camera di
consiglio), la corrispondenza cui si accennava tra sentenze ed udienza
pubblica, da un lato, ed ordinanze e camera di consiglio, dall’altro, è totale:
le 14 sentenze sono state rese a seguito di udienza pubblica, così come le 9
ordinanze sono state pronunciate a seguito di camera di consiglio.
Finalmente, le decisioni
sull’ammissibilità di richieste di referendum
si configurano come eccezioni necessitate alla regola tendenziale riscontrata:
il rito – sia pure assai particolare, come si dirà – è il rito camerale, mentre
la forma della pronuncia è quella della sentenza.
Nell’ambito di un contenzioso che può
dirsi relativamente ingente, i tempi di decisione che sono propri della Corte
costituzionale risultano ragionevolmente brevi. Di seguito si forniscono alcuni
dati relativi ai singoli giudizi, dai quali emerge, peraltro, una certa
differenziazione in termini di rapidità.
Nel giudizio in via incidentale, la
media dei giorni che sono intercorsi tra la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza di
rimessione e la data di trattazione in udienza pubblica o in camera di
consiglio è di 291,91. Sulle 1.149 ordinanze di rimessione per le quali
Nel giudizio in via principale, il
dato cresce rispetto a quello del giudizio in via incidentale. Dalla data di
pubblicazione dei ricorsi alla data di trattazione sono passati, infatti,
672,97 giorni, in media, con punte di quasi 3.000 giorni (2.946, per due dei
ricorsi decisi con la sentenza n. 272).
Se si eccettuano, tuttavia, i 22 ricorsi più risalenti, la cui trattazione era
stata oggetto anche di plurimi rinvii, tutti gli altri si sono mantenuti entro
i 1.000 giorni. Per contro, in 13 casi il lasso di tempo tra la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale e la
trattazione del ricorso è stato inferiore ai 200 giorni (il valore più basso,
di 63 giorni, si è riscontrato per il ricorso deciso con l’ordinanza n. 103).
I tempi più lunghi si sono verificati
nella trattazione dei conflitti tra Stato e Regioni e tra Regioni, con una
media di 1.113 giorni dalla pubblicazione del ricorso alla sua trattazione. Su
22 ricorsi decisi, 13 sono stati trattati ad oltre 1.000 giorni dalla loro
pubblicazione (il valore più alto è di 2.568, per uno dei ricorsi decisi con la
sentenza n. 324) ed uno soltanto lo
è stato entro i 200 (si tratta del ricorso deciso con l’ordinanza n. 217, trattato dopo 69 giorni dalla
pubblicazione).
I dati migliorano sensibilmente
avendo riguardo alla fase di merito del conflitto tra poteri dello Stato: il
valore medio è stato, infatti, di 458,75 giorni dalla pubblicazione alla
trattazione del ricorso. Il maggior ritardo è stato di 1.203 giorni (per il conflitto
deciso con la sentenza n. 267),
mentre in 3 casi non si è andati oltre i 49 giorni (su 24 ricorsi decisi, 9
sono stati trattati entro i 100 giorni dalla pubblicazione).
A completare i riferimenti sopra
enucleati, è d’uopo rilevare che anche la scelta del rito ha inciso, sia pure
in maniera non particolarmente significativa, sui tempi di decisione. In
effetti, dalla trattazione in camera di consiglio al deposito della decisione
sono trascorsi mediamente 54,26 giorni, con punte di 0 (per l’ordinanza n. 354) e di 206 (per la sentenza n. 63); dalla trattazione in udienza
pubblica, invece, il dato medio è stato di 67,04 giorni, con punte di 10 (per
la sentenza n. 284) e di 218 (in
quattro casi).
In questa sede, ci si è limitati a
fornire una panoramica di alcuni dei dati statistici che si ritengono più
significativi. Per ulteriori dati e per approfondimenti, si rinvia al prospetto
statistico in appendice alla presente relazione.
L’anno 2005 segna un momento
importante nella vita della Corte costituzionale, che giunge al cinquantesimo
anno di attività.
A caratterizzare la giurisprudenza
della Corte non è stata, tuttavia, questa sola ricorrenza, il cui rilievo è
peraltro indiscutibile. Sono, in effetti, molti gli aspetti che contribuiscono
a rendere il 2005 un anno di particolare interesse.
Innanzitutto,
Alla fine del mese di gennaio, a
cessare dalle funzioni sono stati il Presidente, Prof. Valerio Onida, ed il
vice Presidente, Prof. Carlo Mezzanotte, entrambi di nomina parlamentare. La
loro non immediata sostituzione ha fatto sì che il collegio fosse integrato da
soli tredici membri sino alla fine del mese di giugno, quando sono stati eletti
dal Parlamento ed hanno prestato giuramento i due nuovi giudici, l’Avv. Luigi
Mazzella ed il Prof. Gaetano Silvestri.
Il ritardo registratosi ha avuto
inevitabili ripercussioni sul funzionamento della Corte, come è dimostrato, tra
l’altro, dalla circostanza che il nuovo Presidente, in sostituzione del Prof.
Onida, è stato eletto soltanto una volta decorso il termine di cui all’art. 7,
secondo comma, del Regolamento generale della Corte Costituzionale (come
sostituito con deliberazione della Corte costituzionale del 25 maggio 1999), ai
sensi del quale, «nel caso in cui venga a scadenza il mandato di giudice del
Presidente,
Nelle more dell’elezione alla
Presidenza del Prof. Piero Alberto Capotosti, avvenuta il 10 marzo, le funzioni
presidenziali sono state svolte dall’Avv. Fernanda Contri, poi nominata, ai
termini dell’art. 22-bis del
Regolamento generale, vice Presidente, alla stessa stregua del Prof. Guido
Neppi Modona, eletto dal collegio, su proposta del Presidente, secondo quanto
dispone l’art. 23 del Regolamento generale. Il Presidente Capotosti ed i due
vice Presidenti hanno terminato il loro mandato all’inizio del mese di
novembre.
I tre giudici, tutti a suo tempo
nominati dal Presidente della Repubblica, sono stati prontamente sostituiti dal
Prof. Sabino Cassese, dalla Prof.ssa Maria Rita Saulle e dal Prof. Giuseppe
Tesauro.
Alla carica di Presidente è stato
eletto, il 10 novembre, il Prof. Annibale Marini, che ha designato come vice
Presidente il Dott. Franco Bile. In applicazione dell’art. 23 del Regolamento
generale, il collegio ha designato come vice Presidente anche il Prof. Giovanni
Maria Flick.
I molteplici avvicendamenti e la
conseguente pluralità di giudici che hanno esercitato le funzioni presidenziali
hanno fatto sì che ben sei membri della Corte sottoscrivessero, come presidente
del collegio, almeno una decisione: il Prof. Capotosti ne ha sottoscritte 215,
l’Avv. Contri 144, il Prof. Marini 66, il Prof. Onida 48, il Prof. Mezzanotte 5
ed il Prof. Neppi Modona 4.
Con precipuo riguardo all’attività
giurisdizionale, può rilevarsi che, secondo una tendenza ampiamente radicata,
vi è stata una pressoché costante congruenza tra giudici relatori e giudici
redattori delle decisioni, nel senso che sono stati meramente episodici i casi
in cui si è riscontrata, a tal riguardo, una discrepanza. In particolare, nel
corso del 2005, si sono avuti tre casi (stessa quantità del 2004): due relativi
a decisioni (rispettivamente) di inammissibilità e di ammissibilità di
richieste di referendum abrogativo (sentenze nn. 45 e 46) ed un
terzo relativo al conflitto intersoggettivo sorto a seguito del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale era stato nominato
il Commissario dell’Autorità portuale di Livorno (sentenza n. 339).
Sempre con riferimento alla figura
del giudice relatore e redattore, si segnala che la sentenza n. 451, concernente il conflitto
interorganico instaurato dalla Camera dei deputati avverso atti giurisdizionali
nei quali si era disconosciuto, negandogli validità, l’impedimento del deputato
a partecipare all’udienza penale per concomitanti impegni parlamentari, è stata
redatta da due giudici, entrambi designati come relatori (la sentenza ha deciso
due conflitti dichiarati ammissibili con le ordinanze nn. 185
e 186 del 2005, redatte disgiuntamente dai
due giudici).
Venendo ad alcune, brevissime,
considerazioni di ordine più generale, dal quadro statistico che è stato
tratteggiato nei paragrafi precedenti emergono alcuni dati che rendono
l’attività svolta particolarmente interessante. Si è constatata la consistenza
del contenzioso tra lo Stato e le Regioni manifestatosi in sede di giudizio di
legittimità costituzionale in via principale (assai più che in quella di
conflitto intersoggettivo): l’avvenuta riforma del Titolo V della Parte seconda
della Costituzione ha
continuato ad alimentare una conflittualità che, dalla fine del
La tendenziale conferma dei dati del
2004 (pur con la differenza appena ricordata) testimonia un forte radicamento della
funzione arbitrale nell’ambito dei poteri che sono propri della Corte
costituzionale. Nata principalmente come «garante dei diritti», essa ha visto
accrescere il proprio ruolo nelle diverse direzioni prefigurate nella Costituzione (e nelle leggi costituzionali),
al punto di rendere indefettibile un approccio teso a dare piena contezza della
multiformità e della complessità delle competenze all’organo attribuite.
I dati quantitativi, su cui già ci si
è soffermati, non possono comunque dare conto – se non in via di primissima
approssimazione – dell’attività che
Sono stati, infatti, molti i giudizi
che hanno riguardato casi di particolare importanza sotto il profilo
dell’incidenza su situazioni giuridiche soggettive e sotto quello più
propriamente istituzionale, per tacere di quelle decisioni nelle quali
Non è questa la sede per redigere una
elencazione che sarebbe inevitabilmente lacunosa e – proprio per questo – non
scevra di una certa arbitrarietà. Nelle pagine della presente relazione,
d’altra parte, il lettore potrà trovare – questo, almeno, è l’auspicio – ampi
riscontri in ordine all’importanza ed all’interesse che riveste, nel suo
complesso, la giurisprudenza costituzionale dell’anno 2005.
Il
giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Confermando pienamente la tradizione,
il giudizio in via incidentale è stata, nel corso del 2005, la sede in cui
Con specifico riguardo ai profili
processuali, sono piuttosto numerosi gli aspetti sui quali conviene in questa
sede soffermarsi, essenzialmente per rimarcare la linea di continuità rispetto
al passato.
2.
I giudici a quibus e la legittimazione a sollevare
questioni di legittimità costituzionale
Le 1.149 ordinanze di rimessione che
hanno instaurato giudizi decisi nel 2005 sono state sollevate da un ampio
spettro di autorità giudiziarie. Il maggior n. di ordinanze è stato sollevato
dai tribunali ordinari (567, ossia il 49,35% del totale), seguiti dai giudici
di pace (195, il 16,97%) e dai tribunali amministrativi regionali (146, il
12,71%). Piuttosto elevato è stato anche il n. di giudizi promossi dai giudici
per le indagini preliminari (47, il 4,09%), dai magistrati di sorveglianza (47,
il 4,09%) e dalle commissioni tributarie provinciali (46, il 4%). Oltre le
dieci ordinanze si collocano anche
Tra le altre autorità rimettenti si
segnalano, ex plurimis, le commissioni tributarie regionali (5
ordinanze), le commissioni tributarie di I grado (3) e la commissione
tributaria centrale (2); nell’ambito della giurisdizione amministrativa, il
Consiglio di giustizia amministrativa per
In alcuni casi, si sono riproposte
alla Corte costituzionale questioni inerenti alla legittimazione dei giudici a quibus ad instaurare un procedimento
in via incidentale.
Con l’ordinanza n. 298,
L’astratta legittimazione a sollevare
questione di legittimità costituzionale è stata confermata, nella sentenza n. 345,
anche per
Il difetto dei requisiti richiesti
dagli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 (secondo cui la valida rimessione della questione postula
l’azione di un «giudice», nel corso di un «giudizio») è stato invece
riscontrato in occasione della ordinanza n. 170. Nel corso di un
procedimento per l’iscrizione di un periodico nel registro della stampa, il
magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Milano aveva sollevato una
questione che, in ossequio ad una precedente statuizione della Corte (sentenza
n. 96 del 1976), è stata dichiarata manifestamente inammissibile, giacché la
procedura nell’ambito della quale la questione si radicava «è esclusivamente
volta alla verifica della regolarità dei documenti presentati», e dunque «il
presidente o il magistrato da lui delegato è chiamato a svolgere “una semplice
funzione di carattere formale attribuitagli per una finalità garantistica”, sì
che l’intervento di un magistrato non può “da solo essere ritenuto idoneo ad
alterare la struttura di un procedimento meramente amministrativo”». A tale
conclusione non poteva essere d’ostacolo il rilievo secondo cui il procedimento
per la registrazione del periodico riguarda l’esercizio di un diritto
fondamentale, quale è la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 della
Costituzione), «posto che tale diritto non può comunque rimanere privo di
tutela giurisdizionale», nell’ambito dunque di un procedimento «nel corso del
quale potrà sempre essere proposto incidente di costituzionalità».
3.
Il nesso di pregiudizialità tra giudizio a quo e giudizio di legittimità
costituzionale
Caratteristica fondamentale del
giudizio in via incidentale è il rapporto di pregiudizialità che collega il
processo di costituzionalità con il processo a quo: affinché una
questione di legittimità costituzionale sia ammissibile, condizione
imprescindibile è che essa sia «rilevante» ai fini della decisione del processo
nel corso del quale la questione è stata sollevata.
Nel corso del 2005, si riscontrano
varie decisioni nelle quali l’esame di merito è stato precluso dal difetto di
rilevanza, ora derivante dalla «estraneità delle norme denunciate all’area
decisionale del giudice rimettente» (così, espressamente, l’ordinanza n. 447),
ora dal momento nel quale la questione era stata concretamente sollevata.
Nel primo senso, possono menzionarsi
le fattispecie nelle quali
In relazione al momento nel quale la
questione di legittimità è stata sollevata,
Nell’operare il controllo circa la
rilevanza della questione sottopostale,
Un ultimo aspetto da menzionare è la
conferma della autonomia che è propria della questione pregiudiziale di
costituzionalità rispetto alle sorti del processo nell’ambito della quale è
stata promossa: onde disattendere una eccezione di inammissibilità per
irrilevanza sopravvenuta, nella sentenza n. 244 si è chiarito, in
conformità ad una giurisprudenza consolidata, che «il giudizio di legittimità
costituzionale […] una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del
giudice rimettente non è suscettibile di essere influenzato da successive
vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha
occasionato, come previsto dall’art. 22 delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale».
Affinché il giudizio di legittimità
costituzionale sia validamente instaurato, è necessario che l’ordinanza di
rimessione presenti i requisiti minimi di forma e, soprattutto, di contenuto.
Per quanto attiene alla forma,
Non ostativo all’ammissibilità delle
questioni è stato implicitamente ritenuto l’eventuale ritardo con cui
l’ordinanza di rimessione sia pervenuta alla cancelleria della Corte. Pur in un
quadro generalmente improntato alla celerità della trasmissione delle
ordinanze, nel corso del 2005 debbono comunque segnalarsi alcuni casi di lentezza:
se le ordinanze
nn. 197, 313 e 350 hanno
deciso questioni giunte alla Corte circa un anno dopo l’emanazione
dell’ordinanza di rinvio, e l’ordinanza n. 24
ha avuto origine da un’ordinanza pervenuta oltre due anni dopo, i casi più macroscopici
sono quelli di cui alla sentenza n. 433,
dove il ritardo registrato ha superato i sei anni, ed alla ordinanza n. 402,
che ha risolto una questione sollevata venti anni prima del momento in cui la
relativa ordinanza giungesse alla cancelleria del Palazzo della Consulta.
Parzialmente diverso è il caso dell’ordinanza che ha sollevato la questione
risolta con la sentenza
n. 274: il giudice a quo, emanata nel 1997 una prima
ordinanza, con una seconda, del
Con precipuo riferimento al contenuto
dell’ordinanza di rimessione, sono numerose le decisioni con cui
Non
mancano – sono anzi piuttosto frequenti – i casi in cui ad essere carente è la
motivazione tanto in ordine alla rilevanza quanto in ordine alla non manifesta
infondatezza (sentenza
n. 21 ed ordinanze nn. 84,
86, 92, 123, 139, 141, 142, 166, 228, 254, 298, 312, 314, 316, 333, 381, 435 e 448),
carenze che rendono talvolta le questioni addirittura «incomprensibili» (ordinanza n. 448)
e che sono alla base di declaratorie
di (solitamente manifesta) inammissibilità «per plurimi motivi» (così,
testualmente, l’ordinanza
n. 316).
Altra condizione indispensabile onde
consentire alla Corte una decisione sulla questione sollevata è la precisa
individuazione dei termini della questione medesima. A questo proposito, sono
presenti decisioni che rilevano un difetto nella motivazione concernente uno o
più parametri invocati (ordinanze nn. 23,
39, 86, 126, 311 e 414),
talvolta soltanto enunciati (sentenze nn. 322
e 409,
ed ordinanza n. 149),
quando non indicati (ordinanza n. 166)
o addirittura errati (ordinanze nn. 253
e 257).
Del pari, sono da censurare l’errata identificazione dell’oggetto della
questione – non di rado ridondante in una carenza di rilevanza (v. supra,
par. precedente) – che rende impossibile lo scrutinio della Corte (sentenza n. 21
ed ordinanze
nn. 153, 197, 376, 436 e 454),
l’omessa impugnazione dell’oggetto reale della censura (ordinanza n. 400),
la sua mancata individuazione (ordinanza n. 140)
od il riferimento alle disposizioni denunciate soltanto nella parte motiva
della ordinanza di rinvio e non anche nel dispositivo (sentenza n. 243
ed ordinanza
n. 228), alla stessa stregua della genericità della questione
sollevata (ordinanze
nn. 23 e 328).
A precludere una decisione di merito
è altresì il mancato esperimento, da parte del giudice a quo, di un
tentativo teso a rintracciare una interpretazione della disposizione censurata
che la renda conforme alla Costituzione. Non dissimile è, peraltro, l’esito dei
giudizi nei quali l’attività interpretativa del giudice risulti viziata da
erronei presupposti. Sulle problematiche connesse ai poteri interpretativi dei
rimettenti, si rinvia, comunque, a quanto verrà detto infra, par. 8.
Ancora, è da considerarsi vizio
insanabile la mancata presa in considerazione di modifiche legislative (ordinanze nn. 24
e 317)
o di dichiarazioni di illegittimità costituzionale (sentenze nn. 27
e 468,
ed ordinanza n. 313)
intervenuti antecedentemente al promuovimento della questione.
Il vizio dell’ordinanza di rimessione
può riguardare anche l’intervento che il giudice a quo richiede alla
Corte costituzionale: prescindendo dai casi in cui il petitum non è
sufficientemente precisato (ordinanze nn. 188
e 400),
sono colpite da inammissibilità tutte quelle richieste volte ad ottenere dalla
Corte una pronuncia «creativa», da adottarsi, cioè, attraverso l’utilizzo di
poteri discrezionali di cui
Riconducibili ai vizi che inficiano
la richiesta del giudice a quo – oltre a quelle connesse all’esercizio
dei poteri interpretativi da parte della Corte, su cui v., nuovamente, infra,
par. 8 – sono anche le formulazioni delle questioni nell’ambito delle quali il
rimettente non assume una posizione netta in merito alla questione: ne deriva
l’inammissibilità di questioni formulate in maniera contraddittoria (sentenze nn. 163
e 243,
ed ordinanze nn.
58, 112 e 297),
perplessa (ordinanza
n. 246) o alternativa (ordinanze nn. 215
e 363).
Pienamente ammissibili sono, di contro, le questioni poste in via subordinata
rispetto ad altre (ad esempio, sentenze nn. 52,
53 e 174, ed ordinanze nn. 75
e 256).
Le inesattezze che vengano
riscontrate in merito all’indicazione del petitum, o anche relativamente
ad oggetti e parametri, non sempre conducono alla inammissibilità delle
questioni: nei limiti in cui il tenore complessivo dell’ordinanza renda chiaro
il significato della questione posta, è
La sanatoria del vizio è invece
radicalmente esclusa nel caso di ordinanze motivate per relationem, vale
a dire attraverso il riferimento ad altri atti, come scritti difensivi delle
parti del giudizio principale (ordinanze nn. 92,
125, 312 e 423),
sentenze parziali rese nel corso del giudizio medesimo (ordinanza n. 208)
o precedenti ordinanze di rimessione, dello stesso o di altro giudice (ordinanze nn. 8,
22, 84, 141, 166 e 364): per
costante giurisprudenza, infatti, «non possono avere ingresso nel giudizio
incidentale di costituzionalità questioni motivate solo per relationem,
dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene
rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata, mediante una
motivazione autosufficiente» (così, l’ordinanza n. 364).
5. La riproposizione delle questioni
Nel corso del 2005,
La comunanza dell’origine non
implica, come noto, un legame di continuità tra i due giudizi di legittimità
costituzionale proposti: seguendo un orientamento consolidato,
La riproposizione, di per sé, non
presenta, ovviamente, problemi di ammissibilità. È anzi da evidenziare come
essa possa configurarsi come un esito fisiologico delle pronunce di
restituzione degli atti ai giudici a quibus per un riesame della
rilevanza della questione (ciò che postula, in caso di ritenuta persistente
rilevanza, un nuovo atto di promuovimento): non a caso, in varie occasioni la
riproposizione ha fatto seguito ad una restituzione degli atti (sentenze nn. 243,
425 e 442, ed ordinanze nn. 22,
316, 341 e 422).
È peraltro interessante constatare che
la riproposizione può trarre origine anche da altri tipo di dispositivi
processuali, i quali non si configurano esplicitamente come prodromici ad un
nuovo promuovimento. Tale è il caso delle ordinanze di manifesta
inammissibilità, che in taluni casi, nel 2005, hanno originato nuove decisioni
rese dalla Corte. Sulla scorta dell’indicazione del vizio che precludeva
l’esame del merito della questione, il giudice a quo ha provveduto ad
emendare il vizio (o, quanto meno, si è adoperato in tal senso, con esiti non
sempre «fausti»), sollecitando nuovamente uno scrutinio di costituzionalità (sentenze nn. 439
e 459,
ed ordinanze nn.
101, 257, 331 e 347).
Siffatte dinamiche testimoniano,
unitamente ad altri – e più rilevanti – indizi, la vitalità del dialogo tra
6.
L’oggetto delle questioni di legittimità costituzionale
Dalla giurisprudenza del 2005 non
emergono profili di particolare originalità per quanto attiene agli atti che
possono formare oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale. Al
riguardo, possono comunque segnalarsi alcune statuizioni.
Nella sentenza n. 322
si è affrontata una questione nella quale la disciplina legislativa
impugnata si compenetrava con quella della contenuta in contratti collettivi di
lavoro. Nell’esaminare il merito delle censure,
Tale affermazione non è stata
smentita dalla sentenza
n. 441, che ha avuto ad oggetto una disposizione del regio decreto
17 agosto 1907, n. 642, recante il «Regolamento per la procedura dinanzi alle
sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato». In ordine all’ammissibilità
della questione, è stato evidenziato che, «dopo un primo contrario orientamento
volto a desumere la natura regolamentare della normativa dalla formulazione
dell’art. 16, primo comma, della legge di delega 7 marzo 1907, n. 62, per
l’emanazione del decreto n. 642 del 1907»,
Di nuovo in ossequio ad un orientamento
consolidato, è stato affermato che «l’intervenuta abrogazione della
disposizione censurata […] non costituisce impedimento all’esame della
questione di legittimità costituzionale sollevata» allorché tale disposizione
sia stata «integralmente trasfusa» in altra (sentenza n. 345
ed ordinanza
n. 54). Il «trasferimento» della questione da un oggetto ad un altro
è testimonianza dell’atteggiamento rivolto a privilegiare la sostanza normativa
(rimasta inalterata a seguito della abrogazione) rispetto alla pura forma. Ad
analoghe considerazioni si prestano i casi nei quali l’avvenuta modifica della
disposizione censurata non ha impedito l’esame del merito della questione
quando «le modifiche subite dalla norma non incid[eva]no sulla sostanza del
precetto normativo» (sentenza n. 161).
Come è chiaro, allorché siano state apportate modificazioni al testo della
disposizione impugnata tali da incidere sulla sostanza della normazione, si è
imposta la restituzione degli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza della questione (così, con
particolare riferimento ad un decreto legge convertito con modificazioni, l’ordinanza n. 2).
Per quel che concerne le norme che
sono state invocate dai giudici rimettenti come parametri o come norme
interposte, non constano decisioni di particolare rilevanza.
Ciò che può segnalarsi è, peraltro,
una certa frequenza, anche nel giudizio in via incidentale, dell’invocazione
delle disposizioni contenute nel Titolo V della Parte seconda della
Costituzione, nel testo vigente (sentenze nn. 111, 147, 161,
200, 243, 244, 392, 432 e 437, ed
ordinanze nn. 82, 96, 127, 156, 179, 208,
248, 250, 268, 314, 427, 434, 436
e 476) ed anche in quello anteriore alla riforma (sentenze nn. 343
e 459, ed ordinanze nn. 23, 209 e 241).
Non mancano riferimenti al diritto
comunitario ed alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Quest’ultima
fonte è stata invocata come parametro nell’ambito della questione risolta con
l’ordinanza n. 139, mentre nelle questioni a seguito delle quali
Meno numerosi sono stati i casi nei
quali è stato il diritto comunitario è stato evocato. Viene all’uopo in rilievo
l’ordinanza n. 434, che non ha deciso il merito di una questione con cui
si denunciavano varie disposizioni per la loro violazione dell’art. 117, comma
primo, nonché dell’art. 11 della Costituzione, in ragione del contrasto con
l’art. 4, punto 2, della parte II della Carta sociale europea. Da segnalare è
anche l’ordinanza n. 464, con la quale si è negata la parametricità
delle disposizioni del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, non
essendo tale atto ancora entrato in vigore.
Conclusivamente, in merito ai limiti
entro cui la violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione è invocabile,
si rinvia a quanto verrà detto infra,
parte II, cap. II, sez. I, par. 2.4, limitandosi in questa sede a ricordare che
8.
La questione di legittimità costituzionale ed i poteri interpretativi dei
giudici comuni
Uno dei profili maggiormente
caratterizzanti del giudizio in via incidentale è rappresentato dai rapporti
intercorrenti tra la facoltà di sollevare questione di legittimità
costituzionale ed i poteri interpretativi propri dei giudici comuni e della
Corte costituzionale.
Affinché una questione di legittimità
costituzionale possa dirsi validamente sollevata,
L’attenzione della Corte a che i
giudici comuni esercitino la funzione interpretativa alla quale sono chiamati non
può, però, tradursi in una acritica accettazione di qualunque esito cui essa
giunga. Ne discende il potere della Corte di censurare – solitamente con una
decisione in rito – l’erroneo presupposto interpretativo da cui il
promuovimento della questione ha tratto origine (ordinanze nn. 1, 25,
54, 69, 118, 269, 310, 331 e 340).
L’interpretazione delle disposizioni
legislative, d’altra parte, non può essere configurata come un monopolio della
giurisdizione comune: anche
Il «dialogo» che viene così a strutturarsi
– cadenzato da riferimenti, in motivazione, a decisioni rese dal Consiglio di
Stato e, soprattutto, dalla Corte di cassazione (nella sentenza n. 303
si richiama anche «l’unanime opinione dottrinale») – non può prescindere,
tuttavia, da una chiara ripartizione dei rispettivi compiti, veicolata, per un
verso, da (a) la necessità di tener conto dell’acquis ermeneutico
sedimentatosi in seno alla giurisprudenza comune e, per l’altro, da (b)
la considerazione del ruolo proprio della Corte costituzione, che è avant
tout il giudice chiamato ad annullare leggi contrastanti con
a) Sotto il primo profilo, viene in precipuo rilievo la
nozione di «diritto vivente», definibile come l’interpretazione del diritto
scritto consolidatasi nella prassi applicativa.
In diverse circostanze,
Alcune decisioni hanno –
espressamente o meno – suffragato l’individuazione del diritto vivente operata
dal giudice rimettente (sentenza n. 283 ed ordinanza n. 188),
mentre altre decisioni hanno smentito quanto prospettato nell’ordinanza di
rinvio, sia nel senso di escludere l’incidenza del diritto vivente sulla
fattispecie oggetto del giudizio principale (sentenza n. 480), sia nel
senso di negare l’esistenza stessa di un orientamento giurisprudenziale
sufficientemente consolidato. A tale ultimo riguardo, se la rintracciabilità di
un orientamento della giurisprudenza di legittimità divergente rispetto a
quello prevalente impedisce radicalmente la configurabilità di un diritto
vivente (ordinanze nn. 58 e 332), alla stessa stregua di quanto
constatabile in presenza di «diverse, contrarie soluzioni della giurisprudenza
di merito» (ordinanza n. 452), a testimoniare l’inesistenza di un
diritto vivente può essere sufficiente anche una recente decisione della Corte
di cassazione (sentenza n. 460). Parzialmente differente è il caso della
sentenza n. 408, che ha escluso l’esistenza del «diritto vivente» invocato
dalla Avvocatura dello Stato per fondare una eccezione di irrilevanza della
questione.
Con riferimento ai profili ora in
esame, la decisione più importante dell’anno, per il tema affrontato oltre che
per la vicenda nella quale si è inserita, è comunque la sentenza n. 299.
Con essa si è compiuto un passo decisivo nella evoluzione della disciplina del
computo dei periodi di custodia cautelare, in merito alla quale, nel recente
passato, «
Questa vicenda illustra chiaramente
l’importanza di una franca dialettica tra Corte costituzionale e giudici
comuni, nell’ambito della quale confrontare le diverse posizioni al fine di
addivenire a risultati (interpretativi o anche caducatori, come nella specie)
che garantiscano il rispetto dei principî sanciti nella Carta costituzionale.
b) Per quanto concerne i rapporti che sussistono tra
l’attività interpretativa dei giudici comuni e la funzione che
9.
Il contraddittorio di fronte alla Corte
Nel corso del 2005, 295 decisioni
hanno avuto ad oggetto fonti legislative statali, 18 leggi regionali ed 1 un
decreto legislativo ed una legge regionale congiuntamente (sentenza n. 266).
Quando sono state fonti statali ad
essere scrutinate, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha assai frequentemente spiegato
intervento, sempre nel senso della non illegittimità delle disposizioni
denunciate. In particolare, la difesa erariale ha partecipato a 228 giudizi
(nel caso in cui si sia proceduto alla riunione delle cause, peraltro, gli
interventi hanno spesso riguardato soltanto alcuni atti di promuovimento),
mentre in 67 non è intervenuta. È da notare, a quest’ultimo proposito, che nel
giudizio conclusosi con l’ordinanza n. 81 il Presidente del Consiglio,
inizialmente intervenuto, ha poi ritirato l’intervento; l’Avvocatura dello
Stato ha comunque partecipato alla trattazione della causa, giacché contemporaneamente
al ritiro dell’intervento si è costituito il Ministero per i beni e le attività
culturali. Di contro, nel caso deciso con la sentenza n. 32,
l’Avvocatura dello Stato ha difeso congiuntamente il Presidente del Consiglio e
L’Avvocatura dello Stato ha spiegato
intervento anche nel giudizio in cui erano state denunciate congiuntamente
disposizioni statali e disposizioni regionali, mentre non altrettanto ha fatto
Negli altri giudizi che hanno
interessato leggi regionali, la difesa regionale è intervenuta in 10 occasioni,
si è costituita – in quanto
In 82 giudizi si sono costituite
(alcune de) le parti del giudizio principale; in 3 giudizi, peraltro, nessuna
delle parti si è costituita ritualmente, in conseguenza della tardività del
deposito dell’atto di costituzione. In totale, si sono avuti 135 atti di
costituzione, di cui 9 dichiarati inammissibili per tardività.
Gli interventi di soggetti terzi
rispetto al giudizio a quo sono stati 26, ripartiti in 9 giudizi. In 17
casi è stata dichiarata l’inammissibilità. Sul punto, meritano una segnalazione
quattro decisioni.
Nella sentenza n. 163 si
affrontava il tema delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni «alle
quali hanno preso parte membri del Parlamento». L’intervento spiegato dal
Senato della Repubblica è stato dichiarato inammissibile (con decisione che è
stata esplicitata anche nel dispositivo della sentenza).
Il Senato aveva sostenuto la propria
legittimazione ad intervenire «sulla base di un duplice rilievo»: da un lato,
la pronuncia della Corte avrebbe inciso «direttamente sulla propria funzione di
autorizzazione all’utilizzazione delle intercettazioni “indirette”, che trae
titolo dall’art. 68, terzo comma, Cost. e dall’art. 6 della legge n. 140 del
2003, oggetto, appunto, dello scrutinio di costituzionalità»; dall’altro lato,
si evidenziava che «l’art. 20, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
prevede espressamente che “gli organi dello Stato e delle Regioni hanno il
diritto di intervenire in giudizio”, confermando, così, la “naturale”
legittimazione dell’organo, che sia portatore di un interesse qualificato dal
collegamento alle proprie funzioni costituzionali, ad essere presente nel
giudizio stesso, a prescindere da ogni ulteriore considerazione».
Riguardo al secondo argomento
dedotto,
Nel giudizio concluso con la sentenza
n. 345, concernente i certificati complementari nazionali di protezione
per i prodotti medicinali, si sono avuti ben 18 interventi. Con ordinanza
presidenziale letta nell’udienza del 12 giugno 2005 (poi succintamente ripresa
nella parte motiva della sentenza e nel dispositivo della stessa),
Conformemente a questa impostazione,
nel giudizio concluso con l’ordinanza n. 398 è stata dichiarata
l’inammissibilità degli interventi spiegati da un soggetto privato «parte di un
processo diverso da quelli nei quali [erano] state pronunciate le ordinanze di
rimessione».
Del pari, la sentenza n. 440,
vertente su questioni di legittimità costituzionale di norme concernenti
l’amministrazione di sostegno ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento
spiegato dall’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (Anmic), «trattandosi di un soggetto non
titolare di alcun interesse diretto e qualificato nei giudizi a quibus
(cui [era] rimasto estraneo), in quanto portatore di un mero interesse diffuso
della categoria dei disabili».
Circa il ruolo che le parti
costituite e gli intervenienti svolgono nell’ambito del giudizio di
costituzionalità,
Questa limitazione non osta a che le
difese svolte abbiano una funzione di grande importanza, onde specificare e
chiarire le (sovente molteplici) problematiche che animano il giudizio di
costituzionalità. A testimonianza dell’attenzione che
10.
La trattazione congiunta e la riunione delle cause
Il dato di 1.149 giudizi definiti nel
corso del 2005, attraverso 314 decisioni, rende inequivocabile l’ampio uso
fatto dalla Corte dell’istituto della trattazione congiunta e della riunione
delle cause (in media, ogni decisione definisce 3,66 giudizi di legittimità
costituzionale).
Le decisioni assunte a seguito di
riunione sono ben 103. Non tutti i casi di riunione hanno fatto seguito ad una
trattazione congiunta delle cause: a tal proposito, devono segnalarsi, in
particolare, le sentenze nn. 437 e 444, e l’ordinanza n. 418,
che hanno deciso congiuntamente questioni in parte trattate in udienza pubblica
ed in parte in camera di consiglio (nei tre casi, trattavasi dell’udienza
tenutasi il giorno 11 ottobre e della camera di consiglio del 12).
Varie decisioni (tutte adottate con
ordinanza) hanno definito un n. particolarmente elevato di giudizi, quasi tutti
relativi alla disciplina della condizione giuridica dello straniero e
dell’immigrazione ovvero alla riforma del codice della strada. Nella prima
categoria si annoverano le ordinanze nn. 317 (53 giudizi definiti), 375
(49), 14 (43), 83 (39), 17 (38), 13 (35), 18
(34), 11 (30), 16 (28), 97 (26), 15 (23) e 126
(22), nella seconda le ordinanze nn. 184 (45 giudizi definiti), 60
(38) e 352 (33). Un n. elevato di questioni è stato talvolta deciso
anche in riferimento ad altri settori dell’ordinamento, come testimoniano le
ordinanze nn. 356 (30 giudizi definiti) e 112 (20), ambedue in
tema di sospensione condizionata dell’esecuzione della pena.
Per quanto attiene alla motivazione
che ha condotto alla riunione, in molti casi
Tendenzialmente assimilabili a queste
motivazioni sono quelle che si fondano sulla identità delle norme, dei
parametri e delle censure, nonché sulla sostanziale identità argomentazioni
(ordinanza n. 152, nonché, analogamente, sentenze nn. 174 e 265).
I giudizi sono riuniti anche in caso
di questioni «in parte identiche ed in parte analoghe» (ordinanza n. 9),
nonché quando si riscontra una «sostanziale affinità delle questioni»
(ordinanza n. 236).
Di per sé sufficiente è, comunque,
l’analogia o la parziale analogia delle questioni (rispettivamente, ordinanze
nn. 155 e 368, ed ordinanze nn. 139, 206, 269
e 453).
Parimenti, si riuniscono le cause per
le quali sussiste una connessione oggettiva (sentenze nn. 27 e 63),
o una evidente connessione delle questioni (ordinanze nn. 60, 102,
165, 194, 239, 342, 352, 398) o dei
giudizi (sentenza n. 21).
La riunione segue altresì la
«medesimezza» o l’«identità» della disciplina legislativa impugnata (sentenze
nn. 437 e 481, ed ordinanze nn. 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 83, 92, 157, 166,
228, 312, 333, 381, 419, 420). Tale
identità viene sovente rafforzata dalla identità dei parametri (ordinanze nn. 131,
180 e 313), dei profili fatti valere (sentenze nn. 144 e 408)
o delle motivazioni (sentenza n. 440 ed ordinanza n. 334); le
motivazioni, peraltro, talvolta sono «in parte identiche ed in parte analoghe»
(ordinanze nn. 112, 289, 346 e 350). Più
analiticamente, la riunione può seguire alla constatazione della identità della
normativa impugnata, della parziale coincidenza delle censure proposte e dei
parametri invocati, nonché delle argomentazioni svolte (ordinanze nn. 315
e 316, nonché, similmente, ordinanza n. 96).
La diversità delle norme impugnate
non è, comunque, ostacolo alla riunione, quanto meno allorché le questioni si
pongano negli stessi termini (ordinanza n. 126) o in termini non diversi
(sentenza n. 78).
In un caso, a fondare la riunione è
stata l’identità delle ragioni poste a fondamento dei dubbi di legittimità
costituzionale (ordinanza n. 69).
Per quanto piuttosto rari, non
mancano giudizi nei quali la riunione è stata disposta lasciando implicita la
motivazione (peraltro riconducibile alla identità dell’oggetto: ordinanze nn. 99,
464 e 475).
Nel 2005,
11.1.
Le decisioni interlocutorie
Prive di numerazione, le ordinanze
interlocutorie non hanno, generalmente, una rilevanza verso l’esterno,
trattando aspetti organizzativi interni alla Corte, come è il caso, ad esempio,
dei decreti di rinvio a nuovo ruolo di cause già fissate.
In taluni casi, peraltro, le
decisioni interlocutorie hanno una incidenza sul giudizio in corso che
coinvolge direttamente altri soggetti. Nel quadro dei giudizi definiti nel
2005, possono all’uopo segnalarsi le ordinanze lette in udienza concernenti
l’ammissibilità o meno di interventi di terzi (sul punto, si rinvia a quanto
detto supra, par. 9) e quelle c.d. istruttorie ex art. 12 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Con precipuo riguardo
all’acquisizione dei mezzi di prova, sono generalmente sufficienti le
informazioni che giungono alla Corte attraverso l’ordinanza di rimessione (o,
eventualmente, con l’attività dei soggetti intervenuti o costituitisi in
giudizio). È dunque raro che la decisione sulla/e questione/i necessiti di una
integrazione istruttoria. Nel 2005, tale è stato il caso del giudizio definito
con la sentenza n. 110, concernente la tariffa delle tase sulle
concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie. Con ordinanza
istruttoria del 10 aprile 2002, depositata il 12 successivo,
Successivamente, con ordinanza
istruttoria del 2 luglio 2003, depositata e comunicata il 18 successivo,
11.2.
Le decisioni processuali
A] Nell’ambito delle decisioni
processuali, le 16 sentenze che recano un dispositivo di inammissibilità
costituiscono una netta minoranza rispetto agli altri tipi di pronunce.
L’insieme più ampio di statuizioni di
inammissibilità è quello connesso a carenze riscontrate nella motivazione
dell’ordinanza di rimessione. In 3 casi, il difetto di motivazione è stato
individuato relativamente alla rilevanza della questione (sentenze nn. 66,
303 e 461); in altrettanti, ad essere censurata è stata la
circostanza che i parametri fossero stati evocati «senza alcuna motivazione
specifica» (sentenze nn. 149 e 322) o con una motivazione
comunque non congrua (sentenza n. 409). Di diverso segno, ma con
identico risultato, è la motivazione di cui alla sentenza n.
Nella sentenza n. 21, i vizi
hanno riguardato molteplici aspetti, e segnatamente «la formale mancanza,
nell’ordinanza di rimessione, di una motivazione della rilevanza e della non
manifesta infondatezza specificamente riferite [agli] articoli [denunciati]» e
«la sostanziale estraneità delle norme in essi contenute […] alle censure
sollevate dalla [autorità] rimettente»; la sentenza n. 147 dichiara
invece l’inammissibilità delle questioni relative ad alcune delle disposizioni
denunciate, in quanto sollevate «senza svolgere alcuna argomentazione in
relazione» ad esse.
Il difetto di pregiudizialità –
variamente motivato – della questione di legittimità costituzionale nei
confronti del giudizio principale è stato alla base di 3 decisioni di
inammissibilità, rese con le sentenze nn. 148, 266 e 345
(per ulteriori dettagli, sul punto, si rinvia supra, par. 3).
Per quanto attiene all’oggetto del
giudizio di costituzionalità, la sentenza n.
Nella sentenza n. 109,
B] I dispositivi di manifesta
inammissibilità sono stati 124, di cui 3 contenuti in sentenze e
a) Il difetto di legittimazione a sollevare questione
del giudice rimettente è stato alla base della manifesta inammissibilità di cui
all’ordinanza n. 170 (si veda anche supra, par. 2).
b) Un n. consistente di decisioni hanno avuto riguardo
al riscontrato difetto del nesso di pregiudizialità tra il giudizio a quo
e la questione di legittimità costituzionale sollevata (ordinanze nn. 9,
55, 57, 81, 82, 90, 97, 208, 213,
292, 296, 340, 341, 363, 370, 375,
377, 382, 429, 434, 443 e 447). Per
maggiori dettagli in merito alle ragioni che fondano tale difetto, si rinvia a
quanto detto supra, par. 3.
c) La categoria numericamente più cospicua è quella
delle dichiarazioni di manifesta inammissibilità derivanti da vizi di
motivazione dell’ordinanza di rimessione in riferimento alle condizioni
legittimanti il promuovimento della questione (sentenza n. 243 ed ordinanze nn. 3, 29, 74,
84, 86, 90, 92, 100, 123, 126,
139, 140, 141, 142, 153, 155, 166,
183, 189, 195, 196, 197, 207, 210,
212, 226, 228, 236, 237, 251, 254,
256, 288, 295, 297, 298, 312, 314,
316, 318, 328, 331, 333, 340, 364,
381, 382, 390, 396, 413, 418, 434,
435, 448, 453, 472, 476 e 482).
Analogamente, la manifesta inammissibilità ha colpito le carenze di motivazione
sui termini della questione (ordinanze nn. 23, 39, 86, 126,
311 e 414). In tale ambito possono essere annoverate anche le
decisioni inerenti ad ordinanze motivate per relationem (ordinanze nn. 8,
22, 84, 92, 125, 141, 166, 208,
312, 364 e 423).
L’errore nella individuazione dei
termini delle questioni è stato alla base delle declaratorie di inammissibilità
manifesta rese con le ordinanze nn. 257, 376 e 454.
Le carenze censurate con la manifesta
inammissibilità riguardano anche la mancata presa in considerazione di
modifiche legislative (ordinanze nn. 24 e 317) o di precedenti
dichiarazioni di illegittimità costituzionale della Corte (sentenze nn. 27
e 468, ed ordinanza n. 313).
Anche le questioni sollevate in modo
generico, perplesso o contraddittorio hanno condotto ad ordinanze di manifesta
inammissibilità (ordinanze nn. 58, 112, 188, 246, 297
e 400), così come le questioni alternative (ordinanze nn. 215 e 363).
Specificazioni ulteriori,
relativamente alle decisioni processuali motivate da carenze delle ordinanze di
rimessione, possono essere rinvenute supra, par. 4.
d) In ordine ai rapporti tra la questione di
legittimità costituzionale ed i poteri interpretativi del giudice a quo,
e) Il tipo di intervento richiesto alla Corte è stato
alla base di alcune pronunce di manifesta inammissibilità, motivate dalle conseguenze
incostituzionali che l’eventuale accoglimento della questione avrebbe creato
(ordinanza n. 68) ovvero dal tipo di intervento additivo cui
C] 71 (
Nella maggior parte dei casi, la
restituzione è stata dovuta al sopravvenire di una decisione di
incostituzionalità che ha caducato la disposizione denunciata o che ha comunque
inciso sull’oggetto della questione (ordinanze nn. 24, 60, 75,
102, 127, 158, 184, 229, da
Altra fattispecie ricorrente è stata
quella di restituzione in dipendenza di modifiche legislative sopravvenute a
mutare il quadro normativo tenuto presente dal giudice a quo (sentenza
n. 174 ed ordinanze nn. 2, 41, 80, 93, 101,
157, 165, 248, 258, 259, 317, 398,
411 e 422).
Soprattutto con riferimento alle
questioni aventi ad oggetto la disciplina dell’immigrazione e della condizione
giuridica dello straniero, molto numerosi sono stati i casi nei quali alla
decisione di incostituzionalità incidente sull’oggetto si è associato un
successivo intervento legislativo, conducendo ad una restituzione per il
concorrere di questi due motivi (ordinanze nn. da
A queste tre grandi categorie di
restituzioni si aggiungono due ordinanze che hanno dato atto di una
sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee:
l’ordinanza n.
A] La maggioranza delle decisioni di
rigetto sono state adottate nella forma della manifesta infondatezza: dei 72
dispositivi, 2 si trovano in sentenze e
Dalle rationes decidendi
emerge che buona parte delle pronunce sono derivate dalla infondatezza ictu
oculi delle questioni poste (ordinanze nn. 57, 59, 67,
132, 181, 213, 215, 216, 218, 228,
230, 247, 257, 296, 307, 309, 310,
381, 421, 452 e 453); in molti di questi casi,
Non mancano le dichiarazioni di
manifesta infondatezza derivanti dall’impossibilità di operare uno scrutinio
che avrebbe avuto ad oggetto la discrezionalità legislativa (ordinanze nn. 87,
113, 155, 215, 255, 261, 262, 380,
401 e 463).
L’erroneità del presupposto
interpretativo da cui muoveva il giudice a quo è stata all’origine delle
declaratorie contenute nelle ordinanze nn. 1, 54, 69, 118,
124, 332, 340, 347, 348 e 389. La
possibilità di dare della disposizione denunciata una interpretazione conforme
alla Costituzione è stata sottolineata, invece, nelle ordinanze nn. 8 e 115.
L’erroneità dei parametri evocati è
stata censurata con una decisione di «manifesta» nelle sentenze nn. 174
e 243, nonché nelle ordinanze nn. 125 e 209; mentre
difetti concernenti l’individuazione del tertium comparationis nel
giudizio di uguaglianza-ragionevolezza sono stati riscontrati nelle ordinanze
nn. 25, 59, 122, 227, 350 e 402.
Piuttosto numerosi sono stati i casi
in cui la decisione di manifesta infondatezza è stata dedotta da statuizioni
della Corte. Precedenti decisioni di infondatezza di analoghe questioni hanno
dato luogo alle decisioni di manifesta infondatezza di cui alle ordinanze nn. 136,
179, 289, 334, 359, 395 e 464. Ancor
più frequenti sono state le decisioni di manifesta infondatezza che sono
seguite a dichiarazioni di manifesta infondatezza aventi ad oggetto le medesime
questioni (ordinanze nn. 114 e 128) o questioni analoghe
(ordinanze nn. 23, 85, 91, 137, 154, 291,
305, 312, 382, 415 e 430); l’ordinanza n.
Merita un cenno, infine, l’ordinanza
n.
B] Delle 51 decisioni di rigetto adottate
nel corso dell’anno, 6 presentano il dispositivo tipico delle decisioni
interpretative (sentenze nn. 63, 394, 410, 460, 471 e 480). Tra queste ultime, merita un
cenno la sentenza n.
Delle sentenze di rigetto formalmente
non interpretative, è da constatare come molte rechino una motivazione nella
quale
11.4.
Le decisioni di accoglimento
Nel corso del 2005, sono state
pronunciate 30 sentenze che contengono una o più declaratorie di illegittimità
costituzionale, per un totale di 32 dispositivi di annullamento.
A] Soltanto in 6 occasioni si è avuta
una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una intera disposizione
(sentenze nn. 191, 220, 221, 278, 437
e 466). Tra queste decisioni, può
constatarsi come la sentenza n. 466, avendo ad oggetto una disposizione
nel testo anteriore a modifiche apportate dal legislatore, ma non applicabili
nel giudizio a quo, ha dichiarato l’incostituzionalità precisando, in
motivazione, che essa colpisce «la disposizione censurata nel testo vigente
prima delle modifiche introdotte».
B] L’insieme nettamente più cospicuo
di incostituzionalità è quello delle sentenze «manipolative». Le più numerose,
14, sono le decisioni additive, id est
quelle che «aggiungono» alla disposizione legislativa significati normativi,
dichiarandola incostituzionale «nella parte in cui non prevede» un determinato
contenuto (sentenze nn. 63 – con due dispositivi di questo tipo –, 144,
199, 233, 280, 281, 299, 343, 385
e 458), «nella parte in cui non si applica» a fattispecie ulteriori
(sentenza n. 408), «nella parte in cui non include» (tra i beneficiari
di una prestazione) determinati soggetti (sentenza n. 432) ovvero «nella
parte in cui non equipara» determinati soggetti ad altri (sentenza n. 433).
Con precipuo riferimento alle
decisioni additive, la sentenza n. 343 dichiara «l’illegittimità
costituzionale degli articoli 4 e 30 della legge della Regione Marche 5 agosto
1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del
territorio), nella parte in cui non prevedono che copia dei piani attuativi,
per i quali non è prevista l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni
alla Regione (o alla Provincia delegata)». Alla luce di questo dispositivo
viene inserito un adempimento all’interno di un procedimento di adozione di un
atto giuridico; in tal senso, questa decisione può essere annoverata tra le
sentenze «manipolative di procedura», riscontrabili in più occasioni nel
giudizio in via principale (v. infra, cap. II, par. 8.5).
Di notevole interesse è anche la
sentenza n. 280, che pone fine ad una vicenda nella quale
Oltre a questo «invito» al
legislatore, nella sentenza si enunciano anche alcuni «suggerimenti», in quanto
si sottolinea, per un verso, che «la ragionevolezza del termine che verrà
stabilito dal legislatore, ferma la sua natura decadenziale, discenderà dalla
adeguata considerazione del carattere estremamente elementare (tanto da
richiedere “procedure automatizzate”) dell’attività di liquidazione ex
art. 36-bis e della successiva attività di iscrizione nei ruoli:
attività che la vigente disciplina prevede si esauriscano entro il 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione», e,
per l’altro, che, «nel fissare il termine la cui mancanza qui si dichiara
incostituzionale, il legislatore non potrà non considerare che il vigente art.
43, comma primo, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che l’avviso di
accertamento – quale atto conclusivo di un ben più complesso procedimento – sia
notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo
alla presentazione della dichiarazione, e che solo entro tale limite temporale
il contribuente è obbligato a conservare la documentazione sulla base della
quale ha redatto la dichiarazione».
Un ulteriore caso di decisione
additiva, per quanto particolare, è rappresentato dalla sentenza n. 438 (su cui v. infra).
C] 9 sono state le decisioni di tipo
ablatorio (o di accoglimento parziale), le quali caducano una parte dei
contenuti della disposizione legislativa attraverso le formule secondo cui la
disposizione è incostituzionale «nella parte in cui prevede» un certo contenuto
(sentenze nn. 7, 320 e 437), «nella parte in cui fa
divieto» di compiere una determinata azione (sentenza n. 161) oppure
«nella parte in cui si riferisce» a certe fattispecie (sentenza n. 274).
In taluni casi, analogamente, la formula ablativa si traduce in una
illegittimità costituzionale di una disposizione «limitatamente alle parole»
espressamente individuate (sentenze nn. 392 e 457).
Un dispositivo più elaborato, pur se
sempre di tipo ablativo, è quello che reca la sentenza n. 78, con cui si
dichiara «l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 7, lettera c),
della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo), e dell’art. 1, comma 8, lettera c), del
decreto legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con
modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui fanno
derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del
lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei
reati per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l’arresto
obbligatorio o facoltativo in flagranza».
Tra le decisioni manipolative, un
caso particolare è quello della già ricordata sentenza n. 438, il cui
dispositivo («illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 8 giugno
1966, n. 424 […] nella parte in cui prevede, per i dipendenti degli enti
pubblici diversi dallo Stato, la sequestrabilità e la pignorabilità delle
indennità di fine rapporto di lavoro, per crediti da danno erariale, senza
osservare i limiti stabiliti dall’articolo 545 del codice di procedura civile»)
presenta una costruzione complessa, associando elementi tipici di una
illegittimità costituzionale ablativa («nella parte in cui prevede che …») ad
altri riconducibili, di fatto, ad una additiva («senza osservare …»).
D] Infine, 3 sentenze sono
riconducibili al genus delle decisioni sostitutive che censurano una
disposizione «nella parte in cui prevede [un contenuto] anziché [un altro]»
(sentenze nn. 27 e 168). Un dispositivo sostitutivo di
tipo più analitico è contenuto nella sentenza n. 444, che ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui esclude la pignorabilità per
ogni credito dell’intero ammontare della pensione erogata dalla Cassa nazionale
del notariato, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste
dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria
per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la
pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte».
E] Non constano, nel 2005,
dichiarazioni di illegittimità costituzionale consequenziali rese ai sensi
dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953.
12.
Sindacato di costituzionalità e discrezionalità legislativa
Nell’operare il sindacato di
legittimità costituzionale,
Se è vero che la «discrezionalità»
del legislatore rappresenta un argine al giudizio di costituzionalità, è però
anche vero che tale argine può essere superato, sia pure soltanto nelle ipotesi
in cui le scelte operate a livello politico ridondino in vizi di legittimità del
prodotto legislativo.
Onde dare consistenza al proprio
margine di azione,
La «non manifesta irragionevolezza o
arbitrarietà» è stata posta come limite nelle ordinanze nn. 213 e 382,
mentre nella sentenza n. 243 si è fatto riferimento alla «non palese
arbitrarietà o irragionevolezza».
L’ordinanza n.
Alla «corrispondenza ai canoni di
coerenza e di ragionevolezza» ha fatto richiamo l’ordinanza n. 452; le
ordinanze nn. 262 e 401, dal canto loro, hanno posto quale
condizione per lo scrutinio della Corte l’esercizio della discrezionalità
legislativa che «ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da
configgere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza».
Una definizione ancor più analitica è
stata fornita dalla sentenza n. 325, secondo cui sono sindacabili in
sede di giudizio di legittimità costituzionale le «scelte normative palesemente
arbitrarie o radicalmente ingiustificate, ovvero contrastanti in modo manifesto
con il canone della ragionevolezza, che si traducono in un uso distorto della
discrezionalità».
Il tema concernente il controllo
sulla discrezionalità legislativa, sul piano sostanziale, si interseca con il
giudizio di ragionevolezza, su cui si avrà modo di tornare infra, parte
II, cap. I, par. 2.
Nel corso del 2005, per la prima
volta dal 1988
Con riferimento ai problemi connessi
al ricorso con cui vengono sollevate le questioni di legittimità
costituzionale, di particolare interesse sono le affermazioni concernenti la
notifica ed il deposito, il rapporto tra il ricorso e la delibera del Governo o
della Giunta regionale contenente la determinazione all’impugnazione ed i
contenuti che del ricorso sono propri.
2.1.
La notifica, il deposito ed i termini per ricorrere
Per quel che attiene alla disciplina
del procedimento di impugnazione delle leggi ai sensi dell’art. 127 della
Costituzione, un primo profilo che è venuto in evidenza riguarda la notifica
del ricorso.
La sentenza n.
Diversa è stata la decisione sul caso
prospettatosi nel giudizio concluso con la sentenza n. 383, dove uno dei
ricorsi avverso un atto legislativo statale risultava, sì, notificato al
Presidente del Consiglio dei ministri presso
L’ordinanza n.
Sempre connesse ai tempi
dell’impugnazione, sia pure in un’ottica più generale, sono quelle statuizioni
nelle quali
2.2.
I rapporti tra il ricorso e la delibera recante la determinazione
all’impugnazione
Con riferimento all’incidenza che ha
la deliberazione con cui l’ente statuale, regionale o provinciale si determina
all’impugnazione, può constatarsi come, in varie occasioni,
Questa impostazione ha trovato
conferma in altre decisioni, tra cui la sentenza n.
In applicazione di siffatto
principio, nella sentenza medesima si è circoscritto l’oggetto del ricorso ai
soli articoli di cui si proponeva l’impugnazione nella relazione del Ministro
per gli affari regionali, la cui proposta risultava approvata nella riunione
del Consiglio dei ministri in cui era stata deliberata l’impugnazione della
legge provinciale.
La relazione del Ministro per gli
affari regionali assume, in effetti, un valore generalmente definitorio dei
limiti dell’impugnazione deliberata dal Consiglio dei ministri. In tal senso,
nella sentenza n. 150, preso atto che «la generica previsione contenuta
nella deliberazione del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge [era]
specificata dall’allegata relazione ministeriale con riferimento esclusivo
all’art. 2» di una delle leggi regionali oggetto del giudizio, si è concluso
che il ricorso dovesse essere ritenuto «validamente proposto solo nei confronti
dell’art. 2 della legge della Regione Marche n. 5 del 2004».
Ed ancora, nel giudizio concluso con
la sentenza n. 360, si è evidenziato che la delibera del Consiglio dei
ministri conteneva la generica determinazione di impugnare «la legge della
Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2002, n. 12», ma, al contempo, poiché la
relazione del Dipartimento affari regionali, sulla cui base il Consiglio dei
ministri aveva deciso di impugnare, censurava espressamente solo alcuni
articoli di essa, l’esame delle doglianze svolte nel ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri si doveva limitare a quelle relative a tali articoli (in
termini analoghi
L’importanza che la deliberazione del
Consiglio dei ministri (o della Giunta regionale o provinciale) assume ai fini
dell’individuazione del thema decidendum giustifica anche il vaglio
della Corte in ordine alla sua sufficiente determinatezza (vaglio per
consentire il quale
La giurisprudenza costituzionale del
2005 mostra una costante attenzione della Corte nei confronti dei contenuti del
ricorso, e segnatamente della idoneità dello stesso a radicare questioni di
costituzionalità che siano sufficientemente precisate ed adeguatamente
motivate.
Una siffatta attenzione è ben
rappresentata dalla sentenza n.
Alla luce di tali principî,
espressamente o implicitamente confermati in molte decisioni,
a) Avendo riguardo ai termini delle questioni, possono
evidenziarsi alcuni casi in cui il ricorso omette di individuare i parametri di
giudizio o, più frequentemente, sia inficiato da una loro erronea indicazione.
Nel primo senso, può citarsi la
sentenza n. 202, che reca una decisione di inammissibilità basata sulla
omessa deduzione di norme parametro rilevanti nella materia in questione.
Un caso in parte analogo è quello di
cui alla ordinanza n. 428, che ha deciso un ricorso evidentemente
incompleto relativamente ai parametri invocati:
In varie occasioni,
Relativamente alla erroneità
dell’indicazione delle norme di raffronto,
In ordine all’oggetto del giudizio,
il difetto di individuazione è stato talvolta ricavato dalla circostanza che
venisse impugnato un atto legislativo nel suo complesso, specie allorché,
invece, la delibera governativa (o giuntale) facesse riferimento soltanto ad
alcuni articoli o ad alcune disposizioni (v. supra, par. precedente).
Come è chiaro, quando la legge rechi un contenuto omogeneo (come, ad esempio,
nei casi di cui alle sentenze nn. 62 e 159) l’impugnazione della
sua totalità non trova alcun ostacolo.
L’esigenza che i termini delle
questioni siano adeguatamente determinati non si traduce, peraltro, in una
attitudine censoria della Corte costituzionale, la quale procede, nei limiti
del possibile, alla precisazione del thema decidendum, quando esso
presenta elementi di vaghezza. Così, nella sentenza n. 203, si è
pervenuti a «dare un coerente significato alla impugnazione» analizzando
l’articolo di legge impugnato e constatando, alla luce della pluralità di
contenuti che esso recava, che l’intentio impugnatoria del ricorrente
doveva essere ricondotta soltanto ad una parte di essi (una ridefinizione
analoga della questione è contenuta anche nella sentenza n. 407). Del
pari, nella sentenza n. 26, sebbene nelle conclusioni del ricorso si
chiedesse la caducazione per illegittimità costituzionale degli articoli
censurati nella loro totalità, la circostanza che gli articoli medesimi
avessero una sfera soggettiva di applicazione molto vasta, relativa a tutte le
pubbliche amministrazioni, imponeva una circoscrizione dell’ambito oggettivo
dell’impugnazione veicolata dal parametro evocato – l’art. 117, comma secondo,
lettera g), della Costituzione –, in ragione del quale ad essere
censurata doveva intendersi semplicemente l’applicabilità degli articoli
impugnati alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
Nell’ambito di siffatti poteri della
Corte rientra anche la «correzione» dell’individuazione dei termini della
questione, sempreché essa sia inequivocabilmente ricavabile dal contesto del
ricorso. Se ne ha un esempio con la sentenza n.
b) Per quel che concerne le carenze che inficiano la
motivazione, a precludere un esame del merito delle questioni sono state
l’insufficienza (sentenza n. 151), la «genericità ed apoditticità»
(sentenza n. 205), la non adeguatezza della motivazione (sentenza n. 462)
o il suo limitarsi alla semplice invocazione delle norme parametro (sentenza n.
65), alla stessa stregua della carenza di specifici motivi (sentenza n. 417)
o della mancata specificazione delle censure (sentenza n. 272).
Lo scrutinio inerente a queste
carenze viene operato sul piano sostanziale, più che formale, come prova la
sentenza n.
L’onere di motivazione, valutato in
senso sostanziale, rende inammissibili anche quei ricorsi nei quali le
argomentazioni si rivelino contraddittorie, come nel caso della sentenza n. 462,
dove si è evidenziata la natura «intrinsecamente contraddittoria» della
censura, «perché il ricorrente, da un lato, nel denunciare la violazione
dell’evocato parametro costituzionale, afferma[va] la competenza esclusiva
dello Stato a legiferare nella [dedotta] materia e, dall’altro, nel denunciare
l’omessa disciplina del termine di prescrizione da parte del legislatore
regionale, presuppone[va] invece la competenza legislativa della Regione, che
prima aveva negato».
Lungi dal potersi ritenere
contraddittorie, e dunque pienamente ammissibili, sono le questioni subordinate
(sentenze nn. 26, 162, 234, 270, 279, 285,
319 e 383) o le questioni che presentino profili di illegittimità
costituzionale in via gradata (sentenze nn. 51, 77, 205, 234,
321 e 467, ed ordinanza n. 349) : è ben possibile
contestare la legittimità costituzionale di una norma di legge
contemporaneamente alla luce di diversi parametri, «sia che si faccia valere un
rapporto gradato tra i due presunti vizi, sia anche che si sostenga […] la
contemporanea incidenza su più profili di una singola disposizione
legislativa»; in tali evenienze, non si ravvisano dunque «elementi di
perplessità o contraddittorietà che possano sostenere una pronuncia di
inammissibilità del ricorso» (sentenza n. 467).
Parimenti ammissibili sono le
questioni proposte in via «cautelativa»: la finalità interpretativa, o
«cautelativa», della questione non incide, infatti, sull’ammissibilità della
questione medesima, in quanto, per giurisprudenza costante, «a differenza del
giudizio in via incidentale, il giudizio in via principale può ben concernere
questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente
come possibili, soprattutto nei casi in cui […] sulla legge non si siano ancora
formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio
delle sue astratte potenzialità applicative e le interpretazioni addotte dal
ricorrente non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle
disposizioni impugnate, così da far ritenere le questioni del tutto astratte o
pretestuose» (così, testualmente, la sentenza n. 249, ma nel medesimo
senso è anche la sentenza n. 449).
Pur in un quadro tendenzialmente
improntato ad un certo rigore, sufficiente ai fini di una pronuncia sul merito
dell’impugnazione è che «il ricorso, sebbene succintamente argomentato, [sia]
chiaro e determinato e non [lasci] dubbi sull’oggetto della contestazione»
(sentenza n. 159): in quest’ottica,
La essenzialità della motivazione si
apprezza anche con riferimento alle argomentazioni poste a sostegno
dell’individuazione di una determinata norma oggetto o di una norma parametro.
In tal senso, non mancano decisioni
che censurano la genericità delle motivazioni dedotte al fine di giustificare
la individuazione di una disposizione come affetta da vizio di
incostituzionalità (sentenze nn. 37, 279, 336 e 450)
e ciò, a maggior ragione, quando la disposizione sia indicata come oggetto di
questione soltanto nell’epigrafe del ricorso, senza essere ripresa nella sua
parte motiva (sentenza n. 384).
Al pari di quanto riscontrabile per
le disposizioni oggetto, anche sulla scelta dei parametri è indefettibile una
motivazione ad hoc, con il che uno scrutinio di merito risulta precluso
quando le argomentazioni a tal riguardo si appalesino generiche (sentenza n. 50)
o siano addirittura, del tutto o per l’essenziale, omesse (sentenze nn. 202,
203, 304, 321, 335 e 383).
3.
L’oggetto delle questioni di legittimità costituzionale
In merito agli atti che sono stati
oggetto di ricorso in via principale, non constano, nella giurisprudenza del
2005, particolari novità. Le tipologie, per l’essenziale costituite da atti
legislativi statali e leggi regionali, conoscono alcune peculiarità in
relazione a determinati giudizi, e segnatamente quelli di cui all’art. 123
della Costituzione, il cui oggetto è la delibera statutaria di una Regione a
statuto ordinario (ordinanza n. 353, nonché – salvo quanto si dirà infra,
par. 9 –, sentenza n. 469), e quelli previsti dall’art. 28 dello Statuto
della Regione Siciliana (ordinanze nn. 103, 69, 293 e 403).
Con riferimento all’oggetto del
giudizio, sono peraltro da segnalare soprattutto alcune statuizioni nelle quali
il tipo di disposizione impugnata aveva riflessi anche in ordine alla
sussistenza di un interesse alla pronuncia di illegittimità costituzionale. Sul
tema, si rinvia a quanto verrà detto infra, par. 5.
4.
Il parametro di costituzionalità
Nel corso del 2005,
Con riferimento ai parametri
invocabili, molteplici decisioni hanno affrontato questioni in cui l’art. 10
della legge costituzionale n. 3 del 2001 era invocato come parametro (sentenze
nn. 35, 50, 62, 145, 201, 234, 279,
378, 383 e 384). La portata di tale disposizione,
confermando precedenti statuzioni, è stata ricostruita tenendo conto che le disposizioni
della legge costituzionale modificativa del Titolo V della Costituzione si
applicano alle Regioni ed alle Province autonome, ai sensi dell’art. 10 della
stessa legge costituzionale, solo «per le parti in cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite», con il che «deve
necessariamente escludersi che le disposizioni della suddetta legge
costituzionale possano comportare limitazioni alla sfera di competenza
legislativa già attribuita [alle Regioni speciali o alle Province autonome] per
effetto dello statuto di autonomia».
Circa la portata dell’art. 10, merita
un cenno anche la sentenza n. 279, nella quale si è disattesa la
eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa erariale, motivata
sull’assunto che «le Regioni a statuto speciale godrebbero, in virtù della
norma citata, di una tutela solo riflessa e derivata da quella spettante alle
regioni ordinarie, con la conseguenza che non potrebbero reagire con autonomo
ricorso principale alla eventuale violazione delle maggiori autonomie anche ad
esse riconosciute dalla novella costituzionale». La perentoria replica della
Corte è stata nel senso che il tenore dell’art. 10 è tale «da non lasciare
alcun dubbio circa la volontà del legislatore costituzionale di estendere in via
diretta alle Regioni a statuto speciale le maggiori autonomie riconosciute alle
Regioni a statuto ordinario, senza alcuna limitazione quanto alle forme di
tutela».
Per quel che concerne l’invocabilità
di norme parametro che risultino abrogate, la sentenza n.
Tra tutte, la decisione probabilmente
più innovativa, è comunque la sentenza n. 406, nella quale, per la prima
volta,
Molteplici sono le decisioni che
hanno avuto riguardo all’interesse a ricorrere, analizzato sotto molteplici
profili. Operando una schematizzazione dell’ampia giurisprudenza
rintracciabile, possono distinguersi tre ambiti, relativi a (a) i
parametri invocabili, a (b) le vicende incidenti sul persistere
dell’interesse ed a (c) i casi che potrebbero definirsi di «sostituzione
processuale».
a) Come noto, la configurazione del giudizio in via
principale – sia prima che dopo la riforma del Titolo V – si presenta in forme
parzialmente diverse a seconda che a ricorrere sia lo Stato ovvero una Regione
o una Provincia autonoma.
Quando il giudizio è radicato a
seguito di un ricorso statale, le questioni di legittimità costituzionale non
debbono necessariamente essere costruite come conflitti competenziali, ben
potendo avere ad oggetto la violazione di parametri costituzionali estranei a
quelli che regolano i rapporti tra Stato e Regioni. Ed effettivamente non
mancano i casi in cui
Tali rilievi non valgono per il caso
in cui a proporre ricorso sia una Regione (sentenze nn. 30, 36, 37,
50, 64, 107, 270, 272, 285 e 383),
nella misura in cui la logica competenziale è l’unica che possa trovare
cittadinanza, e ciò anche se, in certa misura, anche parametri tendenzialmente
estranei a questa logica posso venire invocati.
b) Relativamente alle vicende che incidono sul
persistere dell’interesse al ricorso ed alla decisione, sono molteplici le affermazioni
che si connettono alla modifica ed all’abrogazione delle disposizioni oggetto
del giudizio.
L’abrogazione della disposizione
conduce ad una cessazione della materia del contendere soltanto quando la
disposizione abrogata non abbia avuto medio tempore attuazione (sentenza
n. 407 ed ordinanza n. 477), nel caso contrario potendosi
constatare la persistenza dell’interesse alla pronuncia di merito (sentenza n. 203).
Analogamente, l’intervenuta conversione in legge di un decreto legge non fa venir
meno l’interesse ad una pronuncia su disposizioni del medesimo: in tal senso,
nella sentenza n. 378, si è escluso che il sopravvenire della legge di
conversione, con le sostanziali modifiche apportate al testo originario della
disposizione impugnata, avesse fatto venir meno l’interesse alla decisione del
ricorso, dal momento che la legge di conversione – facendo salvi gli effetti
degli atti compiuti nelle more del procedimento legislativo di conversione –
aveva conferito piena vigenza al testo originario della disposizione del
decreto legge.
Caso affatto peculiare è quello delle
delibere legislative siciliane promulgate parzialmente – con omissione delle
disposizioni impugnate – nelle more del giudizio di costituzionalità (ordinanze
nn. 103, 169, 293 e 403).
A fortiori inidonea ad escludere l’interesse al
ricorso è stata ritenuta la modificazione della disposizione impugnata, purché,
scil., il contenuto precettivo non risulti mutato, donde la necessità di
trasferire le censure dalla disposizione impugnata a quella risultante dalle
modifiche intercorse (sentenza n. 50). Né può risultare cessata la
materia del contendere allorché la sopravvenienza di una norma di «sanatoria»
non abbia effetti, ratione temporis, su quelle oggetto del giudizio
(sentenza n. 455). Di contro, la sopravvenuta carenza di interesse è
riscontrabile quando la modifica normativa sia satisfattiva delle richieste del
ricorrente (sentenze nn. 50, 108, 205, 304 e 378,
ed ordinanze nn. 428 e 474) e/o quando sia intervenuta
successivamente all’avvenuta attuazione della disposizione impugnata (sentenze
nn. 272 e 383).
La radicale modificazione può anche
derivare da una pronuncia della Corte, il cui decisum e la cui ratio
decidendi producano un mutamento del quadro normativo tale da rendere
superate le eventuali violazioni di parametri costituzionali (così la sentenza
n.
Sotto un diverso profilo, è da
sottolinearsi come la cessazione della materia del contendere non possa
derivare dalla attuazione che abbia avuto la norma censurata, «permanendo
nell’ordinamento una disposizione che, in ipotesi, potrebbe dare luogo anche a
diverse applicazioni, non conformi agli evocati parametri» (sentenza n. 33).
Come è chiaro, il difetto
sopravvenuto di interesse può essere reso manifesto dalla rinuncia formale al
ricorso, che produce, se accettata, la estinzione del giudizio. Non mancano,
peraltro, casi di rinuncia sostanziale, cioè non formalizzata ma espressa in
sede di trattazione della causa, rinuncia che, senza poter estinguere il
giudizio, fornisce comunque un segno inequivocabile del venir meno di ogni
interesse alla decisione della Corte (si pensi, ad esempio, a quanto avvenuto
nel giudizio concluso con la sentenza n. 36).
c) Per quanto attiene, infine, alle ipotesi di
«sostituzione processuale», è da evidenziare la sentenza n.
6.
La riunione e la separazione delle cause
A tale tecnica
I 133 ricorsi integralmente definiti
nel 2005, di cui 65 promossi dallo Stato, hanno visto 22 casi di riunione e 7
ricorsi decisi con separate pronunce.
La riunione è stata disposta in 5
casi relativamente a ricorsi statali avverso leggi regionali aventi una certa
omogeneità o, comunque, una continguità contenutistica (sentenze nn. 95, 150, 431, 456 e 469, tutte concernenti due ricorsi); in 2 casi il collegamento
materiale ha riguardo atti legislativi statali impugnati da Regioni e leggi
regionali impugnate dallo Stato (sentenze nn. 62 e 378,
rispettivamente concernenti tre ricorsi statali ed uno regionale e quattro
ricorsi statali ed uno regionale). Nei restanti 15 casi, si sono avute riunioni
di impugnative regionali avverso gli stessi atti o avverso atti connessi: le
sentenze nn. 30, 31, 35, 36, 234, 279, 285 e 336 hanno deciso due ricorsi regionali;
la sentenza n. 383 e l’ordinanza n. 349 su quattro; la sentenza n. 417 su cinque; la sentenza n. 384 su 7; la sentenza n. 270 su 8; la sentenza n. 50 su 9; la sentenza n.
Per quanto
attiene alla separazione dei giudizi, cinque ricorsi regionali aventi ad
oggetto la legge 14
febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del
lavoro) – c.d. «legge Biagi» – sono
stati decisi in parte con la sentenza n. 50 ed in parte con la sentenza
n. 384. Le sentenze nn. 277 e 462 hanno deciso un ricorso
statale avverso una legge della Regione Lazio recante contenuti eterogenei,
alla stessa stregua di quanto avvenuto, relativamente ad una legge della
Provincia autonoma di Bolzano, con le sentenze nn. 304 e 323.
A questi dati devono aggiungersi i 3
ricorsi che erano stati parzialmente decisi nel 2004 e che, nel 2005, sono
stati solo parzialmente definiti nel 2005, giacché restano pendenti alcune
questioni. In questi tre casi, si è trattato di discipline statali coinvolgenti
una pluralità di materie, e segnatamente la legge finanziaria (legge 24
dicembre 2003, n. 350, per cui resta pendente il ricorso n. 33 del 2004,
parzialmente deciso con le sentenze nn. 36,
71, 77, 107, 134, 151, 160, 162, 175, 219, 222, 231, 242, 270 e 449) ed il c.d. collegato ordinamentale in materia di pubblica
amministrazione (legge 16 gennaio 2003, n. 3, per cui restano pendenti i
ricorsi n. 31 del 2003, parzialmente deciso con la sentenza n. 270, e n. 32 del 2003, parzialmente
deciso con le sentenze nn. 31 e 270).
7.
Il contraddittorio di fronte alla Corte
Il processo in via principale, in
quanto processo di parti, si caratterizza per una assai elevata percentuale di
casi nei quali le parti si costituiscono di fronte alla Corte.
L’anno 2005 non fa, in questo senso,
eccezione. A fronte dei 136 ricorsi decisi (parzialmente o integralmente), si
sono avuti soltanto 12 casi di mancata costituzione. Lo Stato è rimasto inerte
in un solo giudizio, conclusosi con la dichiarazione di estinzione per rinuncia
(ordinanza n. 6). Gli 11 casi di mancata costituzione delle Regioni
sembrano, invece, assumere diversi significati: così, in 4 giudizi in cui lo
Stato è rimasto l’unico soggetto presente si è avuta una dichiarazione di
incostituzionalità (sentenze nn. 167, 319, 335 e 445)
ed in un quinto un accoglimento parziale delle censure (sentenza n. 456,
resa peraltro relativamente a due giudizi riuniti, in cui solo una delle
Regioni non si era costituita). In un ulteriore caso si è fatto luogo ad una
pronuncia di merito, ma di rigetto (sentenza n. 95, che ha deciso due
giudizi riuniti, in uno dei quali era presente la difesa regionale). Nei
restanti 5 giudizi non si è proceduto ad uno scrutinio di merito, ora in
ragione della constata cessazione della materia del contendere (ordinanze nn. 103,
403 e 428) ora per la rinuncia al ricorso, prodromo
dell’estinzione (ordinanze nn. 353 e 478).
In quattro casi la costituzione di
una Regione è stata dichiarata inammissibile.
Nel giudizio concluso con la sentenza
n. 150, con ordinanza letta nella pubblica udienza del 22 febbraio 2005
e allegata alla sentenza, è stata dichiarata inammissibile la costituzione
della Regione Puglia, in quanto avvenuta oltre il termine prescritto dall’art.
23, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte.
Nella sentenza n. 391 si è
dato conto che
In tutto analoghe sono state le
decisioni relative alla costituzione tardiva della Regione Umbria nel giudizio
definito con la sentenza n. 393 ed a quella della Regione Molise nel
giudizio definito con la sentenza n. 397.
Una fattispecie peculiare si è
presentata nel giudizio concluso con la sentenza n. 455, nel quale il
Presidente della Regione Liguria, resistente, si era costituito senza previa
autorizzazione della Giunta regionale. Il vizio riscontrabile non ha inficiato,
tuttavia, l’avvenuta costituzione, risultando sanato dall’avvenuto deposito,
unitamente alla memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, della
copia autentica della deliberazione della Giunta che aveva proceduto alla
ratifica della costituzione medesima.
Al di là di questi casi inerenti alla
costituzione delle parti, uno dei profili che maggiormente hanno caratterizzato
il processo in via principale nel corso del 2005 è rappresentato dalla
frequenza degli atti di intervento spiegati da terzi, che hanno riguardato i
giudizi conclusi da ben 10 pronunce (sentenze nn. 150, 232, 336,
344, 355, 378, 383 e 469, ed ordinanze nn. 20
e 103), per un n. totale di 36 interventi.
In taluni casi, degli interventi si è
dato conto soltanto nella decisione definitiva. Nella ordinanza n. 20 si
sono citati quattro interventi, di cui uno fuori termine; la manifesta
inammissibilità del ricorso ha peraltro precluso ogni decisione in merito
all’ammissione di questi soggetti.
Analoga è stata la sorte
dell’intervento, spiegato anch’esso fuori termine, nel giudizio concluso con la
dichiarazione di cessazione della materia del contendere di cui all’ordinanza
n. 103.
Fuori termine è risultato altresì
l’intervento – per un lapsus calami
definito «nel ricorso per conflitto di attribuzioni» – posto in essere nel
giudizio concluso con la sentenza n. 232.
Più articolata è stata la motivazione
che ha presieduto alla declaratoria di inammissibilità dell’intervento nella
sentenza n.
In un caso, sull’intervento è stato
deliberato con ordinanza collegiale, all’udienza del 26 ottobre 2004, sentite
le parti: nella fattispecie, i cinque interventi sono stati dichiarati inammissibili
«in base al consolidato orientamento [della] Corte, secondo il quale nei
giudizi di legittimità costituzionale proposti in via principale non è ammessa
la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della
potestà legislativa il cui esercizio sia oggetto di contestazione» (sentenza n.
336).
Più frequente è stato l’utilizzo
della forma dell’ordinanza presidenziale letta in udienza pubblica.
Così, nel giudizio concluso con la
sentenza n. 150, l’ordinanza del 22 febbraio
Parimenti, l’ordinanza letta
all’udienza del 7 giugno
Sostanzialmente assimilabile è la
motivazione che ha condotto, nell’ordinanza letta nell’udienza del 24 maggio
2005, alla declaratoria di inammissibilità dell’intervento spiegato: «il
giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d’azione, è
configurato come svolgentesi esclusivamente fra soggetti titolari di potestà
legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di
tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad
altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte
in via incidentale» (sentenza n. 383).
Identica è stata la motivazione
dell’ordinanza letta all’udienza del 29 novembre 2005, la quale, nel negare
ingresso all’intervento spiegato dai promotori del referendum sullo
Statuto della Regione Umbria (anche in proprio, nonché in qualità di
rappresentanti dell’apposito «Comitato per il referendum sullo Statuto
regionale dell’Umbria»), ha ulteriormente precisato che «anche nel giudizio
previsto dall’art. 123, secondo comma, della Costituzione, [la] Corte ha già
avuto modo di chiarire che gli unici soggetti legittimati ad esserne parti sono
Un caso a sé, infine, è costituito
dall’intervento della Regione Friuli – Venezia Giulia nel giudizio di cui alla
sentenza n. 344. Essendo oggetto di impugnazione, promossa dalla Regione
Veneto, un decreto di attuazione dello Statuto speciale del Friuli – Venezia
Giulia, quest’ultima Regione è stata destinataria, al pari dello Stato, della
notifica del ricorso, donde la sua contiguità con la posizione di parte del
giudizio.
Le 101 decisioni rese nel 2005, di
cui 85 sentenze e 16 ordinanze, recano, in totale, 348, un n., dunque, quasi
equivalente ai 366 del giudizio in via incidentale.
8.1.
Le decisioni interlocutorie
In taluni giudizi,
Il primo è quello – già menzionato supra,
par. 2.2 – di cui alla sentenza n. 321, dove si afferma che, a seguito
di una prima udienza di trattazione,
Il secondo caso concerne l’ordinanza
emanata, in data 15 dicembre
8.2.
L’estinzione del giudizio
I casi di estinzione a seguito di
rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, sono stati, in totale 14. Di questi,
un dispositivo dà conto di una rinuncia parziale (sentenza n. 272), uno
della rinuncia intervenuta relativamente ad un ricorso trattato congiuntamente
ad altri (rinuncia, dunque, non preclusiva dell’esame del merito: ancora
sentenza n. 272) ed un terzo dà conto congiuntamente di una rinuncia
parziale e di rinunce relative a ricorsi trattati congiuntamente ad altri
(sentenza n. 270). In altri undici casi la rinuncia ha prodotto una
preclusione assoluta alla trattazione del merito dei ricorsi (ordinanze nn. 6,
40, 329, 349, con quattro identici capi di dispositivo, 353,
412, 426 e 478).
Da notare che in 3 casi la rinuncia è
intervenuta in relazione a giudizi che non avevano visto la costituzione del resistente
(ordinanze nn. 6, 353 e 478), donde l’assenza della
necessità di una accettazione della rinuncia, altrimenti indefettibile.
Le decisioni processuali, che nel
complesso si attestano a quota 80 capi di dispositivo, sono ripartite tra
dichiarazioni di cessazione della materia del contendere, inammissibilità e
manifeste inammissibilità.
A] Si sono avuti 18 casi di
cessazione della materia del contendere. La maggior parte di queste ipotesi si
sono avute – come più dettagliatamente riferito supra, par. 5 – in
relazione all’avvenuta abrogazione, sostituzione o modifica delle disposizioni
impugnate (sentenze nn. 50, 108, 205, 272, 304,
378 383 e 407, ed ordinanze nn. 428, 474 e 477).
In quattro casi, si è riproposta, invece, la cessazione della materia del
contendere conseguente alla promulgazione parziale delle leggi siciliane
sottoposte allo scrutinio di legittimità costituzionale (ordinanze nn. 103,
169, 293 e 403).
B] Il n. più cospicuo di decisioni
processuali è costituito, comunque, dalle 61 pronunce di inammissibilità,
sovente presenti in n. plurimo all’interno di una decisione (ad esempio, si
contano 13 capi di dispositivo nella sentenza n. 50, 8 nella sentenza n.
272 e 5 nella sentenza n. 383).
Siffatte pronunce sono motivate
principalmente da difetti riscontrati in ordine alla motivazione delle censure
(sentenze nn. 50, 65, 202, 205, 272, 279,
304, 323, 335, 336, 383, 417, 450
e 462), da vizi nella individuazione dei termini delle questioni
(sentenze nn. 26, 37, 150, 151, 203, 360
e 383), dall’invocazione di parametri diversi da quelli concernenti il
riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni (sentenze nn. 36, 50,
270, 285, 383 e 384) e dal difetto di interesse,
variamente argomentato (sentenze nn. 37, 50, 71 e 397),
anche in relazione ad una rinuncia «sostanziale» (sentenza n. 36; sul
punto, si rinvia a quanto detto supra, par. 5).
Piuttosto numerosi sono anche i casi
nei quali l’inammissibilità deriva dall’assenza, nella deliberazione del
Consiglio dei ministri o della Giunta regionale, di riferimenti relativi alle
poi disposizioni oggetto di impugnazione (sentenze nn. 50, 150 e 300);
non mancano, poi, decisioni che censurano la genericità della delibera in
questione (sentenze nn. 50, 384).
Nella sentenza n. 344, la
decisione processuale ha fatto seguito alla constatazione della tardività della
notifica del ricorso, mentre la sentenza n. 469 censura l’erroneità del
procedimento di impugnazione per il quale si è optato (trattavasi di una
delibera statutaria di una Regione ordinaria impugnata nelle forme di cui
all’art. 127 della Costituzione; sul tema, si rinvia, comunque, alle
considerazioni svolte infra, par. 9).
C] Ad esaurire il novero delle
decisioni di tipo processuale, deve menzionarsi l’ordinanza n. 20, con
la quale il deposito tardivo del ricorso è stato all’origine di una
declaratoria di manifesta inammissibilità.
La maggioranza relativa delle formule
contenute nei dispositivi delle decisioni è rappresentata da quelle che constatano
la non fondatezza delle questioni poste, che sono, in totale, 155. Tra queste,
8 sono interpretative di rigetto, presentando il riferimento a «i sensi di cui
in motivazione».
Il dato relativamente esiguo delle
decisioni interpretative non osta alla constatazione del notevole impiego di
strumenti ermeneutici anche nell’ambito del giudizio in via principale. Sono,
infatti, assai frequenti le sentenze di rigetto che, pur non recando traccia
nel dispositivo, possono dirsi, nella sostanza, interpretative (sentenze nn. 31,
36, 120, 231, 270, 278, 431 e 449).
Ad esse possono aggiungersi le statuizioni che muovono dal riconoscimento di un
erroneo presupposto interpretativo (sentenze nn. 272 e 336),
ovvero dalla necessità di disattendere interpretazioni prospettate in chiave
difensiva (sentenze nn. 108 e 465). Parimenti,
Lo sviluppo dell’attività ermeneutica
nel giudizio in via principale ha fatto sì che anche in esso la declaratoria di
illegittimità costituzionale si configurasse alla stregua di una extrema ratio. Ne sono dimostrazioni
eloquenti quelle statuizioni nelle quali
8.5.
Le decisioni di accoglimento
I capi di dispositivo che recano una
declaratoria di illegittimità costituzionale sono 99. Le tipologie di
accoglimento presentano forti profili di comunanza con quelle che si sono
riscontrate nel giudizio in via incidentale (accoglimento tout court, ablativo, additivo, sostitutivo), con l’aggiunta della
declaratoria in via consequenziale, quest’anno assente nei dispositivi dei
processi in via d’eccezione.
A] Per quel che concerne le
illegittimità costituzionali tout court,
si segnalano 33 casi (sentenze 50 –
2 capi di dispositivo –, 51, 62 – 3 capi –, 77, 106, 107, 159, 160, 167, 190, 232, 270, 271, 272, 277, 285 – 2 capi –, 286, 319, 335, 355, 378 – 2 capi –, 391, 405, 406, 407, 424, 455 e 465).
Da notare è che, se generalmente
queste formule si rivolgono ad uno o più articoli o commi, talvolta colpiscono un
atto nel suo complesso. A tal proposito si segnalano i 3 capi di dispositivo di
cui alla sentenza n. 62 e la
sentenza n.
A queste decisioni può ricondursi, in
certa misura, anche la sentenza n. 391
che reca una illegittimità costituzionale dell’«articolo unico» di una legge
regionale.
B] In ordine alle decisioni additive,
al loro n. piuttosto elevato (33 capi di dispositivo), corrisponde anche una
certa varietà nella formulazione. Così, se nella maggior parte dei casi
l’incostituzionalità di una disposizione viene pronunciata «nella parte in cui
non prevede» un determinato contenuto (sentenze nn. 51, 162, 219, 242, 279 – 2 capi di
dispositivo –, 285 – 2 capi –, 383 – 5 capi – e 384 – 2 capi –), non mancano altri tipi di dichiarazioni:
dall’incostituzionalità della disposizione «nella parte in cui non esclude» un
certo contenuto (nella specie, l’applicazione di un regolamento alle Province
autonome di Trento e di Bolzano: sentenza n. 145) all’incostituzionalità «nella parte in cui non dispone»
(sentenze nn. 285 – 11 capi di
dispositivo – e 383 – 2 capi –),
formula, quest’ultima, particolarmente utilizzata nei casi di decisioni
«manipolative di procedura» (su cui, v. infra).
Tra le decisioni di tipo additivo,
alcune presentano peculiarità che meritano almeno un cenno.
La prima è la sentenza n. 271, con la quale si dichiara
l’incostituzionalità di una disposizione legislativa regionale «nella parte in
cui non richiama», all’interno del testo, il necessario rispetto della
legislazione statale nella materia su cui va ad incidere (nella specie, la
protezione dei dati personali): l’additiva, in questo caso, non si pone come
una «aggiunta» di contenuto normativo, ma semmai come una esplicitazione dei
rapporti intercorrenti tra legislazione statale e legislazione regionale.
Altra decisione da segnalare è la
sentenza n. 62, che reca due
dispositivi costruiti come una compenetrazione tra incostituzionalità additiva
ed interpretativa. Vi si dichiara, infatti, l’illegittimità costituzionale di
due disposizioni legislative statali «nella parte in cui non preved[ono] una
forma di partecipazione della Regione interessata, nei sensi di cui in
motivazione», a determinati procedimenti. Questo tipo di declaratoria appare
funzionale alla introduzione, attraverso una «manipolativa di procedura», di
meccanismi di raccordo ulteriori – individuati in motivazione – rispetto a
quelli già contemplati dalle disposizioni censurate, in merito a procedimenti e
fasi diverse da quelli nelle quali le Regioni hanno già la possibilità di
intervenire.
Infine, la sentenza n. 231 può annoverarsi nell’ambito delle
decisioni «additive di principio», adottando una «manipolativa di procedura»
(veicolata dalla illegittimità costituzionale di una disposizione, «in quanto
non prevede alcuno strumento volto a garantire la leale collaborazione tra
Stato e Regioni») che, constatata l’esigenza di un coinvolgimento delle Regioni
nel procedimento disciplinato dalla disposizione legislativa statale oggetto
del giudizio, non precisa quali in concreto debbano essere gli strumenti
attraverso cui garantire un tale coinvolgimento, all’uopo rilevando, in
motivazione, che «il principio di leale collaborazione può essere diversamente
modulato poiché nella materia in oggetto non si riscontra l’esigenza di
specifici strumenti costituzionalmente vincolati di concretizzazione del
principio stesso», e dunque che «deve essere rimessa alla discrezionalità del
legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale».
C] Meno numerose delle sentenze
additive, ma comunque tutt’altro che infrequenti – 26 capi di dispositivo, in
totale – sono le decisioni di tipo ablativo. La maggior parte di esse sono
strutturate come illegittimità costituzionali di una disposizione
«limitatamente alle parole» specificate nel dispositivo (sentenze nn. 270 – 7 capi –, 321, 383 – 2 capi –, 384 – 2 capi –, 431 – 2 capi – e 445).
Negli altri casi, l’incostituzionalità della norma è dichiarata «nella parte in
cui prevede» qualcosa (sentenze nn. 30,
145, 397 e 456) o «nella
parte in cui introduce» una nuova disposizione legislativa (sentenza n. 383). Ancora, con valore
sostanzialmente analogo, l’incostituzionalità ha avuto riguardo alla
disposizione «nella parte in cui include» determinati soggetti tra i propri
destinatari (nella specie, le amministrazioni statali e degli enti pubblici
nazionali esistenti nel territorio della Regione da cui la legge impugnata
proveniva: sentenza n. 26), «nella
parte in cui si applica» a certi soggetti (nella specie, il personale delle
Regioni: sentenza n. 449) o «nella
parte in cui si riferisce» a certe categorie di personale ovvero alle Regioni
ed agli enti locali (rispettivamente, sentenze nn. 407 e 417).
L’incostituzionalità ablativa ha
avuto anche riguardo all’annullamento della disposizione «nella parte in cui
disciplina» una certa attività (sentenza n. 108) o, infine, «nella parte in cui demanda» alla fonte
regolamentare la disciplina di alcuni aspetti della normativa oggetto del
giudizio» (sentenza n. 431).
D] In 4 casi,
E] Come si vede, tutte le decisioni
sostitutive possono classificarsi all’interno di una specifica categoria,
quella concernente le «manipolative di procedura», le decisioni, cioè, nelle
quali l’illegittimità costituzionale mira a modulare una disciplina che sia
pienamente conforme al principio di leale cooperazione, principio cardine
dell’assetto autonomistico.
Con siffatte statuizioni,
Questo tipo di decisioni ha assunto
una consistenza assai rilevante: al fianco delle decisioni sostitutive e della
additiva di principio cui si è accennato, possono citarsi, al riguardo, varie
decisioni additive strutturate secondo lo schema classico (sentenze nn. 51, 62, 162, 219, 242, 278, 383 e 384).
F] Nel corso del 2005, sono state
adottate anche 3 dichiarazioni di illegittimità costituzionale in via
consequenziale, ai sensi dell’art. 27, secondo periodo, della legge n. 87 del
1953.
Nelle sentenze nn. 355 e 405, alla declaratoria principaliter
di alcune disposizioni ha fatto seguito la incostituzionalità di tutte le altre
disposizioni della legge regionale censurata,
9.
Il controllo degli statuti ordinari ai sensi dell’art. 123 della Costituzione
Nel corso del 2005,
Il Presidente del Consiglio dei ministri
aveva impugnato molteplici disposizioni dello statuto della Regione Liguria
approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione
il 28 settembre 2004. Nelle more della decisione della Corte, il ricorrente –
premesso che, in adeguamento ai rilievi formulati,
Più significative, ai fini della
individuazione delle peculiarità del procedimento di approvazione dello statuto
(e, quindi, anche del giudizio della Corte), sono le sentenze nn. 445 e 469, ambedue rese a proposito di ricorsi promossi ex art. 127 della Costituzione.
La prima ha deciso il ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri avverso l’articolo 3, comma 3, della
legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004, n. 31 (Norme procedurali per lo
svolgimento del referendum previsto dall’art. 123, comma 3, della
Costituzione), nella parte in cui prevedeva che le operazioni referendarie di
cui all’art. 123, terzo comma, Cost., iniziate prima del giudizio della Corte
costituzionale sulla deliberazione statutaria impugnata dal Governo, perdessero
efficacia «qualora [venisse] pronunciata l’illegittimità totale della
deliberazione statutaria ovvero [venisse] pronunciata l’illegittimità parziale
della medesima e le parti dichiarate incostituzionali coincid[essero] con
l’oggetto della richiesta referendaria».
Ad avviso del ricorrente, la
previsione che potessero esservi richieste referendarie coincidenti con le
parti della deliberazione statutaria in ipotesi dichiarate incostituzionali si
poneva in contrasto con la previsione costituzionale secondo cui il referendum
deve avere ad oggetto soltanto l’intera delibera statutaria e non singole norme
o parti di essa.
Sulla scorta di questi rilievi di
ordine generale, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3,
comma 3, della legge regionale della Liguria n. 31 del 2004 è stata peraltro
limitata alle sole parole «e le parti dichiarate incostituzionali coincidano
con l’oggetto della richiesta referendaria», in quanto erano queste a far
erroneamente ritenere ammissibile l’ipotesi di una richiesta referendaria
limitata ad alcune delle disposizioni contenute nella deliberazione statutaria
(esente da profili di illegittimità era, invece, il riferimento, contenuto
nello stesso comma 3 dell’art. 3 della legge regionale, alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale solo di parte della deliberazione statutaria, «dal momento che
anch’essa determinava la necessità che venisse considerato inefficace il
precedente procedimento di richiesta referendaria, in quanto concernente un
testo statutario diverso da quello risultante dalla pronuncia di accoglimento
[della] Corte»).
Di notevole interesse è anche la
sentenza n. 469, relativa ai giudizi
di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 16 aprile 2005,
n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), e della legge della Regione
Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna),
promossi con distinti ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell’art. 127 della Costituzione.
Entrambi i testi statutari erano
stati oggetto di precedenti impugnative del Governo, ai sensi dell’art. 123,
secondo comma, della Costituzione, e le conseguenti sentenze della Corte nn.
378 e 379 del 2004, accogliendo in minima parte le questioni di legittimità
sollevate, avevano dichiarato la illegittimità costituzionale di alcune
disposizioni delle due delibere statutarie.
Entrambi i testi non erano stati
oggetto di riesame da parte dei rispettivi Consigli regionali tramite la
procedura di cui all’art. 123, secondo comma, della Costituzione, ma, dopo una
fase di pubblicazione notiziale degli esiti del giudizio di costituzionalità e
la riapertura dei termini per l’eventuale richiesta di referendum ai
sensi dell’art. 123, terzo comma, erano stati promulgati dai Presidenti delle rispettive
Regioni.
A fondamento dell’impugnativa, il
Governo negava che si potesse, sulla base dell’art. 123 della Costituzione,
procedere alla promulgazione di una delibera statutaria dichiarata parzialmente
illegittima senza procedere previamente al suo riesame e ad una nuova
approvazione secondo la procedura di cui all’art. 123, secondo comma, della
Costituzione (l’asserita illegittimità della procedura di promulgazione seguita
dalle Regioni avrebbe inoltre leso – sempre ad avviso del Governo – il diritto
degli elettori regionali ad esercitare il potere di richiedere referendum
popolare sul testo della deliberazione statutaria).
Entrambi i ricorsi sono stati dalla
Corte dichiarati inammissibili, in quanto proposti «non già nell’ambito del procedimento
di controllo preventivo di cui all’art. 123, secondo comma, Cost., ma
nell’esercizio del potere che l’art. 127, primo comma, Cost. riconosce al
Governo di impugnare a posteriori le leggi regionali, quindi assumendo
come termine iniziale di riferimento per l’esercizio dell’azione la data della
pubblicazione della legge regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione
interessata».
Nella sentenza si è sottolineato che
le due azioni promosse dal Governo contrastavano «con il sistema dei controlli sulle
fonti primarie regionali quale attualmente configurato nel Titolo V della Parte
II della Costituzione e, specificamente, con le previsioni contenute nell’art.
123, secondo comma, e nell’art. 127, primo comma, che individuano due ben
distinte procedure di controllo, mediante ricorso diretto del Governo [alla]
Corte, per la legge che adotta lo statuto regionale e per tutte le altre leggi
regionali».
Secondo
Ad evitare lacune nel sistema delle
garanzie,
In entrambi i casi di specie la
suddetta seconda pubblicazione notiziale si era verificata, ed era dunque
evidente che il Governo avrebbe potuto promuovere il ricorso di cui al secondo
comma dell’art. 123, sollevando le questioni di legittimità costituzionale
oggetto dei giudizi nel termine dei trenta giorni successivi alle suddette
pubblicazioni notiziali, termine che era invece ampiamente scaduto al momento
della proposizione dei due ricorsi avverso le leggi di adozione degli statuti
in questione.
Conclusivamente, si osservava che «la
tipicità dell’azione prevista dall’art. 123, secondo comma, Cost. e la
conseguente inutilizzabilità del ricorso ex 127, primo comma, Cost., per
le deliberazioni di adozione delle leggi statutarie non esclude […] che possa
impugnarsi la promulgazione e la successiva vera e propria pubblicazione di un
testo statutario in ipotesi incostituzionale per vizi non rilevabili tramite il
procedimento di cui all’art. 123, secondo comma, Cost.»; «in simili casi
(peraltro senza dubbio marginali) al Governo resta comunque la eventuale
possibilità di utilizzare lo strumento del conflitto di attribuzione,
analogamente a quanto nel passato si è ammesso per le ipotesi, in qualche
misura analoghe, concernenti la asserita lesione dei poteri governativi
relativi al controllo preventivo sulle leggi regionali ai sensi del previgente
art. 127 Cost. (sentenza n. 40 del 1977)».
Il giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni
e tra Regioni
Nel contenzioso che oppone lo Stato
alle Regioni ed alle Province autonome, il giudizio per conflitto di
attribuzione ha avuto un ruolo decisamente meno rilevante di quello che, nel
2005 (come, del resto, nel 2004), ha avuto il giudizio di legittimità
costituzionale in via principale.
Nonostante la relativa esiguità del n.
di decisioni (16), possono comunque riscontrarsi alcuni spunti di un certo
interesse concernenti gli aspetti processuali del conflitto.
Dei 22 conflitti decisi nel 2005, 20
sono stati promossi da una Regione o da una Provincia autonoma contro lo Stato;
in un solo caso si è avuta l’ipotesi inversa (ordinanza n. 217), mentre in un caso il conflitto è stato promosso da una
Regione contro una Provincia autonoma (sentenza n. 133).
Generalmente, i resistenti si sono
sempre costituiti. Le uniche eccezioni sono rappresentate dalla Regione
Sardegna, nel conflitto deciso con l’ordinanza n. 217, e dallo Stato nel conflitto deciso con la sentenza n.
Oltre al ricorrente ed al resistente,
in due casi hanno presentato memorie anche soggetti ulteriori.
Il primo si è avuto nel giudizio
vertente sulla controversia tra
Il secondo caso ha riguardato il
conflitto deciso con la sentenza n. 386,
nel quale era stato sottoposto allo scrutinio della Corte l’atto di nomina del
Presidente dell’Autorità portuale di Trieste. Tale intervento è stato
dichiarato ammissibile in quanto l’interveniente era, «pacificamente, parte di
giudizi pendenti davanti al Tar del Friuli-Venezia Giulia, aventi ad oggetto la
legittimità del provvedimento di nomina del Presidente dell’Autorità portuale».
In ragione di ciò, trovava applicazione il principio, enunciato dalla Corte in
fattispecie analoghe, secondo il quale «il potere di intervento non può essere
precluso quando “l’esito del conflitto è suscettibile di condizionare la stessa
possibilità che il giudizio comune abbia luogo” (sentenze n. 225
e n. 76 del 2001;
sentenza n. 154
del 2004)».
3.
La deliberazione del ricorso
Nell’ambito delle decisioni
pronunciate nel 2005, non si riscontrano questioni di particolare momento
relativamente alla deliberazione del ricorso per conflitto ed al procedimento
che da tale deliberazione prende avvio. A tal proposito, possono comunque
menzionarsi due decisioni.
Nella sentenza n. 121
Con precipuo riguardo al caso di
specie, il conflitto non poteva essere inficiato dall’asserita tardività, in
quanto
Nella sentenza n. 386 si è affrontato il tema dei
rapporti tra il giudizio per conflitto di attribuzione ed il giudizio di
legittimità costituzionale in via principale. Il ricorso per conflitto di
attribuzione poneva alcune questioni che erano oggetto anche di ricorso in via
principale. A tal proposito,
La categoria di atti più
frequentemente impugnata, nel quadro delle decisioni rese nel 2005, è stata
quella dei decreti ministeriali, di natura regolamentare oppure amministrativa
(nel primo senso, vengono in rilievo i due decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali oggetto delle sentenze nn. 263 e 287 ed i quattro
decreti del Ministro per le politiche agricole di cui alla sentenza n. 324; nel secondo senso, possono citarsi
il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’ordinanza n. 4 ed i due decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti oggetto delle sentenze nn. 339 e 387).
Ancora nell’ambito degli atti del
potere esecutivo nazionale, la sentenza n.
Le sentenze nn. 72 e 73 hanno
riguardato, l’una, risoluzioni dell’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale
Gestione Tributi e, l’altra, una analoga risoluzione ed un provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate.
L’Avvocatura dello Stato aveva
eccepito l’inammissibilità dei conflitti in quanto aventi ad oggetto atti «non
dello Stato, ma dell’Agenzia delle entrate».
Riconducibili ancora
all’amministrazione statale sono gli atti impugnati nei conflitti decisi –
peraltro, nel senso dell’inammissibilità (v. infra, par. 6) – con la sentenza n. 177, che ha avuto ad oggetto un decreto dell’Agenzia del demanio,
una convenzione tra amministrazione dello Stato e Comune di Cagliari,
convenzioni aventi ad oggetto un compendio immobiliare situato in Cagliari,
atti di gestione concernenti determinati beni immobili.
La sentenza n.
Per quanto attiene alle funzioni di
controllo della Corte dei conti, la sentenza n.
Dodici ordini di esibizione in forma
integrale della documentazione e degli atti contabili pertinenti le
contribuzioni e i finanziamenti liquidati dall’Assemblea regionale siciliana,
emessi dalla Procura regionale presso la sezione giurisidizionale della Corte
dei conti per
Infine, per quanto concerne gli atti
regionali o provinciali impugnati in sede di conflitto, trattasi, in un caso, di
una deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento e di una
determinazione del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche
della Provincia di Trento (sentenza n. 133)
e, nell’altro, di una ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della
Giunta della Regione Sardegna (ordinanza n. 217).
La circostanza che, dei 22 conflitti
definiti nel 2005, ben 14 abbiano visto coinvolti (in posizione di ricorrente o
di resistente) una Regione speciale o una Provincia autonoma, ha inciso
inevitabilmente sui parametri invocati.
In effetti, l’evocazione di uno degli
statuti speciali ha caratterizzato i giudizi definiti con le sentenze nn. 72, 73, 121, 133, 135, 171, 177, 263, 287, 302, 337 e 386, e l’ordinanza
n. 217). Generalmente, al fianco
della violazione dello statuto speciale, è stata dedotta anche la violazione
delle norme di attuazione dello stesso (sentenze nn. 72, 73, 121, 171, 177, 263, 287, 302 e 386). A questi parametri si è aggiunto
il riferimento, veicolato dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, alle disposizioni del Titolo V della Parte seconda della
Costituzione, riferimento che talvolta si è sommato a quello dei decreti di
attuazione degli statuti (sentenze nn. 121,
263 e 287) e talaltra vi si è sostituito (sentenze nn. 217 e 337).
Le disposizioni del nuovo Titolo V
sono state invocate come unico parametro di giudizio in due sole occasioni
(sentenza n. 339 ed ordinanza n. 4), tante quante sono state le invocazioni
del Titolo V in sede di conflitto sollevato anteriormente alla riforma
(sentenze nn. 133 e 324): per giurisprudenza consolidata,
in questi casi ad essere impiegati sono stati i parametri vigenti al momento
della proposizione del ricorso.
Da notare è che, sia nella sentenza
n. 133 che nella sentenza n. 324, il parametro costituzionale è
stato integrato anche con il richiamo a disposizioni di rango legislativo
(rispettivamente, il decreto legislativo n. 112 del 1998, sul conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali,
ed il decreto legislativo n. 143 del 1997, sul conferimento alle Regioni delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca).
Piuttosto frequente è stata anche
l’invocazione del principio costituzionale di leale cooperazione (in
particolare, sentenze nn. 72, 73, 177, 324 e 386, nonché, implicitamente ma
inequivocabilmente, sentenza n. 339).
6.
La materia del contendere ed il «tono costituzionale» del conflitto
Con riferimento alla materia del
contendere ed al «tono costituzionale» del conflitto, possono segnalarsi
quattro diverse categorie di pronunce, relative, rispettivamente, a (a) l’esistenza di un contrasto puramente
interpretativo, a (b) il difetto di
interesse al conflitto, a (c) la
inidoneità dell’atto impugnato a ledere le attribuzioni costituzionali ritenute
violate ed a (d) il conflitto avente
ad oggetto una vindicatio rerum.
a) Nella prima
categoria, si annovera la sentenza n. 121,
nella quale si è deciso il conflitto sollevato avverso un decreto di revoca
dell’autorizzazione alla certificazione comunitaria, rilasciata all’organismo I
& S, Ingegneria e Sicurezza S.r.l., di Bolzano.
Le posizioni rispettivamente
sostenute dalla Provincia e dal Governo non consentivano di ravvisare nella
controversia «la materia di un conflitto di attribuzione ex art. 39
della legge n. 87 del 1953, sia sotto il profilo soggettivo della rivendicazione
di una sfera di competenza costituzionalmente riservata alla Provincia, sia
sotto l’aspetto oggettivo della menomazione della sfera di attribuzioni
costituzionali della Provincia a seguito dell’esercizio illegittimo del potere
dello Stato». Ciò in quanto
Risultava pertanto «evidente che la
controversia, risolvendosi in un contrasto interpretativo sulla sfera di
applicazione» della normativa comunitaria e del d.P.R. n. 162 del 1999, era
«priva del necessario carattere costituzionale, in quanto non tocca[va] la
ripartizione delle competenze tra Stato e Provincia autonoma»: l’eventuale
illegittimità del decreto impugnato, «non essendo riconducibile ad un contrasto
con norme costituzionali relative alla spettanza del potere, avrebbe dunque
potuto offrire motivo per un ricorso avanti alla giurisdizione amministrativa,
ma non incide[va] sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente riconosciuta
alla Provincia».
b) Nelle
sentenze nn. 263 e 287,
Con la sentenza n. 324, si è constatato che le modifiche
legislative e l’abrogazione del decreto ministeriale oggetto del conflitto da
parte di un decreto legge poi convertito, con modificazioni, in legge, non
facevano venire meno l’interesse al conflitto proposto dalla Regione, «atteso
che gli effetti dell’abrogazione del regolamento impugnato non [erano]
retroattivi, ma decorr[eva]no “dal primo periodo di applicazione del medesimo
decreto legge” […] e considerato che la norma secondaria, medio tempore,
ha ricevuto attuazione».
c) Circa
l’inidoneità dell’atto impugnato a ledere le attribuzioni costituzionali del
ricorrente,
Nella prospettazione erariale, la
(eventuale) lesione della sfera di attribuzione della Provincia di Trento
sarebbe, in ipotesi, stata prodotta dalla legge attributiva del potere
regolamentare di cui la ricorrente lamentava l’esercizio, e non dal regolamento
ministeriale oggetto del conflitto, meramente esecutivo della prima.
L’inidoneità dell’atto impugnato a
ledere le attribuzioni costituzionali contestate è stata invece all’origine
delle decisioni di inammissibilità pronunciate con le sentenze nn. 72 e 73. Premesso che, «per aversi materia di un conflitto di
attribuzione tra Regione e Stato, è necessario che l’atto impugnato sia idoneo
a ledere la sfera di competenza costituzionale dell’ente confliggente», si è
riconosciuto che gli atti oggetto dei conflitti, vale a dire risoluzioni
dell’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Gestione Tributi e un
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, non possedevano questa
caratteristica, in quanto, in un caso, si limitavano, «attraverso l’istituzione
di codici-tributo, a fornire istruzioni sulle modalità di versamento delle imposte
e, pertanto, inserendosi in una fase procedimentale meramente provvisoria (che
precede l’intervento dell’indicata struttura di gestione e non ne condiziona
l’operato), non incid[eva]no sulla spettanza del gettito e non [erano] idonei a
ledere le prerogative costituzionali della Regione Siciliana in materia
finanziaria» (sentenza n. 72), e,
nell’altro caso, «si limita[va]no a regolare le modalità di versamento del
contributo unificato, senza incidere sull’assegnazione della quota spettante
alla Regione Siciliana del gettito correlativo, e a disciplinare un aspetto
esecutivo del procedimento di riscossione del contributo, con efficacia esterna
solo nei confronti dei contribuenti e dei soggetti abilitati a riceverne i
versamenti» (sentenza n. 73).
La sentenza, infine, n.
d) Due sono
stati i casi di declaratoria di inammissibilità motivata dalla circostanza che
il conflitto si risolveva (in tutto o in parte) in una pura vindicatio rerum: per consolidata
giurisprudenza, infatti,
Nel caso deciso con la sentenza n. 177, le pretese delle due ricorrenti,
che avevano promosso conflitto avverso un atto del Direttore dell’Agenzia del
demanio, che individuava come appartenenti al patrimonio dello Stato taluni
beni immobili esistenti nei rispettivi territori, erano fondate esclusivamente
sulla dedotta appartenenza ad esse dei beni immobili in questione, «senza alcun
riferimento a (neanche ipotizzate) lesioni di attribuzioni regionali
costituzionalmente garantite, in ragione di un eventuale nesso di strumentalità
necessaria tra beni e attribuzioni». Questo specifico contenuto rendeva
manifesto come i conflitti fossero «in realtà diretti soltanto all’accertamento
del titolo giuridico di appartenenza dei beni».
Nella sentenza n. 302, invece, pronunciandosi circa una
nota del Provveditorato regionale alle opere pubbliche – Magistrato alle acque
di Venezia con la quale si eccettuava dal trasferimento al demanio della
Regione talune tratte del torrente Judrio e dei fiumi Tagliamento e Livenza e
si invitavano le Agenzie del demanio interessate a non procedere al
trasferimento a favore dell’ente territoriale di alcuni beni immobili (caselli
e magazzini idraulici) del demanio idrico statale,
In tre casi, si è proceduto ad una
riunione di più ricorsi.
La sentenza n. 171, che ha deciso congiuntamente due ricorsi promossi dalla
Provincia autonoma di Trento, ha dato conto della «connessione soggettiva ed
oggettiva» dei due giudizi, aventi ad oggetto rispettivamente una nota della
sezione di controllo di Trento della Corte dei conti ed una connessa
deliberazione delle sezioni riunite in sede di controllo della medesima Corte.
Nella sentenza n. 177 si è dato conto, ai fini della
riunione, che le due Regioni ricorrenti chiedevano l’annullamento «del medesimo
provvedimento in base a motivazioni sostanzialmente coincidenti, pur se
riferite alle rispettive norme statutarie».
Infine, con la sentenza n. 324,
si sono decisi cinque ricorsi, promossi da due diverse Regioni, aventi tutti ad
oggetto regolamenti ministeriali in materia di «quote latte»; a fondamento
della riunione è stata addotta «la sostanziale identità dell’oggetto delle
questioni proposte nei cinque giudizi».
Le 14 sentenze e le 2 ordinanze rese
nel 2005 recano, complessivamente, 18 formule all’interno dei dispositivi,
molte delle quali di tipo processuale.
8.1.
Le decisioni interlocutorie
Nell’ambito del giudizio concluso con
la sentenza n. 324,
8.2.
L’estinzione del giudizio
In tre casi, i giudizi sono stati
dichiarati estinti a seguito dell’intervenuta rinuncia al ricorso accettata
dalla controparte costituita (sentenza n. 324
ed ordinanza n. 4). Nel caso della
ordinanza n. 217, la mancata
costituzione della resistente ha reso superflua la sua accettazione
(trattavasi, peraltro, dell’unico ricorso promosso dallo Stato).
Da notare è che la sentenza n.
8.3.
Le decisioni di inammissibilità
I 6 dispositivi di inammissibilità
del ricorso sono stati motivati, come si evince da quanto evidenziato supra, par. 6), dalla inidoneità
dell’atto impugnato a ledere le attribuzioni costituzionali del ricorrente
(sentenze nn. 72, 73 e 386), dalla esistenza, al fondo del conflitto, di un contrasto
puramente interpretativo (sentenza n. 121)
e dalla mera vindicatio rerum che
caratterizzava il petitum (sentenze
nn. 177 e 302).
Le 9 formule con le quali
La decisione di non spettanza della
competenza esercitata dall’ente che ha posto in essere l’atto ha condotto al
conseguente annullamento dell’atto. Tale annullamento è stato, in quattro casi,
totale (sentenze nn. 133, 171, 337 e 339), mentre in
due casi degli atti regolamentari impugnati sono state annullate varie
disposizioni, ma non integralmente bensì «nella parte in cui si applica[va]no
alle Province autonome di Trento e di Bolzano» (sentenze nn. 263 e 287). Queste ultime decisioni hanno spiegato dunque effetti, non
solo nei confronti della ricorrente (Provincia di Trento), ma anche dell’altra
Provincia autonoma, a seguito dell’estensione motivata dalla «piena
equiparazione statutaria delle Province autonome di Trento e di Bolzano
relativamente alle attribuzioni di cui tratta[va]si»).
Il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato
Nel 2005,
Gli organi della magistratura
giudicante sono stati all’origine della maggioranza dei ricorsi della cui
ammissibilità
Tutte le ordinanze che hanno fatto
seguito ad un ricorso di organi della magistratura giudicante hanno riguardato
delibere di insindacabilità dei parlamentari, donde l’individuazione
preliminare del soggetto resistente in una delle due camere (
Parzialmente diverso è il caso
affrontato con l’ordinanza n.
Il Presidente della Repubblica (in
carica) è stato all’origine del conflitto dichiarato ammissibile con
l’ordinanza n. 354, che ha riservato
alla fase di merito una più approfondita indagine circa l’ammissibilità del
conflitto, coinvolgente il Ministro della giustizia, anche con riguardo ai
requisiti soggettivi.
Nell’ordinanza n. 404 è stata positivamente valutata la
legittimazione al conflitto degli organi della magistratura requirente («in
conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, deve essere
riconosciuta la legittimazione del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Tempio Pausania a sollevare conflitto di attribuzione, in quanto
organo direttamente investito delle funzioni previste dall’art. 112 della
Costituzione e dunque gravato dell’obbligo di esercitare l’azione penale e le
attività di indagine a questa finalizzate»), oltre che del Presidente del
Consiglio dei ministri, «in quanto organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela,
apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato» (indirizzo,
quest’ultimo, ampiamente consolidato).
Un conflitto è stato sollevato anche
dal Consiglio superiore della magistratura, la cui legittimazione è stata
ribadita in ragione del suo essere «organo direttamente investito delle
funzioni previste dall’art. 105 della Costituzione» (ordinanza n. 116, che ha contestualmente
riconosciuto la legittimazione passiva del Governo nel suo complesso e delle
due camere).
Per quanto attiene agli organi
esterni allo Stato-persona, l’ordinanza n.
I profili soggettivi del conflitto
sono dunque stati riscontrati in quasi tutte le occasioni. L’unica eccezione è
costituita dal ricorso di cui all’ordinanza n. 479, sollevato dai promotori del referendum sullo statuto
della Regione Umbria e di rappresentanti dell’apposito «Comitato per il referendum
sullo Statuto regionale dell’Umbria», avverso la promulgazione della legge
della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione
Umbria), nonché, «per quanto occorr[esse]», avverso le modificazioni introdotte
al quesito referendario e ai moduli per la richiesta di referendum ad
opera dell’Ufficio di Presidenza e del Segretario generale del Consiglio
regionale dell’Umbria con decisione del 14 dicembre 2004».
Nel vaglio circa la legittimazione
attiva e passiva,
Sempre con riferimento ai profili
soggettivi, pur se in un’ottica estranea alla legittimazione attiva e passiva,
può segnalarsi l’atto di intervento depositato, nel giudizio di ammissibilità
concluso con l’ordinanza n. 404,
dalla associazione “Friends of the earth international – Amici della Terra”
associazione non governativa ambientalista, riconosciuta con d.m. 20 febbraio
1987, ex art. 13 della legge n. 349 del 1986, nonché l’associazione
“Gruppo d’intervento giuridico”, associazione ambientalista non riconosciuta ex
articoli 36 e ss. cod. civ. Essendo
Nella maggioranza dei casi sottoposti
alla Corte, ad essere impugnate erano – come detto – delibere parlamentari di
insindacabilità, in ordine alla quali è stata riconosciuta la sussistenza della
materia di un conflitto: gli organi giurisdizionali denunciavano, infatti, la
menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme
costituzionali, in conseguenza dell’adozione, da parte di una delle camere, di
una deliberazione ove si affermava, in modo asseritamente illegittimo, che le
opinioni espresse da un proprio membro rientravano nell’esercizio delle
funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilità
stabilita dall’art. 68, primo comma, della Costituzione (ordinanze nn. 5, 10,
56, 94, 105, 117, 119, 178, 294, 330, 416 e 473; le ordinanze nn. 104 e 129, di inammissibilità, non hanno smentito questa ricostruzione).
Validamente instaurati sono stati
anche i conflitti in cui
Nel caso di cui all’ordinanza n. 44, oggetto del conflitto sono stati
due provvedimenti di rinvio dell’udienza, il provvedimento di trattenimento
della causa in decisione ed anche un’ordinanza di rimessione degli atti alla
Corte costituzionale posti in essere dal Tribunale di Messina; la ricorrente
prospettava la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente
garantite, in conseguenza degli impugnati provvedimenti, contestando non già
«il semplice esercizio della funzione giudiziaria, bensì la stessa appartenenza
all’ordine giudiziario del potere in concreto esercitato», e inoltre negando
«la titolarità, in capo al giudice, del potere di proseguire il giudizio».
Il ricorso dichiarato ammissibile con
l’ordinanza n. 185 aveva ad oggetto
un’ordinanza con la quale erano state respinte le eccezioni relative al dedotto
impegno parlamentare dell’imputato concomitante con un’udienza, ed era stato
disposto doversi procedere oltre nel dibattimento, un’ordinanza con la quale,
relativamente allo stesso impedimento del predetto imputato, erano state
respinte le eccezioni difensive in ordine alla nullità degli atti processuali tra
cui il decreto che aveva disposto il giudizio, ed era stato disposto doversi
procedere oltre nel dibattimento, la sentenza con la quale, relativamente allo
stesso impedimento del predetto imputato, era stato implicitamente ribadito, ma
senza alcuna motivazione, quanto stabilito nelle predette ordinanze. La
ricorrente, dunque, prospettava la lesione della sfera di attribuzioni
costituzionalmente garantite alla Camera, per via del mancato riconoscimento
giudiziale del «legittimo impedimento» di un deputato a partecipare all’udienza
del processo penale in cui è imputato per concomitanti impegni parlamentari.
Del tutto analoga alla materia del
contendere di cui al ricorso dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 185 era quella contemplata nel ricorso
di cui all’ordinanza n. 186.
L’ordinanza n.
Circa il conflitto instaurato dal
Presidente della Repubblica,
È stata confermata la astratta
possibilità di impugnare, in sede di conflitto interorganico, un atto
legislativo, sebbene
L’ordinanza n.
I ricorrenti deducevano, in via
principale, che la data fissata per lo svolgimento delle consultazioni
referendarie non avrebbe tenuto conto di situazioni oggettive idonee ad
incidere negativamente sull’esercizio del diritto di voto, influendo in
concreto sulla possibilità dei cittadini di esprimere la loro volontà
elettorale; e ledendo così la sfera di attribuzioni garantita ai promotori.
Riprendendo quanto già affermato,
In via subordinata, i ricorrenti si
dolevano del fatto che il Governo non avesse concordato la data di votazione
con i comitati promotori, violando con ciò – in assunto – il principio di leale
collaborazione tra i poteri dello Stato. Anche tale prospettazione è stata
rigettata, in quanto «non è configurabile alcuna concorrente attribuzione,
costituzionalmente garantita, del comitato promotore del referendum riguardo
alla scelta della data di votazione entro la fascia temporale prestabilita dal
legislatore: circostanza, questa, che rende inconferente il richiamo al
principio di leale collaborazione» (ed esclude, altresì, che sussistano i
presupposti affinché
In ragione di queste considerazioni,
doveva desumersi che «le determinazioni assunte con i decreti di indizione
delle consultazioni referendarie oggetto di ricorso non appa[rivano], neppure
astrattamente, idonee ad incidere sulla sfera di attribuzioni
costituzionalmente garantita ai ricorrenti».
Altra decisione di inammissibilità è
stata assunta con l’ordinanza n. 404.
Nelle more della fase
dell’ammissibilità, era intervenuta una nota del Ministero dell’interno con la
quale, rappresentandosi espressamente la volontà del Presidente del Consiglio
dei ministri, si era consentito al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Tempio Pausania di accedere all’area già oggetto del provvedimento
di apposizione del segreto di Stato «ai fini di procedere all’ispezione
richiesta», e che tale ispezione era stata pienamente effettuata, in attuazione
del relativo decreto.
Conseguentemente, il compimento
dell’ispezione, ai sensi dell’art. 244 e seguenti del codice di procedura
penale, da parte dell’autorità giudiziaria ricorrente aveva rimosso l’ostacolo
frapposto all’esercizio del potere d’indagine spettante alla stessa autorità
giudiziaria, così da far venir meno, allo stato, l’oggetto del conflitto.
D’altro canto, in relazione ai
lamentati possibili effetti sui poteri dell’autorità ricorrente derivanti dal
trascorrere del tempo relativo allo svolgimento della vicenda,
Due decisioni hanno evidenziato vizi
nel contenuto dei ricorsi introduttivi tali da rendere inammissibile il
conflitto proposto (in entrambi i casi si verteva su delibere di
insindacabilità approvate da una camera).
Nell’ordinanza n. 104 si è sottolineato come l’atto con
il quale il conflitto era stato proposto non descriveva «in modo
sufficientemente analitico i fatti in relazione ai quali [era] stata adottata
la impugnata delibera di insindacabilità», non essendovi riportate le
dichiarazioni in relazione alle quali era pendente il procedimento penale
dinanzi al giudice ricorrente. In tal modo, restava «del tutto preclusa, per
Analoga è stata la ratio decidendi dell’ordinanza n.
Profili di inammissibilità non sono
invece stati riscontrati in relazione alla forma assunta dall’atto di
promuovimento del giudizio (il riferimento va alle «ordinanze» emanate da
organi giurisdizionali), né alla contestuale emanazione di una ordinanza di rimessione
di una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la
disposizione legislativa in applicazione della quale l’atto oggetto del
conflitto presentava i connotati di lesività delle attribuzioni fatte valere
(trattavasi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 140 del
Sui 23 ricorsi esaminati, 18 sono
stati dichiarati ammissibili. I 5 dichiarati inammissibili lo sono stati, in
due casi, in ragione dei vizi che inficiavano l’atto introduttivo (ordinanze
nn. 104 e 129: v. supra, par. 4),
in altri due in ragione dei profili oggettivi del conflitto (ordinanze nn. 198 e 404: v. supra, par. 3) ed
in uno in relazione ai profili soggettivi (ordinanza n. 479).
L’inammissibilità pronunciata con
l’ordinanza n.
In tutti i casi in cui il conflitto è
stato dichiarato ammissibile,
Nel corso del 2005,
Sul totale delle decisioni, ben 21
hanno avuto origine da un ricorso di un organo della magistratura giudicante, e
segnatamente un tribunale (sentenze nn. 28,
88, 146, 164 e 204, ed ordinanze nn. 42, 43, 61, 76, 290, 308 e 326), una corte d’appello (sentenze nn.
79, 193 e 235, ed ordinanza
n. 327), un giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale (sentenze nn. 38 e 223) ed un giudice
per l’udienza preliminare presso il tribunale (sentenze nn. 176 e 267, ed ordinanze nn. 76
e 143). In questi casi, oggetto del
conflitto sono state delibere di insindacabilità delle opinioni espresse da
parlamentari, per cui il soggetto resistente è stato individuato nella Camera
dei deputati (sentenze nn. 28, 79, 88, 146, 164, 193, 204, 223 e 235, ed ordinanze nn. 42,
43, 61, 76, 143 e 326) o nel Senato della Repubblica (sentenze nn. 176 e 267, ed ordinanze nn. 290,
308 e 327). In un caso, Camera e Senato sono stati entrambi resistenti,
in conseguenza dell’avvenuta impugnazione di una molteplicità di delibere di
insindacabilità rese da entrambe le camere (sentenza n. 38).
Due decisioni hanno riguardato
vicende di natura diversa. La sentenza n.
La sentenza n.
In cinque occasioni, hanno spiegato
atti di intervento soggetti diversi da quelli che
Nel quarto caso, la valutazione è
stata preclusa dalla tardività dell’atto di intervento del soggetto privato cui
le disposizioni legislative impugnate si sarebbero applicate (sentenza n. 284).
Per quanto attiene ai profili
oggettivi del conflitto, le deliberazioni di insindacabilità delle opinioni
espresse, validamente impugnabili per costante giurisprudenza, non hanno posto
particolari problemi. Può segnalarsi, a tal riguardo, la sentenza n. 267, che ha respinto l’eccezione di
inammissibilità fondata sul rilievo che il ricorso , investendo contestualmente
due deliberazioni adottate nel corso della medesima seduta, nei confronti di
due senatori, sarebbe risultato per ciò solo carente di un distinto e motivato
riferimento alla posizione di ciascuno dei due parlamentari. Riprendendo
precedenti affermazioni,
Altra decisione di interesse è la
sentenza n. 204, con cui si è
dichiarato improcedibile il conflitto per sopravvenuta carenza di interesse
alla pronuncia da parte dei soggetti confliggenti, a seguito dell’intervenuta
remissione di querela, accettata dall’imputato, e della conseguente sentenza di
non doversi procedere. L’esame del ricorso per conflitto è risultato, pertanto,
precluso, quanto al merito della spettanza delle attribuzioni costituzionalmente
garantite e quanto ai dedotti profili di inammissibilità».
La inattualità dell’interesse al
conflitto è stata invece esclusa nella sentenza n. 235. Di fronte al ricorso promosso da una corte d’appello, la
camera resistente ha eccepito l’omesso chiarimento in ordine alla avvenuta
sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, sostenendo che ciò
avrebbe avuto rilievo perché, «ove l’efficacia della predetta sentenza fosse
tuttora perdurante, in punto di accertamento della esimente di cui all’art. 68,
primo comma, Cost., ne [sarebbe risultata] preclusa la configurabilità di un
interesse attuale e concreto alla elevazione del conflitto».
Contestualmente, la camera resistente
adduceva l’incidenza sull’esito del conflitto della sopravvenuta legge 20
giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della
Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte
cariche dello Stato). In particolare, l’art. 3, comma 1, di tale legge avrebbe
introdotto «nuovi fattori di valutazione in ordine alla estensione della
garanzia dell’insindacabilità», con conseguente necessità della restituzione
degli atti al giudice ricorrente per una rivalutazione della perdurante
sussistenza dei presupposti per l’elevazione del conflitto. Nel respingere tale
prospettazione,
Nella sentenza n. 451, chiamata a giudicare su alcuni
atti giurisdizionali che si ritenevano lesivi delle attribuzioni delle camere
in conseguenza della mancata considerazione del «legittimo impedimento»
dell’imputato parlamentare a partecipare ad udienze per concomitanti impegni
presso il Parlamento,
Da tale affermazione, deriva che «il
giudice non può limitarsi ad applicare le regole generali del processo in tema
di onere della prova del legittimo impedimento dell’imputato, incongruamente
coinvolgendo un soggetto costituzionale estraneo al processo stesso, ma (come
Alla luce di tali principî, sono
stati esaminati i provvedimenti impugnati, anche attraverso un vaglio delle
motivazioni che essi recavano, sottolineando come, se il sindacato sulle
motivazioni di tipo processuale «compete esclusivamente al giudice del processo
penale», non altrettanto poteva dirsi in ordine alle motivazioni nelle quali,
«pur in presenza di una situazione di potenziale conflitto con le attribuzioni
costituzionali della Camera, soggetto estraneo al giudizio penale», siffatte
attribuzioni non erano state tenute adeguatamente in conto.
Infine, la sentenza n. 284, sciogliendo la «riserva» formulata
nell’ordinanza n. 116 (v. supra, sez. I, par. 3), ha deciso nel
senso dell’inammissibilità il conflitto interorganico sollevato dal Consiglio
superiore della magistratura per la lesione delle proprie attribuzioni
costituzionali, in relazione agli articoli 77, 97, 105 Cost., nonché al
principio di leale collaborazione, ad opera dell’art. 3, comma 57, della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nonché dell’art. 2, comma 3,
del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66 (Interventi urgenti per i pubblici
dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego a causa di procedimento penale,
successivamente conclusosi con proscioglimento), convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 11 maggio 2004, n. 126, «nella parte in
cui prevedono che il Csm debba,
senza procedere ad alcuna valutazione, riammettere in servizio il magistrato
prosciolto in sede penale con una formula piena dopo che questi sia
volontariamente cessato, a causa di tale pendenza, dall’ordine giudiziario, e
laddove stabiliscono che a questi venga conferita, in casi di anzianità non
inferiore a dodici anni nell’ultima funzione esercitata, una funzione di
livello immediatamente superiore, previa valutazione della sola anzianità di
ruolo e delle attitudini desunte dalle ultime funzioni esercitate, e, nel caso
di anzianità inferiore, una funzione, anche in soprannumero, dello stesso
livello».
Anche se, secondo la più recente
giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 457 del 1999), l’ammissibilità del
conflitto tra poteri dello Stato «non può essere negata sulla sola base della
natura legislativa degli atti ai quali venga ascritta, dal ricorrente, la
lesione delle attribuzioni costituzionali in gioco»,
Nella sentenza n. 284
Nel caso di specie, risultava,
dunque, determinante «la circostanza che il Csm,
nel corso di uno dei giudizi comuni che po[tevano] essere attivati dagli
interessati a seguito dell’adozione, da parte dello stesso Csm, dei provvedimenti regolati dalle
norme de quibus, o comunque a seguito dell’inerzia serbata su istanze
tendenti alla emanazione di tali provvedimenti, dispone[sse] della possibilità
di eccepire, in via incidentale, l’illegittimità costituzionale delle norme
legislative presentate […] come asseritamente lesive delle proprie
attribuzioni». E proprio la possibilità che le disposizioni contestate fossero
scrutinate in via incidentale nel corso di simili giudizi ha comportato
l’inevitabile dichiarazione di inammissibilità del ricorso per conflitto di
attribuzione.
Numerose sono state, nel corso del
2005, le prese di posizione della Corte (peraltro tutte confermative di
orientamenti già enunciati) in ordine ai requisiti indefettibili affinché il
conflitto di attribuzione sia validamente instaurato.
Innanzi tutto, per quanto attiene al
rispetto della cadenza temporale degli adempimenti delineati nell’ordinanza di
ammissibilità, in un caso si è constatata la tardività della notifica del
ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità (sentenza n. 88).
La peculiare disciplina dei conflitti
di attribuzione tra poteri dello Stato contempla, infatti, l’avvio, rimesso
all’iniziativa della parte interessata, di due distinte ed autonome fasi
procedurali, destinate a concludersi, la prima, con la preliminare e sommaria
delibazione circa l’ammissibilità del conflitto e, la seconda, con la pronuncia
sul merito, oltre che con il definitivo giudizio sull’ammissibilità.
Su questa base, è onere del
ricorrente, a conclusione della prima fase ed affinché si possa aprire la
seconda, provvedere alla notificazione del ricorso e dell’ordinanza di
ammissibilità, entro il termine da quest’ultima fissato. In proposito,
La medesima ratio decidendi ha connotato gli 8 casi nei quali si è verificato
un deposito tardivo del ricorso con la prova delle avvenute notifiche presso la
cancelleria della Corte (ordinanze nn. 42,
43, 61, 76, 290, 308, 326 e 327). La perentorietà del termine per
il deposito non è suscettibile di deroghe, a nulla rilevando, in proposito, il
fatto che il decorso dei termini sia maturato durante la sospensione feriale di
cui all’art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, «poiché tale
sospensione non si applica ai processi davanti [alla] Corte, come affermato da
costante giurisprudenza» (così l’ordinanza n. 76; conformemente, l’ordinanza n. 43).
Questo orientamento ha reso
ininfluente l’istanza presentata da un tribunale ricorrente che, ricevuta
comunicazione relativa alla trattazione in camera di consiglio del ricorso
depositato fuori termine, ha chiesto alla Corte di valutare nel merito il
ricorso stesso, «poiché la tardività del deposito non [avrebbe potuto]
addebitarsi alla struttura giudiziaria cui appart[eneva] il Tribunale ma agli
ufficiali giudiziari di Roma, l’operato dei quali sarebbe [stato] sottratto al
potere di intervento dell’ufficio ricorrente» (ordinanza n. 290).
Analogo esito ha avuto il conflitto
deciso con l’ordinanza n. 143. Il
ricorrente riproponeva un conflitto di attribuzione già dichiarato ammissibile
e non più coltivato con l’esecuzione dei prescritti adempimenti, adducendo che
l’identità tra i due conflitti sarebbe ininfluente. Disattendendo tale
prospettazione,
L’esigenza di «tempi certi» non può
tuttavia produrre preclusioni derivanti dalla fase processuali in cui si versi
nel giudizio da cui il conflitto trae origine. La sentenza n.
Né, a sostegno dell’eccezione, poteva
addursi l’argomento secondo cui nel nostro ordinamento costituzionale sussisterebbe
il principio «di “favorire al massimo”, attraverso la cooperazione tra gli
organi interessati al conflitto, la composizione extragiudiziaria delle
relative controversie; con la conseguenza che ove la situazione di
conflittualità sia “oramai palesata”, sorge la necessità che il contrasto si
concluda entro limiti temporali certi», così che non sarebbe «pensabile che la
facoltà di reazione nei confronti dell’atto parlamentare da parte degli organi
giudiziari possa tranquillamente protrarsi per tutti i gradi di giudizio»: a
smentire questo rilievo, oltre all’assenza di un termine decadenziale, doveva
constatarsi che «anteriormente all’instaurazione del giudizio dinanzi alla
Corte i tempi processuali sono solo quelli scanditi dalle regole proprie del
processo nel quale il conflitto insorge».
Con riferimento alla forma dell’atto
di promuovimento, la sentenza n.
Relativamente ai contenuti del
ricorso, la sentenza n.
Il giudice ricorrente incorreva in
una contraddizione in quanto, da un lato, poneva in rilievo la circostanza che
le dichiarazioni rese extra moenia
dai parlamentari erano di molto anteriori alla delibera camerale,
mostrando così di considerare rilevante la circostanza che quelle dichiarazioni
riguardassero la richiesta di autorizzazione all’esecuzione di misure
restrittive della libertà personale a carico di un altro parlamentare;
dall’altro, il ricorrente notava come le dichiarazioni pronunciate dai
querelati non fossero legate da alcun nesso funzionale con l’esercizio delle
funzioni parlamentari, spostando quindi il problema su un piano ben diverso
rispetto a quello evocato in precedenza, quello cioè secondo cui le
dichiarazioni rese da un membro del Parlamento fuori della sede parlamentare
fruiscono della garanzia di cui al primo comma dell’art. 68 Cost. solo se
divulghino o riproducano atti già compiuti dal dichiarante nell’esercizio delle
sue funzioni.
Oltre che contraddittorie, le
argomentazioni del ricorrente erano «del tutto generiche», anche perché
accomunavano «in una valutazione indifferenziata e priva di specificità le
posizioni dei cinque parlamentari querelati, senza considerare che le loro
dichiarazioni erano state rese in momenti distinti, avevano contenuti
disomogenei e la loro insindacabilità era stata dichiarata da cinque diverse
deliberazioni, quattro della Camera e una del Senato».
Anche nella sentenza n. 79, si è dichiarata l’inammissibilità
del ricorso avverso una delibera di insindacabilità, in quanto esso non
conteneva «una compiuta esposizione dei fatti, non solo perché non [venivano]
riportate le frasi pronunciate dal deputato […] – frasi che assum[eva]no
importanza fondamentale ai fini dell’accertamento dell’eventuale nesso
funzionale con atti parlamentari tipici di cui le frasi [avrebbero potuto]
essere la divulgazione –, ma soprattutto perché, in luogo delle parole
pronunciate […], [venivano] espresse valutazioni circa l’incidenza lesiva delle
dichiarazioni del deputato […]». Ora, sebbene le frasi pronunciate fossero
riprodotte nella deliberazione di insindacabilità allegata al ricorso, ciò che
rendeva il ricorso inammissibile non era soltanto l’aver omesso di riprodurre
quelle frasi nel ricorso, «bensì la loro sostituzione con una libera
rielaborazione ad opera dell’autorità giudiziaria ricorrente». Ne risultava, infatti,
«una impropria sovrapposizione tra l’oggettiva rilevanza delle opinioni
espresse dal deputato […] e l’interpretazione soggettiva che ne [era] stata
data, che interferi[va] con l’accertamento del nesso funzionale tra le frasi
pronunciate […] e gli eventuali atti parlamentari tipici di cui le frasi stesse
[avrebbero potuto] essere la divulgazione esterna». In definitiva, «la mancanza
di una compiuta esposizione dei presupposti di fatto del conflitto di
attribuzione si traduce[va], a norma degli articoli 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, nel difetto di un requisito essenziale del ricorso, che
[doveva] conseguentemente essere dichiarato inammissibile».
Analogamente, nella sentenza n. 267, anch’essa avente ad oggetto
delibere di insindacabilità delle opinioni espresse, si è censurata l’omessa
precisazione circa quale fosse il comportamento addebitato ai senatori
imputati, atteso che né la loro posizione risultava adeguatamente differenziata
rispetto a quella degli altri coimputati nei medesimi reati, né risultava
specificata la natura (morale o materiale) del contributo recato dai predetti
parlamentari a titolo di concorso nella realizzazione delle fattispecie
criminose oggetto di contestazione.
Il ricorso, in effetti, si limitava
«a riprodurre sic et simpliciter il contenuto dei capi di imputazione
riportati nella richiesta di rinvio a giudizio». Dalla lettura del ricorso non
era dunque dato comprendere se quello posto in essere dai due parlamentari
consistesse in un concorso materiale ovvero morale, e quindi se essi, lungi
dall’operare come autori o complici nella realizzazione delle fattispecie
suddette, avessero comunque suscitato o rafforzato il proposito criminoso,
mantenendo in tal modo il loro contributo alla realizzazione «collettiva» del
reato entro limiti astrattamente idonei ad essere ricompresi nella
manifestazione di una opinione.
A fronte di tale indeterminatezza,
mancava «in radice» la possibilità di stabilire se quella ascrivibile a
ciascuno dei due parlamentari fosse la realizzazione di un comportamento di
carattere materiale o la manifestazione di una opinione, «rimanendo così
preclusa la possibilità di valutare se ricorrano le condizioni per
l’operatività della prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, della
Costituzione».
Eccezioni inerenti alla formulazione
dell’atto introduttivo del conflitto sono state invece disattese nella sentenza
n. 146.
Con una prima eccezione, la
resistente denunciava sia il mancato richiamo, da parte del ricorrente, delle
disposizioni costituzionali relative alle attribuzioni dell’autorità
giudiziaria, che sarebbero state violate, sia la circostanza che lo stesso
ricorrente non avesse lamentato una specifica menomazione delle anzidette
attribuzioni, limitandosi ad evidenziare «supposti motivi di illegittimità
della delibera camerale». Si assumeva, in secondo luogo, che il ricorso per
conflitto fosse privo di «sufficiente chiarezza […] in ordine al thema
decidendum», atteso che le censure da esso mosse non avrebbero riguardato
la delibera di insindacabilità nella sua interezza, ma solo parte di essa.
Ad avviso della Corte, tuttavia, «il
ricorso proposto non genera[va] incertezza»: risultava, infatti, «chiara ed
univoca – al di là di ogni formale evocazione dei relativi parametri
costituzionali – la denuncia di menomazione delle attribuzioni funzionali,
ritenuta dal giudice ricorrente»; risultava altresì completo il petitum,
articolato tanto nella richiesta alla Corte di una pronuncia di non spettanza
alla Camera dei deputati della valutazione contenuta nella deliberazione
assunta, quanto nell’esplicita domanda di annullamento della stessa.
D’altra parte, la stessa Corte, nella
sentenza n. 28 (confermata, dalla
sentenza n. 164), ha sottolineato
come l’indicazione del petitum, «pur ovviamente necessaria a pena di
inammissibilità del ricorso», «non richied[a] certo l’adozione di formule
predeterminate, essendo al riguardo necessaria e sufficiente, in assenza di una
deroga al principio generale della libertà di forma, qualsiasi espressione
idonea a palesare, in modo univoco e chiaro, la volontà del ricorrente di
richiedere la decisione della Corte su un determinato conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato» (nella specie, la stessa richiesta di una pronuncia di
non spettanza alla Camera della deliberazione di insindacabilità doveva
ritenersi compresa, «alla stregua dei generali canoni ermeneutici», sia nella
volontà di promuovere il conflitto che nella richiesta di annullamento della
delibera adottata dall’Assemblea).
Con la sentenza n. 451 sono stati decisi due conflitti,
sollevati dalla Camera dei deputati nei confronti di due diverse sezioni del
Tribunale di Milano. Alla base della riunione è stata rilevata la circostanza
che i due giudizi per conflitto ponessero «questioni in gran parte analoghe».
Delle 23 decisioni rese, 14 sono
sentenze e 9 ordinanze.
Tra queste ultime si annoverano gli 8
casi in cui il giudizio è stato dichiarato improcedibile per tardività del
deposito del ricorso con la prova delle avvenute notifiche (ordinanze nn. 42, 43, 61, 76, 290, 308, 326 e 327). La nona ordinanza reca un dispositivo di inammissibilità
derivante dalla riproposizione di un conflitto non coltivato (ordinanza n. 143).
Tra le sentenze, 6 definiscono il
giudizio senza scendere nel merito. Si tratta della sentenza n. 88, che dichiara improcedibile il
giudizio per tardiva notifica del ricorso alle controparti, e della sentenza n.
204, nella quale l’improcedibilità
deriva dal sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia.
In quattro sentenze, le pronunce di
inammissibilità derivano dalla inidoneità dell’atto impugnato ad essere oggetto
del conflitto (sentenza n. 284) o da
vizi concernenti il contenuto del ricorso (sentenze nn. 38, 79 e 267).
Delle 8 decisioni di merito, soltanto
una è stata di infondatezza (sentenza n. 223),
mentre tutte le altre, accogliendo il ricorso, hanno condotto all’annullamento
degli atti impugnati (sentenze nn. 28,
146, 164, 193, 235 e 451). Peculiare è, peraltro, il decisum
della sentenza n. 451, che reca
annullamenti «nei limiti di cui in motivazione». In conseguenza della rilevata
non spettanza al giudice del potere di formulare le affermazioni lesive delle
attribuzioni costituzionali della Camera dei deputati,
Il giudizio di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo
Nel 2005,
Tutti i giudizi hanno avuto ad
oggetto la legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita». Più in
particolare, la sentenza n.
2.
Il contraddittorio di fronte alla Corte
Nei cinque giudizi di ammissibilità,
hanno depositato memorie i presentatori dei referendum
ed è intervenuto altresì il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato.
Oltre a questi soggetti, la cui
partecipazione al giudizio – attraverso il deposito di scritti – è prevista
direttamente dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, hanno presentato memorie,
tutte volte a sollecitare pronunce di inammissibilità, altri soggetti (7 nei
giudizi conclusi con le sentenze nn. 45
e 46, 6 negli altri tre giudizi).
Con l’ordinanza letta nella camera di
consiglio del 10 gennaio 2005,
Nella decisione finale, l’ammissione
è stata confermata. Con l’occasione
Nel decidere sull’ammissibilità delle
5 richieste di referendum,
3.1.
La decisione di inammissibilità
La sentenza n.
Alla luce di tale constatazione, un
limite all’ammissibilità è stato individuato nelle «leggi a contenuto
costituzionalmente vincolato», cui si sono affiancate, a far tempo dalla
sentenza n. 27 del 1981, le «leggi costituzionalmente necessarie», «la cui
eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni
che tale tutela esigono secondo
Sulla scorta della ricostruzione
della giurisprudenza pregressa,
La richiesta di sottoporre a referendum
abrogativo l’intera legge n. 40 del 2004 coinvolgeva quindi una normativa che è
costituzionalmente necessaria, donde l’inammissibilità della richiesta stessa.
Non poteva a tal proposito obiettarsi che successivamente all’esito
referendario, in ipotesi favorevole ai richiedenti, si sarebbe potuta adottare
una diversa legislazione in tema di procreazione medicalmente assistita, pur
essa idonea a garantire almeno un minimo di tutela agli interessi
costituzionalmente rilevanti nella materia:
3.2.
Le decisioni di ammissibilità
Le quattro pronunce nelle quali
Nelle sentenze nn. 46, 47 e 48 si è sottolineato,
in particolare, che andava «escluso che le disposizioni di legge po[tessero]
ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così da
sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria».
Le richieste, inoltre, non si ponevano
«in contrasto con i principî posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile
1997, sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, e dal Protocollo addizionale
del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, cui si
è data esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145», in quanto oggetto del
divieto di cui all’art. 1 del richiamato Protocollo addizionale sono «solamente
gli interventi diretti ad ottenere un essere umano geneticamente identico ad un
altro essere umano vivente o morto, e tali interventi […] restano vietati anche
alla stregua della normativa di risulta».
Analogamente, non faceva difetto il
carattere dell’omogeneità del quesito, sebbene quest’ultimo fosse, nei casi
decisi con le sentenze nn. 47 e 48, «a carattere plurimo».
Le medesime considerazioni sono state
svolte nella sentenza n. 49, dove,
escluso il contrasto con vincoli internazionali, si è rilevato che la richiesta
di referendum riguardava
«disposizioni fra loro intimamente connesse, le quali forma[va]no un autonomo e
definito sistema», donde la «omogeneità e non contraddittorietà» del quesito.
Sotto altro profilo, si è evidenziato
che la eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del quesito non era
«suscettibile di far venir meno un livello minimo di tutela costituzionalmente
necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria».
Infine, non poteva sostenersi «il
carattere sostanzialmente propositivo e non puramente demolitorio del referendum, perché [sarebbe stato]
semplicemente abolito un divieto e, conseguentemente, una condotta fino ad
allora vietata [sarebbe divenuta] consentita».
4.
I rapporti tra giudizio di ammissibilità del referendum e controllo di costituzionalità
Nelle sentenze nn. 45, 46, 47 e 48 si è confermato il consolidato
orientamento relativo alla non incidenza dell’eventuale dichiarazione di
ammissibilità della richiesta di referendum
sulla valutazione in termini di legittimità costituzionale della normativa di
risulta.
Per costante giurisprudenza, il
giudizio sulla «sola ammissibilità della richiesta referendaria» si atteggia
«con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi
riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti
con forza di legge» (cfr. sentenze n. 251 del 1975 e n. 16 del 1978). Ne è
derivato che non era in discussione in quella sede la valutazione «di eventuali
profili di illegittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004», cosicché
dalla decisione non era certo lecito «trarre conseguenze circa la conformità o
meno a Costituzione della menzionata normativa».
Del pari, la decisione
sull’ammissibilità non era «la sede di un giudizio sulla illegittimità
costituzionale dell’eventuale disciplina di risulta derivante dall’effetto
abrogativo del referendum». Sotto quest’ultimo profilo, «ciò che può
rilevare, ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria, è
soltanto una valutazione liminare e inevitabilmente limitata del rapporto tra
oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se, nei
singoli casi di specie, il venir meno di una determinata disciplina non
comporti ex se un pregiudizio totale all’applicazione di un precetto
costituzionale, consistente in una diretta e immediata vulnerazione delle
situazioni soggettive o dell’assetto organizzativo risultanti a livello
costituzionale».
1.
Il principio personalistico
Nel periodo considerato, è
estremamente significativa sotto il profilo del «principio di tutela della
persona, desumibile dall’art. 2 della Costituzione», la sentenza n. 63, con cui
Nell’ambito dei diritti inviolabili
della persona, si segnala una questione sollevata in tema di responsabilità
civile e decisa con l’ordinanza n. 58.
Il rimettente, investito della domanda di risarcimento dei danni all’immagine,
dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile, in
quanto preclusivo della risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da
un fatto non corrispondente ad una fattispecie almeno astratta di reato. Il
dubbio di costituzionalità muoveva dalla premessa interpretativa secondo la
quale tale preclusione sarebbe derivata da alcune pronunce del giudice di
legittimità e dalla sentenza costituzionale n. 233 del 2003, che avrebbe
individuato nella sussistenza di una fattispecie astratta di reato la «soglia
minima per la risarcibilità» del danno non patrimoniale.
Con la sentenza n. 425
La questione di costituzionalità era
stata sollevata, anche in riferimento all’art. 2 della Costituzione, sotto il
profilo che la norma censurata «farebbe prevalere in ogni caso l’interesse
della madre naturale all’anonimato sul diritto inviolabile del figlio
all’identità personale».
Secondo
Per l’affermazione dell’esistenza di
«un nucleo irrinunciabile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione
come ambito inviolabile della dignità umana» v. la sentenza n. 432 (infra, par 4.4).
2.
I principî di eguaglianza e di ragionevolezza
Il ruolo di preminenza che, da
sempre, assume nei giudizi di legittimità costituzionale (specialmente) in via
incidentale il parametro di cui all’art. 3 della Costituzione è attestato dal
n. di questioni sollevate davanti alla Corte che ad esso fanno diretto
riferimento: nel giudizio in via incidentale, 251 decisioni su un totale di 314
(79,94%) hanno definito giudizi nei quali veniva invocato l’art. 3; per quanto
attiene al giudizio in via principale, d’altro canto, le 29 decisioni su 101,
pur se lungi – per ovvie ragioni – dal dato dell’incidentale, rappresentano una
quota tutt’altro che trascurabile (28,71%).
Per ragioni intuibili, in questa sede
non verranno analizzate le sentenze ed ordinanze che hanno avuto ad oggetto la
violazione del parametro costituzionale in parola: ci si limiterà, infatti, ad
enucleare le principali affermazioni al riguardo, implicitamente rinviando ai
paragrafi nei quali le varie rationes decidendi sono state inserite in
base alle materie affrontate (una siffatta impostazione, del resto, pare
coniugarsi anche con la circostanza che, nella grande maggioranza dei casi, le
questioni di legittimità costituzionale nelle quali l’art. 3 della Costituzione
è stato invocato hanno visto anche l’invocazione di parametri ulteriori).
Sul piano espositivo, il titolo del
paragrafo dà conto della natura multiforme dei principî ricavati dall’art. 3
della Costituzione: al fianco del principio di eguaglianza (formale e sostanziale)
esplicitamente contemplato, la giurisprudenza costituzionale – con una
evoluzione le cui prime mosse risalgono ai primi anni di funzionamento della
Corte – ha dedotto anche un altro principio, generalmente definito di
«ragionevolezza».
In estrema sintesi, il principio di
eguaglianza (formale) può essere declinato nel senso di richiedere una parità
di trattamento tra situazioni identiche (o simili o ancora assimilabili). Il
giudizio si struttura dunque secondo un modulo trilatero, nel quale alla luce
del parametro costituzionale si raffronta la norma oggetto dell’impugnazione (e
la situazione che essa disciplina) con una norma altra (c.d. tertium
comparationis), che – sul presupposto della sua omogeneità con la norma
oggetto (recte, della omogeneità della situazione che disciplina con
quella disciplinata dalla norma oggetto) – assurge a termine di paragone al
fine di verificare la sussistenza o meno di una disparità di trattamento. Nel
contesto di tale giudizio, il termine «ragionevolezza» (o «irragionevolezza»)
ben può essere impiegato (anzi, solitamente lo è), in un’accezione che può
essere traslitterata come «giustificatezza» (o «non giustificatezza») della
disparità di trattamento riscontrata, ergo come corrispondenza della
differenziazione normativa con la diversità delle situazioni disciplinate.
In una accezione più pregnante, il
principio di ragionevolezza fa riferimento alla «razionalità» della
disposizione legislativa, id est alla non contraddittorietà della stessa
rispetto al sistema giuridico o al fine per il quale la disposizione è stata
redatta. Lo schema del giudizio torna allora ad essere binario, nel senso che
la ragionevolezza come razionalità non implica un confronto con altre norme,
postulando un giudizio incentrato esclusivamente sulle caratteristiche della
norma oggetto. Come è chiaro, un siffatto scrutinio non può sfociare, da parte
della Corte costituzionale, nel controllo sulle scelte di merito operate dal
legislatore: il controllo è di tipo «esterno», limitato, cioè, alla giustificatezza
(o, meglio, alla non arbitrarietà) delle scelte legislative.
2.1.
Il principio di eguaglianza
La violazione dell’art. 3 della
Costituzione si produce in tutti quei casi in cui situazioni (tendenzialmente)
omogenee conoscano discipline profondamente differenziate (trattavasi, nella
specie, di tipi di trasporto, in ordine ai quali non si sono riscontrate
peculiarità insuperabili): tale affermazione è contenuta nella sentenza n. 199,
che ha ulteriormente rilevato che a confutazione dell’irragionevolezza di tale
disparità di trattamento non è sufficiente invocare il carattere risalente e
peculiare della disciplina, specie quando – come nel caso – la peculiarità
derivi dal collegamento genetico con la normativa pattizia internazionale,
evolutasi, però, successivamente all’entrata in vigore della disciplina
interna.
Affermazioni generali di analogo
tenore sono rintracciabili in un buon n. di decisioni. Senza alcuna pretesa di
completezza, possono citarsi la sentenza n. 301, secondo cui la censura
relativa ad una asserita ingiustificata disparità di trattamento deve ritenersi
infondata in presenza di una (evidente) non comparabilità delle situazioni
messe a raffronto dal rimettente, la sentenza n. 481, che ha
ulteriormente ribadito che deve escludersi la violazione del principio di
eguaglianza argomentata sulla base di un trattamento analogo per situazioni che
non siano «sostanzialmente assimilabili» (nella specie, trattavasi dei soci e
dei sindaci, nell’ambito del diritto societario), o ancora l’ordinanza n.
Siffatti canoni di giudizio trovano
ampie conferme in tutta una serie di ambiti normativi sui quali
a) Con la sentenza n. 425,
b) Di particolare rilievo è l’applicazione del
principio di eguaglianza all’ambito religioso. In effetti, le esigenze costituzionali
di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno alla
equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla
religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose, sono riconducibili,
tra l’altro, al principio di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione
di religione sancito dall’art. 3 della Costituzione. Tali esigenze sono state
riscontrate, nella sentenza n. 168,
anche in relazione alla questione di legittimità costituzionale che riguardava
l’unica fattispecie incriminatrice tra quelle contemplate dal capo dei delitti
contro il sentimento religioso che ancora prevedeva un trattamento
sanzionatorio più severo ove le offese fossero recate alla religione cattolica.
c) Altro settore in cui
La sentenza n. 224 e
l’ordinanza n. 463 si sono invece incentrate sul confronto tra
stranieri. La prima ha dichiarato infondata la censura relativa alla disparità
di trattamento, asseritamente sussistente tra il richiedente il
ricongiungimento che non abbia altri fratelli o sorelle e quello che invece li
abbia: la differente disciplina è stata giustificata avuto riguardo alla
diversità delle situazioni poste a raffronto, e preso atto che il diritto al
godimento della vita familiare deve essere garantito senza condizioni a favore
dei coniugi e dei nuclei familiari con figli minori, mentre negli altri casi
esso può anche subire restrizioni, purché nei limiti della ragionevolezza,
nella specie non superati (tale ratio decidendi è stata integralmente
ripresa nell’ordinanza n. 464). Nell’ordinanza n. 463 si è
stabilito che l’omessa presentazione della richiesta del permesso di soggiorno,
da un lato, e la tardiva presentazione della domanda di rinnovo del permesso,
dall’altro, sono situazioni tra loro eterogenee – sotto due distinti e
concorrenti profili: la rilevanza dell’obbligo rimasto inadempiuto ed il tipo
di violazione – e come tali non comparabili al fine di desumerne una violazione
del principio di eguaglianza.
d) Con riferimento al diritto penale, nella sentenza n.
144 si è censurata la irragionevole equiparazione, ai fini del
trattamento sanzionatorio, di situazioni tra loro diseguali (quali, nella
fattispecie, quelle che facevano capo a soggetti che utilizzavano lavoratori
irregolari da momenti diversi e per i quali la constatazione della violazione
fosse in ipotesi avvenuta nella medesima data).
Nell’ordinanza n. 296, invece,
si è riscontrata una palese inidoneità del tertium comparationis evocato
dal giudice rimettente, stante l’eterogeneità delle situazioni poste a
confronto: l’affidamento in prova al servizio sociale è una forma di esecuzione
della pena, alternativa rispetto alla detenzione in carcere, mentre la
sospensione condizionale si traduce in una semplice «astensione a tempo»
dall’esecuzione della pena, che non implica alcuna limitazione della libertà
personale del condannato.
e) Un ambito nel quale sono particolarmente numerosi i
casi di svolgimento dello scrutinio relativo al rispetto del principio di
eguaglianza è quello concernente il diritto processuale, tanto civile quanto
penale.
Quanto alla pretesa disparità
denunciata tra la disciplina della costituzione in giudizio dell’opponente a decreto
ingiuntivo, con la sanzione di improcedibilità per costituzione tardiva, e
quella della costituzione in giudizio dell’attore nel processo ordinario,
Analogamente, la circostanza che una
norma (art. 163, n. 7, cod. proc. civ.) preveda la necessità dell’avviso al
convenuto, a pena di nullità (art. 164 cod. proc. civ.), dell’esistenza di un
termine decadenziale – peraltro, non inseribile, quale previsto dall’art. 166
cod. proc. civ., nel procedimento di opposizione di terzo all’esecuzione ex art.
619 cod. proc. civ. – non comporta certamente che debba ritenersi
costituzionalmente dovuta identica, o analoga, disciplina anche relativamente a
procedimenti diversamente strutturati, quando l’omessa previsione di
quell’avviso non renda – com’è evidente nella specie – la diversa disciplina
manifestamente irragionevole (ordinanza n. 389).
In ordine a procedimenti particolari,
nell’ordinanza n. 25 si è stabilito che la disomogeneità dell’oggetto
dell’opposizione alla sospensione disciplinata dal decreto legge 20 giugno
2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di
edilizia e di espropriazione) e di quella agli atti esecutivi rende
ingiustificata l’adozione dell’intera disciplina dell’opposizione agli atti
esecutivi come tertium comparationis.
Al fine di negare la sussistenza di
una disparità di trattamento tra l’ipotesi di esecuzione di sentenza
amministrativa di primo grado, perseguita attraverso il giudizio di
ottemperanza, e l’ipotesi di esecuzione delle sentenze di primo grado del
giudice ordinario,
Con precipuo riguardo al processo
penale, la sentenza n.
Nell’ordinanza n. 309, invece,
è stato rilevato che la disciplina contenuta nell’art. 552 cod. proc. pen. –
relativa al decreto di citazione a giudizio nel procedimento (a citazione
diretta) davanti al tribunale in composizione monocratica, la quale stabilisce
che l’imputato deve essere avvertito, a pena di nullità, della facoltà di
presentare richiesta dei riti alternativi prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento – non può essere utilmente richiamata quale tertium comparationis per sostenere la
necessità di estenderla, nel rispetto dell’art. 3 Cost., al decreto di
fissazione dell’udienza preliminare.
Infine, secondo quanto riportato
nell’ordinanza n. 125, nel quadro di un procedimento promosso da un
condannato al fine di far dichiarare la non esecutività di una sentenza di
condanna, il richiamo al diverso regime previsto per il giudizio abbreviato si
rivela del tutto improprio, al fine di fondare su di esso un pertinente termine
di raffronto, giacché la natura di procedimento speciale che caratterizza quel
giudizio ne contrassegna i caratteri ampiamente derogatori rispetto al giudizio
ordinario. Sotto altro profilo, la distinzione concettuale tra imputato
contumace ed imputato assente, ben può comportare scelte differenziate, ove
correlata ad un modello processuale che, come il giudizio abbreviato, si
celebra in camera di consiglio, in una fase processuale che precede il
dibattimento e secondo uno schema procedimentale idealmente caratterizzato
dalla massima concentrazione.
f) Relativamente alla disciplina delle locazioni, come
si evidenzia nella sentenza n. 264, non può reputarsi irragionevole e
discriminatorio il differente trattamento in punto di rivalutazione annuale del
canone tra locazioni di immobili di proprietà statale e locazioni di immobili
privati, giacché non sussiste piena omogeneità tra le situazioni poste a
raffronto.
g) Cospicua è la giurisprudenza concernente i diversi
profili del diritto del lavoro.
In ordine all’inquadramento dei
pubblici dipendenti, si segnala la sentenza n. 322, , secondo cui la
questione di legittimità costituzionale con cui si invochi una disparità di
trattamento risulta infondata quando sia palese che il giudice a quo sia
stato mosso dall’erroneo convincimento – espressamente smentito dal dato
normativo – che le categorie di personale operanti all’interno di una medesima
istituzione (nella specie, quella scolastica) fossero riconducibili ad una
medesima disciplina di stato giuridico (con la conseguenza che sarebbe stata
ingiustificata una diversa regolamentazione in ordine alle modalità e alla durata
del trattenimento in servizio in caso di riconosciuta inabilità allo
svolgimento delle rispettive funzioni di istituto per motivi di salute).
Due importanti sentenze meritano un
cenno relativamente alla confrontabilità dei diversi sistemi previdenziali. La
sentenza n. 192 riconosce che un principio che può dirsi consolidato
nella giurisprudenza della Corte costituzionale è quello relativo «alla
impossibilità di istituire confronti tra sistemi previdenziali diversi […], in
quanto i diversi sistemi hanno una loro specificità»: la circostanza che le
relative discipline non siano uniformi non lede, di per sé, il principio di
uguaglianza, salvo il caso, nella specie non sussistente, di una evidente
irragionevolezza (declinata anche in termini di «manifesta arbitrarietà») della
differenza di disciplina. Con analoga argomentazione, la sentenza n. 433
sottolinea che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, «la regola
generale della non confrontabilità» dei sistemi previdenziali «ai fini
dell’art. 3 Cost. […] incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga
una evidente irragionevolezza». Alla stregua di tale principio – e preso atto
del riconoscimento, nei diversi ordinamenti previdenziali, del diritto alla
pensione di riversibilità non solo agli orfani minorenni ma anche agli orfani
maggiorenni infraventiseienni impegnati, per tutta la durata legale, in corsi
universitari –
In merito all’indennità di fine rapporto,
la sentenza n. 438 richiama
espressamente la sentenza n. 225 del 1997, dove
Sulla scorta di tale precedente,
nella sentenza n. 438 si è censurata
la previsione concernente la sequestrabilità e la pignorabilità della indennità
di fine rapporto spettante ai dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato
per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno erariale causato da quei
dipendenti, non sussistendo alcuna ragione che possa giustificare il più
gravoso regime cui sono sottoposti i dipendenti degli enti pubblici diversi
dallo Stato che, diversamente dai dipendenti statali, possono veder sequestrata
e pignorata l’indennità di fine rapporto senza alcun limite.
La sentenza n. 458, partendo dalla constatazione della connotazione unitaria, per
natura e funzione, delle varie categorie di indennità di fine rapporto, anche
se governate da diversi sistemi di finanziamento e di erogazione dei singoli
trattamenti, ha riconosciuto che la disparità di trattamento nella disciplina
di fine rapporto – e segnatamente nelle norme che non consentono
l’applicabilità delle regole della successione mortis causa – riservata dalla legge al
dipendente non di ruolo rispetto agli altri dipendenti è palese con riguardo a
qualsiasi rapporto di lavoro, sia pubblico che privato: ne consegue
l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del d. lgs. C.p.S. n.
207 del 1947, nella parte in cui non prevede, in mancanza dei soggetti ivi
indicati, la devoluzione dell’indennità di fine rapporto spettante al
dipendente non di ruolo defunto, secondo le regole della successione legittima
e testamentaria.
h) Per quel che concerne il diritto tributario,
nell’ordinanza n. 181 si è negata la sussistenza di una irragionevole
disparità di trattamento nell’esenzione dall’imposta di registro ma non dall’Iva per gli atti connessi allo
svolgimento delle attività proprie delle organizzazioni di volontariato: la
prospettazione del rimettente non teneva tuttavia alcun conto della profonda
diversità di natura e struttura delle due imposte.
i) Assai di frequente, un effettivo scrutinio relativo
al rispetto del principio di eguaglianza deve fondarsi sulla individuazione
della ratio della disposizione oggetto di censura.
A tal proposito, nella sentenza n. 264
è rintracciabile l’enucleazione del modus procedendi che
Più succintamente, nella sentenza n. 281
si sottolinea come la diversità di trattamento tra situazioni poste a raffronto
debba essere valutata avendo riguardo alla ratio della norma censurata:
alla luce di tale principio, è da dichiararsi incostituzionale la disposizione
che preveda trattamenti differenziati sulla base di un criterio che non collima
con le finalità che sono proprie del sistema in cui la norma si pone.
D’altronde, la diversità di trattamento tra due fattispecie simili, e la
conseguente, eventuale, irragionevolezza, non può essere rimediata
assoggettando entrambe le fattispecie ad una disciplina che potrebbe non essere
conforme alla ratio – e,
pertanto, essa stessa intrinsecamente irragionevole – che ha ispirato una
determinata previsione (sentenza n. 379).
In questa prospettiva, di particolare rilievo è la sentenza n. 432,
che ha avuto ad oggetto un caso di disparità di trattamento derivante da una
valutazione della ratio della norma e
del novero dei soggetti destinatari della stessa.
Una disposizione legislativa della
Regione Lombardia, nell’attribuire il beneficio della circolazione gratuita sui
servizi di trasporto pubblico regionale alle persone totalmente invalide, lo
limitava ai soli cittadini italiani, escludendo così gli stranieri residenti.
La ratio
del beneficio era, dunque, riconducibile alla scelta del legislatore regionale
di agevolare – attraverso la fruizione gratuita del servizio – l’accesso al
sistema dei trasporti pubblici locali in favore di un gruppo di persone
accomunate dalla appartenenza alla più grave condizione di invalidità. Ci si
muoveva, in sostanza, nell’ambito di una provvidenza dettata da finalità
eminentemente sociali, nella specie raccordata, sul piano della «causa» normativa,
a valori di solidarietà, non disgiunti dagli intuibili riverberi che le
peculiari condizioni dei beneficiari e la natura stessa del beneficio possono
in concreto presentare rispetto alle esigenze di vita e di relazione; non
ultime quelle connesse alla tutela del diritto alla salute, in presenza di una
così grave menomazione.
L’applicazione
di questa normativa veniva, tuttavia, espressamente esclusa nei confronti degli
stranieri: con ciò compromettendo – secondo il giudice a quo – non
soltanto «il generale canone di ragionevolezza […] che può evocarsi come
parametro di coerenza della norma legislativa regionale con i principî sanciti
a tutela di situazioni riconducibili ad un’identica ratio
interpretativa»; ma, anche, la necessaria tutela della salute (art. 32 Cost.),
e del lavoro (art. 35, primo comma, Cost.), oltre che la riserva alla
legislazione statale circa la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lettera m,
Cost.), e circa i principî fondamentali in tema di legislazione concorrente
regionale sulla salute.
Sempre in
merito ai criteri che
possono fondare una legittima differenziazione di trattamento, la sentenza n. 394,
riprendendo precedenti statuizioni (ed in particolare quella contenuta nella
sentenza n. 166 del 1998), ha stabilito che «il matrimonio non costituisce più elemento
di discrimine nei rapporti fra genitori e figli – legittimi e naturali
riconosciuti – identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti,
degli uni nei confronti degli altri».
j) L’attenzione riposta sulla ratio della norma,
al fine di valutare la sussistenza di una disparità di trattamento avvicina,
inevitabilmente, il giudizio relativo al rispetto del principio di eguaglianza
a quello concernente la ragionevolezza-razionalità della norma.
Se ne ha una dimostrazione quando si
vadano a considerare eventuali disparità di trattamento correlate a rapporti di
durata. Sul presupposto che «lo stesso fluire del tempo costituisce un elemento
diversificatore delle situazioni giuridiche» (ordinanza n. 216), è da
evidenziare che, «nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al
legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso
sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se
l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo,
ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale
dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione)»: unica condizione essenziale
è «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale,
frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi
precedenti, l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da
intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto» (sentenza n. 264).
All’uopo viene in rilievo anche la
sentenza n.
k) La contiguità tra il giudizio inerente
all’uguaglianza e quello relativo alla ragionevolezza è tale che, in non poche
fattispecie, risulta pressoché impossibile individuare un discrimen
preciso, nella misura in cui il giudizio di ragionevolezza-razionalità
contribuisce in maniera determinante a definire una diversità di trattamento
giustificata o ingiustificata.
Anche a questo riguardo, la
giurisprudenza costituzionale del 2005 offre vari esempi.
La ratio del sistema normativo è stata alla base anche della
dichiarazione di infondatezza della censura prospettata nel giudizio concluso
con la sentenza n. 338. La disciplina
impugnata è stata infatti vista come non in contraddizione con la finalità
della contribuzione volontaria e, dunque, non irragionevole: deve escludersi
che sia costituzionalmente illegittima l’apposizione di limiti alla
retribuzione pensionabile non corrispondenti a quelli operanti in costanza di
rapporto di lavoro, ché «non può predicarsi una equiparazione a tutti gli
effetti tra contribuzione volontaria e contribuzione obbligatoria» né può
reputarsi sussistente una ingiustificata disparità di trattamento tra
lavoratori con retribuzione inferiore a detti limiti.
Un altro caso di rilievo si è avuto
nel giudizio definito con la sentenza n.
Ancora, nell’ordinanza n. 113,
Un ambito nel quale la commistione
tra i due tipi di giudizio in esame viene in considerazione piuttosto
frequentemente è quello del diritto penale. Per costante giurisprudenza della
Corte, il potere di configurare le singole ipotesi criminose e di determinarne
la pena, come pure quello di abrogare le varie previsioni punitive, rientra
nella discrezionalità del legislatore, censurabile, in sede di sindacato di legittimità
costituzionale, soltanto nel caso in cui sia stata esercitata in modo
manifestamente irragionevole. Sulla scorta di tale principio, nell’ordinanza n.
261 si è escluso che tale ultima evenienza si verificasse, essendo
evidente come il confronto prospettato dal giudice remittente tra la
fattispecie impugnata ed il reato di cui all’art. 650 cod. pen. fosse
incongruo, attesa l’evidente diversità esistente tra la generica inosservanza
dei provvedimenti dell’autorità e la trasgressione dello specifico divieto di
rientrare nel territorio nazionale conseguente al provvedimento di espulsione
emesso nei confronti dello straniero, diversità che dà ragione del differente
trattamento sanzionatorio.
Analogamente, secondo l’ordinanza n. 262,
rientra nella discrezionalità del legislatore sia l’individuazione delle
condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni:
discrezionalità che può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di
costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto
o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della
ragionevolezza. La scelta del legislatore del 2001 di ripristinare la sanzione
penale rispetto alla violazione del censurato dell’art. 109 Tulps, già oggetto di depenalizzazione,
non può dirsi manifestamente irrazionale o arbitraria sulla scorta della mera
valutazione in ordine all’asserita minore o pari gravità della condotta ivi
descritta rispetto a quelle previste dagli articoli 86 e 108 Tulps, assunti a tertia comparationis, e la cui violazione è punita con sanzione
amministrativa in base all’art. 17-bis
Tulps. Le disposizioni nella
specie evocate come termini di comparazione si riferiscono, infatti, ai
presupposti per l’esercizio stesso dell’attività alberghiera, che è espressione
di libera iniziativa economica, mentre l’obbligo di comunicazione delle
generalità delle persone alloggiate imposto dall’art. 109, terzo comma, investe
una modalità di svolgimento di tale attività d’impresa che si correla, con immediatezza,
a specifiche esigenze di sicurezza pubblica, giacché il predetto obbligo è
volto a consentire all’autorità di polizia la più rapida cognizione dei
nominativi degli ospiti dell’albergo al fine di garantire, appunto, la
sicurezza pubblica: evidente è dunque la disomogeneità delle fattispecie poste
a raffronto.
Non mancano, peraltro, applicazioni
relative a settori dell’ordinamento ulteriori. Così, la disparità di
trattamento tra i dipendenti privati e quelli pubblici – soggetti ad un termine
di decadenza per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle
controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni – è stata ritenuta, con l’ordinanza n. 213,
ragionevolmente giustificata dall’esigenza di contenere gli effetti, temuti dal
legislatore come pregiudizievoli per il regolare svolgimento dell’attività
giurisdizionale, prodotti dal trasferimento della competenza giurisdizionale al
giudice ordinario e dal temporaneo mantenimento di tale competenza in capo ai
tribunali amministrativi; d’altronde, «è ampia la discrezionalità del
legislatore nell’operare le scelte più opportune – purché non manifestamente
irragionevoli e arbitrarie – per disciplinare la successione di leggi
processuali nel tempo».
Trattandosi di situazioni
eccezionali, fondate su uno specifico e circoscritto apprezzamento del
legislatore, non può
Ancora, non appare manifestamente
irragionevole ritenere che i soggetti danneggiati, che hanno residenza,
domicilio o sede nell’area colpita dal sisma ed ivi svolgano la loro attività,
abbiano subito un pregiudizio complessivo maggiore rispetto agli altri danneggiati
e, in relazione a tale circostanza, siano meritevoli essi soli di un
particolare beneficio fiscale: fondandosi su questa considerazione,
Secondo la costante giurisprudenza
della Corte, poi, «l’individuazione del concreto ambito di applicazione di
un’agevolazione fiscale rientra nella discrezionalità del legislatore, salva la
manifesta irragionevolezza»: così si è espressa l’ordinanza n. 87, nella
quale si è ulteriormente rilevato – ad escludere la denunciata violazione del
principio di eguaglianza – che la giustificazione dell’agevolazione fiscale
oggetto del giudizio risiedeva in un intento di incentivazione dell’attività
agricola, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa
riferimento l’art. 44 della Costituzione, e che in relazione alla suddetta ratio
incentivante non appariva manifestamente irragionevole che dal beneficio
fossero esclusi coloro che – per il fatto di godere di trattamenti
pensionistici – all’evidenza non traevano dal lavoro agricolo la loro esclusiva
fonte di reddito.
A tutt’altro proposito, la sentenza
n. 320 stabilisce, in continuità con precedenti statuizioni, che non è
compatibile con il principio di ragionevolezza l’operato del legislatore che
qualifichi un pagamento come non dovuto e nello stesso tempo lo sottragga
all’azione di ripetizione.
Sussiste, dunque, una palese
violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento di
situazioni sostanzialmente uguali, quando si vada riservare un trattamento
deteriore a chi abbia erroneamente pagato un’imposta non dovuta rispetto a chi,
versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun
pagamento.
Infine, nella sentenza n. 243
si è dichiarata non fondata la censura di violazione dell’art. 3 della
Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento tra Comuni ubicati
in zone montane, litoranee, lacuali e termali e quei Comuni che, pur potendo
vantare il carattere prevalentemente turistico delle rispettive economie, si
trovino diversamente ubicati. In proposito,
2.2.
Il principio di ragionevolezza
Come si è accennato nell’ultima parte
del paragrafo precedente, il giudizio di ragionevolezza-razionalità di una
norma legislativa si interseca sovente con il giudizio su asserite disparità di
trattamento. Sussistono comunque – e sono tutt’altro che sporadici – casi nei
quali la norma venga fatto oggetto di scrutinio indipendentemente da ogni
riferimento a tertia comparationis. È in questo ambito che l’utilizzo
dell’art. 3 della Costituzione diviene (può divenire) il parametro alla luce
del quale sindacare le scelte operate dal legislatore, attraverso la
valutazione della non irragionevolezza dell’esercizio della discrezionalità che
ad esso deve essere riconosciuta (si veda anche supra, parte I, cap. I,
par. 12).
In linea generale, può dirsi che, un
caso tipico di violazione del principio di ragionevolezza è riscontrabile
quando viene dettata una disciplina che, animata da un fine (nella specie,
combattere il fenomeno dell’abusivismo), finisce per favorire pratiche opposte
(distorsive della concorrenza). Come conseguenza dell’intrinseca, manifesta
irragionevolezza della norma può derivare, ovviamente, l’irragionevolezza della
disparità di trattamento che essa crea tra i soggetti che ne sono destinatari.
Sul piano contenutistico, ad evitare
l’intrinseca irragionevolezza della disposizione può essere anche la posizione
di una regola flessibile, derogabile in taluni, seppur limitate, ipotesi
(sentenza n. 32).
Queste affermazioni di principio
hanno conosciuto applicazione, nel
a) Se è vero che, per essere in armonia con l’art. 3
della Costituzione, la normativa deve essere conforme ad un principio di
ragionevolezza «intrinseca», le norme censurate nel giudizio definito dalla
sentenza n. 78 non potevano essere
ritenute che contrastanti con questo parametro. Esse, infatti, facevano
irragionevolmente derivare dalla denuncia per uno dei reati per i quali gli
articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l’arresto obbligatorio o
facoltativo in flagranza conseguenze molto gravi in danno di chi della medesima
era soggetto passivo, imponendo il rigetto dell’istanza di regolarizzazione che
lo riguardava e l’emissione nei suoi confronti dell’ordinanza di espulsione;
conseguenze tanto più gravi qualora s’ipotizzassero denunce non veritiere per
il perseguimento di finalità egoistiche del denunciante e si avesse riguardo
allo stato di indebita soggezione in cui, nella vigenza delle norme stesse,
venivano a trovarsi i lavoratori extracomunitari. Da tali rilievi, è stata
dedotta l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate nella parte in cui
facevano derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione
del lavoratore extracomunitario dalla presentazione nei suoi confronti di una
denuncia per uno dei reati suddetti.
Una ratio decidendi analoga a quella di cui alla sentenza n. 78 è stata seguita nella sentenza n. 466 onde dichiarare l’illegittimità
costituzionale della dispozione che puniva più severamente lo straniero espulso
che avesse fatto rientro in Italia, se già denunciato per la contravvenzione di
reingresso nel territorio nazionale senza autorizzazione ministeriale (la
denuncia – si è ribadito – «è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o
alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il
denunciante riferisce», per cui non è possibile far derivare dalla sola
denuncia conseguenze pregiudizievoli per il denunciato, in quanto essa comporta
soltanto l’obbligo degli organi competenti «a verificare se e quali dei fatti
esposti in denuncia corrispondano alla realtà e se essi rientrino in ipotesi
penalmente sanzionate, ossia ad accertare se sussistano le condizioni per
l’inizio di un procedimento penale»).
D’altra parte, in linea di principio,
la previsione normativa in forza della quale lo straniero, pur regolarmente
entrato nel territorio nazionale, è abilitato a trattenersi in esso solo ove si
munisca di apposito permesso – da richiedere alla competente autorità
amministrativa entro un termine perentorio, sotto minaccia di espulsione –
rappresenta, di per sé, espressione non irragionevole della discrezionalità che
al legislatore compete nella regolamentazione del fenomeno dei flussi migratori
(ordinanza n. 463).
b) In ordine alla configurazione delle fattispecie
criminose, la sentenza n.
Con riferimento alle problematiche
più direttamente inerenti alla determinazione delle pene, nella sentenza n.
La questione di legittimità
costituzionale nella specie sottoposta non rientrava, tuttavia, nell’ambito dei
limiti entro cui
Come per la determinazione delle
sanzioni, anche per la disciplina dei benefici sussiste, per il legislatore,
una discrezionalità limitata dalla non manifesta irragionevolezza. Questo
limite è stato ritenuto, nella sentenza n. 278,
violato dalla previsione in base alla quale un discrimine per il godimento del
c.d. «indultino» veniva individuato nella circostanza dell’ammissione o meno a
misure alternative alla detenzione, e ciò soprattutto perché di un siffatto
beneficio avrebbero goduto condannati ritenuti non meritevoli di misure
alternative e non anche quelli che sono stati giudicati meritevoli di tali
misure.
Sulla discrezionalità del legislatore
nell’individuazione delle condotte punibili e nella scelta e la quantificazione
delle relative sanzioni, si segnalano anche la sentenza n. 144 e le
ordinanze nn. 262 e 401, secondo cui siffatta discrezionalità che
può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità,
soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così
da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza.
L’ordinanza n.
c) Affermazioni non dissimili si rintracciano con
riferimento alle sanzioni amministrative.
Nell’ordinanza n. 247 si è
evidenziato che, se la complessiva disciplina sanzionatoria prevista dal codice
della strada tende a soddisfare l’esigenza, connessa alla strutturale
pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l’incolumità personale dei
soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni),
appare allora evidente come la salvaguardia di tale esigenza non possa certo
giustificare interventi volti ad escludere l’operatività delle sanzioni
amministrative accessorie in un caso – quale quello contemplato dalla norma
impugnata – connotato dalla reiezione del ricorso proposto avverso il verbale
di contestazione dell’infrazione, e quindi, in definitiva, dalla conferma della
sua legittimità.
Del resto, poiché neppure
l’estinzione dell’illecito amministrativo, in ragione dell’avvenuto pagamento
in misura ridotta, consente al giudice alcun intervento modificativo sulla
sanzione accessoria (o finanche solo sulla sua entità), non si vede come possa
tacciarsi di irragionevolezza la mancata previsione di un intervento siffatto
allorché il giudice, addirittura, rigetti il ricorso volto a contestare la
legittimità del verbale di contestazione dell’infrazione stradale.
Secondo quanto stabilito con
l’ordinanza n. 218, deve poi escludersi che il legislatore, nel
configurare la fattispecie sanzionatoria relativa al mancato rispetto della
disposizione che impone di regolare adeguatamente la velocità del veicolo
nell’attraversamento di un centro abitato fiancheggiato da edifici, abbia
esorbitato, nell’esercizio della sua discrezionalità, dai limiti della
ragionevolezza e lasciato all’arbitrio dell’agente accertatore dell’infrazione
il compito di riempirne il contenuto, dovendosi constatare che il giudizio
sulla valutazione della velocità non è ancorato ad astratti valori numerici,
bensì assume un connotato relativo, postulando che il concreto apprezzamento
della condotta del conducente si svolga proprio in rapporto a quelle
determinate circostanze di tempo e di luogo che la fattispecie legale evidenzia
come parametri di riferimento per un comportamento prudente.
È anche da notare che
l’irragionevolezza di una disposizione legislativa può essere testimoniata
anche dal tipo di sanzione amministrativa che essa crea: nella sentenza n. 27, si è infatti censurata la
previsione di «una sanzione assolutamente sui generis» (peraltro irragionevolmente
assimilabile, in parte, ad altra, concernente però un illecito amministrativo
di diversa natura).
d) Sul piano del diritto processuale, nell’ordinanza n.
215 si è sottolineato come, onde conseguire l’obiettivo di un ordinato
svolgimento del giudizio, il legislatore, nella sua discrezionalità, ben possa
utilizzare gli eventuali condizionamenti di ordine temporale alla proposizione
dell’intervento ovvero le preclusioni all’apporto probatorio a sostegno della
relativa domanda. Che il legislatore goda di ampia discrezionalità nel
disegnare gli istituti processuali è, del resto, principio ampiamente
consolidato, e più volte ribadito anche nel 2005 (sentenze nn. 109 e 379,
e, con precipuo riguardo all’esecuzione delle sentenze rese nel processo
amministrativo, ordinanza n. 122), anche quando ciò incida – scil.,
non irragionevolmente – sul diritto di difesa (ordinanze nn. 230 e 350).
Alcune scelte operate nella
conformazione degli istituti processuali sono state invece ritenute affette da
irragionevolezza. Si segnala, al riguardo, la sentenza n. 274,
concernente il processo tributario: la compensazione ope legis delle
spese nel caso di cessazione della materia del contendere, rendendo inoperante
il principio di responsabilità per le spese del giudizio, si traduce, ad avviso
della Corte, in una intrinseca irragionevolezza, motivata dall’ingiustificato
privilegio per la parte che pone in essere un comportamento di regola
determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, e,
corrispondentemente, dal parimenti ingiustificato pregiudizio per la
controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina
del processo tributario, dell’assistenza tecnica di un difensore e, quindi,
costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato
alla difesa in giudizio.
e) Per quanto specificamente attiene al diritto
(sostanziale) tributario, la sentenza n.
Analogamente, sono rimesse alla
discrezionalità del legislatore sia l’individuazione delle situazioni
significative della capacità contributiva sia la determinazione dell’entità
dell’onere tributario, con il limite della non arbitrarietà o irrazionalità
della scelta legislativa, non superato nel considerare indice di capacità
contributiva l’acquisto di terreni agricoli, ponendo l’imposta a carico di
ciascun successivo acquirente, con una aliquota raccordata ai criteri di
valutazione dei beni iscritti in catasto tale da avere una contenuta incidenza
sul valore del bene (ordinanza n. 23). Nel medesimo senso, anche
l’ordinanza n.
Su singoli profili del rapporto
tributario, sono da menzionare anche la sentenza n. 225 e l’ordinanza n.
402. Nella prima si è stabilito che la presunzione di ricavi iuris
tantum relativa alla destinazione dei prelievi non risultanti dalle
scritture contabili non appare lesiva del canone di ragionevolezza di cui
all’art. 3 della Costituzione, non essendo manifestamente arbitrario ipotizzare
che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un
imprenditore siano stati destinati all’esercizio dell’attività d’impresa e
siano, quindi, in definitiva, detratti i relativi costi, considerati in termini
di reddito imponibile. L’ordinanza n.
Non è comunque consentito lasciare il
contribuente assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo
indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione,
certamente eccessivo e irragionevole. L’irragionevolezza discende,
segnatamente, dal peculiare trattamento che verrebbe riservato, con la
soggezione al termine prescrizionale ordinario, proprio all’ipotesi nella quale
l’Amministrazione (lato sensu intesa), sempre soggetta a rigorosi
termini di decadenza per attività ben più complesse, è chiamata a compiere una
elementare operazione di verifica (non a caso definita dalla legge meramente)
formale (sentenza n. 280).
f) Il giudizio sulla ragionevolezza delle scelte
operate dal legislatore non può non spingersi alla valutazione circa la
giustificatezza dei parametri concretamente individuati nella disciplina di
trattamenti economici. È quanto emerge, tra l’altro, nella sentenza n. 220,
dove si precisa che, sebbene debba riconoscersi al legislatore la facoltà di
ancorare l’indennità spettante ai giudici onorari a parametri indipendenti da
quelli, propri della retribuzione, connessi alla qualità e quantità del lavoro
svolto, non può negarsi l’irragionevolezza della norma che individui parametri
che, oltre a rivelarsi inadeguati ad una corretta ponderazione delle situazioni
economiche dei soggetti destinatari dell’indennità, si appalesino non coerenti
con la ratio sottesa al sistema.
Per quel che attiene al trattamento
pensionistico, il vulnus all’art. 3 (oltre che all’art. 38) della
Costituzione è ravvisabile – secondo quanto affermato nella sentenza n. 338
– soltanto ove sia assente una clausola di salvaguardia della posizione
acquisita a seguito del raggiungimento dell’anzianità minima contributiva, che
segna un limite intrinseco alla discrezionalità del legislatore nella scelta,
ad esso riservata, del criterio di individuazione del periodo di riferimento
della retribuzione pensionabile.
Come noto, nella valutazione del
corretto esercizio della discrezionalità legislativa, non possono non
rientrare, poi, se del caso, anche coefficienti di ordine prettamente
economico, ad esempio nella considerazione della necessità di porre limiti di
spesa (sentenza n. 111), nel bilanciamento tra oneri da sostenere e
risparmi che una determinata norma può ingenerare (sentenza n. 191) o
nel bilanciamento tra costi di un servizio e tutela degli utenti (sentenza n. 199).
È, in effetti, alla luce della
preminente valutazione dell’interesse pubblico che molte disposizioni debbono
essere scrutinate. Ciò è quanto si è verificato, peraltro, anche con
riferimento ad una fattispecie sostanzialmente diversa da quelle appena sopra
menzionate: nella sentenza n. 147, segnatamente, si è ritenuto
nient’affatto contraddittorio rispetto all’affermazione della generale libertà
dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale di svolgere
attività libero-professionale al di fuori delle strutture pubbliche, al di
fuori dell’orario di servizio, al di fuori del «plus orario» e al di fuori del
lavoro straordinario, che il legislatore regionale abbia ritenuto di porre
limitazioni allo svolgimento di tale attività a tutela delle esigenze delle
finalità istituzionali delle strutture pubbliche, in misura tale da non
svuotare del tutto il contenuto del diritto.
Sempre in ordine all’applicazione del
principio di ragionevolezza all’attività amministrativa, con precipuo riguardo
al suo possibile collegamento con il principio di buon andamento, si rinvia a
quanto verrà detto infra, cap. III, sez. I, par. 5.1.
g) Con riferimento ai rapporti di durata, nella
statuizione resa con la sentenza n. 264, la non irragionevolezza della
disciplina concernente l’aumento dei canoni di locazione è derivata dall’essere
la norma impugnata frutto di una valutazione del legislatore orientata ad un
aumento non indiscriminato dei canoni, essendo stati utilizzati al riguardo i
criteri, di natura oggettiva, del reddito dell’assegnatario del bene e del
valore di mercato degli immobili locati, quest’ultimo assunto a regola di chiusura
per temperare l’incremento complessivo del canone derivante dall’applicazione
dei coefficienti di rivalutazione. Al non irragionevole esercizio della
discrezionalità legislativa non è dato, peraltro, opporre considerazioni di
opportunità volte a porre rimedio a mere incoerenze e disarmonie della
normativa censurata, che non possono assurgere a motivo di incostituzionalità
della medesima.
h) L’importanza del fattore temporale sulla prognosi in
ordine alla ragionevolezza di una disposizione – ben testimoniato, tra l’altro,
anche dall’orientamento secondo cui la discrezionalità del legislatore è
particolarmente ampia quando trattasi di dettare disposizioni transitorie
(sentenza n. 21) – si apprezza, ovviamente, anche (se non soprattutto),
con riferimento agli effetti retroattivi che le norme possono avere. Sul punto
specifico, si rinvia, comunque, a quanto verrà detto infra, cap. III,
sez. I, par. 2.2.
3.
Il principio di laicità dello Stato
Con la sentenza n. 168
Nell’accogliere la questione
4.
La condizione giuridica dello straniero
Con riferimento alla condizione
giuridica dello straniero,
4.1.
Il diritto all’unità familiare
Il godimento dei diritti inviolabili dell’uomo
non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello
straniero:
In particolare, con la sentenza n. 224
In particolare, si ricorda nella
sentenza come il legislatore possa «legittimamente porre dei limiti all’accesso
degli stranieri nel territorio nazionale effettuando un “corretto bilanciamento
dei valori in gioco”, poiché sussiste in materia un’ampia discrezionalità
legislativa limitata solo dal vincolo che le scelte non risultino
manifestamente irragionevoli».
Secondo
Quanto infine alle «ragioni di
solidarietà familiare» invocate dal giudice a
quo,
4.2.
L’espulsione dello straniero
Richiamando la sentenza n. 224,
quanto ai limiti della tutela costituzionale del diritto all’unità familiare,
Nell’ordinanza n. 463,
Con la sentenza n. 466
Ciò posto
Nel senso della manifesta
infondatezza è stata invece decisa con l’ordinanza n. 261 una diversa
questione avente ad oggetto proprio la fattispecie di cui all’art. 13, comma
13, d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002. Detta
norma era censurata dal rimettente, in riferimento agli articoli 2 e 3 della
Costituzione, nella parte in cui prevede un trattamento sanzionatorio più
severo per lo straniero espulso che violi il divieto di rientro nel territorio
dello Stato senza speciale autorizzazione rispetto a quello stabilito dall’art.
650 cod. pen. per il cittadino italiano nel caso di inosservanza di
provvedimenti dell’autorità.
Da segnalare infine che numerose sono
le ordinanze di restituzione degli atti adottate a seguito delle sentenze di
illegittimità costituzionale n. 222
(immediata esecutività del provvedimento di espulsione) e n. 223 (arresto obbligatorio in flagranza
per il reato di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il
territorio nazionale) del 2004 e della sopravvenuta modifica del diritto
positivo dovuta all’entrata in vigore del decreto legge n. 241 del 2004,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 271 del 2004.
4.3
La regolarizzazione del lavoratore extracomunitario
In tema di legalizzazione del lavoro
irregolare si segnala la sentenza n. 78
con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma
7, lettera c), della legge n. 189 del 2002 e dell’art. 1, comma 8,
lettera c), del decreto legge n. 195 del 2002 (Disposizioni urgenti in
materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari),
convertito, con modificazioni, nella n. 222 del 2002, nella parte in cui non
consentono la regolarizzazione del lavoratore extracomunitario denunciato per
uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale
prevedono l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.
Ha osservato infatti
4.4.
Il diritto alla fruizione dei servizi pubblici
Con la sentenza n. 432
Ciò posto,
Ed è sotto questo profilo che, a
giudizio della Corte, la disposizione censurata, il cui «scrutinio va
circoscritto all’interno della specifica previsione, in virtù della quale la
circolazione gratuita viene assicurata non a tutti gli invalidi residenti in
Lombardia che abbiano un grado di invalidità pari al 100%, ma soltanto a
quelli, fra essi, che godano della cittadinanza italiana», si pone in contrasto
con il principio sancito dall’art. 3 della Costituzione. Il requisito della
cittadinanza si atteggia infatti nella disposizione in esame «come uno
specifico presupposto che condiziona l’ammissione al regime di favor,
non diversamente dagli altri specifici requisiti che valgono ad identificare le
singole categorie privilegiate», ma, ha affermato
Dalla norma censurata, ha concluso
4.5.
Questioni non decise nel merito
Fra le questioni non decise nel
merito per ragioni processuali (difetto di motivazione sulla rilevanza)
meritano una menzione particolare quelle oggetto delle ordinanze n. 126, n. 189 e n. 295,
concernenti: a) l’esclusione della regolarizzazione, a seguito di istanza di
emersione, dei lavoratori che siano stati destinatari di provvedimenti di
espulsione con accompagnamento alla frontiera; b) la disposizione secondo cui
«la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuni dei reati previsti dalle
disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore,
e dagli articoli 473 e 474 del codice penale, comporta la revoca del permesso
di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica»; c) la mancata
previsione del «ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di espulsione
del questore emesso quando non sia possibile trattenere lo straniero entro un
centro di permanenza».
Diritti e doveri degli individui
Nelle sentenze nn. 299 e 408, entrambe di illegittimità costituzionale, viene in rilievo la
garanzia sancita dall’art. 13, quinto comma, Cost. dei limiti massimi di durata
della custodia cautelare.
In particolare, la sentenza n. 299 pone fine ad una tormentata vicenda interpretativa che aveva ad
oggetto la portata dell’art. 303, comma 2, del codice di procedura penale.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 303
del codice di rito, nell’ipotesi di regressione del procedimento a seguito di
annullamento con rinvio, dalla data del provvedimento che dispone il rinvio
decorrono nuovamente i termini previsti dal precedente comma 1. Permaneva tuttavia
il dubbio circa la compatibilità, ai fini del calcolo dei termini massimi di
fase previsti dall’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., della custodia sofferta
in pendenza di fasi o gradi del giudizio diversi rispetto alla fase o al grado
in cui il procedimento regredisce: così, con riguardo all’ipotesi di
annullamento con rinvio, se risultava pacifico che dovesse computarsi la
custodia subita nella fase conclusasi con il provvedimento poi annullato, cui
occorreva addizionare la privazione di libertà sofferta nella parallela fase di
rinvio, ci si chiedeva, invece, se nel computo dovesse o no rientrare anche la
custodia subita nelle fasi intermedie, quale il giudizio di Cassazione
conclusosi con l’annullamento con rinvio del primo decisum.
Nel quadro della giurisprudenza
costituzionale, ha sottolineato ancora
Dunque, torna a riaffermare
Pertanto, «le limitazioni della
libertà connesse alle vicende processuali devono rispettare il principio di
proporzionalità, posto che contrasterebbe con il giusto equilibrio tra le
esigenze del processo e la tutela della libertà una disciplina della detenzione
cautelare priva di limiti di durata ragguagliati, da un lato, alla pena
prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza e, dall’altro, alla
concreta dinamica del processo e alle diverse fasi in cui esso si articola».
Invero, «unitamente al principio di adeguatezza, il criterio di proporzionalità
tra la gravità della pena prevista per il reato e la durata della custodia
lungo l’intiero corso del procedimento ispira l’esigenza di assicurare un
ragionevole limite di durata della custodia cautelare in relazione alla sua
durata complessiva e alle singole fasi del processo».
In tal senso «processo e fatto di reato
sono infatti termini inscindibili del binomio al quale va sempre parametrata la
disciplina della custodia cautelare e ad entrambi deve sempre essere ancorata
la problematica dei termini entro i quali la durata delle misure limitative
della libertà personale può dirsi proporzionata e, quindi, ragionevole», in
conformità, tra l’altro, ai valori espressi dall’art. 5, par. 3, della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo l’interpretazione datane
dalla Corte di Strasburgo, e tenuto conto che «proporzionalità e ragionevolezza
stanno alla base del principio secondo cui, in ossequio al favor libertatis
che ispira l’art. 13 Cost., deve comunque essere scelta la soluzione che
comporta il minor sacrificio della libertà personale».
Ne deriva che «la tutela della libertà personale che si realizza
attraverso i limiti massimi di custodia voluti dall’art. 13, quinto comma,
Cost. è quindi un valore unitario e
indivisibile, che non può subire deroghe o eccezioni riferite a
particolari e contingenti vicende processuali, ovvero desunte da una
ricostruzione dell’attuale sistema processuale che non consenta di tenere
conto, ai fini della garanzia del termine massimo finale di fase, dei periodi
di custodia cautelare “comunque” sofferti nel corso del procedimento».
Sulla base di tali principî
Alla tutela della libertà personale
si ispira anche la sentenza n. 408 che ha ad oggetto la disciplina
della retrodatazione dei termini di custodia cautelare nel caso di più
ordinanze emesse nei confronti dello stesso soggetto in tempi diversi (c.d.
divieto di contestazioni a catena).
Ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod.
proc. pen. il meccanismo della retrodatazione risultava applicabile solo in
relazione a fatti diversi, se avvinti da un rapporto di connessione
«qualificata» ex art. 12, comma 1,
lettere b) e c), cod. proc. pen., e cioè limitatamente ai casi di reati
commessi per eseguire gli altri, e non anche in relazione a fatti diversi non
connessi. Tale esclusione è stata ritenuta dalla Corte del tutto ingiustificata
nelle ipotesi in cui gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già
desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza,
sulla base della considerazione che, in una «cornice normativa attenta a
calibrare l’intera disciplina dei termini di durata delle misure limitative
della libertà personale, e di quelle custodiali in particolare, sulla falsariga
dei valori della adeguatezza e proporzionalità, nessuno spazio può residuare in
capo agli organi titolari del “potere cautelare” di scegliere il momento a
partire dal quale possono essere fatti decorrere i termini custodiali in caso di
pluralità di titoli e di fatti reato cui essi si riferiscono», in perfetta
aderenza d’altronde con i valori di
certezza e di «durata minima» della custodia cautelare (di cui all’art.
13, primo e quinto comma, Cost., nonché all’art. 5 par. 3 della Convenzione
europea dei diritti umani). Nello stesso senso si erano del resto già espresse
le Sezioni unite, ma la sentenza di
accoglimento è stata imposta dal fatto che il giudice a quo era
vincolato dal principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento con
rinvio della Corte di cassazione, che in quel caso aveva seguito l’orientamento
opposto.
Con la sentenza n. 66,
La libertà di circolazione è venuta
in considerazione anche con riferimento all’art. 120, primo comma, Cost.,
segnatamente con la sentenza n. 147,
per la trattazione della quale v. infra,
sez. III, par. 1.
3.
La libertà di manifestazione del pensiero
Non decisa nel merito, ma comunque,
di rilievo la questione sollevata dal Tribunale di Milano, chiamato a decidere
sulla richiesta di registrazione di un periodico destinato alla comunità araba,
presentata da un cittadino egiziano iscritto come pubblicista nell’elenco dei
giornalisti di nazionalità straniera annesso all’albo dei giornalisti, il quale
riteneva l’art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla
stampa) in contrasto con gli articoli 2, 3 e 21 Cost., in quanto preclusivo
della registrazione di un periodico per il solo fatto che la persona indicata
come direttore responsabile non è cittadino comunitario.
4.
I principî costituzionali in materia penale
Per quanto attiene al diritto penale
materiale, le questioni giunte all’attenzione della Corte hanno riguardo
principalmente il principio di offensività, il trattamento sanzionatorio e la
finalità della pena (in collegamento con la personalità della responsabilità
penale).
4.1.
Il principio di offensività
Con la sentenza n. 265
Nel sollevare la questione il giudice
a quo denunciava il contrasto dell’art.
707 del codice penale con i principî di materialità e, soprattutto, di
offensività del reato, riconducibili all’art. 25, secondo comma, Cost., anche
in collegamento con gli articoli 13 e 27, primo, secondo e terzo comma, Cost.
Nell’escludere la violazione del
principio di materialità
Quanto al secondo profilo di censura
Tuttavia – aggiunge
Conclude
4.2.
La discrezionalità del legislatore nella determinazione del trattamento
sanzionatorio
La giurisprudenza della Corte è
consolidata nel ritenere circoscritto il sindacato di costituzionalità su
scelte operate dal legislatore nella configurazione delle fattispecie e nella
determinazione del relativo trattamento sanzionatorio, con riferimento in
particolare alla congruità della pena rispetto alla gravità del reato, ai casi
in cui esse si rivelino palesemente arbitrarie o radicalmente ingiustificate,
ovvero contrastanti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza.
Nel ribadire tale indirizzo la
sentenza n. 325 ricorda come «le
sentenze di accoglimento per avere il legislatore superato il limite della
ragionevolezza sono state pronunciate in situazioni in cui l’arbitrarietà delle
scelte legislative derivava dal diretto confronto tra fattispecie di reato
sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio
(sentenze n. 102 del 1985, n. 341 del 1994 e n. 287 del 2001), ovvero in casi
in cui era prevista la medesima pena sia per il delitto consumato (omicidio),
sia per il tentativo del medesimo delitto (commesso da un militare contro un
superiore: sentenza n. 26 del 1979)».
Sulla base di tali premesse
Con riferimento alla prima decisione
(ordinanza n. 262)
Quanto alla seconda decisione (sentenza
n. 325),
Sotto il diverso profilo della
«irragionevole equiparazione, ai fini dell’applicazione della sanzione, di
situazioni tra loro diseguali» si segnala, invece, in tema di legalizzazione
del lavoro irregolare, la sentenza n. 144
(v. anche supra, cap. I, par. 4.3),
con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3,
del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il
completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e
di lavoro irregolare), convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile
2002, n. 73, «nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il
rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio
dell’anno in cui è stata constatata la violazione».
Secondo
Richiamando una consolidata
giurisprudenza secondo cui rientra nella discrezionalità del legislatore anche
individuare cause estintive del reato, ovvero cause sopravvenute di non
punibilità legate a condotte lato sensu riparatorie
4.3.
I principî di personalità della responsabilità penale e della funzione
rieducativa della pena
Nell’ordinanza n. 296
Più precisamente, secondo
Ora, ha affermato
Il
principio della funzione rieducativa della pena è stato evocato, unitamente
all’art. 3 della Costituzione, anche in numerose questioni aventi ad oggetto il
beneficio della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva
previsto dalla legge 1° agosto 2003 n. 207 (cosiddetto «indultino»).
Con un primo gruppo di ordinanze si
dubitava, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d), della legge n. 207 del
2003, nella parte in cui sulla base del tenore letterale (la sospensione condizionata
dell’esecuzione della pena detentiva non
si applica «quando la persona condannata è stata ammessa alle misure
alternative alla detenzione») consente
l’accesso al beneficio a chi ha subito la revoca di precedenti misure
alternative, per fatti concludenti quindi poco affidabile, «precludendolo
invece a chi è già stato ammesso ad altri benefici penitenziari e pertanto
sicuramente più meritevole».
La questione è stata ritenuta fondata
per l’irragionevole disparità di trattamento che si determina tra imputati ai
fini dell’ammissione al beneficio. Nella sentenza si osserva che «è bensì vero
che rientra nella discrezionalità del legislatore modulare in vario modo i
benefici da concedere ai condannati, con l’unico limite della non manifesta
irragionevolezza, ma questo limite, nella specie, risulta violato, non potendo
la circostanza dell’ammissione o meno a misura alternative alla detenzione
costituire un discrimine per il godimento dell’”indultino”», tanto più «ove si
tenga presente che di quest’ultimo verrebbero a godere condannati ritenuti non
meritevoli di misure alternative e non anche quelli che sono stati giudicati
meritevoli di tali misure».
Successivamente è stata disposta la
restituzione degli atti ai giudici a quibus per l’esame della perdurante
rilevanza, alla luce della sopravvenuta declaratoria di illegittimità
costituzionale, di questioni aventi ad oggetto l’art. 1, comma 3, lettera d),
e sollevate, in riferimento tra gli altri anche all’art. 79, comma primo, della
Costituzione, in data antecedente a tale pronuncia (ordinanze n. 346, n. 351, n. 356
e n. 358).
Infine, con l’ordinanza n. 255 (v. anche supra, cap. I, par. 1),
5.
I principî costituzionali in materia processuale
I principî costituzionali in materia
processuale rappresentano un settore su cui
Il fondamento di qualsiasi arbitrato
per il combinato disposto degli articoli 24, comma 1, e 102, comma 1, della Costituzione,
è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti (intesa come uno dei possibili
modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all’art. 24,
comma 1, Cost.) e non in una legge ordinaria o, più generalmente, in una
volontà autoritativa.
Richiamando questo consolidato
indirizzo,
Infine, investita di una questione di
legittimità costituzionale avente ad oggetto una disposizione della legge
finanziaria del
Sul diritto di difesa vanno
segnalate, in particolare, la sentenza n.
La sentenza n. 144 va menzionata per quanto riguarda il problema della compatibilità
con il diritto di difesa di discipline che introducono presunzioni assolute,
con esclusione della possibilità di fornire prova contraria.
Nella specie,
In tal modo, «il legislatore ha
evidentemente inteso determinare un ulteriore inasprimento del trattamento
sanzionatorio per coloro che continuino ad impiegare lavoratori irregolarmente,
nonostante che siano stati introdotti meccanismi agevolati di varia natura per
incentivare l’emersione del lavoro sommerso», ma il meccanismo previsto dalla
disposizione censurata è «tale da non consentire al datore di lavoro di fornire
la prova che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio in una data
diversa da quella del primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata la
violazione, e che, dunque, ha avuto una durata inferiore rispetto a quella
presunta dalla legge».
La suddetta «presunzione assoluta
determina la lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della
Costituzione, dal momento che preclude all’interessato ogni possibilità di
provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta e che
pertanto sono in grado di incidere sulla entità della sanzione che dovrà
essergli irrogata» e «determina, altresì, la irragionevole equiparazione, ai
fini del trattamento sanzionatorio, di situazioni tra loro diseguali, quali
quelle che fanno capo a soggetti che utilizzano lavoratori irregolari da
momenti diversi e per i quali la constatazione della violazione sia in ipotesi
avvenuta nella medesima data».
Di qui l’illegittimità costituzionale
della norma censurata, «nella parte in cui non ammette la possibilità di
provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al
primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione».
Attestandosi nel solco di una
giurisprudenza consolidata,
Nel dichiarare manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento
agli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione, dell’art. 69-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, aggiunto dall’art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 2002,
n. 277, nella parte in cui stabilisce che «il magistrato di sorveglianza
provveda con rito senza formalità sulla concessione della liberazione
anticipata al condannato detenuto in carcere o in misura alternativa»,
In questo ambito può essere altresì
ricordata la sentenza n. 32, che ha
ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4,
comma 10, del decreto legislativo n. 58 del 1998, censurato, in riferimento
agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui assoggetta al
segreto d’ufficio l’intera documentazione in possesso della CONSOB in ragione
dell’attività di vigilanza.
Parimenti, la norma de qua non è viziata da
irragionevolezza, poiché la disciplina dell’accesso ai documenti acquisiti
dalla CONSOB non si traduce in un divieto assoluto: «il legislatore, per meglio
garantire la funzione di vigilanza della CONSOB, finalizzata […] alla tutela
della stabilità dei mercati finanziari, ha sì introdotto un regime di segreto
sugli atti acquisiti nell’esercizio di quella funzione, ma ha previsto
deroghe», con la conseguenza che «la limitazione stabilita per la ostensione di
atti acquisiti nell’attività di vigilanza non appare manifestamente
irragionevole o arbitraria».
5.3.
La difesa dei non abbienti
In tema di patrocinio a spese dello
Stato vanno segnalate le ordinanze n. 54
e n. 350.
Con la prima
Con la seconda
In
applicazione di tale principio
Risultano, infine, inammissibili per
difetto di motivazione sulla rilevanza (ordinanze n. 251 e 482) due questioni
di costituzionalità concernenti l’art. 91 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 e l’art. 1, comma 9, della legge n. 217 del 1990,
sollevate in riferimento agli articoli 3, 24 e 27, secondo comma, Cost.,
laddove stabiliscono che l’ammissione al patrocinio dei non abbienti è esclusa
per l’imputato, l’indagato e il condannato per reati commessi in violazione
delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi
e sul valore aggiunto.
5.4.
La riparazione per l’ingiusta detenzione
L’ordinanza n. 59 merita di essere segnalata per la particolarità della vicenda
processuale da cui trae origine. Il processo, iniziato nel vigore del codice di
procedura penale del 1930, si era concluso con sentenza istruttoria di
proscioglimento nel giugno del 1990. Nel 2001 l’imputato, che aveva subito
carcerazione preventiva per i fatti dai quali era stato prosciolto, chiedeva la
riparazione per ingiusta detenzione. Il giudice, rilevando che la richiesta
risultava tardiva a norma dell’art. 315, sollevava questione di legittimità
costituzionale di tale norma, nella parte in cui prevede che il termine per
proporre la richiesta di equo indennizzo decorre da quando la sentenza di non
doversi procedere ex art. 378 cod.
proc. pen. del 1930 è divenuta inoppugnabile, anziché dal giorno in cui è stata
notificata all’imputato o comunque questo ne ha avuto effettiva conoscenza.
Secondo il rimettente la situazione in esame era analoga a quella esaminata
dalla Corte con la sentenza n. 446 del 1997, concernente il decorso del termine
a seguito di decreto di archiviazione: da qui il denunciato contrasto con gli
articoli 3 e 24 Cost.
Secondo
Sul diritto alla salute va in primo
luogo richiamata la sentenza n. 432 (già
citata nelle parti dedicate rispettivamente al principio personalistico e alla
condizione giuridica dello straniero) nella quale
Dunque «anche lo straniero presente
irregolarmente nello Stato “ha diritto di fruire di tutte le prestazioni che
risultino indifferibili ed urgenti, secondo i criteri indicati dall’art. 35,
comma 3 (del d.lgs. n. 286 del 1998), trattandosi di un diritto fondamentale
della persona che deve essere garantito, così come disposto, in linea generale,
dall’art. 2 dello stesso decreto legislativo n. 286 del
La tutela del diritto alla salute è
stata evocata anche in una questione di costituzionalità avente ad oggetto la
disciplina della detenzione domiciliare e decisa nel senso della manifesta
infondatezza con ordinanza n. 255.
Il rimettente censurava, in
riferimento tra gli altri all’art. 32 della Costituzione, l’art. 47-ter,
comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall’art.
4 della legge 27 maggio 1998, n. 165, lamentando che il magistrato di
sorveglianza non possa disporre in via provvisoria la misura della detenzione
domiciliare nel caso disciplinato dal comma 1-ter del medesimo articolo (ovvero quando potrebbe essere disposto
il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli
articoli 146 e 147 cod. pen.).
Va infine menzionata l’ordinanza n.
Nell’evocare la tutela del diritto
alla salute, il rimettente evidenziava in particolare come il ricovero in una
struttura terapeutica psichiatrica di tipo contenitivo «consentirebbe
all’imputato di fruire dei trattamenti terapeutici più adeguati sotto il
profilo psichiatrico».
La questione è stata dichiarata
manifestamente inammissibile sul duplice rilievo che «esulano dalla sfera dei
poteri della Corte interventi di carattere normativo, in quanto comportano
scelte discrezionali che rientrano nella esclusiva competenza del legislatore»
e che il rimettente, pur richiamando la sentenza n. 253 del 2003, con la quale
si è consentito al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza idonea a contemperare
le esigenze di cura con quelle di controllo della pericolosità sociale, non ha
esposto «le ragioni per cui nel caso di specie la misura della casa di cura e
di custodia non sarebbe adeguata e non chiarisce i motivi per i quali la
libertà vigilata sarebbe in concreto insufficiente».
Le decisioni che hanno avuto ad
oggetto i rapporti familiari hanno riguardato principalmente la tutela dei
minori, quella dei disabili e quella degli incapaci, nonché la disciplina della
famiglia di fatto.
2.1.
La tutela del minore e il principio di «responsabilità genitoriale»
La tutela dei rapporti familiari e
del minore è al centro di due importanti pronunce che riconfermano l’attenzione
prestata dai giudici a quibus e dalla Corte a questioni complesse
involgenti conflitti spesso apparentemente insanabili in tema di diritto di
famiglia.
La sentenza n. 385, con cui è stata
dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, «nella parte in cui non prevedono il
principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre
l’indennità di maternità, attribuita solo a quest’ultima», si colloca in
particolare nel solco di quell’indirizzo già seguito in passato dalla Corte e
volto a garantire parità di trattamento fra figure genitoriali (padre e madre;
genitori naturali e adottivi) e fra categorie di lavoratori.
Il giudice rimettente aveva
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 29, secondo comma, 30, primo comma,
e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli
70 e 72 del d.lgs. n. 151 cit., «nella parte in cui non consentono al padre
libero professionista, affidatario in preadozione di un minore, di beneficiare
– in alternativa alla madre – dell’indennità di maternità durante i primi tre
mesi successivi all’ingresso del bambino nella famiglia».
«Tale discriminazione rappresenta un vulnus
sia del principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra
lavoratori autonomi e dipendenti, sia del valore della protezione della
famiglia e della tutela del minore»: invero, ha affermato
E’ necessario, invece, «garantire
un’effettiva parità di trattamento fra i genitori nel preminente
interesse del minore che risulterebbe gravemente compromessa ed
incompleta se essi non avessero la possibilità di accordarsi per un’organizzazione
familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela della prole,
ammettendo anche il padre ad usufruire dell’indennità di cui all’art. 70 del
d.lgs. n. 151 del
«Il compito di approntare un meccanismo
attuativo che consenta anche al lavoratore-padre un’adeguata tutela», afferma
Al
preminente interesse del minore e al «principio di responsabilità genitoriale»
espresso dall’art. 30 Cost., già indicato nella sentenza n. 166 del 1998 come
«il fondamento di quell’insieme di regole, che costituiscono l’essenza del
rapporto di filiazione e si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione
e di educazione della prole, regole che debbono trovare uniforme applicazione
indipendentemente dalla natura, giuridica o di fatto, del vincolo che lega i
genitori», si richiama anche la sentenza n. 394.
Nel dichiarare non fondata «nei sensi
di cui in motivazione» la questione di legittimità costituzionale degli
articoli 261, 147 e 148, 2643 n. 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, «nella
parte in cui non consentono la trascrizione del titolo che riconosce il diritto
di abitazione del genitore affidatario della prole naturale, che non sia
titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile assegnato»,
In particolare,
2.2.
La tutela del minore nella disciplina dell’adozione
Il
Tribunale per i minorenni di Cagliari aveva sollevato questione di legittimità
costituzionale delle disposizioni sopra menzionate, «nella parte in cui
escludono la possibilità di ottenere la dichiarazione di idoneità all’adozione
internazionale, in casi particolari, a favore di singoli, e quindi di
perfezionare l’adozione internazionale in Italia, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, per irragionevole
preclusione dell’adozione da parte di singoli a favore di bambini in stato di
abbandono, dell’art. 30 della Costituzione, per violazione del diritto del
minore in stato di abbandono, italiano e straniero, ad essere allevato in
ambiente idoneo, dell’art. 2 della Costituzione per sottrazione del minore
straniero alle garanzie offerte dalla legge italiana, e discriminazione
rispetto al minore italiano».
Secondo il
remittente «l’adozione internazionale ammetterebbe l’adozione in casi
particolari, non legittimante (e quindi consentibile anche a persone non
coniugate ai sensi dell’art. 44, terzo comma), solo nel caso previsto dall’art.
44, primo comma, lettera a), della legge n. 184 del 1983, e ciò sulla
base del richiamo operato dall’art. 31, secondo comma, individuando, in una
disposizione di esclusivo carattere procedurale, il presupposto implicito
dell’ammissibilità di una sia pur limitata adozione internazionale “in casi
particolari”».
Tale «interpretazione,
costituzionalmente corretta» ha concluso
2.3.
La tutela dei disabili all’interno della famiglia
Con la sentenza n. 233 è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle
sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a
fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi in cui i genitori siano
impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché
totalmente inabili.
La tutela della salute psico-fisica
del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (l.
5 febbraio 1992, n. 104), che la norma denunciata concorre ad attuare, postula
infatti anche l’adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle
famiglie, il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei
soggetti portatori di ‘handicap’, interventi fra cui si inscrive il diritto al
congedo straordinario in questione: esso, tuttavia, rimane privo di concreta
attuazione proprio in situazioni che necessitano di un più incisivo e adeguato
sostegno, come si verifica quando la presenza del genitore totalmente invalido
e privo di autonomia irragionevolmente esclude che possano beneficiare
dell’agevolazione il fratello o la sorella conviventi del soggetto diversamente
abile, benché questi si diano cura di entrambi.
Nella sentenza n. 440,
Nella medesima pronuncia
2.5.
La tutela della famiglia di fatto
Infine, nell’ambito della tutela
riconosciuta alla convivenza more uxorio,
va menzionata una questione con la quale si censurava, in riferimento agli
articoli 2 e 3 Cost., l’art. 1, comma 6, della legge 25 luglio 1997, n. 238
(Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n.
Il rimettente denunciava la
violazione dell’art. 2 e 3 Cost. perché la disciplina censurata non
garantirebbe adeguata protezione ai vincoli affettivi e solidaristici che
caratterizzano la convivenza di fatto e che trovano riconoscimento fra i
diritti inviolabili dell’uomo, ledendo altresì il diritto alla salute nel suo
nucleo irriducibile di tutela della persona, nonché per l’irragionevolezza del
diverso trattamento riservato al convivente more
uxorio rispetto al coniuge.
Con l’ordinanza n. 461,
In materia di tutela del lavoro merita
di essere segnalata, in primis, la sentenza n. 192, che ha ritenuto
non fondata la questione di legittimità dell’art. 22, primo comma, del decreto
legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83,
censurato nella parte in cui prevede un termine di decadenza di soli centoventi
giorni – decorrenti dalla notifica o dal momento di conoscenza del
provvedimento – dall’azione giudiziaria nei confronti dei provvedimenti
definitivi relativi alla mancata inclusione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati a
tempo determinato.
Secondo
Di rilievo è anche la sentenza n. 276, che ha esaminato, ritenendola
infondata, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento
agli articoli 3 e 38 Cost., dell’art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999,
n.144 e dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,
censurati laddove, secondo il tribunale rimettente, attribuirebbero determinati
benefici a soggetti «che abbiano maturato un’anzianità in lavori socialmente utili eseguiti in
un certo periodo (nella specie, dodici mesi di anzianità dal 1 gennaio 1998 al
31 dicembre 1999), senza tener conto dell’effettivo momento in cui, in linea di
fatto, i progetti hanno iniziato il loro svolgimento».
Nella materia lavoristica in senso
lato può essere inserita anche la sentenza n. 220 che affronta il problema della determinazione dell’indennità
spettante ai giudici onorari aggregati.
Con tale pronuncia
Con riferimento all’attività svolta
dai dipendenti del settore pubblico,
Nello stesso settore, l’ordinanza n.
Sempre nella materia del pubblico
impiego deve essere inquadrata la sentenza n. 149 avente ad oggetto, tra
le altre, la questione di legittimità del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, laddove stabilisce, nel quadro della disciplina delle modalità di
progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche l’innalzamento
dei limiti di età per il personale in servizio nel ruolo direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria. Secondo
il Tribunale amministrativo rimettente, la disciplina de qua sarebbe in
contrasto con l’art. 3 Cost. «in quanto non prevederebbe, in via transitoria,
per il personale (già in servizio) del ruolo direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria, la medesima possibilità di innalzamento del limite di età per il
collocamento a riposo, assicurata per il personale di pari qualifica del
corrispondente ruolo della Polizia di Stato».
Dopo aver ricostruito il quadro
normativo in cui si inserisce il provvedimento contestato,
Sulle peculiarità dell’ordinamento
del personale della Polizia di Stato,
ma con riferimento all’ordinamento del personale dell’Arma dei Carabinieri, si
è pronunciata anche la sentenza n. 442 di non fondatezza della questione
di legittimità dell’art. 36, primo comma, cpv. XX, della legge 1 aprile 1981,
n. 121 e dell’art. 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339.
Pertanto, secondo la sentenza qui in
esame, «se può esservi identità di funzioni (di polizia) tra Polizia di Stato e
Arma dei carabinieri (ad es. ai fini dell’unitarietà del coordinamento tecnico
operativo e della direzione unitaria delle forze di polizia…), non può esservi
commistione alcuna tra i rispettivi ordinamenti del personale e, dunque, anche
sul regime attinente a momenti particolari del rapporto di lavoro, quali, ad
esempio, quelli connessi alle diverse situazioni di inidoneità al servizio,
parziale o totale, temporanea o permanente»: infatti, «la distinzione degli
ambiti ordinamentali propri del personale appartenente all’Arma dei carabinieri
[…] e
A tematiche relative all’attività
lavorativa prestata alle dipendenze di strutture pubbliche va ricondotta anche
la sentenza n. 147, che affronta la questione di legittimità dell’art. 2
della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, con riferimento, in
particolare, per ciò che qui interessa, agli articoli 3, 4 e 35 Cost.. La norma
de qua vieta al veterinario
l’attività professionale nell’ambito territoriale dell’azienda sanitaria di
appartenenza e gli impedisce di essere titolare di uno studio privato,
intervenendo, pertanto, in una materia, la tutela della salute, che rientra
nella competenza legislativa concorrente ed in relazione alla quale il
legislatore statale ha dettato i principî fondamentali mediante l’art. 36, comma
1, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, secondo cui «il personale veterinario
ha la facoltà di esercitare l’attività libero-professionale, fuori dei servizi
e delle strutture dell’unità sanitaria locale, purchè tale attività non sia
prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli
interessi ed i fini istituzionali dell’unità sanitaria stessa, né incompatibile
con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti previsti dalla legge
regionale».
Secondo
Pertanto, «le limitazioni
all’attività libero-professionale, oltre a non essere assolute, perché operanti
solo nel territorio della USL presso la quale il veterinario svolge il suo
servizio […] appaiono connesse all’esigenza di garantire che non siano
compromesse le finalità istituzionali nel settore della assistenza e della
vigilanza zooiatrica che
Con riferimento all’attività
professionale notarile,
La decisione si inscrive nel solco
dei numerosi precedenti con i quali è stata affrontata la medesima questione:
in ciascuno di essi
Nel caso in esame, i giudici
costituzionali hanno, altresì, rimarcato che, «contrariamente a quanto
sostenuto dal giudice a quo, la
misura irrisoria delle sanzioni pecuniarie non equivale a trasformare il
procedimento disciplinare in una “farsa”, perché esso reca in sé comunque un
notevole grado di afflittività».
Secondo
Un ulteriore profilo riconducibile
alla tutela del lavoro, sub specie di
diritto all’ottenimento di qualifiche professionali, è quello affrontato nella
sentenza n.
Il remittente sosteneva che la norma
censurata, in quanto dotata di efficacia retroattiva, fosse lesiva dell’affidamento
nella equipollenza ai diplomi universitari dei diplomi non universitari
rilasciati da istituzioni diverse in determinate situazioni o in possesso di
soggetti parti di rapporti di lavoro nella qualità di assistenti sociali.
Onde disattendere la cesura,
Nell’intento di ricondurre
nell’ambito dell’istruzione universitaria la formazione degli assistenti
sociali, doveva, dunque, tenersi conto della vicenda sia normativa sia di fatto
che si era svolta, considerando la varietà di origine delle scuole e dei corsi
per assistenti sociali via via istituiti, oltre che da università, anche da
altri enti pubblici, nonché da organizzazioni private. Conseguentemente, il
successivo d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, dopo aver dettato la regola che «il
diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie
costituisce l’unico titolo abilitante per l’esercizio della professione di
assistente sociale» (art. 1), stabiliva l’equipollenza a tale diploma di
diverse situazioni nate nel corso degli anni, attribuendo – in particolare – la
stessa efficacia giuridica: ai diplomi di coloro che erano in servizio, al
momento dell’entrata in vigore della legge, alle dipendenze di amministrazioni
o enti pubblici o vi avevano lavorato per cinque anni (art. 4); ai diplomi,
comunque conseguiti, convalidati entro tre anni – termine poi prorogato per un
anno (d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280) – dalle scuole speciali universitarie (art.
5); ai diplomi rilasciati, fino al completamento dei corsi, agli allievi già
iscritti, da scuole dichiarate idonee con decreto del Ministro della pubblica
istruzione che avrebbe vigilato avvalendosi eventualmente delle università
(art. 6).
La legge 19 novembre 1990, n.
Sulla scorta della ricostruzione
diacronica fornita,
D’altra parte, la riforma
dell’ordinamento universitario, con l’istituzione delle lauree di primo livello
e delle lauree specialistiche, ha ricevuto la sua prima attuazione solo con il
d.m. 3 novembre 1999, n. 509, di talché è evidente che nella normativa
precedente non potessero esservi norme che ad essa facessero riferimento: non
poteva quindi esistere un contesto normativo tale da giustificare l’affidamento
che l’equipollenza di situazioni valesse anche al diverso fine della
considerazione delle situazioni stesse quali titoli abilitanti per il prosieguo
degli studi.
Ora, giacché la disposizione
interpretata da quella oggetto di censura concerneva i diplomi di assistente
sociale come titoli «validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea
specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di
cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica», doveva evidenziarsi la non
omogeneità della finalità (esercizio della professione di assistente sociale)
riguardo alla quale era stata riconosciuta l’equipollenza delle posizioni in
questione al diploma rilasciato in ambito universitario, rispetto a quella
(accesso a corsi di istruzione universitaria superiore) prevista dalla norma
interpretata. D’altra parte, non poteva ritenersi intrinsecamente irragionevole
il fatto che l’accesso ad un corso di laurea specialistica (o ad altri corsi di
istruzione superiore) venisse ristretto a coloro i quali fossero già titolari
di un diploma universitario.
A conclusione della rassegna relativa
alla tutela del lavoro, possono segnalarsi due pronunce – largamente coincidenti
tra loro – che hanno avuto ad oggetto le modalità di accesso alle professioni,
segnatamente attraverso lo svolgimento di concorsi. Trattasi delle ordinanze
nn. 419 e 420, che hanno
dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della
Costituzione, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla luce
dell’interpretazione di detta disposizione fornita dalla giurisprudenza
amministrativa in pronunce, che i rimettenti reputavano «diritto vivente», che
hanno escluso l’obbligo di esplicita motivazione per i giudizi espressi in sede
di valutazione degli esami di abilitazione professionale. La manifesta
inammissibilità era già stata dichiarata per identiche questioni, in quanto
esse si traducevano in un tentativo di ottenere l’avallo a favore di una
determinata interpretazione della disposizione impugnata (ordinanza n. 466 del
2001; altra declaratoria di manifesta inammissibilità era contenuta nella
ordinanza n. 233 del 2001).
A tale impostazione
In materia di previdenza deve essere
ricordata in primo luogo la sentenza n. 191,
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con il
principio di ragionevolezza, dell’art. 9, commi 5, 6 e 7, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che consente di impugnare i provvedimenti
di rettifica adottati dall’INAIL nel vigore dell’art. 55, comma 5, della legge
9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell’Istituto, che ne ammetteva
l’adozione senza limiti di tempo, al fine di far valere retroattivamente la
violazione del termine decadenziale – di dieci anni – introdotto dalla nuova
disciplina. Sul punto
Interessante appare, poi, l’ordinanza
n. 1, relativa al controllo di
legittimità dell’art. 2, terzo comma, del d.P.R.30 giugno 1965, n. 1124,
aggiunto dall’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
censurato, in riferimento agli articoli 3, primo comma e 38, secondo comma,
della Costituzione, nella parte in cui esclude dall’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli infortuni in
itinere in ogni caso di interruzione non necessitata dal normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e non
solo quando l’interruzione determini l’insorgenza di una situazione di rischio
diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative, così
da comportare il venir meno dell’occasione di lavoro prevista dall’art.2. primo
comma, del citato d.P.R..
Nella specie,
Richiamando in toto la precedente
giurisprudenza in materia, la sentenza n.
Sempre in tema previdenziale, debbono
in questa sede essere ricordate due pronunce di illegittimità che hanno
affrontato il profilo dei limiti alla pignorabilità
dei trattamenti pensionistici e di fine rapporto.
La sentenza n.
La seconda pronuncia è la sentenza n.
438, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione,
dell’art. 4 della legge 8 giugno 1996, n. 424, nella parte in cui prevede, per
i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato, la sequestrabilità e la
pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, per crediti da danno
erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall’art. 545 del codice di
procedura civile. Innestandosi nel solco tracciato dal precedente costituito
dalla sentenza n. 225 del 1998,
Sulla connotazione unitaria, per
natura e funzione, delle varie categorie di indennità di fine rapporto si è
espressa anche la sentenza n. 458,
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207,
nella parte in cui non prevede che l’indennità di fine rapporto spettante al
dipendente non di ruolo defunto, in mancanza dei soggetti ivi indicati (ossia
coniuge, figli minorenni e parenti entro il secondo grado se viventi a carico),
si devolva secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa.
Eseguendo un rapido excursus dei numerosi precedenti in materia,
Sempre in tema di previdenza, la
sentenza n.
In tema di trattamento pensionistico
di rilievo appare, altresì, la sentenza n. 281,
con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, in riferimento
all’art. 3 Cost., dell’art. 219, comma quarto, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede che il
beneficio dell’aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni
spetti anche alle dipendenti dimissionarie
delle Ferrovie dello Stato non coniugate e con prole a carico: se,
infatti, «siffatto beneficio previdenziale attribuito alle lavoratrici
coniugate…trova la propria giustificazione […] nel perseguimento del valore
rappresentato dalla essenziale funzione familiare della donna, espressamente
tutelato, nell’ambito dei rapporti di lavoro, dall’art. 37 della Costituzione
[…], l’attribuzione del beneficio alle sole donne coniugate…risulta palesemente
lesiva del principio di eguaglianza, per l’ingiustificata disparità di
trattamento che ne deriva rispetto alla categoria generale delle dipendenti
civili dello Stato, non essendo dubbio che proprio il rapporto di filiazione
costituisca una delle espressioni più significative della funzione familiare
della donna, alla cui tutela la norma è esclusivamente rivolta».
3.
L’autonomia privata e l’iniziativa economica
Piuttosto variegati sono stati gli
interventi attinenti alla libertà di iniziativa economica ed all’autonomia
privata. Si segnalano, in particolare, decisioni relative alla disciplina dei
rapporti contrattuali, a quella degli esercizi commerciali ed ai rapporti
societari.
In materia di trasporto debbono essere ricordate due pronunce, la sentenza n. 199 e la sentenza n. 7, che, per quanto rese su argomenti
affatto differenti quali la responsabilità del vettore nel trasporto marittimo
e la forma del contratto di trasporto di merci per conto terzi, sono tuttavia
accomunate dall’esito della declaratoria di incostituzionalità in parte qua
della norma censurata.
Nel primo caso, ad essere impugnato è
stato l’art. 423, comma primo, del codice della navigazione, ritenuto in
contrasto con l’art. 3 della Costituzione nella parte in cui non esclude il
limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in ipotesi di responsabilità
determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti.
(sentenza n. 199).
Dopo una rapida disamina della
normativa vigente nei settori del trasporto aereo, ferroviario e su strada,
Con la seconda pronuncia (sentenza n.
7),
In parallelo con la pronuncia da
ultimo citata deve essere analizzata la sentenza n. 283 che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 5, secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
censurato, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, nella parte
in cui – nel regime precedente l’entrata in vigore del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61 – prescriveva che il contratto di lavoro a tempo parziale dovesse essere stipulato in forma scritta,
richiesta ad substantiam, e che, in
caso contrario, il contratto fosse nullo, senza possibilità di conversione in contratto
di lavoro a tempo pieno, ha fornito un’interpretazione costituzionalmente
orientata della norma de qua: secondo
In materia locatizia, la sentenza n.
Parimenti, sempre secondo la stessa
pronuncia, deve essere disattesa la censura dell’art. 5, comma 7-bis del
decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 novembre 1995, n. 507, secondo cui il canone di locazione
rideterminato nel 1995 viene aggiornato negli anni successivi in base
all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati accertata dall’ISTAT: infatti, il diverso trattamento in
tema di rivalutazione annuale del canone non è irragionevole e discriminatorio
rispetto al regime degli aggiornamenti del canone nei rapporti di locazione fra
privati, alla luce della maggior durata dei rapporti di locazione degli
immobili di proprietà statale e stante la non omogeneità fra le situazioni
poste a confronto.
Infine, è opportuno in questa sede
ricordare l’ordinanza n. 25, che ha
dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito
nella legge 1 agosto 2002, n. 185, il quale, stabilendo che «avverso il decreto
con cui il giudice dell’esecuzione abbia provveduto in ordine alla sospensione
dell’esecuzione, previa verifica in capo al conduttore dei requisiti richiesti,
è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con
le modalità di cui all’art. 618 del codice di procedura civile», viene
censurato nella parte in cui non prevede che detta opposizione sia proposta
entro il termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ..
La sentenza n.
Da quanto rilevato, se ne è dedotto
che il giudice rimettente, nel denunciare la disparità di trattamento tra
Comuni, aveva omesso di considerare che i criteri dettati dalla norma, non
soltanto non risultavano discriminatori o arbitrari, ma neppure apparivano
improntati ad una intrinseca palese irragionevolezza. Peraltro, il Tribunale
rimettente aveva travalicato in apprezzamenti che sconfinavano nel merito delle
opzioni legislative, contrapponendo, ai criteri dettati nella norma censurata,
canoni e valutazioni che esulavano, evidentemente, da profili di legittimità
costituzionale.
Con la sentenza n. 481
Il ricorrente ne denunciava il
contrasto sotto vari profili con il principio di eguaglianza del voto (art. 48
Cost.), nonché con le norme statutarie sulla competenza legislativa in materia
elettorale, che non attribuirebbero alla Regione Friuli-Venezia Giulia alcuna
competenza legislativa in materia.
Con sentenza n. 173
In particolare, rinviando per gli
aspetti concernenti la competenza regionale alla trattazione specifica sul
tema, va segnalato che
Quanto al secondo profilo, della
limitazione dell’effettività del diritto di voto mediante l’astensione,
Infine, nel ritenere infondato anche
il terzo profilo di censura prospettato in riferimento all’art. 48 Cost. (con
il quale il rimettente si doleva del fatto che gli elettori residenti
all’estero, qualora si recassero a votare, verrebbero «estromessi dal computo
degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, ma verrebbero
comunque computati nel n. dei votanti, con innalzamento di questo secondo quorum»),
Tale regime, del resto, «trova la sua
giustificazione nell’alto tasso di emigrazione che caratterizza alcune aree
della Regione Friuli-Venezia Giulia, il quale potrebbe determinare il mancato
raggiungimento del quorum richiesto, con conseguente annullamento delle
elezioni e successivo commissariamento del Comune in attesa dell’indizione di
nuove elezioni che peraltro, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 21
aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché
modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14), si possono svolgere
soltanto in un turno unico annuale».
Alle decisioni precipuamente
concernenti i rapporti politici potrebbero ricollegarsi altre statuizioni rese
nel corso del
1.
Le prestazioni patrimoniali
Nel corso del 2005,
Rinviando, per quest’ultimo profilo,
a quanto si dirà infra, cap. III, sez. II, par. 7, deve sottolinearsi
come, nell’affrontare la materia tributaria,
Ciò è particolarmente evidente nella
sentenza n. 303, dove si è negato fondamento al dubbio di
costituzionalità riferito all’art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, che, nel consentire il riordino, mediante regolamento governativo di
delegificazione, della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse
dei cavalli, per quanto atteneva agli aspetti organizzativi, funzionali,
fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi, avrebbe
conferito al Governo, in violazione del principio della riserva relativa di
legge in materia fiscale il potere di individuare i soggetti passivi
dell’imposta concernente le suddette scommesse ed avrebbe perciò omesso di
fissare limiti all’arbitrio dell’autorità governativa.
Nella specie, ha osservato
Con la sentenza n. 66 (v. anche supra sez. I, par. 2)
Al di là di queste affermazioni, di
carattere generale,
1.1.
La disciplina dei tributi
Sono sei le decisioni che è d’uopo
menzionare relativamente a svariati aspetti della disciplina di singoli
tributi.
I giudici rimettenti evocano
essenzialmente il principio di eguaglianza e di proporzionalità del prelievo
alla capacità contributiva in quanto la norma denunciata comporterebbe, a
carico delle banche, degli altri enti e società finanziari e delle imprese di
assicurazione, un maggior prelievo fiscale, a parità di capacità contributiva,
misurata quest’ultima secondo il valore aggiunto prodotto dalle attività
autonomamente organizzate, a sua volta calcolato – al fine di ottenere una base
imponibile confrontabile tra i vari settori e le varie attività produttive –
con regole diverse stabilite dal legislatore in relazione al tipo di attività.
Il tutto, senza che ricorrano transitorie esigenze di gradualità nel passaggio
dal regime fiscale anteriore all’istituzione dell’Irap a quello successivo. Queste, infatti, sarebbero già
soddisfatte dall’art. 45, commi da
Le censure, in sostanza, muovono dal
presupposto per cui la struttura dell’Irap
esigerebbe, per intrinseca necessità logica e normativa, l’unicità
dell’aliquota da applicarsi all’imponibile, data la confrontabilità,
nell’ambito di tutto il settore privato, della misura del valore aggiunto
prodotto, con la conseguenza della irragionevolezza di qualsiasi
differenziazione, anche transitoria, di aliquote per settori e, quindi, della
violazione del principio di capacità contributiva.
A regime, tale discrezionalità è
esercitata dalle Regioni entro limiti prefissati ed a partire da una certa
data, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 446 del
Con riferimento alla prima
applicazione del tributo, tali ragioni trovano il loro specifico fondamento nel
carattere dell’Irap di tributo
sostitutivo di altri tributi e prestazioni imposte e, quindi, nel ragionevole
intento del legislatore delegato di garantire una certa continuità tra il
precedente e il nuovo regime, soprattutto in termini redistributivi e di
gettito.
L’aumento provvisorio e calibrato
delle aliquote per i settori bancario, finanziario e assicurativo è dunque
pienamente giustificato, essendo esso la conseguenza, da una parte, della
valutazione circa il minore impatto del nuovo tributo sui detti settori e,
dall’altra, di una scelta di politica redistributiva volta ad assicurare, in
ragione del carattere surrogatorio del tributo, la continuità del prelievo e ad
evitare, quindi, possibili divergenze tra la precedente ripartizione del carico
fiscale e quella che si sarebbe verificata ove nella fase di prima applicazione
si fosse adottata una aliquota unica e indifferenziata per tutti i settori
produttivi del comparto privato. Ciò tanto più vale se si considera che la
discrezionalità del legislatore è particolarmente ampia quando trattasi di
dettare disposizioni transitorie (v., ex plurimis, le ordinanze n. 131
del 1988 e n. 66 del 1994).
Viene, infine, ricordata l’ordinanza
n. 426 del
Altra censura prospettata dai
rimettenti è quella relativa al citato art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del
1997, per violazione del principio della generalità dell’obbligo contributivo,
perché, con la norma denunciata, a parità di gettito complessivo dell’imposta
nel settore privato, il minor gettito derivante dall’applicazione, in favore
dei soggetti operanti nel settore agricolo e delle cooperative della piccola
pesca e loro consorzi, di un’aliquota inferiore a quella ordinaria del settore
privato, comporterebbe l’attribuzione esclusivamente ai soggetti di cui agli
articoli 6 e 7 dello stesso d.lgs. del peso della copertura finanziaria della
predetta agevolazione.
Ad avviso della Corte, tale lettura
del principio di generalità dell’obbligo di concorrere alle spese pubbliche è
erronea, perché non considera il necessario collegamento con la capacità
contributiva postulato dallo stesso art. 53, primo comma, della Costituzione e
perché, di conseguenza, impedirebbe ogni politica redistributiva del carico
fiscale, ogni differenziazione di aliquote ed ogni agevolazione, pur se
rispettose dei principî di eguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva.
A parte ciò, l’erroneità di quanto
presupposto dai rimettenti è dimostrata non solo dall’autonomia delle ragioni
giustificatrici della differenziazione delle aliquote di ciascun settore
(neutralizzazione sia del maggiore impatto del nuovo tributo sui settori
agricolo e della piccola pesca, sia del minore impatto sui settori bancario,
finanziario ed assicurativo), ma anche dalla diversa durata dei periodi
transitori previsti per i menzionati settori. Non v’è, perciò, alcuna
correlazione biunivoca tra il differenziale virtuale di gettito complessivo nei
settori ad aliquota agevolata ed il differenziale virtuale di gettito
complessivo nei settori ad aliquota maggiorata.
Va dunque esclusa qualsiasi lesione
del principio dell’obbligo di tutti di concorrere alle spese pubbliche in ragione
della propria capacità contributiva.
Di altro tenore è la seconda
decisione rilevante, e cioè l’ordinanza n. 23, che si sofferma, in
particolare, sui limiti che incontra la discrezionalità del legislatore. Vi si
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36, nella parte in cui prevede
che, nel caso di atti traslativi di terreni agricoli stipulati a titolo oneroso
da soggetti non imprenditori agricoli, l’imposta di registro si applichi con
l’aliquota del 15% anziché con quella dell’8% prevista dall’articolo 1 della
suddetta tariffa per gli imprenditori agricoli. Per respingere la denunciata
lesione del principio di uguaglianza, del principio della capacità
contributiva, del diritto di accesso alla proprietà privata è sufficiente, alla
Corte, richiamare le stesse ragioni per le quali è stata già dichiarata, con
ordinanza n. 449 del 1998, manifestamente infondata la analoga questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della tariffa, parte
prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sul rilievo che sono rimesse
alla discrezionalità del legislatore sia l’individuazione delle situazioni
significative della capacità contributiva sia la determinazione dell’entità
dell’onere tributario, con il limite della non arbitrarietà o irrazionalità
della scelta legislativa, non superato nel caso di specie.
Altra decisione da segnalare è la
sentenza n. 225, che dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 32, primo comma, n. 2), del d. P. R. 29 settembre
1973, n. 600, nella parte in cui prevede che i prelevamenti effettuati
nell’ambito dei rapporti bancari siano posti, come ricavi, a base delle
rettifiche ed accertamenti dell’amministrazione finanziaria, se il contribuente
non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle
scritture contabili. Il rimettente muove, infatti, dall’apodittico assunto
della non deducibilità delle componenti negative dal maggior reddito d’impresa accertato
in base alla norma impugnata, assunto smentito dalla più recente giurisprudenza
di legittimità, secondo cui, in caso di accertamento induttivo, si deve tenere
conto – in ossequio al principio di capacità contributiva – non solo dei
maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che
vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati: così
interpretata, la norma si sottrae alla censura di violazione dell’art. 53
Cost., risolvendosi, quanto alla destinazione dei prelievi non risultanti dalle
scritture contabili, in una presunzione di ricavi iuris tantum
(suscettibile, cioè, di prova contraria attraverso la indicazione del
beneficiario dei prelievi), non lesiva del principio di ragionevolezza, non
essendo manifestamente arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai
conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati
all’esercizio dell’attività d’impresa e siano, quindi, in definitiva, detratti
i relativi costi, considerati in termini di reddito imponibile. Neppure è,
infine, violato il principio di eguaglianza in danno dei titolari di conti
bancari, essendo la disponibilità di tali conti elemento idoneo a legittimare
il rilievo meramente probatorio attribuito al prelievo non giustificato di
somme.
Con la sentenza n. 280, poi,
Nel ribadire tale principio,
Peraltro, essendo del tutto ovvio che
alla Corte è preclusa la possibilità di determinare essa tale termine,
competendo la sua individuazione alla ragionevole discrezionalità del
legislatore, la pronuncia di illegittimità costituzionale rende indispensabile
un sollecito intervento legislativo con il quale si colmi ragionevolmente la
lacuna che si va a creare. Ma
Infine, due decisioni hanno avuto
riguardo alla disciplina fiscale delle aziende faunistico-venatorie.
Nella sentenza n. 110 si
decide la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto
legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella parte in cui dispone, al n. 16 della
tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, che per «le aziende
faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di
lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa».
Nella sentenza n. 266, invece,
si evidenzia che, dalla lettura coordinata della norma di delega (art. 3, comma
1, della legge n. 281 del 1970, nel testo sostituito dall’art. 4 della legge n.
158 del 1990) e di quella oggetto di censura, emanata in sua attuazione (n.
d’ordine 16 della tariffa approvata con decreto legislativo n. 230 del 1991),
non emerge alcun elemento idoneo a porre una distinzione tra tassa e
soprattassa ed a rendere quest’ultima qualificabile come tributo distinto,
unici essendo per ambedue i prelievi sia il presupposto dell’imposizione
(concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria), sia l’ente
impositore (Regione), sia il soggetto passivo della prestazione
(concessionario), sia, infine, la modalità di riscossione (versamento
contestuale di tassa e soprattassa), costituendo la soprattassa, nonostante il nomen
iuris, solo un maggiore importo della tassa stessa, con specifica salvezza
dello specifico vincolo quantitativo imposto dal comma 2, lettera c), dello stesso art. 3 della legge n.
281 del 1970. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, della nota al n.
d’ordine 16 della tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n.
230, nella parte in cui dispone che, per le aziende faunistico-venatorie, per
ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere
versata contestualmente alla tassa.
Con riferimento alle discipline
attinenti ai benefici fiscali, si segnalano quattro decisioni.
Ricorda
Il legislatore, proprio al fine di
superare un oneroso contenzioso, ha scelto, con la legge n. 342 del 2000, la
soluzione alla quale era pervenuta la giurisprudenza di legittimità stabilendo
che «i fondi pubblici di agevolazione […] devono intendersi riconducibili
nell’ambito applicativo dell’articolo 88, comma 1».
Sia il testo della norma sia lo scopo
dalla stessa perseguito di risolvere le incertezze interpretative sorte in
passato sul trattamento tributario dei fondi di agevolazione, non consentono di
dubitare sul carattere interpretativo della norma de qua peraltro
espressamente affermato sia dai citati lavori preparatori che dalla stessa
amministrazione finanziaria.
Stante, dunque, l’indubbia efficacia
retroattiva della prima parte della norma impugnata, la funzione del secondo
periodo è con evidenza quella di limitare gli effetti economico-finanziari di
tale retroattività, escludendo la ripetibilità delle imposte già
(indebitamente) pagate.
Ma proprio siffatta limitazione si
pone in palese contrasto con il parametro costituzionale evocato dalla Corte
rimettente. L’intrinseca contraddittorietà della disposizione si riflette del
resto in una palese violazione del principio di eguaglianza per disparità di
trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, venendo a riservarsi un
trattamento deteriore a chi abbia erroneamente pagato un’imposta non dovuta
rispetto a chi, versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato
alcun pagamento. Di conseguenza, viene dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nella parte
in cui dispone che «non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate».
Affermazioni di ordine generale sono
contenute soprattutto nella sentenza n. 275. Con essa si dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi primo,
secondo e terzo, del decreto legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, nella parte in cui dispone
che non si applica ai soggetti non residenti, né domiciliati, né aventi sede
nei territori dei Comuni colpiti dal sisma il beneficio fiscale di cui all’art.
10 del decreto legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, secondo il quale, per l’anno 1980, sono
esclusi dall’ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai
fini dell’IRPEF e dell’IRPEG i redditi percepiti da soggetti danneggiati dagli
eventi sismici e prodotti nei Comuni disastrati o danneggiati dal sisma.
Il rimettente basa essenzialmente la
propria censura di irragionevolezza delle norme denunciate sulla
contraddittorietà di queste rispetto alla ratio delle provvidenze di cui
all’art. 10 del decreto legge n. 799 del 1980 per il fatto che le norme
sopravvenute, limitando l’applicazione del beneficio ai soggetti danneggiati
residenti o domiciliati nei territori colpiti dagli eventi sismici, contrastano
con l’originario intento del legislatore di attribuire in via generale il
beneficio stesso a tutti i danneggiati dal sisma, ovunque abbiano residenza,
domicilio o sede.
Il giudice a quo omette, però,
di considerare che le denunciate norme modificatrici debbono valutarsi in
riferimento alla loro ratio e non a quella della norma da esse
modificata. E, a tal fine, occorre tener conto del combinato disposto della
norma attributiva del beneficio e delle successive norme che la limitano,
vagliandone la legittimità costituzionale in coerenza con il costante
orientamento di questa Corte, secondo cui «le disposizioni legislative che
prevedono agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne
siano le finalità, hanno di norma carattere derogatorio e costituiscono il
frutto di scelte del legislatore soggette a controllo di costituzionalità nei
limiti della palese arbitrarietà od irrazionalità» (v., ex plurimis,
sentenze n. 346 del 2003 e n. 431 del 1997).
Su questa base normativa, non appare
manifestamente irragionevole ritenere che i soggetti danneggiati, che hanno
residenza, domicilio o sede nell’area colpita dal sisma ed ivi svolgano la loro
attività, abbiano subìto un pregiudizio complessivo maggiore rispetto agli
altri danneggiati e, in relazione a tale circostanza, siano meritevoli essi
soli del menzionato beneficio fiscale. È conseguentemente precluso a questa
Corte estendere a soggetti diversi da quelli indicati dalle norme denunciate
l’àmbito di applicazione del suddetto beneficio fiscale (v., ex plurimis,
in applicazione di analoghi principî, le ordinanze n. 27 del 2001 e n. 10 del
1999).
Da notare è anche la decisione di
manifesta infondatezza, contenuta nell’ordinanza n. 181, concernente
l’art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, denunciata nella parte non prevede
anche l’esenzione dall’Iva, oltre
che dall’imposta di registro, per gli acquisti, da parte delle organizzazioni
di volontariato, di beni immobili da utilizzare per lo svolgimento delle loro
attività. Il rimettente ravvisa una irragionevole disparità di trattamento, con
conseguente violazione del principio di capacità contributiva, nel fatto che la
norma impugnata, non esentando dall’Iva
gli atti connessi allo svolgimento delle attività proprie delle organizzazioni
di volontariato, di fatto condizioni la concessione dell’agevolazione fiscale,
nel caso di acquisto di beni immobili, alla circostanza – del tutto estranea
alla ratio dell’agevolazione – che il venditore sia o meno assoggettato
all’Iva.
Ad avviso della Corte, siffatta
prospettazione, fondata sulla mera considerazione del peso economico del
tributo, non tiene tuttavia alcun conto del fatto che mentre soggetti passivi
dell’imposta di registro sono tutte le parti contraenti, trattandosi di imposta
applicata all’atto, all’Iva sono
invece assoggettati coloro che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi imponibili con obbligo di rivalsa nei confronti del cessionario o
del committente. Appare, perciò, coerente con tale differenziazione che
un’esenzione fiscale disposta in considerazione dell’attività svolta da
determinati soggetti (le organizzazioni di volontariato) riguardi
esclusivamente l’imposta di registro gravante sugli atti da questi compiuti e
l’Iva relativa alle prestazioni
dai medesimi eseguite, ma non anche, in caso di acquisto di beni, l’imposta sul
valore aggiunto cui è assoggettato altro contribuente, cioè il cedente, il
quale svolge un’attività diversa da quella considerata dalla norma di
esenzione.
Infine, con specifico riguardo
all’incentivazione dell’attività agricola, l’ordinanza n. 87 dichiara la
manifesta infondatezza della questione di costituzionalità avente ad oggetto
l’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella
parte in cui, prevedendo che, ai fini dei benefici d’imposta sui terreni
agricoli, si considerano coltivatori diretti a titolo principale «le persone
fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali e soggette al corrispondente
obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia», esclude che
della norma agevolativa possano giovarsi coloro che siano cancellati dai
suddetti elenchi a seguito del conseguimento della pensione.
Tre ordinanze riguardano fenomeni di
regolarizzazione di illegittimità concernenti la corresponsione di tributi.
L’evocazione a parametro dell’art.
53, primo comma, della Costituzione, concernente la disciplina sostanziale dei
tributi, è, poi, non pertinente, riguardando la denunciata normativa sul
condono la disciplina della definizione delle pendenze tributarie.
La ordinanza n. 340 si
pronuncia nel senso della manifesta infondatezza delle questioni concernenti
gli articoli 9, commi 9 e 10, e 15, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, per le parti riguardanti gli effetti del condono nella materia tributaria.
Il giudice a quo, infatti, muove da un erroneo presupposto
interpretativo, ritenendo che il perfezionamento del condono precluderebbe
all’amministrazione finanziaria la possibilità di effettuare accertamenti
tributari per contestare la debenza del rimborso e renderebbe incontestabili le
somme richieste dai contribuenti quale rimborso dell’Iva anche nella ipotesi in cui il rimborso si basi sulla
fatturazione di operazioni inesistenti e l’importo dell’Iva non sia mai stato versato. Invero, dalla semplice lettura
delle norme denunciate, dalla natura del condono, nonché dalla giurisprudenza
di legittimità, emerge un esito interpretativo diverso, vale a dire che le
disposizioni censurate vanno intese nel senso che il condono non influisce di
per sé sull’ammontare delle somme chieste a rimborso, non impone al
contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all’erario di accogliere
tali richieste, allorché la pretesa al rimborso sia riscontrata fondata; non
impedisce l’accertamento dell’inesistenza dei crediti posti a base delle
richieste di rimborso, data la natura propria del condono, che incide sui
debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti; mentre, infine,
nell’ipotesi di operazioni inesistenti, le disposizioni censurate non impongono
affatto all’erario di procedere al rimborso, nel casi di intervenuto condono
fiscale, né inibiscono accertamenti diretti a dimostrare l’inesistenza
dell’invocato diritto al rimborso.
Infine, secondo il decisum
dell’ordinanza n. 305, è manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
modificato dall’art. 5-bis del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e
dell’art. 1, comma 2-decies, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212,
nella parte in cui consentono l’applicabilità del condono fiscale anche alle
pene pecuniarie. Rileva, a tal proposito,
Nell’ambito di un giudizio in via
principale avente ad oggetto leggi regionali sul servizio civile,
Al riguardo,
Inoltre, nell’esercizio delle
funzioni amministrative spettanti agli organi centrali, deve essere garantita
la partecipazione degli altri livelli di governo coinvolti, attraverso
strumenti di leale collaborazione, nonché la possibilità per le Regioni e le
Province autonome di istituire e disciplinare, nell’autonomo esercizio delle
proprie competenze legislative, un proprio servizio civile regionale o
provinciale, distinto da quello nazionale, in attuazione del principio di
solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione.
La tutela dei diritti nella giurisdizione
La giurisprudenza costituzionale sul
procedimento civile si è arricchita, nel corso del 2005, di numerose
statuizioni, che hanno coperto molteplici ambiti e diversi tipi di
procedimento.
Fra le numerose pronunce di rilievo
emesse nel corso dell’anno
Sempre in tema di notificazioni altra
pronuncia di rilievo è la sentenza n. 480,
che ha dichiarato non fondata, nei sensi specificati in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 480, comma terzo, del codice
di procedura civile, contestato, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo
comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui consentirebbe al debitore –
qualora il creditore precettante abbia dichiarato la sua residenza o eletto
domicilio in un luogo nel quale non si trovano cose del debitore da sottoporre
ad esecuzione forzata – non solo di proporre opposizione a precetto davanti al
giudice del luogo di notifica del precetto, ma anche di notificare l’atto di
opposizione presso la cancelleria di tale giudice.
Di pari interesse appare la sentenza
n. 441, pronunciata in materia di
giudizio di ottemperanza, con la quale
1.2.
Introduzione del giudizio e competenza
Numerosi sono stati i casi in cui
Così, l’ordinanza n.
Che il simultanues processus non sia oggetto di garanzia costituzionale è
stato, altresì, ribadito nell’ordinanza n. 215,
nella quale è stata affrontata la questione di legittimità dell’art. 268,
secondo comma, del codice di procedura civile, che, secondo il tribunale
rimettente, violerebbe gli articoli 24, 111 e 3 della Costituzione nella parte
in cui non consente al terzo
interveniente di compiere atti che al momento dell’intervento non sono
più consentiti ad alcuna parte e, in particolare, non consente alle parti,
tutte, in caso di intervento principale o litisconsortile successivo allo
scadere dei termini dell’art. 184 c.p.c., di depositare documenti e indicare
nuovi mezzi di prova rispetto alla domanda formulata con l’atto di intervento.
Nel dichiarare infondata la questione,
In materia di competenza per
territorio merita di essere menzionata anche la sentenza n. 194, con la quale
Infine, la sentenza n.
Nel caso qui in esame,
1.3.
Imparzialità e terzietà del giudice
Nel ribadire la costante
giurisprudenza secondo cui «le leggi non si dichiarano incostituzionali se
esiste la possibilità di dare loro un significato che le renda compatibili con
i precetti costituzionali e ciò assume particolare rilevo qualora, come nella
fattispecie, l’opzione interpretativa che consente tale risultato sia stata
ripetutamente condivisa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione»,
Interessante appare, anche, la
sentenza n. 460 (analizzata più
diffusamente infra), con cui è stata
dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 51,
primo comma, n. 4, del codice di procedura civile, contestato, in riferimento
agli articoli 24 e 111 Cost., laddove non prevede l’obbligo di astensione dal
partecipare al giudizio di opposizione per il magistrato che abbia fatto parte
del collegio che ha deliberato la sentenza dichiarativa di fallimento,
concludendo che «l’obbligo di astensione […] presuppone […] che il procedimento
svolgentesi davanti al medesimo ufficio giudiziario sia solo apparentemente
“bifasico”, mentre in realtà esso – per le caratteristiche decisorie e
potenzialmente definitive del provvedimento che chiude la prima fase e per la
sostanziale identità di valutazioni da compiersi in entrambe le fasi nel
rispetto del principio del contraddittorio, ancorché realizzato con modalità
deformalizzate – si articola in due momenti, il secondo dei quali assume il
valore di vera e propria impugnazione, e acquista, pertanto, i caratteri
essenziali di “altro grado del processo”».
1.4.
Il procedimento di esecuzione forzata
In materia di esecuzione forzata deve
essere ricordata la sentenza n. 379,
che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 567, commi secondo e quarto, del codice di procedura civile,
censurato, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, «nella
parte in cui non prevede che il certificato notarile attestante le risultanze
delle visure catastali e dei registri immobiliari possa ritenersi sostitutivo
soltanto dell’estratto del catasto e di certificati delle iscrizioni e
trascrizioni relative all’immobile pignorato» e «non estende la sanzione di
estinzione per inattività di cui all’art. 630, secondo comma, cod. proc. civ.,
per omesso o ritardato deposito dell’estratto delle mappe censuarie e/o del
certificato di destinazione urbanistica, …da allegare al ricorso contenente
istanza di vendita in caso di tempestivo deposito di completo certificato
notarile sostitutivo».
Sul punto, la sentenza conclude nel senso
della non indispensabilità: «quanto all’estratto delle mappe censuarie,…la
funzione di tale documento, consistente nell’individuazione della dislocazione
del bene sul territorio, non è essenziale in tale fase della procedura, essendo
in essa necessario soltanto stabilire l’appartenenza del bene al debitore e
l’eventuale esistenza di atti, iscritti o trascritti, opponibili alla procedura
esecutiva e destinati ad essere travolti…dal c.d. effetto purgativo della
vendita forzata». Parimenti, «quanto al certificato di destinazione
urbanistica, la intrinseca precarietà di quanto da esso risultante esclude
inequivocabilmente che, in questo stadio della procedura esecutiva, esso sia
indispensabile per la sua prosecuzione».
La questione sollevata viene dichiarata
infondata, «in quanto essa sollecita una pronuncia che, al fine di risolvere
una contraddizione interna dell’art. 567 cod. proc. civ., estenderebbe ad
un’ipotesi (quella in cui il creditore sia ricorso all’opera del notaio) –
ragionevolmente disciplinata, ai fini dell’estinzione – quanto previsto, ma in
contrasto con la ratio di tale istituto, per l’altra ipotesi di
creditore che non si avvalga dell’opera del notaio, laddove anche tale ultima
ipotesi, sulla base di una lettura sistematica della disciplina in questione,
può essere interpretata in modo che – escludendosi la dichiarabilità
dell’estinzione per la mancata produzione dell’estratto delle mappe censuarie e
del certificato di destinazione urbanistica – sia risolto ogni contrasto con i
principî costituzionali».
In sede di decisione di
un’opposizione di terzo all’esecuzione, il Tribunale di Venezia ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli articoli 619, 163, n. 7, 164,
primo comma, 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile per
violazione del disposto dell’art. 3 Cost.. L’ordinanza n.
1.5.
Il giudizio di cassazione
Con la sentenza n. 109
1.6.
Le controversie in materia di circolazione stradale
In materia di circolazione stradale
deve in primis essere menzionata la
sentenza n. 27, che ha ritenuto
illegittimo l’art. 126-bis, comma 2,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 7 del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 nel testo risultante all’esito della
modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella
legge 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: «nel caso di
mancata identificazione [del conducente], la segnalazione [all’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida] debba essere effettuata a carico del
proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta
giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e
della patente del conducente», anziché, «nel caso di mancata identificazione di
questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve
fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente
del conducente al momento della commessa violazione».
Sempre in materia di circolazione
stradale, si registrano altre due sentenze, coeve, in tema di art. 204-bis del
Nuovo codice della strada, la n. 468
e la n. 471. Nel dichiarare
infondata la questione di legittimità del combinato disposto di tale articolo
con l’art. 126-bis, censurato laddove stabilisce che la contestazione si
intende definita con il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta e
il trasgressore può proporre ricorso al giudice di pace solo in quanto non sia
stato effettuato il pagamento, la sentenza n.
Parimenti, la sentenza n.
In materia di trattamento
sanzionatorio conseguente alle infrazioni al Codice della strada, l’ordinanza
n.
Hanno affrontato la disciplina
dettata dal codice della strada, ma analizzandone profili di natura sostanziale, anche l’ordinanza n. 218 e la sentenza n. 66 (quest’ultima già analizzata nelle
parti relative alla libertà di circolazione e alle prestazioni patrimoniali).
Nel primo caso, il giudice a quo, chiamato a pronunciarsi in un
giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto nei
confronti del conducente di motoveicolo cui era stata ascritta l’infrazione di
cui al’art. 141, comma 3, del codice della strada per aver omesso di regolare
la velocità in modo da non costituire pericolo nell’attraversamento di un centro
abitato, dubitava della legittimità del menzionato articolo «nella parte in cui
non è previsto alcun criterio legale di riferimento per la configurabilità
dell’infrazione» de qua.
Con la sent.. n. 66,
1.7.
Le controversie in materia di spese di giustizia
Con le sentenze n. 52 e n. 53 sono state dichiarate non fondate questioni con le quali si
censurava, in riferimento agli articoli 3 e 76 Cost., l’attribuzione
all’ufficio giudiziario in composizione monocratica anziché collegiale della
competenza a decidere rispettivamente sulle opposizioni ai provvedimenti di
rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero di
revoca del decreto di ammissione già accordato (art. 99, comma 3, del decreto
legislativo n. 113 del 2002), nonché sulle opposizioni ai decreti di
liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato (art. 170 del medesimo
decreto legislativo).
Nella sentenza n. 52
Delicati problemi connessi al
rispetto dei principî e criteri direttivi fissati nella legge-delega in materia
sono stati affrontati anche nella sentenza n.
Con riferimento all’asserito
contrasto delle norme delegate con i criteri e i principî direttivi posti dalla
legge delega (in particolare, per aver disciplinato la procedura di
restituzione non compresa nelle materie della delega)
Nel rigettare le censure formulate in
riferimento agli articoli 3 e 97 Cost.
In materia di procedure concorsuali
merita di essere segnalata la sentenza n. 301,
che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli articoli 82, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
censurato nella parte in cui consente che la dichiarazione giudiziale dello
stato di insolvenza successiva al decreto di sottoposizione a liquidazione
coatta amministrativa di una banca sia pronunciata dopo un anno dalla data di
emissione del decreto. Non sussiste, infatti, secondo
Non è riscontrabile neppure alcuna intrinseca
irragionevolezza nelle norme de quibus,
che, a differenza di quanto ritenuto dal rimettente, non sono inidonee a
salvaguardare il generale interesse alla certezza delle situazioni giuridiche:
infatti, «se si considera che la società in liquidazione coatta amministrativa
non è cancellata dal registro delle imprese e che l’accertamento della
sussistenza dello stato di insolvenza al momento del decreto di liquidazione
coatta amministrativa ben può essere basato su indagini effettuate dal
commissario liquidatore, appare non irragionevole la scelta del legislatore di
consentire, durante la pendenza della procedura di liquidazione coatta
amministrativa, l’emissione, senza limiti di tempo, di una sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza».
Deve in questa sede essere menzionata
anche la già citata sentenza n. 460,
con la quale
La giurisprudenza costituzionale del
2005 nel settore del processo penale è stata contrassegnata da tre importanti
decisioni: le sentenze n. 299 e n.
E’ importante segnalare che anche in
materia penale
Il principio della ragionevole durata
del processo, espressamente sancito nell’art. 111, secondo comma, della
Costituzione, può essere vulnerato «solamente» da «norme procedurali che
comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica
esigenza, non essendo in altro modo definibile la durata ragionevole del
processo se non in funzione della ragionevolezza degli adempimenti che ne
scandiscono il corso e ne determinano i tempi». E’ quanto ha affermato
Il rimettente si doleva di dover
rinviare il processo ad una successiva udienza, al fine di non incorrere nella
nullità prevista ai sensi dell’art. 178, lettera c), del codice di procedura penale, avendo constatato l’assenza del
difensore dell’imputato e la mancanza di altro avvocato iscritto all’albo.
Per un richiamo al principio della
ragionevole durata del processo in relazione a possibili epiloghi regressivi
del procedimento penale si segnala, invece, l’ordinanza n. 236 nella quale
Sui principî del contraddittorio e
della parità tra le parti, di cui al secondo comma dell’art. 111 della
Costituzione, va menzionata invece l’ordinanza n.
Il difensore dell’imputato aveva
depositato nel corso dell’udienza preliminare il fascicolo delle investigazioni
difensive, contenente il verbale dell’assunzione delle dichiarazioni rese da un
teste, e aveva contestualmente chiesto il rito abbreviato. Il giudice per le
indagini preliminari, su eccezione del pubblico ministero che lamentava di
essere in tal modo privato della possibilità di controesaminare il teste,
sollevava quindi questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma
5, del codice di procedura penale per contrasto con l’art. 111, secondo comma,
della Costituzione.
Nell’ordinanza n. 307
Secondo
Infine nell’ordinanza n. 137 si ribadisce, in linea con altri
precedenti in termini, che l’art. 111, quinto comma, della Costituzione,
nell’individuare «una deroga al principio della formazione della prova in
contraddittorio “per effetto di provata condotta illecita”, (ha) inteso
riferirsi alle sole “condotte illecite” poste in essere “sul” dichiarante
(quali la violenza, la minaccia o la subornazione), e non anche a quelle
realizzate “dal” dichiarante stesso in occasione dell’esame in contraddittorio
(quale, principalmente, la falsa testimonianza): e ciò alla luce sia della ratio
del precetto costituzionale, che del suo necessario coordinamento con la
previsione del secondo periodo del quarto comma del medesimo art. 111, che
immediatamente lo precede».
La questione di costituzionalità,
concernente l’art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, era stata
sollevata sul presupposto che gli articoli 3 e 111, quinto comma, della
Costituzione imporrebbero di equiparare, in relazione al regime della
acquisizione al fascicolo del dibattimento, le dichiarazioni rese nel corso
delle indagini preliminari dal testimone che in dibattimento risulti sottoposto
a violenza, minaccia o subornazione, a quelle rese da chi in dibattimento
scelga liberamente di deporre il falso o di tacere.
La disciplina delle indagini
preliminari è stata oggetto di scrutinio di costituzionalità sotto il
particolare aspetto delle conseguenze che derivano in punto di utilizzabilità
degli atti di indagine dalla ritardata iscrizione della persona indagata nel
registro delle notizie di reato. Questioni analoghe erano già state sottoposte
all’esame della Corte, ma non decise nel merito per ragioni processuali
(ordinanze n. 94 del 1998, 337 del 1996, n. 477 del 1994).
I dubbi di legittimità investivano
detta disciplina sotto il duplice profilo: a) della mancata previsione della
inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti nei confronti di un
determinato soggetto dopo che è emersa la sua qualità di persona sottoposta
alle indagini, ma prima della formale iscrizione del suo nominativo nel
registro delle notizie di reato (cioè degli atti che si collocano temporalmente
«a monte» della iscrizione nel registro e quindi del termine delle indagini);
b) della mancata previsione della inutilizzabilità degli atti investigativi
compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini, computato a partire dal
momento in cui l’iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata (ovvero degli atti
che si collocano temporalmente «a valle» della scadenza di tale termine).
Secondo i rimettenti, dalla ritardata
iscrizione, non sanzionata dalla inutilizzabilità degli atti, sarebbero
derivate nell’uno e nell’altro caso la violazione del principio di uguaglianza
e del diritto di difesa, nonché la compromissione del diritto dell’imputato ad
essere messo in condizione di conoscere tempestivamente l’esistenza di indagini
a suo carico e a vedersi garantita una ragionevole durata del processo.
Nella prima decisione,
Nella seconda ordinanza
Del pari insussistente è stata, di
conseguenza, ritenuta la denunciata disparità di trattamento fra indagati
(tempestivamente o tardivamente iscritti) perché nell’ipotesi in cui il
pubblico ministero procrastini indebitamente l’iscrizione nel registro, il
problema che può porsi, secondo
Infine
Sempre sul versante delle garanzie da
assicurare alla persona che riveste sostanzialmente la qualità di indagato,
Nell’ordinanza si ribadisce che
l’art. 415, comma 2, cod. proc. pen. espressamente prevede che il giudice «se
ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il
nome di questa sia iscritta nel registro delle notizie di reato», sicché, a
prescindere dal «tipo» di archiviazione richiesta dal pubblico ministero,
spetta in ogni caso al giudice il potere – ove nel procedimento non figurino
persone formalmente sottoposte alle indagini – di disporre, nella ipotesi in
cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, l’iscrizione,
nel registro delle notizie di reato, del nominativo del soggetto cui il reato
sia a quel momento da attribuire.
Alla disciplina della chiusura delle
indagini preliminari si riferisce invece l’ordinanza n. 452, con la quale sono state decise nel senso della manifesta
inammissibilità e della manifesta infondatezza tre diverse questioni di
costituzionalità.
Con la prima questione veniva
denunciata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione,
l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 415-bis
e 416, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui tali norme
«non esplicitano», rispettivamente, né l’obbligo, a carico del pubblico
ministero, di non esercitare l’azione penale mediante deposito della richiesta
di rinvio a giudizio prima del compiuto decorso del termine di venti giorni di
effettivo ed integrale deposito degli atti di indagine espletati a far data
dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., né la sanzione di
nullità per tale inadempienza.
Nel prospettare la questione il
giudice per le indagini preliminari rimettente muoveva dall’asserita esistenza
di un «diritto vivente», in forza del quale non risulterebbe configurabile
alcuna nullità per l’ipotesi di richiesta di rinvio a giudizio inoltrata
dall’organo dell’accusa prima del compimento effettivo del termine di deposito
degli atti.
Di qui la manifesta inammissibilità
della questione, avendo il rimettente omesso di esercitare «tutti i poteri
interpretativi che la legge gli riconosce», onde pervenire ad una lettura
costituzionalmente orientata della disciplina censurata.
Lo stesso rimettente aveva sollevato
poi due questioni concernenti l’art. 418 cod. proc. pen., nella parte in cui
non prevede un preliminare vaglio di «validità, diretta o derivata, della
richiesta di rinvio a giudizio», nonché nella parte in cui non prevede, in
presenza di una richiesta di rinvio a giudizio formalmente valida, un «vaglio
di preliminare di ammissibilità» della medesima, lamentando per un verso l’irragionevolezza
della obbligatoria fissazione dell’udienza preliminare pur in presenza di una
richiesta di rinvio a giudizio affetta da nullità rilevabile d’ufficio e, per
altro verso, sia la violazione del principio di ragionevole durata del
processo, sia l’elusione del principio di soggezione del giudice solo alla
legge, risultando impedita la declaratoria immediata di tali patologie in capo
al giudice.
Con riferimento in particolare alla
asserita violazione dell’art. 111 Cost. si sottolinea nell’ordinanza che «il
meccanismo invocato in via additiva dal rimettente, oltre a non costituire
scelta costituzionalmente obbligata, non può ritenersi soluzione destinata a
produrre sempre e comunque effetti acceleratori, comportando infatti, in ogni
caso, un epilogo regressivo del procedimento, a prescindere dai diversi esiti
suscettibili di derivare dal contraddittorio».
Tre sono state le pronunce nell’anno
considerato in tema di custodia cautelare su altrettanti aspetti di estremo
interesse: l’interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia
cautelare (ordinanza n. 230), il
computo dei termini massimi di fase di custodia cautelare in caso di regresso
del procedimento (sentenza n. 299),
il divieto di contestazioni a catena (sentenza n. 408).
Rinviando per la trattazione
specifica delle sentenze n. 299 e 408 alla parte relativa alla libertà
personale, si rammenta in questa sede che in dette pronunce viene in rilievo la
garanzia sancita dall’art. 13, quinto comma, Cost. in ordine ai limiti massimi
di durata della custodia cautelare e che, in particolare, con la sentenza n. 299 è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, nella
parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase
determinati dall’art. 304, comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia
cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il
procedimento è regredito, e con la sentenza n. 408 è stata invece dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 297, terzo comma, del medesimo codice, nella parte in cui non si
applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per
emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della
emissione della precedenza ordinanza.
Con la questione decisa con
l’ordinanza n. 230 veniva invece
prospettata la violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.
Nel profilare la quaestio il giudice a quo
riteneva estensibile anche alla fase dibattimentale la ratio posta a fondamento delle declaratorie di incostituzionalità
con cui l’obbligo di procedere all’interrogatorio dell’imputato in vinculis entro cinque giorni
dall’esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura carceraria –
originariamente previsto solo nel corso delle indagini preliminari – era stato
dapprima esteso fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento
(sentenza n. 77 del 1997) e, di seguito, fino all’apertura del dibattimento
(sentenza n. 32 del 1999).
Sulla base di tale premessa il
rimettente censurava, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, gli articoli 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevedono l’obbligo dell’interrogatorio di garanzia
della persona in stato di custodia cautelare anche dopo la dichiarazione di
apertura del dibattimento.
2.4.
Le intercettazioni telefoniche
Nella sentenza n. 163
Con la sentenza n. 63
In considerazione della «varietà
possibile di situazioni», l’apprezzamento in concreto delle condizioni e delle
circostanze che impongano o consiglino il ricorso, anche nel caso dell’infermo
di mente, alle modalità previste dal legislatore nel caso di testimonianza del
minore o del minore infrasedicenne deve, secondo
2.6.
L’assenza e la contumacia dell’imputato
In concomitanza con il recente
decreto legge n. 17 del 2005 (Disposizioni urgenti in materia di impugnazione
delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna), convertito nella legge
20 aprile 2005, n. 60, emanato a seguito della sentenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo Affaire Sejdovic c.
Italie,
Nel lontano precedente espressamente
richiamato (sentenza n. 18 del 1976), con cui era stata ritenuta esente da vizi
di costituzionalità in relazione al dibattimento l’omologa norma del codice di
procedura penale del 1930,
Quanto alla diversa (e più ampia)
garanzia prevista in favore dell’imputato assente in relazione al rito
abbreviato,
Nella giurisprudenza della Corte è
prevalso anche in passato un orientamento di favore nei confronti dei riti
speciali; le numerose decisioni sui riti alternativi al dibattimento hanno in
genere confermato le esigenze di semplificazione e di rapidità che ispirano le
varie forme di definizione anticipata del procedimento e nello stesso tempo le
giustificano sul piano costituzionale, sempre che risultino rispettate le
garanzie essenziali del giusto processo.
In questa direzione, nell’anno preso
in considerazione, significativa appare l’ordinanza n. 57 nella quale
Più direttamente incentrata sul
sistema degli avvertimenti all’imputato sulla facoltà di chiedere i riti
alternativi è invece la questione decisa con ordinanza n. 309 nel senso della manifesta infondatezza. Oggetto della questione
è l’art. 419, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che
l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare debba contenere, a pena di
nullità, l’avvertimento che l’imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, può
presentare, prima delle conclusioni delle parti, richiesta di giudizio
abbreviato o di applicazione della pena. Il rimettente riteneva ingiustificata
la diversità della disciplina censurata rispetto a quella prevista dall’art.
552, comma 1, lettera f) per il
procedimento a citazione diretta.
Al riguardo si ribadisce, nel solco
di precedenti decisioni, che «l’omessa previsione dell’avvertimento a pena di
nullità circa la facoltà di chiedere i riti alternativi non viola gli articoli
3 e 24 Cost., in quanto, essendo il termine di decadenza posto all’interno di
fasi quali il dibattimento o l’udienza preliminare, l’informazione circa la
facoltà di chiedere i riti è comunque assicurata dalla presenza obbligatoria e
dall’assistenza del difensore».
Secondo
Una interessante questione
concernente il procedimento per decreto e, in particolare, il rispetto del
termine di sei mesi (ritenuto da una consolidata giurisprudenza di legittimità
di natura ordinatoria) per la presentazione della richiesta di decreto penale
di condanna è stata dichiarata manifestamente inammissibile per
indeterminatezza del petitum (ordinanza
n. 188). Il quesito di
costituzionalità riguardava il possibile contrasto tra la corrente
interpretazione della norma sottoposta a scrutinio e il diritto di difesa,
nonché il principio della ragionevole durata del processo e quello del diritto
dell’imputato di essere tempestivamente informato dell’accusa a suo carico di
cui all’art. 111, secondo e terzo comma, Cost.
2.8.
Il procedimento di esecuzione
Con l’ordinanza n. 211
2.9.
Il procedimento davanti al giudice di pace
Le decisioni che hanno avuto ad
oggetto norme che disciplinano il procedimento davanti al giudice di pace,
numericamente inferiori rispetto al 2004, si collocano nel solco delle
precedenti.
Sulla base di tali rilievi di ordine
generale sono state dichiarare manifestamente infondate censure mosse a varie
norme del d.lgs. n. 274 del
Così con l’ordinanza n. 228 (e successivamente con l’ordinanza
n. 312)
In particolare, in riferimento
all’asserita violazione dell’art. 3 Cost.,
Quanto al denunciato eccesso di
delega
Nella medesima direzione si segnalano
le ordinanze n. 85 e n. 415, nonché le ordinanze n. 86 e n. 333, con cui hanno trovato conferma precedenti decisioni di
manifesta infondatezza rese rispettivamente in tema di avviso di conclusione
delle indagini preliminari (art. 415-bis cod. proc. pen.) e di citazione a
giudizio davanti al giudice di pace (sotto il profilo della omessa previsione
dell’avviso all’indagato della possibilità di estinguere il reato attraverso
condotte riparatorie ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000).
In relazione all’aspetto affatto
diverso dei complessi raccordi fra ricorso immediato della persona offesa,
prerogative del pubblico ministero e poteri del giudice adito,
Invero, in un caso almeno il rimettente
palesava di non ritenere praticabili soluzioni diverse, quali la diretta
formulazione dell’imputazione da parte dello stesso giudice di pace, ovvero la
trascrizione dell’«addebito» contenuto nel ricorso, ovvero ancora l’ordine al
pubblico ministero di formulare l’imputazione, in analogia a quanto disposto
dall’art. 17, comma 4, del d.lgs. non 274 del
Manifestamente infondata è stata
invece dichiarata (sempre con l’ordinanza n. 381) una questione di costituzionalità che, pur iscrivendosi
nell’ambito della stessa tematica, assume una propria specifica autonomia per i
delicati problemi di compatibilità che la disciplina del ricorso immediato (nei
suoi aspetti evocativi di una «azione privata»), pone in riferimento all’art.
112 Cost. Il rimettente censurava infatti l’art. 25 del decreto legislativo n.
274 del 2000, sul presupposto che, «in caso di ricorso della persona offesa, il
pubblico ministero sarebbe obbligato a formulare l’imputazione a semplice
richiesta del ricorrente, senza avere la possibilità di svolgere indagini per
valutare i fatti e verificarne la fondatezza, si che gli sarebbe sottratto
“l’effettivo esercizio dell’azione penale”, che avrebbe nel ricorrente l’unico
“dominus”».
In materia di contenzioso tributario
si segnala la sentenza n. 274, che
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 46, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 per contrasto con il principio di
ragionevolezza: la norma, stabilendo che, in caso di estinzione del giudizio
per definizione delle pendenze tributarie o per qualsiasi altra causa di
cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte
che le ha anticipate, rende inoperante il principio, cui è improntato il
processo tributario, di responsabilità per le spese di giudizio, principio in
forza del quale la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese, salvo
il potere di compensazione della commissione tributaria.
Secondo
L’ordinamento della Repubblica
La giurisprudenza costituzionale è
intervenuta su vari aspetti connessi alle funzioni ed alla collocazione nel
sistema del Parlamento e dei parlamentari. L’insieme più cospicuo di decisioni
riguarda la prerogativa dell’insindacabilità delle opinioni espresse da parte
dei parlamentari; non mancano, tuttavia, statuizioni concernenti altri profili.
1.1.
La disciplina dell’elettorato passivo dei parlamentari
Nella sentenza n. 456,
Onde argomentare una siffatta
declaratoria,
1.2.
L’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari
Le pronunce della Corte che nel 2005
hanno deciso conflitti ex art. 68,
primo comma, della Costituzione si inseriscono nel quadro della precedente
giurisprudenza, per lo più nel senso della continuità.
In particolare, nelle sentenze nn. 28 e 164
Il problema se le dichiarazioni rese
da un parlamentare «fuori dell’ambito parlamentare» possano considerarsi
coperte dalla garanzia della insindacabilità, qualora divulghino e riproducano
atti compiuti, nell’esercizio di funzioni parlamentari, da membri del
Parlamento diversi dal loro autore (già risolto in senso negativo dalla
sentenza n. 347 del 2004, peraltro richiamata dalla più recente sentenza n. 164 sopra menzionata), è tornato a
porsi all’attenzione della Corte con riferimento, in particolare, ad atti
tipici posti in essere da altro parlamentare appartenente al medesimo gruppo
(sentenza n. 193) o al medesimo
partito (sentenza n. 235).
Nel conflitto deciso dalla sentenza
n. 193,
La mancanza di una corrispondenza
sostanziale di contenuti ha dunque lasciato impregiudicata la questione in
esame. A conclusioni analoghe è giunta la sentenza n. 235, sia pure, in questo caso, per l’impossibilità di accertare, in
assenza dei resoconti delle audizioni di fronte al Comitato parlamentare per i
servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato indicate dalla
Camera a sostegno dell’insindacabilità, la sostanziale corrispondenza di
contenuti.
In argomento va menzionata, peraltro,
anche la sentenza n. 146, nella quale a venire in rilievo ai
fini della applicabilità del primo comma dell’art. 68 della Costituzione erano,
tra gli altri, anche atti ispettivi
posti in essere dalla persona offesa nel procedimento penale da cui originava
il conflitto:
La sentenza n. 176 si segnala invece sotto due diversi profili.
Per altro verso, invece,
Infine, nella sentenza n. 223,
Secondo
Ne deriva che esse «devono ritenersi
per ciò solo coperte dalla garanzia di insindacabilità prevista dal primo comma
dell’art. 68 della Costituzione, a differenza delle altre dichiarazioni rese extra
moenia da parlamentari al di fuori di una puntuale relazione con il
procedimento di cui al secondo comma dello stesso articolo, che di tale
garanzia possono fruire solo ove ricorrano gli ulteriori requisiti elaborati
dalla giurisprudenza di questa Corte».
Le tematiche concernenti la
prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione sono state
oggetto anche di due giudizi sollevati in via incidentale.
Nel primo, deciso con l’ordinanza n. 136,
si è dichiarata la manifesta infondatezza di questioni identiche a quelle già
dichiarate infondate con la sentenza n. 120 del 2004, con la quale si era
osservato che l’art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, nonostante la più
ampia formulazione lessicale, può considerarsi di attuazione, in quanto
finalizzata a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano
processuale il disposto dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, senza
innovare affatto rispetto alla predetta disposizione costituzionale, ma
limitandosi a rendere esplicito il contenuto della disposizione medesima.
L’ordinanza n.
1.3.
Le immunità previste dal secondo comma dell’art. 68: le intercettazioni
«indirette»
Chiamata a giudicare in un giudizio
in via incidentale, come già con la sentenza n. 120 del 2004, della legittimità
costituzionale della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per
l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi
penali nei confronti delle alte cariche dello Stato),
La questione era stata sollevata
dalla Corte di cassazione che censurava, in riferimento agli articoli 3, 24 e
112 della Costituzione, l’art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e l’art. 7 della legge
n. 140 del 2003.
La norma «a regime» (l’art. 6)
sottoposta a scrutinio di costituzionalità, disciplina le intercettazioni,
effettuate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, di
conversazioni o comunicazioni «alle quali hanno preso parte membri del
Parlamento» («intercettazioni usualmente qualificate come “indirette” o
“casuali”, in quanto si presuppone che la captazione avvenga nella cornice di
un’attività investigativa che non ha ab origine come destinatario il parlamentare»),
stabilendo che il giudice per le indagini preliminari, qualora, su istanza di
una parte processuale e sentite le altre parti, ritenga necessario utilizzare
le intercettazioni in parola, debba richiedere, nei dieci giorni successivi
alla relativa decisione, l’autorizzazione della Camera alla quale il membro del
Parlamento appartiene (o apparteneva al momento in cui le conversazioni o
comunicazioni sono state intercettate), e che, in caso di diniego
dell’autorizzazione, la documentazione delle intercettazioni debba essere
distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla
comunicazione del diniego, e tutti i verbali e le registrazioni di
comunicazioni acquisiti in violazione del disposto dello stesso art. 6 debbano
essere dichiarati inutilizzabili dal giudice, in ogni stato e grado del
processo.
Tuttavia
La collocazione della disciplina
denunciata al di fuori della tutela accordata alla funzione parlamentare
dall’art. 68, comma terzo, della Costituzione, era poi alla base del
prospettato contrasto con gli articoli 3 (per disparità di trattamento sotto
vari profili), 24 (per l’irreparabile pregiudizio del diritto di difesa non
soltanto della parte civile, ma anche dello stesso imputato, avuto riguardo
all’ipotesi in cui le conversazioni intercettate risultassero idonee a
scagionarlo o potessero essere comunque «rilette», a seguito di successive
acquisizioni, in senso a lui favorevole) e 112 (per la compressione
dell’obbligo del pubblico ministero di esercitare l’azione penale che
deriverebbe dall’impossibilità di utilizzare i risultati del mezzo
investigativo in oggetto) della Costituzione.
Il dubbio di costituzionalità si
estendeva anche all’art. 7 della legge n. 140 del 2003, nella parte in cui
rende applicabili le disposizioni dell’art. 6 ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della suddetta legge, allorché – come nel giudizio a
quo – le intercettazioni non siano già state utilizzate in giudizio
In particolare, sotto il primo profilo,
Sotto diverso profilo, inoltre, «il
percorso interpretativo, dal quale l’ordinanza di rimessione deriva il giudizio
di rilevanza, si presenta intrinsecamente contraddittorio rispetto a quello che
sorregge la successiva affermazione della non manifesta infondatezza della
questione». Ed infatti, si sottolinea al riguardo nella sentenza, il giudice
rimettente dapprima motiva la rilevanza della questione «facendo leva su una
interpretazione lata della norma impugnata – quanto alla formula “prendere
parte” – giustificandola essenzialmente con l’esigenza di assicurare una
garanzia piena, e non dimidiata, all’interesse da essa protetto» e sostiene
invece subito dopo la non manifesta infondatezza della stessa «sulla scorta di
una interpretazione restrittiva della norma costituzionale di riferimento»
(art. 68, terzo comma, Cost.).
1.4.
Esercizio della giurisdizione e svolgimento dei lavori parlamentari
Con la sentenza n. 451,
I provvedimenti impugnati sono stati
adottati nell’ambito degli stessi processi penali nel corso dei quali erano
state pronunciate le ordinanze del giudice dell’udienza preliminare annullate,
in accoglimento di un analogo conflitto, con la sentenza n. 225 del 2001 e
concernenti «le medesime situazioni processuali».
Ciò posto e sottolineato che «il
prosieguo del giudizio penale – dopo l’annullamento, da parte di questa Corte,
delle ordinanze del giudice dell’udienza preliminare – sotto nessun profilo può
considerarsi come “giudizio di ottemperanza” del giudicato costituzionale,
ostando a tale configurazione le differenze oggettive e soggettive esistenti
fra il processo costituzionale e quello penale»,
In accoglimento parziale dei ricorsi
Non affette da «vizi rilevabili in
sede di conflitto di attribuzione» sono state invece ritenute le sentenze, in
quanto non contenenti alcuna nuova, autonoma valutazione delle situazioni
oggetto del conflitto, né affermazioni lesive delle prerogative del Parlamento.
In merito alle eventuali conseguenze
processuali dell’annullamento parziale,
Nel corso del 2005, sono state molte
le pronunce che hanno avuto riguardo a profili inerenti alle fonti del diritto,
sia nell’ottica definitoria che in quella della loro collocazione nel sistema.
Limitandosi, in questa sede, alle principali statuizioni, possono passarsi in
rassegna le affermazioni relative alla riserva di legge, alle leggi di
interpretazione autentica ed alle (altre) leggi retroattive, alla delegazione
legislativa, alla decretazione d’urgenza ed alla delegificazione. Altre fonti
sono state prese in considerazione in pronunce sulle quali ci si è soffermati
altrove, donde un doveroso rinvio.
Le questioni concernenti la natura
delle varie riserve di legge contemplate nel testo costituzionale sono trattate
nelle sedes materiae specifiche. Pare
comunque opportuno passare in rassegna, sia pure sinteticamente, le principali
affermazioni rese dalla Corte relativamente ai profili formali e sistematici.
Sono state, in particolare, quattro
le riserve di legge sulle quali
La decisione più significativa a tal
proposito è da individuarsi nella sentenza n. 66. Tra i molteplici parametri tesi a fondare il dubbio di
costituzionalità relativo alle disposizioni che consentono di subordinare la
sosta dei veicoli al pagamento di una somma di denaro, il giudice a quo aveva invocato anche l’art. 16
della Costituzione, leso per violazione della riserva di legge e per il difetto
dei motivi di sanità e sicurezza che soltanto potrebbero giustificare una
limitazione del diritto di circolazione.
Onde respingere la censura,
Il medesimo giudice a quo aveva lamentato la violazione di
un’altra riserva di legge, quella che l’art. 23 della Costituzione prevede in
materia di prestazioni patrimoniali imposte.
L’infondatezza di questa questione è
stata argomentata, da parte della Corte, sul rilievo che «rientrano nella
nozione di prestazione patrimoniale imposta anche prestazioni di natura non
tributaria e aventi funzione di corrispettivo, quando per i caratteri e il
regime giuridico dell’attività resa, sia pure su richiesta del privato, a
fronte della prestazione patrimoniale appare prevalente l’elemento della
imposizione legale». In effetti, ai fini dell’individuazione delle prestazioni
patrimoniali imposte, «non costituiscono profili determinanti né le formali
qualificazioni delle prestazioni né la fonte negoziale o meno dell’atto
costitutivo né l’inserimento di obbligazioni ex lege in contratti privatistici», mentre deve invece riconoscersi
«un peso decisivo agli aspetti pubblicistici dell’intervento delle autorità ed
in particolare alla disciplina della destinazione e dell’uso di beni o servizi,
per i quali si verifica che, in considerazione della loro natura giuridica,
della situazione di monopolio pubblico o della essenzialità di alcuni bisogni
di vita soddisfatti da quei beni o servizi, la determinazione della prestazione
sia unilateralmente imposta con atti formali autoritativi, che, incidendo
sostanzialmente sulla sfera dell’autonomia privata, giustificano la previsione
di una riserva di legge» (sentenza n. 236 del 1994).
Sulla scorta di tali considerazioni
di ordine generale, con riguardo alla disciplina oggetto del giudizio,
Riprendendo alcuni precedenti
piuttosto risalenti,
Nella sentenza n. 33, una delle censure proposte dalla
Regione ricorrente in via principale riguarda una disposizione della legge 10
marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all’istruzione), asseritamente lesiva della riserva di legge
prevista dall’art. 119 Cost., in quanto demandava al Presidente del Consiglio
dei ministri il potere di stabilire i criteri di ripartizione tra le Regioni e
le Province autonome delle somme da destinare al sostegno della spesa sostenuta
dalle famiglie per l’istruzione, senza porre alcun limite alla discrezionalità
dell’esecutivo.
In due ipotesi (sentenza n. 53 ed ordinanza n. 289), l’evocazione nell’atto di promuovimento di una riserva
(assoluta) di legge è stata funzionale a «rafforzare la dedotta violazione
dell’art. 76 della Costituzione»; in entrambi i casi, la constatata inesistenza
di una violazione da parte del decreto legislativo dei limiti imposti dalla
legge di delega ha precluso ogni indagine circa la natura della riserva
assoluta di legge (nella specie, quella di cui all’art. 25 della Costituzione,
in relazione alla competenza del giudice).
Finalmente, deve evidenziarsi che l’esistenza
di una riserva assoluta di legge in materia penale è stata alla base della
pronuncia di manifesta inammissibilità di cui all’ordinanza n. 187, nella quale
2.2.
Le leggi di interpretazione autentica e le (altre) leggi retroattive
Per quel che concerne l’efficacia
delle leggi nel tempo, un particolare interesse è rivestito da due statuizioni
relative a norme di interpretazione autentica. Una terza decisione ha avuto
invece precipuamente ad oggetto una legge retroattiva.
Con la sentenza n. 282,
Ad avviso della Corte, «la
riconosciuta natura effettivamente interpretativa di una legge non esclude che
da essa possano derivare violazioni costituzionali». Invero, «al di fuori della
materia penale (dove il divieto di retroattività della legge è stato elevato a
dignità costituzionale dall’art. 25 Cost.), l’emanazione di leggi con efficacia
retroattiva da parte del legislatore incontra una serie di limiti che questa
Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia, tra l’altro,
di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari
della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il
rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela
dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato
allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate
al potere giudiziario (da ultimo, sentenze n. 376 del 2004, n. 291 del 2003 e
n. 446 del 2002)». In particolare, «al legislatore è precluso intervenire, con
norme aventi portata retroattiva, «per annullare gli effetti del giudicato»
(sentenza n. 525 del 2000): se vi fosse un’incidenza sul giudicato, la legge di
interpretazione autentica non si limiterebbe a muovere, come ad essa è
consentito, sul piano delle fonti normative, attraverso la precisazione della
regola e del modello di decisione cui l’esercizio della potestà di giudicare
deve attenersi, ma lederebbe i principî relativi ai rapporti tra potere
legislativo e potere giurisdizionale e le disposizioni relative alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (cfr. sentenze n. 374
del 2000 e n. 15 del 1995)».
La portata retroattiva della
disposizione nella specie denunciata non era comunque tale da riguardare e da
porre nel nulla anche gli effetti di sentenze passate in giudicato basate su
un’interpretazione difforme da quella poi imposta dal legislatore. Ciò in
quanto a norma censurata, nel contemplare la perdita di efficacia delle
«decisioni di autorità giurisdizionali», quindi delle decisioni impugnate o
impugnabili, non andava ad incidere sulle decisioni irrevocabili o passate in
giudicato (il silenzio del legislatore doveva ritenersi «significativo di
un’implicita salvezza del giudicato»).
Nella sentenza n. 409 si è analizzata una disposizione
interpretativa, la cui efficacia retroattiva, oltre ad evidenziare una
intrinseca irragionevolezza, era causa, ad avviso del rimettente, di
illegittimità in quanto produceva la lesione del principio dell’affidamento
ingeneratosi nel vigore della normativa precedente in materia di attribuzione
della qualifica di assistente sociale.
Le problematiche inerenti alle leggi
interpretative presentano, come è chiaro, alcuni elementi di forte comunanza
con quelle relative alla retroattività delle leggi. Per la chiarezza delle
affermazioni ivi contenute, sul punto si segnala, la sentenza n. 191. Oggetto del giudizio erano norme
che avevano introdotto un termine decadenziale per l’esercizio, da parte dell’Inail, dei poteri amministrativi di
accertamento e rettifica dell’errore commesso in sede di attribuzione,
erogazione o riliquidazione delle prestazioni, salvi i casi di dolo o colpa
grave dell’assicurato. Contestualmente, erano state impugnate le norme che di
far valere retroattivamente la violazione del termine decadenziale introdotto
dalla nuova disciplina. Dato atto che, secondo la costante giurisprudenza
costituzionale, «il divieto di retroattività della legge non è stato elevato a
precetto costituzionale, salva, per la materia penale, la previsione dell’art.
25 della Costituzione»,
La portata retroattiva di una
disposizione è stata oggetto di scrutinio anche nella sentenza n. 320. Nella specie, veniva impugnato
l’art. 39 della legge 21 novembre 2000, n.
Siffatta limitazione della portata
retroattiva della disposizione impugnata (che qualificava un pagamento come non
dovuto e nello stesso tempo lo sottraeva all’azione di ripetizione) è stata
alla base della declaratoria di illegittimità costituzionale per
incompatibilità con il principio di ragionevolezza.
2.3.
Il referendum abrogativo (rinvio)
In merito al referendum di cui all’art. 75 della Costituzione, nel 2005
Una sesta decisione è rappresentata
dalla ordinanza n. 198, che ha
deciso nella fase dell’ammissibilità il conflitto radicatosi in ordine alla
data di indizione della consultazione referendaria. Questa decisione è stata
oggetto di analisi supra, parte I,
cap. IV.
2.4.
La delegazione legislativa
Assai numerose, e di notevole
importanza, sono state le statuizioni che, nel corso del 2005, hanno riguardato
il procedimento di delegazione legislativa.
Tra i profili maggiormente
caratterizzanti, possono segnalarsi: (a)
i contenuti minimi che la legge di delega deve recare; (b) i rapporti intercorrenti tra la nozione di «principio
fondamentale» ex art. 117, terzo
comma, e quella di «principio e criterio direttivo» ex art. 76 della Costituzione; (c)
l’esatta individuazione dei principî e criteri direttivi, onde operare lo
scrutinio di legittimità costituzionale del decreto delegato; (d) l’interpretazione da seguire nel
ricostruire i rapporti tra legge di delega e decreto legislativo; (e) i margini di azione che i principî e
criteri direttivi lasciano al legislatore delegato; (f) i particolari margini che sussistono nel caso in cui la delega
abbia ad oggetto il «coordinamento» di diversi atti normativi attraverso
l’emanazione di un testo unico; (g)
il mancato (o l’incompleto) esercizio della delega.
a) Circa i
contenuti minimi della delega, si segnala, tra tutte, la sentenza n. 66, che ha avuto ad oggetto l’art. 2,
comma 1, lettera a), della legge delega per la revisione delle norme
sulla circolazione stradale 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la
revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) e
l’art. 7, comma 1, lettera f), del legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), che consentono di subordinare la sosta dei veicoli
al pagamento di una somma di denaro.
Tra i profili di incostituzionalità
si denunciava il contrasto con l’art. 76 Cost., per essere stata del tutto
omessa la determinazione dei principî e dei criteri direttivi e di valutazione
sia in ordine alla individuazione delle zone che possono essere sottoposte
all’onere del pagamento di una somma per il parcheggio sia in ordine alle
tariffe applicabili; ed inoltre perché, in assenza di delega del Parlamento,
l’indicazione di tali criteri sarebbe stata demandata dal Governo al Ministro
dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti).
Le censure sono state dichiarate
fondate. Rifacendosi a precedenti affermazioni,
Sulla scorta di questa constatazione,
si è dedotto che «la revisione e il riordino, ove comportino l’introduzione di
norme aventi contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente,
necessitano della indicazione di principî e di criteri direttivi idonei a
circoscrivere le diverse scelte discrezionali dell’esecutivo, mentre tale
specifica indicazione può anche mancare allorché le nuove disposizioni abbiano
carattere di sostanziale conferma delle precedenti (sentenza n. 354 del 1998)».
Nel caso di specie, era quest’ultima ipotesi a ricorrere, «in quanto il
previgente codice della strada conteneva già una disposizione del tutto analoga
a quella del decreto legislativo in esame, introdotta dall’art. 15 della legge
24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma
triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di
alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393),
che ha modificato l’art. 4 del testo unico n. 393 del 1959, attribuendo ai
comuni la facoltà di stabilire aree destinate al parcheggio, sulle quali la
sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo della durata anche senza custodia del
veicolo, e di fissare le relative condizioni e tariffe». La sostanziale
identità delle due norme consentiva allora di affermare che la disposizione
contenuta nel nuovo codice della strada era in realtà meramente ricognitiva e
confermativa della precedente.
b) La sentenza
n.
In definitiva, «la lesione delle
competenze legislative regionali non deriva dall’uso, di per sé, della delega,
ma può conseguire sia dall’avere il legislatore delegante formulato principî e
criteri direttivi che tali non sono, per concretizzarsi invece in norme di
dettaglio, sia dall’aver il legislatore delegato esorbitato dall’oggetto della
delega, non limitandosi a determinare i principî fondamentali».
Questa impostazione è stata seguita,
in particolare, nel decidere circa la questione relativa all’art. 1, comma 2,
lettera a), della legge n. 30 del
2003, sollevata in riferimento agli articoli 76 e 117, terzo comma, della
Costituzione: la prescrizione di «snellimento e semplificazione delle procedure
di incontro tra domanda ed offerta di lavoro» è stata ritenuta
«sufficientemente specifica per soddisfare l’esigenza di determinatezza che un
criterio direttivo deve possedere per non essere in contrasto con l’articolo 76
Cost.» e, nel contempo, si è constatato che essa «non fissa norme di
dettaglio».
Riprendendo le affermazioni di cui
alla sentenza n. 50, nella sentenza
n. 205 si è ribadito, da un lato,
che «ben può lo Stato, in materie di competenza concorrente, dettare i principî
fondamentali per mezzo di leggi delegate» e, dall’altro lato, che la legge
delega può essere oggetto di impugnazione se i principî ed i criteri direttivi
fissati sono essi stessi, tenuto «conto del complessivo contesto di norme in
cui si collocano e delle ragioni e finalità poste a fondamento della legge di
delegazione», invasivi della sfera di competenza regionale.
Analogamente, la sentenza n.
Anche la sentenza n. 384 si è posta sulla medesima linea
tracciata dalla sentenza n. 50
(stante anche la parziale identità degli atti impugnati). Nella sentenza n. 384, peraltro, si è provveduto anche a
dichiarare l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive
in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della
legge 14 febbraio 2003, n. 30), in quanto prevedevano organi prima non
esistenti», attinenti soprattutto all’organizzazione della sanità, cioè ad una
materia estranea alla delega e di competenza legislativa concorrente (la
violazione della legge di delega si associava, dunque, ad una illegittima
intrusione da parte dello Stato nella sfera di competenza regionale).
c) Per quel
che concerne l’individuazione dei principî e criteri direttivi, in più di una
occasione
Nel giudizio concluso con la sentenza
n. 32, il remittente deduceva la
violazione dell’art. 76 Cost., in riferimento all’art. 1 della legge 6 febbraio
1996, n. 52 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994),
in base al quale era stato emanato il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
La disposizione del decreto
legislativo che assoggettava al segreto d’ufficio l’intera documentazione in
possesso della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) in ragione dell’attività di
vigilanza, donde il giudice a quo
ricavava il contrasto con l’art. 1, comma 1, della legge n. 52 del 1996, che
tra i principî e criteri generali includeva quello della piena trasparenza e
della imparzialità dell’azione amministrativa.
Per decidere tale questione, doveva
prendersi in considerazione la circostanza che la delega in questione fosse
volta a dare attuazione alla direttiva 93/22/Cee
del Consiglio del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel
settore dei valori mobiliari. A questo atto era dunque necessario riportarsi; e
proprio facendo leva su quanto previsto in sede comunitaria si escludeva che
l’ambito oggettivo del principio (di piena trasparenza) sancito dalla legge di
delega potesse estendersi alla materia per la quale il decreto legislativo
aveva previsto il segreto d’ufficio.
Profili inerenti alla violazione dei
limiti posti dalla legge di delega da parte del decreto legislativo sono stati
sollevati anche nel giudizio deciso con le sentenze nn. 110, 194 e 266.
Nella sentenze nn. 110 e 266,
Nell’ambito del giudizio di
legittimità costituzionale instaurato in via principale deciso con la sentenza
n. 285, una Regione aveva impugnato,
per violazione dell’art. 76 Cost., le disposizioni in materia di finanziamento
contenute in taluni articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma
della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal momento che «la legge delega non
prevedeva tra i criteri direttivi anche la possibilità di stralciare la quota
del Fondo unico per lo spettacolo per disporne separatamente», né prevedeva «di
modificare i criteri di selezione dei soggetti destinatari dei contributi».
d) «I principî
e i criteri direttivi della legge di delegazione devono essere interpretati sia
tenendo conto delle finalità ispiratrici della delega, sia verificando, nel
silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte operate
dal legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali
della stessa legge delega»: così si è espressa l’ordinanza n. 228, che,
rilevato, per un verso, come il legislatore delegante avesse raccomandato al
legislatore delegato di «tenere conto», quale modello di riferimento nella
struttura del procedimento penale di fronte al giudice di pace, del
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, nonché a prevedere
lo svolgimento del giudizio in forma semplificata, la introduzione di forme di
definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto e di
occasionalità della condotta e di ipotesi di estinzione del reato conseguente a
condotte riparatorie o risarcitorie, nonché l’obbligo del giudice di procedere
al tentativo di conciliazione, e rilevato, per altro verso, che in attuazione
di tali principî il legislatore delegato aveva delineato un procedimento già di
per sé caratterizzato da una accentuata semplificazione rispetto al
procedimento davanti al giudice monocratico, ha escluso che la omessa
previsione del patteggiamento nel procedimento di fronte al giudice di pace
integrasse una violazione della legge delega. Alla ratio decidendi
espressa nell’ordinanza n. 228 si è integralmente rifatta l’ordinanza n.
312, per decidere una analoga questione di legittimità costituzionale.
Similmente,
Secondo il primo rimettente, doveva
escludersi che la procedura di cui all’art. 2409 cod. civ. fosse comunque – e
cioè anche ad iniziativa del collegio sindacale obbligatoriamente nominato ex
art. 2477, comma terzo, cod. civ. – esperibile nei confronti di una società a
responsabilità limitata; l’altro giudice a
quo riteneva, invece, che il collegio sindacale, ma non anche i soci,
potesse promuovere il controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 cod. civ.:
l’eccesso di delega veniva, conseguentemente, ravvisato ora nell’esclusione
totale, ora nella limitazione dell’operatività dell’art. 2409, sostenendosi
altresì, da parte della seconda ordinanza, che la limitazione sarebbe stata
tale da comportare una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei soci
della società a responsabilità limitata rispetto ai soci di una società per
azioni e, comunque, rispetto al collegio sindacale.
Entrambe le ordinanze di rimessione
imputavano al legislatore delegato la violazione del criterio di cui all’art.
4, comma 2, lettera a), n. 4, con il quale il legislatore delegato era
impegnato a «prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei sindaci o, nei
casi di cui al comma 8, lettera d), nn. 2 [consiglio di sorveglianza] e
3 [comitato preposto al controllo interno sulla gestione], dei componenti di
altro organo di controllo, di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri
degli amministratori»: criterio volto, in una disciplina che prevede «un
ampliamento dell’autonomia statutaria», ad individuare «limiti e condizioni in
presenza dei quali sono applicabili a società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio norme inderogabili» (così il comma 2, lettera a). Da
tale criterio – e da quello (art. 5, comma 2, lettera g) che prevedeva
il controllo giudiziario per le società cooperative non inquadrabili nella c.d.
cooperazione costituzionalmente riconosciuta – i rimettenti desumevano che il
legislatore delegato era vincolato esclusivamente ad estendere la
legittimazione attiva e l’ambito oggettivo del controllo giudiziario come
previsto dall’art. 2409 cod. civ.; norma che, in quanto espressamente citata
dall’art. 5, comma 2, lettera g), doveva rimanere «inalterata».
Ad avviso della Corte, anche a tacere
la circostanza che la legittimazione riconosciuta ai sindaci poteva intendersi
riferita (nella legge delega) alle società per azioni che «fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio» («caratterizzate da un maggior grado di
imperatività»: art. 4, comma 1), doveva, infatti, considerarsi che l’art. 2,
lettera f) fissava, come generale, il principio per cui la società a
responsabilità limitata e la società per azioni debbono costituire «due modelli
societari» distinti. A siffatto principio generale faceva da corollario quello
della previsione, per la società a responsabilità limitata, di «un autonomo ed
organico complesso di norme» (art. 3, comma 1, lettera a), e cioè una
impostazione della disciplina radicalmente divergente da quella adottata dal
codice civile anteriormente alla riforma, e che trovava la sua compiuta
manifestazione negli articoli 2486, comma secondo, 2487, comma secondo, e 2488,
commi terzo e quarto, cod. civ.
L’insieme di queste considerazioni
rendeva chiaro che non era da accogliere la censura relativamente alla mancata
previsione dell’applicabilità dell’art. 2409 cod. civ. alle società a
responsabilità limitata: la ratio
della delega risiedeva, infatti, proprio nell’enucleazione di caratteristiche peculiari
per questo tipo di società.
Sempre in ordine alla interpretazione
dei principî e criteri direttivi, merita un cenno l’ordinanza n. 1, con la quale si è affermato che,
quando uno dei criteri direttivi posti dalla legge delega consiste nel
recepimento dei principî giurisprudenziali consolidati in una determinata
materia, l’esigenza del rispetto di tale criterio di delega (art. 76 della
Costituzione) richiede di interpretare la disposizione censurata, posta dal
legislatore delegato, in modo che sia in armonia con la giurisprudenza in
materia.
e) Sui
rapporti tra legge di delega e decreto legislativo, relativamente ai margini di
azione che debbono riconoscersi al secondo, nella sentenza n. 174 si è ribadito che l’art. 76 della
Costituzione «non osta all’emanazione di norme che rappresentino un coerente
sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal
legislatore delegante; va escluso, infatti, che le funzioni del legislatore
delegato siano limitate ad una mera “scansione linguistica” delle previsioni
dettate dal delegante, essendo consentito al primo di valutare le situazioni
giuridiche da regolamentare e di effettuare le conseguenti scelte, nella
fisiologica attività di “riempimento” che lega i due livelli normativi,
rispettivamente, della legge di delegazione e di quella delegata» (così, ex
plurimis, sentenze n. 199 del 2003 e n. 308 del 2002).
Questa impostazione è stata
integralmente ripresa nell’ordinanza n. 213,
dove si è ulteriormente rilevato che il giudizio di conformità della norma
delegata alla norma delegante si esplica attraverso il confronto tra gli esiti
di due processi ermeneutici paralleli, tenendo conto delle finalità che,
attraverso i principî ed i criteri enunciati, la legge delega si prefigge con
il complessivo contesto delle norme da essa poste e tenendo altresì conto che
le norme delegate vanno interpretate nel significato compatibile con quei
principî e criteri, in quanto la delega legislativa non fa venir meno ogni
discrezionalità del legislatore delegato, che risulta più o meno ampia a
seconda del grado di specificità dei principî e criteri direttivi fissati nella
legge delega; sicché, «per valutare di volta in volta se il legislatore
delegato abbia ecceduto tali – più o meno ampi – margini di discrezionalità,
occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma
delegata sia ad essa rispondente».
Alla luce di tali principî, si è
nella specie affermato che il legislatore delegato aveva fatto corretto uso del
potere conferitogli dal Parlamento, allorché aveva individuato nella decadenza
dal diritto di azione una «misura processuale» idonea a conseguire l’obiettivo
di evitare il «sovraccarico di lavoro» che, per i tribunali amministrativi
regionali, si sarebbe determinato conservando temporaneamente la giurisdizione
sul pubblico impiego ed acquisendo quella in materie correlate ai servizi
pubblici ed al governo del territorio, di talché il legislatore delegato aveva
fatto ragionevole uso della discrezionalità insita nel potere legittimamente
conferitogli dal Parlamento, preoccupandosi del «sovraccarico del contenzioso»
presso il giudice ordinario, sia prevedendo strumenti processuali originali sia
evitando di gravarlo del contenzioso relativo a diritti sorti anteriormente
alla data fissata dalla legge per la «devoluzione», e preoccupandosi, altresì,
del sovraccarico del contenzioso per i tribunali amministrativi (all’ordinanza
n.
f) Tra le
problematiche che più di frequente sono state poste alla Corte nel corso del
2005, si annovera certamente quella dell’esatto contenuto che è proprio della
nozione di «coordinamento».
Con la sentenza n. 52,
Si denunciava, in particolare, la
violazione dell’art. 76 della Costituzione, per avere il legislatore delegato
ecceduto dalla delega conferita con l’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50
(Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi
– legge di semplificazione 1998), come modificato dall’art. 1 della legge 24
novembre del 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per
la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione
1999). Ciò in quanto non si sarebbe rinvenuto tra i criteri direttivi della
legge di delega la previsione della facoltà di modificare la distribuzione di
compiti tra giudice monocratico e collegiale, né la volontà di armonizzazione
della materia con la sopravvenuta riforma del giudice unico.
Nel negare fondamento alla censura,
Se l’obiettivo era quello della
coerenza logica e sistematica della normativa, il coordinamento non poteva
essere solo formale (come, del resto, aveva sottolineato lo stesso Consiglio di
Stato nel parere espresso nel corso della procedura di approvazione del testo
unico). Inoltre, se l’obiettivo era quello di ricondurre a sistema una
disciplina stratificata negli anni, con la conseguenza che i principî erano
quelli già posti dal legislatore, non era necessario che fosse espressamente
enunciato nella delega il principio già presente nell’ordinamento, essendo
sufficiente il criterio del riordino di una materia delimitata. Entro questi
limiti il testo unico poteva innovare per raggiungere la coerenza logica e
sistematica e, come nel caso di specie, prevedere la composizione monocratica,
anziché collegiale del giudice, applicando al processo in questione il
principio generale affermato con la riforma del 1998, al fine di rendere la
disciplina più coerente nel suo complesso e in sintonia con l’evolversi
dell’ordinamento (si noti, peraltro, che le finalità di riordino e
semplificazione contemplate nella legge di delega non possono condurre a
ravvisare la violazione della delega per aver il legislatore delegato
semplificato poco rispetto a quello che avrebbe potuto, trattandosi di scelte
di merito rimesse alla discrezionalità del legislatore: sentenza n. 174).
Né a diversa conclusione poteva
indurre l’art. 50-bis cod. proc. civ. (inserito dall’art. 56 del decreto
legislativo n. 51 del 1998), il quale, nell’elencare in via di eccezione,
rispetto al successivo art. 50-ter, le cause in cui il tribunale decide
in composizione collegiale, ha richiamato (al secondo comma) i procedimenti in
camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del codice di
rito, salvo che sia altrimenti disposto: infatti, il procedimento camerale
disciplinato dall’art. 29 della legge n. 794 del 1942, al quale rinvia la norma
impugnata, non rientra tra quelli di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice (a tal fine era sufficiente considerare che il provvedimento non è impugnabile,
mentre l’art. 739 cod. proc. civ. prevede espressamente il reclamo).
La ratio decidendi della sentenza n. 52 è stata ribadita nella sentenza n. 53, relativa alla questione di legittimità costituzionale dell’art.
170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotto nel decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in
riferimento all’art. 76 della Costituzione, per avere il legislatore delegato –
al comma 2 del suddetto articolo – trasferito la competenza dal giudice in
composizione collegiale al giudice in composizione monocratica, così
introducendo una innovazione radicale senza rispettare i limiti della delega.
La violazione dell’art. 76 della
Costituzione sarebbe derivata dall’impossibilità di ricondurre l’innovazione
nell’ambito del coordinamento formale, né in quello delle modifiche necessarie
per garantire la coerenza logica e sistematica – ai sensi della lettera d),
comma 2, dell’art. 7 della legge delega – alla luce del richiamo al dcreto
legislativo n. 51 del 1998 che ha introdotto il giudice unico, contenuto nella
relazione governativa.
Anche in questo caso,
Contestualmente, era stato denunciato
l’art. 7 della legge di delega 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi
unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – legge di
semplificazione 1998), come modificato dall’art. 1 della legge 24 novembre
2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione
1999), in riferimento all’art. 76 della Costituzione, non prevedendo la norma
impugnata i limiti e l’oggetto della delega in una materia, quale quella
riguardante la competenza del giudice, coperta da riserva assoluta di legge ai
sensi dell’art. 25 della Costituzione.
Onde respingere la questione, è stato
evidenziato che la norma prevedeva l’emanazione di testi unici intesi a
riordinare le materie elencate nelle leggi annuali di semplificazione (comma 1,
lettera b) mediante il richiamo dei relativi provvedimenti normativi;
materie che, per il testo unico in tema di spese di giustizia, risultavano
dall’allegato 1 della stessa legge, nn. 9, 10 e 11, attraverso
l’individuazione, tra i tanti, dei cosiddetti campione penale e civile (n. 10),
che regolavano anche le spese concernenti gli ausiliari del giudice. La materia
oggetto di riordino risultava, quindi, delimitata dalla normativa richiamata negli
allegati, mentre i limiti di intervento del legislatore delegato erano segnati
dai principî e criteri direttivi fissati dall’art. 7, comma 2 (tali
affermazioni sono state riproposte nella sentenza n. 174, che ha ulteriormente precisato che i provvedimenti richiamati
nell’allegato 1 servono solo a delimitare la materia oggetto di riordino, senza
ritenere tassativo il richiamo dei singoli articoli, e nelle ordinanze nn. 289 e 334).
Sia pure incidentalmente, il tema del
coordinamento normativo è stato affrontato anche dalla sentenza n. 303,
la quale ha evidenziato che, «in mancanza di princípi e criteri direttivi che
giustifichino la riforma» della normativa preesistente, la delega «deve essere
intesa in un senso minimale, tale da non consentire, di per sé, l’adozione di
norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo».
Aspetto connesso al coordinamento
normativo è, come ovvio, quello della abrogazione delle disposizioni
precedenti. Sul punto, sebbene a proposito di una delegazione di tipo diverso
rispetto a quelle appena menzionate, può citarsi nuovamente la sentenza n. 50, secondo cui «l’inclusione, tra i
principî direttivi, dell’abrogazione delle norme incompatibili è soltanto
l’esplicitazione di un principio generale già esistente nell’ordinamento».
g) Nella
sentenza n. 149 si è posto il
problema del mancato (recte,
incompleto) esercizio di una delega legislativa, da cui il giudice a quo muoveva per denunciare la
violazione dell’art. 76 della Costituzione. Sul punto,
2.5.
La decretazione d’urgenza
Relativamente esigue, ma non per
questo di scarso rilievo sono state le pronunce che
Nella sentenza n. 62, una delle questioni poste nel
ricorso di una Regione avverso un decreto legge concerneva la mancanza dei
requisiti di straordinaria necessità ed urgenza idonei a legittimare
l’intervento del Governo, e quindi la violazione dell’art. 77 della
Costituzione:
La censura è stata disattesa in
quanto, non solo non era evidente, nella specie, la mancanza dei presupposti di
straordinaria necessità ed urgenza, che legittimano il ricorso al decreto
legge, ma, al contrario, appariva evidente come l’esigenza di prevedere una
adeguata disciplina idonea a consentire la realizzazione delle opere, allo
stato mancanti, necessarie per un corretto smaltimento dei rifiuti radioattivi,
evitando pericoli per la salute e per l’ambiente, configurasse un valido
presupposto per un intervento d’urgenza: anche se poi il completamento delle
procedure e delle opere necessarie potesse richiedere tempi non brevi:
l’urgenza, infatti, «riguarda il provvedere, anche quando occorra tempo per
conseguire il risultato voluto».
I presupposti legittimanti
l’emanazione di un decreto legge sono stati valutati anche nella sentenza n. 272, nella quale
Nella medesima decisione,
Tutt’altro tema è stato quello
affrontato con l’ordinanza n.
Sebbene la legge 27 dicembre 2002, n.
289 avesse fatti salvi gli effetti delle disposizioni abrogate (ivi compresa
l’immediata entrata in vigore delle stesse), essa non era stata oggetto di
specifica censura da parte del giudice rimettente, che si era limitato a
sollevare la questione di legittimità costituzionale del solo art. 4 del
decreto legge n. 253 del 2002, pur mostrando di conoscere l’esistenza della
norma abrogatrice e di quella di sanatoria.
A fondamento della decisione di tipo
processuale,
Di rilievo sono state alcune
affermazioni rese con riferimento al procedimento di delegificazione, e ciò
specialmente nella sentenza n. 303,
con cui
La seconda questione, di carattere
generale, aveva ad oggetto l’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nella parte in cui stabilisce che le leggi ordinarie, nell’autorizzare
l’esercizio della potestà regolamentare governativa in materie non coperte da
riserva assoluta di legge, possono limitarsi ad indicare le «norme generali regolatrici
della materia», anziché più restrittivi «princípi e criteri direttivi»,
analoghi a quelli prescritti dall’art. 76 Cost. per la delega al Governo
dell’esercizio della funzione legislativa. La censura veniva dichiarata
inammissibile, in quanto il giudice a quo
aveva omesso «sia di esplicitare le ragioni per le quali ritiene di porsi in
contrasto con l’unanime opinione dottrinale secondo cui (data anche l’evidente
differenza semantica tra i termini “norma” e “principio”) le “norme generali
regolatrici della materia” hanno, tendenzialmente, una funzione delimitativa
più stringente rispetto ai “principî e criteri direttivi”; sia di precisare le
“norme generali regolatrici della materia” delegificata affette dal dedotto
vizio di genericità e delle quali [avrebbe dovuto] fare applicazione nel
giudizio principale».
Sempre con riferimento alla
delegificazione, è da segnalare come la sentenza n. 30 abbia confermato il principio (già espresso nella sentenza n.
376 del 2002), secondo cui essa può riguardare «disposizioni di leggi statali
regolanti oggetti a qualsiasi titolo attribuiti alla competenza dello Stato».
2.7.
Le fonti esterne (rinvio)
Tra le affermazioni più significative
concernenti il diritto comunitario, si segnalano la sentenza n. 406,
concernente la portata dell’art. 117, primo comma, della Costituzione come
fonte attraverso la quale il diritto comunitario si impone rispetto alla
legislazione interna (v. supra, parte
I, cap. II, par. 4, e infra, sez. I,
par. 2) e le ordinanze nn. 241 e 268, relativamente al valore delle
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (v. supra, parte I, cap. I, par. 11.2).
Per quanto attiene alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, e segnatamente alla collocazione della stessa
nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale, possono menzionarsi la
sentenza n. 224 e l’ordinanza n. 464 (sulle quali, v. supra, parte I, cap. I, par. 7).
3.
Il Presidente della Repubblica
Circa i poteri del Presidente della
Repubblica, sono da segnalare le ordinanze nn. 354 e 357, di
ammissibilità di conflitti interorganici, entrambe già trattate supra,
parte I, cap. IV.
La giurisprudenza del 2005 non
presenta rilevanti affermazioni relative alla collocazione istituzionale del
Governo o di membri di esso, se si fa eccezione per alcune pronunce, rese in
sede di ammissibilità di un conflitto tra poteri dello Stato, per le quali è
d’uopo rinviare a quanto detto supra, parte I, cap. IV.
5.
La pubblica amministrazione
Nel corso del 2005,
5.1.
Il principio di buon andamento
Con riferimento al principio di buon
andamento della pubblica amministrazione, possono individuarsi, in particolare,
quattro diverse categorie di affermazioni rese, concernenti rispettivamente (a)
la mancata violazione del principio, (b) l’estraneità del principio alla
materia disciplinata dalla norma impugnata e (c) il collegamento
rintracciabile tra il principio del buon andamento e quello di ragionevolezza.
In un solo caso (d),
a) La sentenza n.
In proposito,
Il principio di buon andamento è
stato oggetto di valutazione anche nella sentenza n. 191, resa a
proposito della norma che introduce un termine decadenziale – peraltro di
peculiare ampiezza – per l’esercizio, da parte dell’Inail, dei poteri amministrativi di accertamento e rettifica
dell’errore commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle
prestazioni, salvi i casi di dolo o colpa grave dell’assicurato (art. 9, commi
1, secondo periodo, e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38).
Sull’assunto che la comparazione tra
i maggiori oneri presumibilmente derivanti dalla introduzione del termine
decadenziale ed i risparmi conseguenti alla probabile riduzione del contenzioso
è senz’altro riservata alla discrezionale valutazione del legislatore e,
quindi, censurabile solamente nei limiti di una manifesta irragionevolezza (che
nella specie non era sicuramente dato di ravvisare),
Nel decidere in merito alla
legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 3, della legge della Regione
Marche 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), il
quale dispone che, fino alla definizione degli accordi di cui all’art. 5, comma
4, di detta legge (negoziazione, da parte delle Aziende Usl, dei servizi e delle prestazioni con le altre Aziende Usl e ospedaliere, con istituzioni
sanitarie private accreditate e con professionisti), restano valide le modalità
di accesso alle prestazioni così come disciplinate dall’art. 19 della legge 11
marzo 1988, n. 67, e cioè che, in via provvisoria, resta fermo l’obbligo della
preventiva autorizzazione per l’accesso alle strutture sanitarie non pubbliche,
entro i limiti ed i termini stabiliti da quest’ultima norma, la sentenza n.
La sentenza n.
I criteri legali di determinazione
dell’incremento dei canoni, con il temperamento rappresentato dal limite di
aumento non superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per
immobili aventi caratteristiche analoghe, rispondono ad esigenze di uniformità
di disciplina dei rapporti implicati, tanto più rilevanti allorché (come era
nel caso di specie) investano il complesso dei beni patrimoniali che lo Stato
deve gestire su tutto il territorio nazionale: una disciplina così conformata
non può quindi vulnerare i principî di imparzialità e buon andamento di cui
all’evocato art. 97 della Costituzione.
Nel giudicare sulla questione di
legittimità costituzionale dell’art. 43, secondo comma, della legge 10 aprile
1954, n. 113 (Stato degli Ufficiali dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica), nella parte in cui – disciplinando la cessazione volontaria
dell’ufficiale dal servizio permanente – non prevede che l’Amministrazione
della difesa possa riammettere in servizio l’ufficiale cessato a domanda dal
servizio permanente effettivo e collocato in congedo,
Sulla scorta di questi rilievi, e
premesso che non è consentito al controllo di costituzionalità di travalicare
nel merito delle opzioni legislative,
b) In varie decisioni,
Così, la sentenza n. 174 e
l’ordinanza n. 122 hanno ribadito che, in base ad un costante
orientamento, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è
estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i
provvedimenti che ne costituiscono espressione, essendo riferibile anche agli
organi dell’amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene alle
leggi concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro
funzionamento sotto l’aspetto amministrativo.
L’ordinanza n.
L’ambito entro il quale il principio
del buon andamento può essere invocato è stato oggetto di analisi anche nella
sentenza n. 244.
Con riferimento all’art. 17 della
legge della Regione Molise 8 luglio 2002, n. 12 (Riordino e ridefinizione delle
comunità montane), impugnato nella parte in cui attribuisce «ai poteri del
Presidente della Giunta regionale lo scioglimento, la sospensione e il
commissariamento del consiglio della Comunità montana», il giudice a quo
riteneva che la mancata previsione di un limite temporale di durata della
supplenza dell’organo commissariale straordinario, nonché la mancanza di una
«scansione procedimentale» e di «particolari garanzie», si ponesse in contrasto
con «il principio della riserva di legge in materia di organizzazione
amministrativa» e con i principî di imparzialità e buon andamento, di cui
all’art. 97 della Costituzione.
c) Nella sentenza n. 243,
d) Nella sentenza n. 277,
Ad avviso della Corte, la promozione
della costituzione della società di servizi della quale
5.2.
Lo status dei funzionari pubblici
La sentenza n.
Oggetto del giudizio è stato l’art. 3
della legge della Regione Veneto 27 febbraio 2004, n. 4, nella parte in cui
stabilisce che l’amministrazione regionale procede immediatamente al
trasferimento di sede o all’attribuzione ad altro incarico del dipendente
condannato, per i reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza di
primo grado. Ad avviso della Corte, tale disposizione non era da ritenersi
invasivo dell’ambito della legislazione esclusiva dello Stato in tema di
ordinamento penale, riconosciuta dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Le finalità che la norma intende
perseguire sono ravvisabili nell’esigenza di tutelare l’immagine, la
credibilità e la trasparenza dell’amministrazione regionale; interessi che,
anche prima dell’eventuale pronuncia di una sentenza definitiva di condanna,
possono risultare pregiudicati dalla permanenza nell’ufficio del dipendente che
abbia commesso nell’esercizio delle sue funzioni un reato contro la pubblica
amministrazione.
Alla luce del principio di buon
andamento dei pubblici uffici e del dovere dei cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche di «adempierle con disciplina ed onore» (articoli 97 e 54,
secondo comma, della Costituzione), la disposizione oggetto del giudizio offre
dunque alla amministrazione regionale uno strumento volto a realizzare
l’interesse pubblico di garantire la credibilità e la fiducia di cui
l’amministrazione deve godere presso i cittadini (v. sentenze n. 206 del 1999 e
n. 145 del 2002); interesse leso dal discredito che la condanna, anche solo di
primo grado, può recare all’immagine del corretto funzionamento dei pubblici
uffici, e certo prevalente su quello individuale del dipendente alla permanenza
nella medesima sede o nel medesimo ufficio.
La disposizione è dunque risultata
ispirata, non già da ragioni punitive o disciplinari, quanto da esigenze, lato sensu cautelari, in funzione
dell’organizzazione interna degli uffici (v. sentenza n. 206 del 1999), atteso
che le esigenze di trasparenza e di credibilità della pubblica amministrazione
sono direttamente correlate al principio costituzionale di buon andamento degli
uffici.
Con l’ordinanza n. 398 sono
stati definiti i giudizi nei quali si poneva la questione di legittimità
costituzionale – in riferimento a molteplici parametri – dell’art. 3, comma 7,
della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della
dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra
pubblico e privato), nella parte in cui prevede che gli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale e quelli di direttore generale degli enti
pubblici vigilati dallo Stato in corso all’entrata in vigore della legge
medesima (che ha modificato la disciplina della dirigenza nella pubblica
amministrazione) cessano il sessantesimo giorno da tale data.
I rimettenti censuravano altresì
l’art. 3, comma 1, lettera b), della stessa legge n. 145 del 2002, nella
parte in cui, in relazione al nuovo regime della dirigenza, pone la disciplina
a regime della durata degli incarichi in esame, prevedendo un limite massimo
triennale.
Successivamente alla proposizione
delle questioni, l’art. 14-sexies del decreto legge 30 giugno 2005, n.
115, inserito dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n.
5.3.
L’accesso ai pubblici uffici
Per quanto attiene all’accesso ai
pubblici uffici,
Quest’ultimo principio è stato
affrontato nell’ordinanza n. 39, con
la quale
Con precipuo riferimento ai pubblici
concorsi, possono essere segnalate quattro decisioni.
Di notevole interesse è la sentenza
n. 159, con cui
Nel caso in esame, la legge regionale
era viziata da evidente irragionevolezza, in conseguenza della limitazione, al
solo personale interno, della partecipazione al concorso; né valeva addurre che
questa limitazione si sarebbe giustificata per l’esperienza professionale
maturata in relazione alle specificità colturali e vegetali del territorio
calabrese, in quanto, vista la platea degli aspiranti, questa presunta
specificità assoluta non sussisteva affatto. Di conseguenza, non si poteva
negare che, nella fattispecie, il passaggio da un’area ad un’altra comportava
l’accesso ad un nuovo posto di lavoro, con relativa progressione in carriera,
ed era quindi soggetto al principio del pubblico concorso (cfr. sentenza n. 320
del 1997).
Parimenti, con la sentenza n. 190,
Se una deroga alla regola del
pubblico concorso è possibile soltanto in presenza di peculiari situazioni
giustificatrici individuate dal legislatore nell’esercizio di una
discrezionalità non irragionevole, nella specie non poteva ritenersi
utilizzabile la valorizzazione delle «specifiche professionalità acquisite» dal
personale in discorso, al fine di legittimare la deroga al principio del
concorso pubblico, per il fatto che non si trattava di «consentire il
consolidamento di pregresse esperienze maturate nella stessa amministrazione»
(cfr. sentenza n. 205 del 2004). Le disposizioni censurate, infatti, stabilivano
l’inserimento nei ruoli regionali di personale assunto con contratto a tempo
indeterminato da strutture sanitarie private, e dunque di personale non
reclutato a suo tempo dalla pubblica amministrazione mediante pubblico concorso
(sentenza n. 205 del 2004).
Anche nella sentenza n. 465
Il richiamato art. 86 subordinava il
passaggio di livello al superamento di un concorso speciale, per soli titoli,
cui era «consentito» l’accesso a varie categorie di dipendenti in presenza di
determinati requisiti. Di contro, le disposizioni oggetto del giudizio
prevedevano il passaggio nel livello superiore automaticamente, a richiesta
degli aventi diritto tenuti, unicamente a presentare domanda nel termine di
decadenza di giorni trenta, con ciò realizzando un reinquadramento ope legis di una ristrettissima
categoria di dipendenti.
In tale disciplina,
Di contro, nella sentenza n. 407,
Peculiari ragioni giustificative
hanno sorretto, infatti, l’inquadramento ope
legis, previsto dalla norma censurata, la quale ha inteso soddisfare le
aspettative di una residua quota di funzionari (sei in totale) rivestenti una
particolare posizione giuridica, cioè quella di coloro che, ancora alla data di
entrata in vigore della legge provinciale n. 12 del 1983, avevano la qualifica
di direttore di sezione e che non avevano potuto fruire della disciplina
prevista dall’art. 19, comma 9, della legge provinciale n. 3 del 1998 per la
prima attribuzione della qualifica di direttore, giacché non in possesso
dell’anzianità quinquennale prevista per il passaggio alla qualifica di
direttore di divisione in base a scrutinio per merito comparativo. La
circostanza, poi, che il passaggio avvenga in una qualifica ad esaurimento,
offre ulteriore giustificazione alla deroga, che il legislatore provinciale ha
previsto rispetto alla regola del concorso pubblico.
Viceversa, è stata dichiarata fondata
la questione di costituzionalità dell’art. 6, comma 7, della stessa legge
provinciale, nella parte in cui stabiliva che il personale che fosse stato
incaricato presso
Sulla scorta di tali considerazioni,
il previsto meccanismo dell’inquadramento «a domanda» nella qualifica
dirigenziale, non realizzava, nella specie, quel necessario contemperamento tra
il principio posto dall’art. 97, terzo comma, Cost. e l’interesse al
consolidamento di esperienze lavorative in precedenza maturate, imponendosi
dunque una declaratoria di incostituzionalità della disposizione impugnata.
5.4.
L’amministrazione sanitaria
Nella sentenza n. 437,
Tali norme, infatti, confondevano gli
esiti della gestione delle vecchie unità sanitarie locali con gli esercizi
facenti capo alle aziende e, pertanto, non assicurando la separazione fra la
gestione liquidatoria delle passività anteriori al 31 dicembre 1994, risalenti
alle unità sanitarie locali, e le attività poste in essere direttamente dalle
aziende, non risultavano conformi ai principî fondamentali della legislazione
statale.
Il legislatore statale, infatti, ha
stabilito il principio che le neoistituite aziende unità sanitarie locali
cominciassero a funzionare secondo i nuovi criteri di maggiore economicità e di
responsabilità dei dirigenti, senza essere oberate dal passivo accumulato in un
sistema di gestione della sanità pubblica che si riteneva generatore di
disfunzioni e, perciò, da abbandonare. Ed allo scopo,
Nella sentenza n. 111,
Il Tribunale rimettente, in sostanza,
riteneva che il riferimento ai volumi di prestazioni sanitarie erogate nel 1998
(ed al limite derivante dalla relativa spesa complessiva, sostenuta nello
stesso anno), determinasse una inammissibile sfasatura temporale tra tali
elementi e gli effettivi volumi di prestazione (nonché la spesa corrispondente)
relativi all’anno 2003.
Si sarebbe trattato, dunque, di una
previsione irragionevole, in quanto il legislatore regionale non avrebbe tenuto
in alcun conto l’andamento della domanda registrato nel quinquennio intercorso
tra il 1998 ed il 2003, e ciò con evidente danno delle strutture sanitarie
private.
In quest’ottica, è stato evidenziato
che il riferimento all’anno 1998, con particolare riguardo ai volumi
quantitativi delle prestazioni sanitarie erogate e alla complessiva spesa
sostenuta, trovasse la sua motivazione nella considerazione che per le
prestazioni di specialistica ambulatoriale in tale anno la capacità produttiva
delle strutture private si era potuta esplicare senza limiti».
Era, del resto, proprio il Tribunale
rimettente ad affermare testualmente che, nell’interpretazione della
disposizione impugnata, «si deve tener conto che per il 1998, se la delibera
della Giunta regionale n. 1800 del 1998 e le successive integrazioni hanno
previsto un tetto di spesa globale per le prestazioni di specialistica
ambulatoriale e la delibera di Giunta regionale n. 74 del
Con riferimento all’ordine
giudiziario,
6.1.
Il principio di indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale
Gli articoli 101, secondo comma, e
108, secondo comma, della Costituzione, nonché il “principio fondamentale della
separazione dei poteri dello Stato”, sono stati evocati dal Tribunale di Lecce
quale parametro nella questione di legittimità dell’art. 20, comma 7, della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, secondo cui la sospensione dei processi
esecutivi per la durata di trecento giorni, prevista a favore dei soggetti che
abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione di cui
agli articoli 3, 5, 6 e 8 della stessa legge, «ha effetto a seguito del parere
favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il Presidente del
Tribunale».
6.2.
Rapporto fra giurisdizioni
In tema di raffronto fra disciplina
del codice civile e norme che regolano il processo amministrativo, l’ordinanza
n.
In materia di controversie aventi ad
oggetto rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione
l’ordinanza n.
La ratio decidendi
dell’ordinanza n. 213 è stata integralmente ribadita con l’ordinanza n. 382.
Nelle pagine che seguono, si passano
in rassegna le decisioni che hanno riguardato il sistema delle autonomie
territoriali all’interno della Repubblica, rese fondamentalmente in sede di
giudizio di legittimità costituzionale in via principale, ma anche in sede di
conflitto tra Stato e Regioni, nonché, sia pure in minima parte, a seguito di
questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale.
Si tratta di un gran n. di decisioni,
molte delle quali coinvolgenti una molteplicità di profili: alla luce di ciò,
le decisioni di più ampio respiro sono state sovente (parzialmente) frammentate
in diversi paragrafi, nella prospettiva di un più immediato riscontro relativo
alla ratio decidendi sui singoli profili.
2.
La legislazione regionale ed i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
Con riferimento ai vincoli che si
impongono al legislatore regionale (oltre che a quello statale) in relazione
alla partecipazione dell’Italia al processo di integrazione comunitaria, di
particolare importanza è la sentenza n. 406.
La pronuncia si segnala perché la
illegittimità si fonda sull’esplicito contrasto con la normativa comunitaria,
risultando così violato il primo comma dell’art. 117 della Costituzione e
restando assorbiti gli altri profili di censura, che evocavano la competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di «profilassi internazionale» e
di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema».
A tanto
Inoltre, l’attuazione della direttiva
è in larga parte affidata alla Commissione, ed in effetti
Pertanto, per
Risulta, infine, inconferente il
tentativo della difesa regionale di utilizzare il principio comunitario di
precauzione, il quale rappresenta un criterio direttivo che deve ispirare l’attuazione
delle politiche ambientali della Comunità europea sulla base di dati
scientifici sufficienti e attendibili valutazioni scientifiche circa gli
effetti che possono essere prodotti da una determinata attività, ma non può
certo essere addotto dai destinatari di una normativa comunitaria ad esso
ispirata per negarle attuazione.
Altra decisione di interesse, ai
presenti fini, è la sentenza n.
In ragione di queste argomentazioni,
le due leggi regionali violerebbero, in definitiva, l’art. 117, primo comma, della
Costituzione, nonché la competenza esclusiva statale in materia di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’art 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione.
Le norme interposte che sarebbero
state specificamente violate dalle disposizioni impugnate – e cioè gli articoli
22 e 23 della direttiva 2001/18/Ce
e l’art. 25 del d.lgs. n. 224 del 2003 – si riferiscono esclusivamente al commercio
degli alimenti contenenti organismi geneticamente modificati: sia la direttiva
europea che il d.lgs. n. 224 del 2003 distinguono nettamente la disciplina
della «emissione deliberata di ogm
per qualsiasi fine diverso dall’immissione in commercio» da quella concernente
la «immissione in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti». La
asserita violazione del primo comma dell’art. 117 Cost. da parte di
disposizioni delle leggi regionali impugnate, che riguardano soltanto tipiche
forme di immissioni di ogm nei
settori dell’agricoltura e della zootecnia, non può dunque conseguire alla
violazione di disposizioni che regolano il diverso profilo della immissione in
commercio di ogm.
Lo stesso riferimento alla presunta
violazione da parte delle disposizioni regionali impugnate della competenza
esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente viene solo accennata
in relazione al presunto contrasto delle discipline impugnate con i poteri
riconosciuti al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio per
l’attuazione delle prescrizioni contenute nella direttiva europea e nella
legislazione nazionale. La genericità e l’incompiutezza della censura rendono,
anche per questa parte, il ricorso inammissibile.
3.
Il riparto di competenze legislative
La massima parte delle decisioni che
3.1.
Le materie di competenza esclusiva dello Stato
Attraverso le proprie pronunce,
La sentenza n. 449 affronta,
tra le altre, una questione concernente la portata dell’art. 117, secondo
comma, lettera a), relativamente alla materia «politica estera».
Con una interpretazione conforme a
Costituzione,
Con riferimento alla materia
«immigrazione», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera b), della
Costituzione, deve segnalarsi, in primo luogo, la sentenza n. 50, nella
quale si rileva che vanno ricondotte a tale materia, in cui allo Stato è
riconosciuta competenza esclusiva, le funzioni amministrative relative alla
gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all’Unione
europea e all’autorizzazione per attività lavorative all’estero.
Con la sentenza n. 201 si
dichiara che le competenze statutarie della Provincia di Bolzano non risultano
violate dalle disposizioni, dettate dal decreto legge 9 settembre 2002, n. 195
(art. 1, commi 1, 4 e 5), in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari.
La normativa censurata va, infatti,
ricondotta alla materia dell’immigrazione, e non è dunque contemplata tra le
attribuzioni statutarie della Provincia ricorrente.
Le disposizioni impugnate, motiva
Con la sentenza n. 300,
Nella sentenza n. 431,
Richiamandosi alle principali
affermazioni contenute nella sentenza n. 228 del 2004,
Non contrastano, invece, con i
parametri costituzionali evocati dallo Stato le disposizioni della legge della
Provincia di Bolzano e della legge della Regione Marche, che disciplinano tanto
il potere di programmazione, anche per il tramite della fissazione di linee
guida, e di vigilanza, quanto quello di dettare criteri per l’approvazione dei
progetti di sevizio civile, in quanto, in questo ambito, sia
Peraltro, continua
Pertanto, ove questo intreccio di
competenze tra Stato, Regioni e Province autonome si realizzi, rientra nei
poteri delle Regioni e delle Province autonome orientare lo sviluppo delle
iniziative attinenti al servizio civile nazionale da svolgersi sul territorio
regionale o provinciale in senso conforme alle linee di indirizzo seguite dalle
stesse nei vari settori interessati all’attuazione dei progetti, purché non in
contrasto con gli indirizzi e le caratteristiche risultanti dalla normativa
statale, come pure stabilire ordini di priorità e criteri ulteriori, ma
specificativi di quelli nazionali, cui attenersi nella approvazione dei
progetti, vigilando sull’attuazione degli stessi.
In definitiva, le norme impugnate si
prestano ad una lettura rispettosa sia della programmazione statale sia della
uniforme delineazione delle caratteristiche di base dei progetti e, al
contempo, capace di cogliere i bisogni delle diverse aree, in vista
dell’attuazione degli interventi nell’ambito delle diverse competenze in gioco.
Infondato risulta anche il ricorso
avverso l’art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Provincia di
Bolzano, che attribuisce alla Provincia stessa il compito di promuovere la
formazione di base dei volontari per supposto contrasto con l’art. 11, comma 3,
del decreto legislativo n. 77 del 2002.
Sottolinea, in proposito,
Pertanto,
La declaratoria di incostituzionalità
colpisce, invece, l’art. 14, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7 del 2004,
nella parte in cui demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina, tra i
benefici previsti a favore dei volontari del servizio civile nazionale, anche
dei crediti formativi per la formazione universitaria e professionale.
In questa prospettiva, tale
incentivazione rientra nell’organizzazione unitaria del servizio civile nazionale,
come tale eccedente la competenza provinciale e di esclusiva spettanza dello
Stato.
Un parziale accoglimento riceve anche
la questione avverso l’art. 14, comma 1, lettera b), della legge
provinciale n. 7 del 2004, che demanda ad un regolamento di esecuzione la
disciplina delle modalità e dei requisiti per l’iscrizione all’albo provinciale
degli enti di servizio civile.
L’art. 5 del decreto legislativo n.
77 del 2002 prevede che presso l’Ufficio nazionale è tenuto l’albo nazionale
cui possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 3 della legge n. 64 del 2001 ai fini della presentazione di
progetti per il servizio civile nazionale e che le Regioni e le Province
autonome provvedono all’istituzione di albi su scala regionale o provinciale,
nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei
medesimi requisiti svolgenti attività esclusivamente in ambito regionale e
provinciale.
Pertanto, la norma della legge
provinciale, là dove prevede il potere della Provincia di stabilire, con
proprio regolamento, requisiti ai fini dell’iscrizione all’albo, ulteriori
rispetto a quelli fissati dalla legge statale, detta una misura direttamente
incidente sull’organizzazione del servizio civile nazionale e sull’accesso ad
esso, e perciò viola la competenza esclusiva statale in materia, in mancanza di
alcun titolo legittimante da parte dello statuto speciale.
Sempre in relazione all’iscrizione
all’albo,
Ad avviso della Corte, la norma
denunciata è priva di contenuto lesivo, essendo meramente strumentale ad una
ricognizione delle realtà organizzative del servizio nazionale presenti sul
territorio regionale, tanto più che la detta iscrizione non condiziona
l’accesso al servizio, come è reso palese dal fatto che, secondo la stessa
legge regionale sono ammessi a svolgere il servizio civile nazionale nel
territorio regionale i soggetti previsti dalla normativa statale vigente.
Altre questioni riguardanti le
disposizioni della legge della Regione Marche, che attribuiscono alla Regione
le attività connesse alla stipulazione dei contratti di servizio civile,
prevedono l’emanazione di un bando regionale anche per i progetti di servizio civile
nazionale e stabiliscono che l’avvenuta prestazione del servizio civile
regionale preclude la possibilità di presentare ulteriore domanda, vengono
dichiarate non fondate in quanto possono essere interpretate nel senso di
riferirsi esclusivamente al servizio civile regionale.
Non fondata si rivela, infine, la
censura che investe gli articoli 12 e 13 della legge della Regione Marche, che
riguardano l’istituzione del fondo per il sistema regionale del servizio civile
e le disposizioni finanziarie ai fini della copertura degli oneri derivanti
dall’attuazione della legge.
Infatti, la legge n. 64 del 2001, che
prevede l’istituzione del fondo nazionale per il servizio civile, costituito
dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato e dagli
stanziamenti per il servizio civile nazionale di Regioni, Province, enti locali
ed altri enti pubblici e privati colloca il fondo stesso presso l’Ufficio
nazionale per il servizio civile, che l’amministra formulando annualmente un
piano di intervento, sentita
Pertanto, la confluenza nel fondo per
il sistema regionale del servizio civile di quote delle risorse del fondo
nazionale non implica il denunciato finanziamento, con risorse nazionali, degli
interventi del servizio civile regionale poiché le quote da ripartire
mantengono la loro originaria caratterizzazione finalistica, ciò che esclude
qualsiasi sottrazione di fondi destinati al servizio civile nazionale.
3.1.4. «Tutela della concorrenza»
Sulla «tutela della concorrenza»,
Con la sentenza n. 134, avente
ad oggetto l’art. 4, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(finanziamento di contratti di programma nei settori dell’agricoltura e della
pesca),
Al riguardo,
Ma l’elemento più significativo è
dato dal fatto che la dimensione macroeconomica dell’intervento previsto dalla
nuova disciplina è assicurata, come nel caso dell’art. 67 della legge n. 448
del 2001, dallo strumento usato (cfr. sentenza n. 272 del 2004) e cioè dal
ricorso ai contratti di programma, i quali hanno la funzione, insieme ad altri
strumenti che rientrano nella più lata nozione di programmazione negoziata, di
stimolare la crescita economica e rafforzare la concorrenza sul piano nazionale.
E non è senza significato che la programmazione negoziata rientri tra gli
strumenti di politica economica previsti dal documento di programmazione
economica e finanziaria per il periodo 2004-2007.
Si tratta, dunque, di interventi
finanziari che rientrano nella materia della tutela della concorrenza di cui
all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e sono di
pertinenza esclusiva dello Stato, per cui non lede
Né vale richiamare la deliberazione
del Cipe, la quale ha deciso di
«regionalizzare» i finanziamenti in questione, nel duplice senso di reimpiegare
nell’ambito del territorio regionale i finanziamenti già concessi e poi
revocati e di prevedere la facoltà per
La sentenza n.
Preliminarmente, osserva
La (pretesa) modestia dell’intervento
statale non determina, quindi, di per sé l’estraneità alla materia di cui alla
lettera e) dell’art. 117, secondo comma, Cost., ma potrebbe semmai
costituire sintomo della manifesta irrazionalità della pretesa dello Stato di
porre in essere, attraverso quell’intervento, uno strumento di politica
economica idoneo ad incidere sul mercato; in breve, le scelte del legislatore
sono, in questa materia, censurabili solo quando «i loro presupposti siano
manifestamente irrazionali e gli strumenti di intervento non siano disposti in
una relazione ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi attesi»
(sentenza n. 14 del 2004). Pertanto, «il criterio della proporzionalità e
dell’adeguatezza appare essenziale per definire l’ambito di operatività della
competenza legislativa statale attinente alla “tutela della concorrenza” e
conseguentemente la legittimità dei relativi interventi statali» (sentenza n.
272 del 2004).
Nel caso di specie, la norma
censurata rivela pianamente la sua natura di «ragionevole e proporzionato»
intervento statale nell’economia volto a promuovere lo sviluppo del mercato
attraverso una campagna che diffonda, con il marchio «made in Italy»,
un’immagine dei prodotti italiani associata all’idea di una loro particolare
qualità: dove è evidente la presenza di un rapporto, che certamente non può
ritenersi irragionevole tra lo strumento impiegato e l’obiettivo (di sviluppo
economico del Paese) che si è prefisso il legislatore statale, così come è
evidente che sussiste il requisito dell’adeguatezza per ciò solo che lo
strumento impiegato, per sua natura, suppone che sia predisposto e disciplinato
dallo Stato perché solo lo Stato può porre in essere strumenti di politica
economica tendenti a svolgere sull’intero mercato nazionale un’azione di
promozione e sviluppo (sentenza n. 303 del 2003).
È ben vero che, dichiaratamente, il
comma 61 dell’art. 4 mira alla diffusione all’estero (nei mercati mediterranei,
dell’Europa continentale e orientale) del «made in Italy», ma tale
previsione, lungi dall’implicare la riconducibilità alla (ovvero una
commistione con la) materia del «commercio con l’estero», esprime soltanto
l’auspicata ripercussione sul commercio con l’estero dell’intervento statale
volto alla diffusione di un’idea di qualità dei prodotti (in generale) di
origine italiana. La circostanza che un intervento di pertinenza dello Stato
abbia in futuro ricadute (anche) su un settore dell’economia soggetto alla
potestà legislativa concorrente non comporta interferenze tra materie.
L’inquadramento della disciplina de
qua nella materia-funzione della «tutela della concorrenza» esclude che
possa ravvisarsi una violazione del precetto di cui all’art. 117, sesto comma,
Cost., per il fatto che il regolamento disciplinante «le indicazioni di origine
e l’istituzione ed uso del marchio» sia emanato dal Ministro delle attività
produttive (di concerto con altri) senza coinvolgimento delle Regioni.
Per quanto riguarda i compiti
attribuiti alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze,
Attesa la natura del marchio «made
in Italy», quale si è in precedenza tratteggiata, non è pertinente l’invocazione,
da parte della Regione ricorrente, delle materie, di competenza concorrente,
della «ricerca scientifica e tecnologica» e del «sostegno all’innovazione per i
settori produttivi», essendo evidente che il «supporto formativo e scientifico»
di cui parla la norma censurata, per ciò solo che mira alla «diffusione del “made
in Italy”», è funzionale unicamente all’efficacia della comunicazione e,
quindi, della promozione di prodotti (in quanto) italiani.
Più pertinente appare il richiamo
alla materia del «commercio con l’estero», specie se visto in connessione –
come sottolinea
In proposito, tuttavia, l’attività
istituzionale della Scuola – come si evince dalla previsione che essa «è svolta
prioritariamente dal personale di ruolo» – ha come principale destinatario il «personale
dell’amministrazione dell’economia e delle finanze, nonché, su richiesta delle
agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalità e
dell’economia, il personale di questi ultimi» (art. 1, comma 2, d.m. 28
settembre 2000, n. 301): il che, unitamente al fatto che la disciplina in esame
deve ricondursi, come si è chiarito, alla materia di cui all’art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost., rende evidente come ad un organismo statale,
quale è
Altrettanto evidente è che tale
attività ben potrà essere svolta anche dalle Regioni nei corsi di formazione da
esse organizzati e che sarebbe auspicabile una «leale collaborazione» tra
3.1.5. «Sistema tributario e contabile dello Stato»
Nella sentenza n. 335, si dichiara
l’incostituzionalità dell’art. 44, comma 3, della legge della Regione
Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7, nella parte in cui rimette a deliberazione
della Giunta il metodo di fissazione del tributo per il deposito in discarica
dei rifiuti, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in
materia di sistema tributario e contabile dello Stato. Motiva, al riguardo,
Nella sentenza n. 397,
3.1.6. «Ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali»
La materia concernente l’ordinamento
e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali è
venuta in considerazione sotto diversi profili, e segnatamente quello del
reclutamento del personale (sentenza n. 26), quello del contenimento
della spesa pubblica (sentenza n. 37), quello collegato alla disciplina
degli Ordini e Collegi professionali (sentenza n. 405) e quello del
personale scolastico (sentenza n. 279).
Secondo quanto si stabilisce nella
sentenza n. 26, l’art. 2 della legge della Regione Toscana 4 agosto
2003, n. 42, là dove disciplina il reclutamento del personale delle pubbliche
amministrazioni per le qualifiche ed i profili per i quali sia richiesta la
sola scuola dell’obbligo, risulta lesivo delle competenze esclusive dello Stato
in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato stesso e
degli enti pubblici nazionali, nella parte in cui include le amministrazioni
statali e gli enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale.
Al riguardo, ricorda
Peraltro, anche il più recente
complesso normativo costituito dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), contenente anche la disciplina dei
servizi per l’impiego ed in particolare del collocamento, espressamente ne
esclude l’applicabilità al personale delle pubbliche amministrazioni. La
formazione dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni costituisce
quindi – come regola generale – oggetto di disciplina autonoma, ciò che è
contraddetto dalla disciplina regionale impugnata, la quale incide direttamente
sui modi del reclutamento e sui contenuti e sugli effetti di tale reclutamento
in relazione al personale delle sedi centrali e degli uffici periferici di
amministrazioni ed enti pubblici a carattere nazionale.
Pertanto, conclude
Oggetto dell’impugnativa decisa con
la sentenza n. 405 sono gli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione
Toscana 28 settembre 2004, n. 50, che definisce le modalità di raccordo tra
Ritiene
La vigente normazione riguardante gli
Ordini e i Collegi, continua
Dalla dimensione nazionale – e non
locale – dell’interesse sotteso e dalla sua infrazionabilità deriva che ad
essere implicata sia la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l’art. 117, secondo comma,
lettera g), della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello
Stato, piuttosto che la materia «professioni» di cui al terzo comma del
medesimo articolo 117 della Costituzione, evocata dalla resistente.
Per tali motivi, gli impugnati
articoli 2 e 3 della legge regionale, in quanto istituiscono e attribuiscono
funzioni ai coordinamenti regionali, devono dichiararsi costituzionalmente
illegittimi. Da tale illegittimità consegue altresì l’illegittimità
costituzionale dell’art. 4 della medesima legge, perché, pur istituendo un
organo regionale con compiti consultivi, prevede in esso la partecipazione di
rappresentanti dei predetti coordinamenti, come sopra ritenuti illegittimamente
costituiti.
Nell’esaminare l’impugnativa,
proposta dalle Regioni Emilia-Romagna e Friuli – Venezia Giulia, di numerose
disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, che detta le
norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53,
Priva di fondamento risulta, pure, la
censura riferita agli art. 7, commi 5, secondo periodo, e 6, e art. 10, comma
5, secondo periodo, che prevedono – rispettivamente per la scuola primaria e
secondaria, indicandone anche, quanto alla scuola primaria, l’impegno orario
minimo – la figura del cosiddetto tutor, definito come il docente in
possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e
con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività
facoltative, di «tutorato» degli allievi, di coordinamento delle attività
educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della
documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo, con l’apporto
degli altri docenti. Nella specie, infatti, tali norme non possono qualificarsi
norme di dettaglio, in quanto la definizione dei compiti e dell’impegno orario
del personale docente, dipendente dallo Stato, rientra nella competenza statale
esclusiva di cui all’art. 117, comma secondo, lettera g), della
Costituzione, trattandosi di materia attinente al rapporto di lavoro del
personale statale.
3.1.7. «Ordine pubblico e sicurezza»
La materia «ordine pubblico e
sicurezza» è stata esaminata in due decisioni.
Con la sentenza n. 95 sono
state decise questioni concernenti leggi regionali che, eliminando l’obbligo
del libretto di idoneità sanitaria, di cui all’art. 14 della legge 30 aprile
1962, n. 283, per il personale addetto alla produzione e vendita di alimenti e
per il personale delle farmacie, si riteneva che violassero la competenza
legislativa esclusiva statale di cui al secondo comma, lettera h),
dell’art. 117 della Costituzione.
Anche la sentenza n. 383 si
sofferma sul profilo definitorio, sottolineando come la materia «ordine
pubblico e sicurezza» riguardi solo gli interventi finalizzati alla prevenzione
dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico (cfr. sentenze n. 407 del
2002, n. 6, n. 162, n. 428 del 2004 e n. 95 del 2005), e non certo la sicurezza
tecnica o la sicurezza dell’approvvigionamento dell’energia elettrica (mentre
eventuali turbative dell’ordine pubblico in conseguenza di gravi disfunzioni
del settore energetico potrebbero semmai legittimare l’esercizio da parte del
Governo dei poteri di cui all’art. 120, secondo comma, della Costituzione).
3.1.8. «Giurisdizione e norme processuali»
Tra le molte questioni che sono state
decise nelle sentenze nn. 50 e 384 alcune hanno riguardato i
confini della materia «giurisdizione e norme processuali».
Ad avviso della Corte, devono essere
ricondotte ad essa quelle disposizioni della c.d. legge Biagi (legge n. 30 del
2003) volte a condizionare l’esercizio in giudizio di diritti nascenti dal
contratto di lavoro e la stessa attività dei giudici. In particolare, nella
sentenza n. 50,
Sulla base di questo assunto, nella
sentenza n. 384, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
Parimenti, vanno ricondotte alla
materia «giurisdizione e norme processuali» le funzioni amministrative relative
alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché
alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale per
l’incidenza che la previsione e la regolamentazione del tentativo di
componimento bonario delle liti possono avere sullo svolgimento del processo.
Sulla base di questa ratio, sempre nella sentenza n. 50,
Nella sentenza n.
L’istituto della conciliazione
rientra nell’ordinamento civile, ma riguarda anche la giurisdizione e
l’applicazione di norme processuali, tutte materie di esclusiva competenza
statale e tali da comportare la disciplina uniforme su tutto il territorio
nazionale; pertanto
Allo stesso modo deve essere
ricondotta all’ordinamento civile e all’applicazione di norme processuali la
disciplina della diffida accertativa per crediti patrimoniali.
Sempre nella sentenza n. 384,
Sulla materia «ordinamento civile»,
a) Nella sentenza n. 50
Va ricondotta alla materia
ordinamento civile anche la disciplina del contratto a tempo parziale come del
resto la disciplina intersoggettiva di qualsiasi rapporto di lavoro. Sulla base
di questo assunto,
Nella stessa decisione
Allo stesso modo rientrano nella
materia «ordinamento civile» le funzioni amministrative relative alla
conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla
risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale. Infatti,
«la conciliazione delle controversie di lavoro, rispetto alla quale le funzioni
amministrative sono strettamente strumentali, non rientra nella materia della
tutela e sicurezza del lavoro, bensì in quella dell’ordinamento civile, in
quanto concernente la definizione transattiva delle controversie stesse».
Analoga collocazione competenziale è
da attribuirsi alle disposizioni della c.d. legge Biagi che contengono norme
sulla somministrazione di manodopera o di lavoro altrui e sui rapporti che da
essa nascono tra fornitore ed utilizzatore e sui diritti dei lavoratori.
Anche le disposizioni che riguardano
la distinzione tra appalto lecito e interposizione vietata sono da ricondurre
all’ordinamento civile.
Anche la disposizione contenuta nel
n.
Sempre nella sentenza n. 50,
Si dichiara, inoltre, non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli articoli 51 (concernente i
crediti formativi che si acquisiscono attraverso il contratto di apprendistato
ed il loro riconoscimento), 52 (concernente le qualifiche professionali) e 53
(concernente «incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali»)
del d.lgs. n. 276 del 2003. Infatti, in relazione all’art. 51, la disciplina
dei rapporti intersoggettivi tra datore e lavoratore, compresa la formazione
all’interno dell’azienda, appartiene alla competenza dello Stato e giustifica
così la disciplina statale del riconoscimento dei crediti stessi, mentre il
coinvolgimento delle Regioni è assicurato mediante lo strumento più pregnante
di attuazione del principio di leale collaborazione e cioè attraverso l’intesa.
In relazione all’art. 52, le qualifiche professionali, la cui armonizzazione la
norma disciplina, sono strettamente collegate ai crediti formativi ed il
coinvolgimento regionale è assicurato dalla partecipazione dei rappresentanti
della Conferenza Stato-Regioni all’organismo all’uopo istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In relazione all’art. 53,
parzialmente modificato dal decreto correttivo n. 251 del 2004, si rileva che
esso contiene norme rientranti nell’ordinamento civile (categorie
d’inquadramento degli apprendisti); nel suo comma 2 contiene norme concernenti
l’ordinamento civile e principî fondamentali in tema di tutela e sicurezza del
lavoro, a seconda degli istituti rispetto ai quali operano i limiti numerici
nel cui computo non rientrano gli apprendisti; nel comma 3 contempla, in primo
luogo, il mantenimento in via provvisoria della disciplina degli incentivi ed
inoltre «il principio che questi sono condizionati alla verifica della
formazione svolta secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, d’intesa con
Del pari, rientra nell’ambito
dell’ordinamento civile la disciplina del contratto di inserimento e quella dei
tirocini estivi di orientamento. Sulla base di questa ratio
b) In merito alla disciplina della legalizzazione del
lavoro irregolare di extracomunitari,
Con la sentenza n. 234,
Le censure proposte, investono, nella
sostanza, le norme relative all’istituzione ed all’attività dei «Comitati per
il lavoro e l’emersione del sommerso» (Cles)
con i correlativi effetti e, quindi, solo la prima delle due fasi che
compongono la procedura di emersione progressiva del lavoro irregolare.
Le norme riguardano il progressivo
adeguamento, da parte degli imprenditori, agli obblighi di legge relativi a
«materie diverse da quella fiscale e contributiva» e agli obblighi previsti dai
contratti collettivi di lavoro in materia di trattamento economico.
L’adeguamento si realizza previa presentazione di «piani individuali di
emersione», contenenti proposte dirette alla graduale regolarizzazione di detti
obblighi, da approvarsi dai Cles
e da realizzarsi nel termine indicato dalla legge.
Questa prima fase, dopo l’approvazione
dei piani individuali di emersione, sfocia necessariamente nella seconda fase,
introdotta dall’obbligatoria presentazione, sempre da parte degli imprenditori,
di apposite «dichiarazioni di emersione» degli inadempimenti agli obblighi
stabiliti dalla normativa vigente «in materia fiscale e previdenziale».
Ritiene al riguardo
L’intento del legislatore è di
raggiungere l’obiettivo del rilancio dell’economia favorendo «l’emersione
dall’economia sommersa», attraverso una disciplina transitoria che mantenga
inalterata la funzionalità economica delle imprese emergenti. Gli strumenti
predisposti sono un appropriato regime di incentivo fiscale e previdenziale e
l’attribuzione agli imprenditori della facoltà di ritardare l’adeguamento agli
obblighi rimasti inadempiuti, secondo le modalità previste da piani individuali
di emersione
In questo contesto, i Cles, ai sensi dei censurati commi 5 e
8 dell’art. 1-bis, svolgono l’importante funzione di modulare l’intervento
pubblico nella delicata materia della progressiva regolarizzazione dei rapporti
irregolari di lavoro, al fine di realizzare gradualmente l’uniforme adempimento
degli obblighi degli imprenditori.
L’attività svolta dai Cles a livello decentrato – e,
segnatamente, l’attività di approvazione dei piani e di formulazione di
eventuali proposte di modifica – si inserisce in una procedura idonea ad
integrare il contratto individuale di lavoro secondo il contenuto dei piani
individuali di emersione approvati e, quindi, ad incidere sui tempi e sulle
modalità di adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva, nonché specificamente sul trattamento economico
pattuito con il contratto individuale di lavoro. In virtù della procedura
gestita dai Cles, i contratti
individuali di lavoro, originariamente irregolari, si trasformano gradualmente
in contratti conformi ai suddetti obblighi e prescrizioni, generando nuovi
impegni degli imprenditori, che valgono, da un lato, a modificare la precedente
regolamentazione convenzionale e, dall’altro, a garantire ulteriormente
l’adempimento degli obblighi di legge in materie diverse da quella fiscale e
previdenziale.
L’assunzione di tali impegni, potendo
incidere sull’autonomia negoziale in funzione della regolarizzazione del
lavoro, soddisfa pertanto l’esigenza – strettamente connessa al principio
costituzionale di eguaglianza – di assicurare, decorso il periodo transitorio
previsto dalla citata legge n. 383 del 2001 (art. 1-bis, comma 2, lettera a), l’applicazione uniforme di quelle
regole e di quei principî generali disciplinanti i rapporti individuali di
lavoro fra privati, che gli imprenditori avevano omesso di applicare.
In materia di trattamento economico,
tale intento uniformatore è reso ancora più evidente dall’estensione del regime
di emersione progressiva agli imprenditori che avevano già fatto ricorso allo
strumento agevolativo dei contratti di riallineamento retributivo di cui al
decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e che non erano riusciti a rispettare gli
obblighi assunti in forza di tali contratti. La possibilità di accedere ai
programmi di emersione progressiva offerta a tali imprenditori è giustificata,
infatti, dalla fungibilità dei due regimi, in ragione della finalità ad essi
comune di garantire ai lavoratori un trattamento retributivo uniforme.
La speciale disciplina contenuta
nelle norme denunciate, essendo idonea a modificare a fini di uniformità
l’originario regolamento contrattuale, attiene dunque – in modo caratterizzante
– all’esercizio dell’autonomia negoziale in tema di contratti di lavoro e deve
perciò essere ricondotta, secondo un criterio di prevalenza, alla materia
dell’«ordinamento civile», ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost. e, quindi, all’esclusiva sfera di competenza legislativa dello Stato.
Se poi si considera che la fase di
emersione progressiva oggetto di censura culmina in quella di regolarizzazione
fiscale e previdenziale disciplinata dall’art. 1 e che quest’ultima è
sicuramente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai
sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e)
ed o) della Costituzione, appare
coerente al disegno complessivo del legislatore ritenere che la prima fase si
coordini con la finalità di «incentivo fiscale e previdenziale» e che, di
conseguenza, anch’essa sia riconducibile, seppure a titolo diverso, alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato.
La disciplina dell’emersione progressiva
del lavoro irregolare, rientrante nella materia dell’«ordinamento civile», è,
perciò, del tutto diversa per oggetto e funzioni dagli ambiti settoriali
invocati dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Ciò è sufficiente per
escludere la lamentata lesione di competenze statutarie.
Neppure sussiste la competenza
legislativa residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost., invocata dalle
Province autonome ricorrenti in forza della «clausola di maggior favore»
prevista in via transitoria dall’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001, anche con riferimento alla asserita esistenza di una «materia
dell’impresa», per la parte di disciplina non inclusa nella competenza relativa
alla «tutela e sicurezza del lavoro». Il criterio di prevalenza che ha portato
ad accertare l’esclusiva competenza legislativa dello Stato in materia di
«ordinamento civile» non consente né di far rientrare le norme denunciate nella
competenza residuale né, comunque, di effettuare la comparazione tra le forme
di autonomia garantite dalla Costituzione e quelle statutarie richiesta dal
citato art. 10.
L’applicazione del criterio della
prevalenza per la risoluzione dell’interferenza tra la norma censurata e le
competenze legislative provinciali, in presenza dell’accertata appartenenza del
nucleo essenziale della disciplina denunciata alla materia dell’ordinamento
civile, esclude, infine, l’operatività del principio di leale collaborazione,
invocato dalle ricorrenti sotto il profilo sia legislativo che amministrativo.
c) La sentenza n. 106 dichiara
costituzionalmente illegittimo l’art. 12 della legge della Provincia autonoma
di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15, dove si prevede l’intervento pubblico di
assistenza, nei confronti dei minori in condizioni di disagio economico, in
caso di inadempienza del genitore obbligato alla corresponsione dell’assegno di
mantenimento mediante l’anticipazione delle somme al genitore o al soggetto
affidatario e con surrogazione legale dell’ente pubblico nel diritto di
credito. Al riguardo, motiva
Poiché si tratta di un istituto del
diritto civile destinato a regolare gli effetti del pagamento di una
obbligazione da parte di soggetto diverso dall’obbligato, non può dubitarsi che
esso rientri nella nozione di «ordinamento civile» di cui all’art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost.: di conseguenza, devesi affermare che gli
«altri casi previsti dalla legge», cui fa riferimento la norma, non possono
essere che quelli disciplinati espressamente da altra legge statale.
In caso contrario, nell’ordinamento
si creerebbe la possibilità di introdurre, mediante leggi regionali o delle
Province autonome, ipotesi di surrogazione legale con la conseguenza che
verrebbe frustrata l’esigenza di una disciplina uniforme su tutto il territorio
nazionale di un modo di adempimento delle obbligazioni e dell’effetto
dell’adempimento da parte di un terzo.
d)
In via preliminare, si considera il
problema della collocazione, rispetto al riparto di competenze fra Stato e
Regioni di cui al Titolo V della Costituzione, della legislazione censurata,
incidente sulla tutela dei dati personali ed, al riguardo, ricorda che il
d.lgs. n. 196 del 2003 attualmente vigente coordina in un testo unico la
normativa originata dal recepimento di numerose direttive comunitarie adottate
in materia per tutelare in modo organico il trattamento dei dati personali
(esplicitamente definiti come «qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione»),
riferendosi all’intera serie dei fenomeni sociali nei quali questi possono
venire in rilievo. Da ciò una disciplina che, pur riconoscendo tutele
differenziate in relazione ai diversi tipi di dati personali ed alla grande
diversità delle situazioni e dei contesti normativi nei quali tali dati vengono
utilizzati, si caratterizza essenzialmente per il riconoscimento di una serie
di diritti alle persone fisiche e giuridiche relativamente ai propri dati,
diritti di cui sono regolate analiticamente caratteristiche, limiti, modalità
di esercizio, garanzie, forme di tutela in sede amministrativa e
giurisdizionale.
Per
Peraltro, pur nell’ambito di questa
esclusiva competenza statale, la legislazione vigente prevede anche un ruolo
normativo, per quanto di tipo meramente integrativo, per i soggetti pubblici
chiamati a trattare i dati personali, per la necessità che i principî posti
dalla legge a tutela dei dati personali siano garantiti nei diversi contesti
legislativi ed istituzionali; in questi ambiti possono quindi essere adottati
anche leggi o regolamenti regionali, ma solo in quanto e nella misura in cui
ciò sia appunto previsto dalla legislazione statale.
Pertanto, il legislatore regionale
può disciplinare procedure o strutture organizzative che prevedono il
trattamento di dati personali, pur ovviamente nell’integrale rispetto della
legislazione statale sulla loro protezione: infatti, le Regioni, nelle materie
di propria competenza legislativa, non solo devono necessariamente prevedere
l’utilizzazione di molteplici categorie di dati personali da parte di soggetti
pubblici e privati, ma possono anche organizzare e disciplinare a livello
regionale una rete informativa sulle realtà regionali, entro cui far confluire
i diversi dati conoscitivi (personali e non personali) che sono nella
disponibilità delle istituzioni regionali e locali o di altri soggetti interessati.
Ciò, tuttavia, deve avvenire nel rispetto degli eventuali livelli di
riservatezza o di segreto, assoluti o relativi, che siano prescritti dalla
legge statale in relazione ad alcune delle informazioni, nonché con i consensi
necessari da parte delle diverse realtà istituzionali o sociali coinvolte.
Sulla base di quanto affermato, viene
dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge della
Regione Emilia-Romagna n. 11 del
Innanzitutto, disponendo che,
mediante apposito regolamento regionale, sia disciplinata la «cessione dei dati
costitutivi del patrimonio informativo pubblico a privati ed enti pubblici
economici», non tiene conto che l’istituto della «cessione» dei dati personali
è del tutto estraneo alla legislazione statale in materia di protezione di tali
dati.
In secondo luogo, il comma 2
dell’art. 12 prevede che
In terzo luogo, nel medesimo comma 2,
si prevede un obbligo per «le associazioni e i soggetti privati che operano in
ambito regionale per finalità di interesse pubblico» di fornire «la
disponibilità dei dati contenuti nei propri sistemi informativi», sia pure «nei
limiti previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003». E tuttavia un obbligo
del genere non è previsto dal Codice, caratterizzato, piuttosto, dalla normale
preminenza della volontà dell’interessato in ordine al trattamento dei propri
dati personali e dal fatto che questi sono raccolti ed utilizzati per scopi
determinati.
Sono altresì fondate le censure mosse
contro l’art.13 della legge regionale n. 11 del 2004, per la parte in cui
assume rilevanza l’assenza di ogni riferimento espresso al doveroso rispetto
della normativa a tutela dei dati personali: infatti, l’art. 13 configura un
vero e proprio sistema informativo regionale, nel quale confluiscono molteplici
dati anche personali, sia ordinari che sensibili, provenienti da diverse
pubbliche amministrazioni. Senza tener conto che tali dati possono essere
utilizzati solo nei limiti e con tutte le garanzie poste dalla legge statale a
tutela della protezione dei dati personali. Il mancato richiamo, da parte della
disposizione censurata, di tali garanzie e limiti, e dunque l’utilizzabilità
dei dati personali nell’ambito del Sir,
determina l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 13 della legge
regionale n. 11 del 2004.
Non constano, nel 2005, decisioni
nelle quali la materia «ordinamento penale» venga trattata in maniera
analitica. Merita, comunque, di essere menzionata la sentenza n. 172,
con cui
Pur senza essere oggetto di disamine
analitiche, la competenza in materia di «determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» è stata oggetto di
molteplici richiami. Di seguito se ne riportano alcuni dei più significativi
(rimandando, per gli altri, alle affermazioni contenute in decisioni che hanno
precipuamente riguardo ad altri ambiti materiali).
La sentenza n. 287, riprendendo quanto affermato nella sentenza n. 423 del 2004,
stabilisce che le norme che pongono vincoli nell’assegnazione alle Regioni
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dall’art.
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), non determinano livelli essenziali
delle prestazioni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., ma si limitano a prevedere
somme a destinazione vincolata.
Secondo quanto sostenuto nella
sentenza n. 271, improprio appare il
riferimento alla competenza in tema di «determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», in relazione alla
legislazione sui dati personali, dal momento che essa non concerne prestazioni,
bensì la stessa disciplina di una serie di diritti personali attribuiti ad ogni
singolo interessato, consistenti nel potere di controllare le informazioni che
lo riguardano e le modalità con cui viene effettuato il loro trattamento.
Nella sentenza n. 383 si è sottolineato come il potere di
predeterminare eventualmente – sulla base di apposite disposizioni di legge – i
«livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali»,
anche nelle materie che
Infine, nella sentenza n. 467,
3.1.12. «Norme generali sull’istruzione»
La
disciplina relativa all’istruzione è oggetto di diversi titoli competenziali.
Di seguito si riportano due decisioni che hanno avuto prevalentemente riguardo
alle «norme generali sull’istruzione», rinviando ad altre sedi l’analisi di
decisioni incentrate maggiormente su altri titoli.
Immune
da censure viene dichiarata, nella sentenza n. 34, la legge della
Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, che detta norme sul rafforzamento
dell’istruzione e della formazione professionale.
In
particolare, risulta non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 7, comma 5, della legge regionale nella parte in cui prevede in
favore del personale scolastico, che si avvalga del periodo di aspettativa di
cui all’art. 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la possibilità
di usufruire di assegni di studio alle condizioni e secondo le modalità
definite con atto della Giunta regionale, nell’ambito degli indirizzi approvati
dal Consiglio regionale. Al riguardo,
Non
risulta, inoltre, invasivo della competenza statale esclusiva a dettare norme
generali sull’istruzione (art. 117, comma secondo, lettera n) della Costituzione, e art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53),
l’art. 9, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n.
12, il quale disciplina l’istituto dell’«alternanza scuola-lavoro», definendolo
come «modalità didattica, non costituente rapporto di lavoro, realizzata
nell’ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche
integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale
e inserimento nel mondo del lavoro». La disposizione censurata, infatti, lungi
dal contrastare con quanto stabilito dall’art. 4 della legge n. 53 del 2003, si
limita a ripeterne sinteticamente il contenuto definitorio, senza porre principî
o regole ulteriori e senza mettere in discussione la competenza statale nel
definire gli istituti generali e fondamentali dell’istruzione, i quali vengono
soltanto assunti a base della legislazione regionale.
Parimenti,
non si pone in contrasto con la competenza statale esclusiva a dettare norme
generali sull’istruzione l’art. 17 della legge regionale, il quale definisce le
finalità della scuola dell’infanzia. La disposizione, infatti, si propone non
già di fornire la definizione del percorso della scuola dell’infanzia, bensì di
predisporre, nell’ambito di quanto stabilito dalla legge statale (art. 2, comma
1, lettera e, della legge 28 marzo
2003, n. 53) e in forza delle competenze regionali in materia di istruzione,
interventi a supporto di un’offerta formativa in un settore, quale è quello
dell’istruzione per l’infanzia, nel quale sono direttamente coinvolti i
principî costituzionali che riguardano l’educazione e la formazione del minore.
L’art.
117, comma secondo, lettera n), della Costituzione non risulta violato
neppure dall’art. 41 della stessa legge, il quale fornisce la definizione
«dell’educazione degli adulti» e delle relative attività. Tale disposizione,
nel solco di quanto già genericamente previsto dalla disciplina statale (legge
28 marzo 2003, n. 53, art. 2, comma 1, lettera a), specifica i contenuti
dell’«educazione degli adulti», che ricomprende le «opportunità formative,
formali e non formali, rivolte alle persone, aventi per obiettivo
l’acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti, di norma
certificabili, e l’arricchimento del patrimonio culturale», al fine di favorire
il rientro nel sistema formale dell’istruzione e della formazione
professionale, la diffusione e l’estensione delle conoscenze, l’acquisizione di
specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale e il pieno
sviluppo della personalità dei cittadini, ponendosi così in linea con le
finalità individuate dalla legge delega del 2003 ed altresì con quelle
prefigurate in ambito comunitario, operando sul versante del sostegno
all’acquisizione o al recupero di conoscenze necessarie o utili per il
reinserimento sociale e lavorativo e, dunque, in un ambito riconducibile a
quello affidato alla competenza regionale in materia di istruzione e formazione
professionale.
Ed
ancora, non contrasta con i principî di uguaglianza e di buon andamento della
pubblica amministrazione l’art. 26, comma 2, della legge regionale, il quale
stabilisce che, nel quadro del sistema formativo, al fine di realizzare un
positivo intreccio tra apprendimento teorico e applicazione concreta, tra
sapere, saper fare, saper essere e sapersi relazionare, di sostenere lo
sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale, nonché di
consentire l’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 68 della legge
17 maggio 1999, n. 144,
Nella sentenza n. 120,
analogamente,
D’altro canto, la tesi che gli standards
strutturali e qualitativi di cui alla norma impugnata si identificherebbero con
i livelli essenziali delle prestazioni e, quindi, rientrerebbero nella
competenza trasversale ed esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, non può essere condivisa, in
quanto la norma censurata non determina alcun livello di prestazione,
limitandosi ad incidere sull’assetto organizzativo e gestorio degli asili nido,
che risulta demandato alla potestà legislativa delle Regioni.
Sotto un diverso profilo, la
individuazione degli standards strutturali e qualitativi non può
neppure, evidentemente, ricomprendersi nelle norme generali sull’istruzione e
cioè in quella disciplina caratterizzante l’ordinamento dell’istruzione e che,
dunque, presenta un contenuto essenzialmente diverso da quello lato sensu
organizzativo nel quale si svolge la potestà legislativa regionale.
L’operare congiunto dei due titoli
competenziali dell’«ordinamento civile» e della «previdenza sociale» è stato
riscontrato, in primo luogo, nella sentenza n. 50, dove
Il binomio ordinamento civile –
previdenza sociale è poi alla base di molta parte delle argomentazioni
contenute nella sentenza n.
Innanzi tutto,
In particolare, in relazione alle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera d), e dell’art. 8 della legge 14
febbraio 2003, n. 30, il primo dei quali enuncia tra i criteri e principî
direttivi della delega di cui al comma 1 dello stesso articolo «il mantenimento
da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in
materia di lavoro», mentre il secondo delega il Governo ad adottare uno o più
decreti legislativi per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in
materia di previdenza sociale e di lavoro, deve escludersi che sia possibile
determinare la competenza a regolare un’attività di vigilanza indipendentemente
dalla individuazione della materia cui essa si riferisce, e in particolare che
la vigilanza sul lavoro e le ispezioni – che della vigilanza costituiscono una
modalità di esercizio – rientrino comunque nella materia «tutela del lavoro»,
quale che sia lo specifico oggetto sul quale vertono. Non è infatti possibile
determinare la competenza a regolare un’attività di vigilanza indipendentemente
dalla individuazione della materia cui essa si riferisce, mentre la
regolamentazione delle sanzioni amministrative, essendo finalizzata al rispetto
di una normativa dalla quale, ai fini del riparto di competenza legislativa,
riceve la propria connotazione, spetta al soggetto nella cui sfera di
competenza rientra la disciplina della materia, la cui inosservanza costituisce
l’atto sanzionabile. Pertanto, deve escludersi che le deleghe di cui alle
disposizioni censurate, relative alla disciplina dei rapporti intersoggettivi
tra datore di lavoro e lavoratore e alla previdenza sociale, si riferiscano
alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Vengono poi dichiarate non fondate le
questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, primo
periodo, e 6, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, i quali,
rispettivamente, prevedono che «il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle Regioni
ed alle Province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e
irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento
allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla
promozione dell’osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi
compresa l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina
previdenziale» e che «le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di
legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le
direzioni regionali e provinciali del lavoro». Nella specie, peraltro
Si dichiarano non fondate anche le
questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2; 3, commi da
Non fondata è pure la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, relativo ai compiti del personale ispettivo, in quanto la disposizione
censurata si riferisce al personale statale, al personale ispettivo degli enti
previdenziali specificamente indicati al comma 3 dell’art. 6 dello stesso
decreto, nonché a quello degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione
obbligatoria, cui pure si riferisce il citato comma 3, sicché essa deve essere
letta nel senso che il personale ispettivo è quello di enti che comunque
svolgono compiti di previdenza obbligatoria, materia di esclusiva competenza
statale.
Ad analogo esito si giunge per le
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1, 2 e 5, del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante la rubrica Prevenzione e
promozione, in quanto le disposizioni censurate prevedono attività
dirette a promuovere l’osservanza delle norme in materia di lavoro e di
previdenza, di competenza esclusiva dello Stato, con l’utilizzazione di
personale statale o di enti cui è affidata la previdenza obbligatoria, al quale
sono devoluti compiti di consulenza a favore delle imprese e dei datori di
lavoro in genere, anche mediante «indicazioni operative sulle modalità per la
corretta attuazione della predetta normativa».
Sulla base della considerazione,
posta a base di tutta la motivazione della sentenza, che la vigilanza, non può
essere ricondotta alla materia di competenza concorrente «tutela e sicurezza
del lavoro», ma attiene alle materie cui si riferisce,
Nella sentenza n. 50,
Peraltro, la disposizione della legge
n. 30 del 2003, volta a mantenere in capo allo Stato le competenze in materia,
non esclude la facoltà delle Regioni di disciplinare la predisposizione in sede
regionale di sistemi di raccolta dati e deve essere valutata insieme con quelle
del decreto delegato concernenti il sistema suindicato che prevedono strumenti
volti a garantire il coinvolgimento delle Regioni nella gestione del sistema
informatico.
La materia del coordinamento
informativo è stata presa in considerazione anche nell’ambito della sentenza n.
336, avente ad oggetto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
(Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, tra le varie
questioni sollevate, le Regioni ricorrenti censuravano l’allegato n. 13 al
decreto legislativo impugnato, il quale, determinando il contenuto dei modelli
da usare nella presentazione dell’istanza di autorizzazione e della denuncia di
inizio attività, avrebbe integrato l’esercizio di una potestà regolamentare,
che lo Stato non può legittimamente esercitare in materie diverse da quelle
riservate alla sua competenza esclusiva.
Onde dichiarare non fondata la
questione,
Un cenno merita anche la sentenza n. 271. Nell’esaminare le questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 12, 13 e 14 della legge della Regione
Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società
dell’informazione), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri per
violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere l), m) e r), e sesto comma, della Costituzione,
nonché dei principî della legislazione statale in materia di protezione dei
dati personali,
D’altra parte questo esclusivo potere
legislativo statale concerne solo un coordinamento di tipo tecnico che venga
ritenuto opportuno dal legislatore statale e il cui esercizio, comunque, non
può escludere una competenza regionale nella disciplina e gestione di una
propria rete informativa.
Nella sentenza n. 31,
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
dell’art. 26 si riferiscono, innanzitutto, all’amministrazione dello Stato e
degli enti pubblici nazionali: per questa parte, pertanto, esse rinvengono la
propria legittimazione nell’art. 117, secondo comma, lettere g) e r),
della Costituzione, che assegnano alla competenza legislativa esclusiva
statale, rispettivamente, le materie «ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale,
regionale e locale».
Le norme in questione sono
suscettibili, però, di trovare applicazione anche nei confronti delle Regioni e
degli enti locali, come risulta dal terzo comma dello stesso art. 26, il quale
prevede che i progetti – «di cui ai commi 1 e 2» – possono riguardare
«l’organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti
territoriali», e dispone che, in tal caso, è necessario sentire
Sotto tale aspetto, dunque, tali
norme, pur potendo avere una diretta incidenza sulla «organizzazione
amministrativa regionale e degli enti locali», non determinano alcuna violazione
– nei limiti in cui siano garantite adeguate procedure collaborative – delle
competenze della ricorrente. Le disposizioni in esame, infatti, devono essere
interpretate, conformemente a Costituzione, nel senso che le stesse – nella
parte in cui riguardano Regioni ed enti territoriali – costituiscono
espressione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia del
«coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale», ex art. 117, secondo
comma, lettera r), della Costituzione.
Ne consegue, pertanto, che «i
progetti da finanziare» cui fa riferimento il primo comma dell’art. 26 della
legge n. 289 del 2002 – nella misura in cui «riguardino l’organizzazione e la
dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali» (comma 3) –
possono essere esclusivamente quelli aventi una connotazione riconducibile a
siffatta finalità di coordinamento tecnico. Del resto, lo stesso decreto
ministeriale 14 ottobre 2003 di attuazione della disposizione in esame ha
indicato, tra i «progetti finanziabili», anche quelli idonei a promuovere
«l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni» (art. 2, comma 1).
Allo stesso modo, la norma contenuta
nell’art. 26, comma 2, deve essere intesa – nella parte in cui riguarda Regioni
ed enti locali – come attributiva al Ministro della innovazione e delle
tecnologie di un potere limitato ad un coordinamento meramente tecnico. Questa
interpretazione è suffragata dalle medesime finalità indicate nella
disposizione in esame: «assicurare una migliore efficacia della spesa
informatica e telematica»; «generare significativi risparmi eliminando
duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il
riuso»; «indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e
telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia». Sul punto,
È invece fondata l’ulteriore
questione sollevata, relativa al comma 3 dello stesso art. 26, nella parte in
cui dispone che deve essere sentita
3.1.16. «Tutela dell’ambiente [e]
dell’ecosistema»
Ponendosi nel solco di un
orientamento ormai consolidato, nell’anno 2005
In applicazione di tali principî, in
una fattispecie concreta, si è evidenziato – sentenza n. 135 – come la
disciplina sulle attività a rischio rilevante, incidendo su una pluralità di
interessi e di oggetti, in parte di competenza esclusiva dello Stato, ma in
parte anche di competenza concorrente delle Regioni, consenta «una serie di
interventi regionali nell’ambito, ovviamente, dei principî fondamentali della
legislazione statale in materia».
Alcune sentenze, pur mantenendosi nel
solco tracciato dalle precedenti, hanno apportato ulteriori specificazioni. Tra
queste può menzionarsi la sentenza n. 214, la quale, nel ribadire che la
tutela dell’ambiente, di cui alla lettera s) dell’art. 117, secondo
comma, della Costituzione, si configura come una competenza statale sovente
connessa ed intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze
regionali concorrenti, ha avuto modo di precisare che, nell’ambito di dette
competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere
dalla Regione stessa, nel rispetto dei principî fondamentali della legislazione
statale in materia ed altresì l’adozione di una disciplina maggiormente
rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale. Nel medesimo
senso, la sentenza n.
Giova, altresì, segnalare la sentenza
n. 62, che ha operato un sintetico raffronto tra il nuovo ed il vecchio
quadro costituzionale, evidenziando come, per quanto riguarda la disciplina
ambientale, non solo le Regioni ordinarie non abbiano acquisito maggiori
competenze, invocabili anche dalle Regioni speciali, ma, al contrario, una
competenza legislativa esclusiva in tema di tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema sia stata espressamente riconosciuta allo Stato, sebbene in
termini che non escludono il concorso di normative delle Regioni, fondate sulle
rispettive competenze, al conseguimento di finalità di tutela ambientale; il
che può avvenire in tema di tutela della salute e di governo del territorio,
ovviamente nel rispetto dei livelli minimi di tutela apprestati dallo Stato e
dell’esigenza di non impedire od ostacolare gli interventi statali necessari
per la soddisfazione di interessi unitari, eccedenti l’ambito delle singole
Regioni. Peraltro – prosegue
Queste definizioni della materia
«ambiente» sono state applicate, a più riprese, nella decisione di fattispecie
specifiche. Operando una schematizzazione a meri fini espositivi, possono
distinguersi, in particolare, quattro ambiti fondamentali, concernenti (a)
i parchi e le aree protette, (b) la prevenzione di incidenti rilevanti,
(c) la gestione di rifiuti e (d) la protezione della fauna.
a)
Dal confronto tra la norma statale
interposta in materia di parchi nazionali e la norma regionale impugnata,
emerge che le modifiche introdotte, lungi dal disporre una disciplina più
rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, derogano in
peius agli standards di tutela uniforme sull’intero territorio
nazionale. Né vale addurre una competenza esclusiva regionale in materia di
cave a seguito della modifica del titolo V della Costituzione, poiché, nel caso
di specie, si è disciplinata la materia delle cave quando le stesse insistano
in un parco, e pertanto la materia «cave» va ad intrecciarsi con il valore
ambiente. Quando viene toccato tale ultimo valore,
D’altro canto, non può sostenersi che
non esisterebbe un divieto assoluto di svolgere attività di cava nelle aree
protette, tanto che la stessa legge n. 394 del 1991 prevede che tale divieto
sia derogabile con il semplice regolamento del Parco, con la conseguenza che se
la deroga può essere effettuata da un regolamento, a maggior ragione si
potranno effettuare deroghe tramite legge. La tesi è infondata in quanto qui
non viene in rilievo il rapporto di gerarchia legge-regolamento, bensì il fatto
che la competenza a disciplinare la materia delle deroghe al divieto di cave
nel parco è attribuita in via esclusiva, da una legge statale, al regolamento del
Parco.
L’illegittimità costituzionale della
norma dunque deve individuarsi non già in una presunta inammissibilità di
deroghe al divieto di cave nel parco, ma nel fatto che tali deroghe possono
essere eventualmente adottate tramite regolamento del Parco. Né si può
convenire con la interpretazione secondo la quale il divieto di svolgere
attività di cava nelle aree protette si riferisce all’apertura di nuove cave,
non anche a quelle in esercizio in base a regolare concessione o dismesse senza
che sia stata attuata la riambientazione del relativo sito. Parimenti infondata
la tesi regionale per la quale gli interventi di ampliamento sarebbero limitati
a quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali, poiché non sono
ammissibili deroghe in peggio alla protezione dell’ambiente, senza che si possa
distinguere tra «piccole deroghe» (tollerate) e «grandi deroghe» (non
tollerate).
La questione non è, invece, fondata
per quanto riguarda i parchi regionali.
Con riferimento alle aree naturali
protette regionali, l’art. 22 della legge n. 394 del 1991 dispone che
l’adozione di regolamenti delle aree protette, secondo i criteri stabiliti con
legge regionale, rientra fra i principî fondamentali per la disciplina di tali
aree. La legge regionale impugnata stabilisce in linea di principio il divieto
di condurre cave nei parchi regionali, in conformità all’art. 11 della legge n.
394 del 1991, e prevede, in alcune ipotesi ben circoscritte, la possibilità di
deroghe a tale divieto.
Il parco regionale, sottolinea
b) Di notevole rilievo, anche per le affermazioni che
recano relativamente alla materia «ambiente», le due pronunce che hanno
riguardo alla prevenzione di incidenti rilevanti.
Con la sentenza n. 135,
Al riguardo,
In attesa di questo trasferimento, le
ispezioni relative agli stabilimenti a maggior incidenza di rischio sono
disposte dal Ministero dell’ambiente; le ispezioni sono svincolate da qualsiasi
cadenza periodica e possono svolgersi in tutti gli stabilimenti a rischio di
incidenti (e cioè sia in quelli soggetti ex art. 8 all’obbligo del
rapporto di sicurezza sia in quelli tenuti soltanto, ai sensi dell’art. 7, ad
una politica di prevenzione comprensiva di un sistema di gestione della
sicurezza).
Sulla base di tali premesse,
Strettamente connessa con le
affermazioni contenute nella sentenza n. 135 è la sentenza n. 214,
che dichiara la infondatezza della questione sollevata nei confronti della
legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n.
L’oggetto del contendere attiene a
competenze amministrative, che la legge regionale impugnata ha assegnato alla
Provincia, mentre la legge statale le attribuisce al prefetto. A tal fine,
In effetti, è lo stesso art. 20,
ultimo comma, del d.lgs. n. 334 del
c) Con riferimento alla gestione dei rifiuti, sono
stati oggetto di statuizione da parte della Corte la circolazione
extra-regionale dei rifiuti (sentenza n. 161)
e, soprattutto, la gestione dei rifiuti radioattivi (sentenza n. 62).
Nella sentenza n. 161, si
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della
Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59, nella parte in cui fa divieto a
chiunque conduca nel territorio della Regione Basilicata impianti di
smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere
negli impianti medesimi rifiuti, diversi da quelli urbani non pericolosi,
provenienti da altre regioni o nazioni.
Al riguardo,
L’impugnata legge regionale pone un
generale divieto per chiunque conduca nel territorio della Regione Basilicata
impianti di smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di
accogliere negli impianti medesimi rifiuti provenienti da altre regioni o
nazioni. Tale divieto, se è legittimo con riferimento ai rifiuti urbani non
pericolosi, si pone, invece, in contrasto con
Nella sentenza n. 62 si
accoglie l’impugnativa del Governo avverso tre leggi regionali, rispettivamente
delle Regioni Sardegna (legge regionale 3 luglio 2003, n. 8), Basilicata (legge
regionale 21 novembre 2003, n. 31) e Calabria (legge regionale 5 dicembre 2003,
n. 26), che dichiarano il territorio regionale come territorio
«denuclearizzato», precluso al transito ed alla presenza di materiali nucleari
provenienti da altri territori.
Per quanto riguarda
In proposito, non vale invocare la
competenza legislativa primaria in materia di «edilizia ed urbanistica» (art.
3, lettera f, dello statuto), che non comprende ogni disciplina di
tutela ambientale, e deve comunque esercitarsi – quando si tratti, ciò che non
è nella specie, di ambiti in cui le Regioni ordinarie non abbiano acquisito,
con il nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, maggiori
competenze invocabili anche dalle Regioni speciali in forza dell’art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001 (cfr. sentenza n. 536 del 2002) – nei limiti
statutari delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e degli
obblighi internazionali e comunitari.
Né, in proposito, può valere il
riferimento all’art. 58 delle norme di attuazione dello statuto sardo di cui al
d.P.R. n. 348 del 1979, che si limita a trasferire alla Regione le funzioni
amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le
riserve ed i parchi naturali, ed all’art. 80 del d.P.R. n. 616 del 1977, il
quale, pur includendo la «protezione dell’ambiente» nell’ambito della
disciplina dell’uso del territorio riconducibile alla materia «urbanistica»,
non ha fatto venir meno le competenze statali in materia specificamente ambientale.
Ancor meno la legge censurata può
giustificarsi in base alla competenza concorrente della Regione in materia di
salute pubblica, protezione civile e governo del territorio: mentre questi
ultimi due titoli di competenza non aggiungono nulla ai poteri della Regione in
campo ambientale, in presenza della competenza statale di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera s), i poteri della Regione nel campo della tutela
della salute non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più
rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi
preclusivi suscettibili, come nella specie, di pregiudicare, insieme ad altri
interessi di rilievo nazionale (cfr. sentenza n. 307 del 2003), il medesimo
interesse della salute in un ambito territoriale più ampio, come avverrebbe in
caso di impossibilità o difficoltà a provvedere correttamente allo smaltimento
di rifiuti radioattivi.
In ogni caso, alle Regioni, sia ad
autonomia ordinaria sia ad autonomia speciale, è sempre interdetto adottare misure
di ogni genere capaci di ostacolare «in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose tra le Regioni» (art. 120, primo comma, Cost.); e la
normativa impugnata, che preclude il transito e la presenza, anche provvisoria,
di materiali nucleari provenienti da altri territori, è una misura tra quelle
che alle Regioni sono vietate dalla Costituzione.
Inoltre, il problema dello
smaltimento dei rifiuti di origine industriale pericolosi non può essere
risolto sulla base di un criterio di «autosufficienza» delle singole Regioni
(cfr. sentenze n. 281 del 2000, n. 335 del 2001, n. 505 del 2002), poiché
occorre tener conto della eventuale irregolare distribuzione nel territorio
delle attività che producono tali rifiuti, nonché, nel caso dello smaltimento
dei rifiuti radioattivi, della necessità di trovare siti particolarmente idonei
per conformazione del terreno e possibilità di collocamento in sicurezza dei
rifiuti medesimi. La comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad
ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri
connessi (secondo il noto detto «not in my backyard»), non può tradursi
in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per
una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di
interessi di rilievo ultraregionale.
La medesima ratio decidendi conduce alla declaratoria di incostituzionalità
della legge regionale della Basilicata, in ordine alla quale
Per le stesse ragioni riferite a
proposito delle precedenti leggi regionali, viene dichiarata la
incostituzionalità della legge regionale della Calabria impugnata.
Con la stessa sentenza n. 62,
La ricorrente lamenta la violazione
delle competenze legislative della Regione in materia di tutela della salute,
protezione civile e governo del territorio, nonché dei principî costituzionali
di sussidiarietà e leale collaborazione tra Stato e Regioni.
Del pari, l’attribuzione delle
funzioni amministrative il cui esercizio sia necessario per realizzare
interventi di rilievo nazionale può essere disposta, in questo ambito, dalla
legge statale, nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva di cui
all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ed in base
ai criteri generali dettati dall’art. 118, primo comma, della Costituzione,
vale a dire ai principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
Nella specie, la localizzazione e la
realizzazione di un unico impianto destinato a consentire lo smaltimento dei
rifiuti radioattivi potenzialmente più pericolosi, esistenti o prodotti sul
territorio nazionale, costituiscono certamente compiti il cui esercizio
unitario può richiedere l’attribuzione della competenza ad organi statali.
Tuttavia, quando gli interventi dello
Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l’uso del
territorio, ed in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti
a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree,
l’intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di
governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall’altro
lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori,
impone che siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che
coinvolgano le Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a
realizzarsi (cfr. sentenza n. 303 del 2003).
Il livello e gli strumenti di tale
collaborazione possono naturalmente essere diversi in relazione al tipo di
interessi coinvolti ed alla natura ed all’intensità delle esigenze unitarie che
devono essere soddisfatte.
I procedimenti concretamente
configurati dal decreto legge impugnato concernono sia la individuazione del
sito in cui collocare il Deposito (e dunque la scelta dell’area più idonea
sotto il profilo tecnico ed in relazione ad ogni altra circostanza rilevante),
sia la concreta localizzazione e la realizzazione dell’impianto.
Sotto il primo profilo, è corretto il
coinvolgimento, che il decreto legge attua, delle Regioni e delle autonomie
locali nel loro insieme, attraverso
Quando, però, una volta individuato
il sito, si debba provvedere alla sua «validazione», alla specifica
localizzazione ed alla realizzazione dell’impianto, l’interesse territoriale da
prendere in considerazione ed a cui deve essere offerta, sul piano
costituzionale, adeguata tutela, è quello della Regione nel cui territorio
l’opera è destinata ad essere ubicata. A questo livello, il semplice
coinvolgimento della Conferenza unificata, il cui intervento non può sostituire
quello, costituzionalmente necessario, della singola Regione interessata (cfr.
sentenze n. 338 del 1994, n. 242 del 1997, n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004).
Da questo punto di vista, la
disciplina recata dal decreto legge impugnato è carente, poiché prevede che
alla «validazione» del sito provveda il Consiglio dei ministri, sulla base
degli studi della Commissione tecnico-scientifica, e sentiti i soli pareri di
enti nazionali.
È dunque necessario, al fine di
ricondurre tali previsioni a conformità alla Costituzione, che siano previste
forme di partecipazione al procedimento della Regione interessata, fermo
restando che, per il caso di dissenso irrimediabile, possono essere previsti
meccanismi di deliberazione definitiva da parte di organi statali, con adeguate
garanzie procedimentali.
Una garanzia, pur minima, della
Regione è invece presente nella previsione del comma 2, primo periodo,
dell’art. 2, ai cui sensi il Commissario straordinario è autorizzato ad adottare,
anche in sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli atti
di qualsiasi natura necessari alla progettazione, all’istruttoria,
all’affidamento e alla realizzazione del Deposito nazionale, con le modalità di
cui all’articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con
modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n.
Quanto alle procedure per la messa in
sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria, cui
provvede, ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, il Presidente del Consiglio
con proprio decreto, vale osservare che per tale messa in sicurezza «si applicano
le procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2» del decreto
(fatta eccezione per quelle speciali previste dalla legge n. 443 del 2001 e dal
d.lgs. n. 190 del 2002). Pertanto, anche a seguito della dichiarazione di
parziale illegittimità costituzionale degli articoli 1 e
d)
Con la sentenza n. 391, ancora
una volta
Analoga ratio va riconosciuta
alla previsione del termine giornaliero, anch’esso fissato al fine di garantire
la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili.
L’articolo unico della legge della
Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15, procrastinando fino ad un’ora dopo il
tramonto il termine di chiusura del periodo venatorio giornaliero relativo agli
acquatici da appostamento che dipendono ecologicamente dalle zone umide, incide
sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ed è pertanto
costituzionalmente illegittima.
Nella sentenza n. 392,
In quest’ottica,
Si tratta chiaramente, secondo
La previsione dell’art. 19 della
legge statale n. 157 del 1992, ribadisce
Ed è proprio con tale principio
espresso dalla norma statale che si pone in contrasto l’articolo 7, comma 3,
primo periodo e lettera a), della legge regionale impugnata, in quanto
qualifica le Riserve «quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi»,
facendo così rientrare le Riserve di caccia, e per esse i cacciatori assegnati,
tra i soggetti autorizzati all’esecuzione dei piani. Non trattandosi nella
specie di attività venatoria, il previsto ampliamento risulta irragionevole, e
in quanto tale si pone come esorbitante rispetto alla potestà integrativo-attuativa
che l’art. 6, n. 3, dello statuto speciale attribuisce al legislatore regionale
in materia di tutela della fauna.
Infine, alla luce della sentenza n. 393, immune da censure, riferite all’art. 117, secondo comma,
lettera s), ed all’art. 117, primo comma, della Costituzione, si rivela
la questione sollevata nei confronti dell’art. 3 della legge della Regione
Umbria 29 luglio 2003, n. 17. La disposizione impugnata prevede che «
Diversamente da quanto sostenuto dal
ricorrente, tale formulazione non esclude, in realtà, il rinvio alle procedure,
alle condizioni ed ai limiti previsti dall’art. 18, comma 2, della legge n. 157
del 1992, limitandosi a disporre che il calendario venatorio può prevedere una
diversa data di inizio per il periodo venatorio relativamente ad alcune specie
solo «ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 18, comma 2, della legge
11 febbraio 1992, n. 157».
Pertanto, la norma regionale non si
discosta da quanto previsto dalla norma statale, la quale fissa uno standard
minimo di tutela della fauna, giacché l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività venatoria in periodi diversi da quelli previsti dall’art. 18,
comma 1, della legge n. 157 del 1992 deve comunque ritenersi subordinata, anche
nella Regione Umbria, alla integrale applicazione della disciplina dettata dal
secondo comma del medesimo articolo. Così intesa la disposizione regionale
impugnata, infondata deve ritenersi anche la censura relativa al mancato
rispetto degli obblighi comunitari, ed in particolare della direttiva
79/409/CEE (c.d. direttiva uccelli), perché la disposizione regionale, mediante
il richiamo espresso all’articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.
157, si pone in conformità con la disciplina statale che di tale direttiva
costituisce attuazione.
3.1.17. «Tutela […] dei beni culturali»
Come è il caso per altri settori
dell’ordinamento, la disciplina della «cultura» viene ripartita, nel nuovo
Titolo V della Parte seconda della Costituzione, sotto diversi titoli
competenziali. Rinviando ad altre sedi la trattazione di decisioni che hanno
avuto riguardo ad altri aspetti della materia, è il caso di passare qui in
rassegna la sentenza n. 232, anche per le affermazioni in essa presenti
relativamente alla distinzione dei concetti «tutela» e di «valorizzazione» dei
beni cultuali (che si traducono in diversi tipi di competenze).
Con tale decisione,
Secondo lo Stato ricorrente siffatte
disposizioni sono lesive delle attribuzioni statali in materia di tutela dei
beni culturali, le quali, essendo esclusive, comprendono anche la potestà
regolamentare, rilevandosi altresì che nella tutela dei beni culturali rientra
anzitutto il potere di riconoscere i beni culturali come tali.
Osserva
Ai fini del discrimine delle
competenze, ma anche del loro intreccio nella disciplina dei beni culturali,
elementi di valutazione si traggono dalle norme del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggistici), dove si
ribadisce l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni
culturali e, nel contempo, si stabilisce che siano non soltanto lo Stato, ma
anche le Regioni, le città metropolitane, le province ed i comuni ad assicurare
e sostenere la conservazione del patrimonio culturale ed a favorirne la
pubblica fruizione e la valorizzazione. A rendere evidente la connessione della
tutela e valorizzazione dei beni culturali con la tutela dell’ambiente sono
anche le lettere f) e g) del comma 4 dell’art. 10 del suindicato
codice, le quali elencano, tra i beni culturali, le ville, i parchi, i
giardini, le vie, le piazze, ed in genere gli spazi aperti urbani di interesse
artistico o storico.
Con riguardo a tale ultimo rilievo è
anche sotto altro, più specifico, aspetto che viene in evidenza la competenza
regionale. La materia del governo del territorio, comprensiva dell’urbanistica
e dell’edilizia (v. sentenze n. 362 del 2003 e n. 196 del 2004), rientra tra
quelle di competenza legislativa concorrente. Spetta perciò alle Regioni,
nell’ambito dei principî fondamentali determinati dallo Stato, stabilire la disciplina
degli strumenti urbanistici.
Ora, non v’è dubbio che tra i valori
che gli strumenti urbanistici devono tutelare abbiano rilevanza non secondaria
quelli artistici, storici, documentari e comunque attinenti alla cultura nella
polivalenza di sensi del termine. Non si può dubitare, ad esempio, che
disposizioni le quali, a qualsiasi livello, limitino l’inquinamento atmosferico
o riducano, disciplinando la circolazione stradale, le vibrazioni, tutelino
l’ambiente ed insieme, se esistenti, gli immobili o i complessi immobiliari di
valore culturale.
Nelle materie in cui ha primario
rilievo il profilo finalistico della disciplina, la coesistenza di competenze
normative rappresenta la generalità dei casi. Ed è significativo che
Concludendo,
La legge regionale non stabilisce
nuovi criteri di identificazione dei beni culturali ai fini del regime proprio
di questi nell’ambito dell’ordinamento statale, bensì prevede che nella
disciplina del governo del territorio – e quindi per quanto concerne le
peculiarità di questa – si tenga conto non soltanto dei beni culturali
identificati secondo la normativa statale, ma eventualmente anche di altri,
purché però essi si trovino a far parte di un territorio avente una propria
conformazione e una propria storia (v. sentenza n. 94 del 2003).
3.2.
Le materie di competenza concorrente
Sebbene meno numerose delle
affermazioni relative alle materie di competenza esclusiva dello Stato, sono
comunque molte le decisioni che hanno riguardato le materie individuate,
dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, come di competenza concorrente.
In buona parte, le decisioni hanno avuto riguardo a leggi statali di ampio
respiro, che, in quanto tali, ponevano «principî fondamentali della materia»
(come è nel caso del paragrafo seguente). Non mancano, però, decisioni (si pensi
a quelle in tema di «professioni») nelle quali
3.2.1. «Tutela e sicurezza del lavoro»
Le sentenze nn. 50 e 384,
intervenendo sulle più recenti riforme del mercato del lavoro, hanno condotto
una vasta opera definitoria della materia «tutela e sicurezza del lavoro», la
cui estensione viene, peraltro, limitata dal concorrere di altri titoli
competenziali, previsti al secondo comma, dell’art. 117.
Nella sentenza n. 50,
Con riferimento alle singole censure
prospettate,
Le affermazioni di più ampio respiro
contenute nella sentenza n. 50 sono comunque quelle che affermano, anche
attraverso il riferimento all’art. 120, primo comma, della Costituzione, le
dimensioni necessariamente nazionali del mercato del lavoro.
Dichiarando non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 30 del 2003, là dove
dispone l’identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento
per gli intermediari pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e
privati,
In applicazione di questa ratio
decidendi,
Sulla base della medesima ratio
Nella sentenza n. 384, si
evidenzia il principio secondo cui la vigilanza (sul lavoro) non rientra nella
competenza concorrente in esame, ma deve essere connotata di volta in volta, in
relazione al suo oggetto specifico: su questa base,
Si dichiara, invece,
costituzionalmente illegittimo l’art. 10, comma 1, ultimo periodo, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nella parte in cui non prevede che il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente le
modalità di attuazione e funzionamento della banca dati sia adottato previa
intesa con
La sentenza n.
Ora, ove si consideri che il problema
si intreccia e si identifica con quello di competenza, è evidente come il
criterio di soluzione cui far capo vada individuato guardando, al di là del
dato testuale, di problematico significato, alla ratio della previsione
costituzionale che ha attribuito le norme generali alla competenza esclusiva
dello Stato.
E, sotto quest’ultimo aspetto, può
dirsi che le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in
relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili
indistintamente al di là dell’ambito propriamente regionale.
Le norme generali così intese si
differenziano, nell’ambito della stessa materia, dai principî fondamentali i
quali, pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro
operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno
numerose.
Nel caso di specie,
Sulla base della sopra menzionata
distinzione tra norme generali e principî fondamentali, non risulta fondata la
questione riferita all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2004,
dove si prevede la promozione da parte di uffici pubblici periferici (uffici
scolastici regionali) di appositi accordi con i competenti uffici delle Regioni
e degli enti locali, in quanto la norma impugnata non attribuisce allo Stato
una funzione amministrativa in senso proprio, ma si limita a riconoscergli la
legittimazione a stipulare accordi funzionali alla realizzazione di quella
continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola
primaria, che costituisce una delle finalità proprie della scuola
dell’infanzia; non vi è, pertanto, dubbio che l’indicazione di tale finalità
sia espressiva della competenza esclusiva statale in materia di norme generali
sull’istruzione. Peraltro, la norma censurata realizza proprio quel modello
collaborativo tra Stato e regioni invocato dalle stesse Regioni ricorrenti.
Immuni da censure risultano anche
l’art. 7, commi 1, 2, primo periodo, e 4, primo periodo, e l’art. 10, commi 1,
2, primo periodo, e 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2004,
che stabiliscono – rispettivamente per la scuola primaria e la scuola
secondaria – l’orario annuale delle lezioni, l’orario annuale delle ulteriori
attività educative e didattiche rimesse all’organizzazione delle istituzioni
scolastiche e l’orario relativo alla mensa ed al dopo-mensa. Non si tratta,
infatti, di indebite norme di dettaglio che fissano, limitandola, l’offerta
formativa, poiché, al contrario, le stesse vanno intese come espressive di
livelli minimi di monte-ore di insegnamento validi per l’intero territorio
nazionale, ferma restando la possibilità per ciascuna regione (e per le singole
istituzioni scolastiche) di incrementare, senza oneri per lo Stato, le quote di
rispettiva competenza.
Altresì non lesive dell’autonomia
regionale e di quella delle istituzioni scolastiche risultano le disposizioni
(articoli 7, comma 4, secondo periodo, e 10, comma 4, secondo periodo, del
decreto legislativo n. 59 del 2004), che prevedono – rispettivamente per la
scuola primaria e per quella secondaria – che le istituzioni scolastiche, per
lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti opzionali che richiedano una
specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei
docenti della scuola primaria o secondaria, stipulino contratti di prestazione
d’opera con esperti in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica. Al riguardo, osserva
Non fondate sono anche le questioni
riferite all’art. 2, che disciplina l’accesso alla scuola dell’infanzia,
stabilendo che possano esservi iscritti le bambine ed i bambini che compiono i
tre anni entro il 30 aprile, ed all’art. 12, che regola l’accesso alla medesima
scuola dell’infanzia nella fase transitoria di sperimentazione, prevista dalla
legge delega, avente inizio con l’anno scolastico 2003-2004 e destinata a
proseguire fino all’anno 2006, prevedendo la possibilità di una graduale
anticipazione dell’età minima per l’iscrizione. In ordine alla denunciata
violazione della delega, per quanto riguarda l’accesso alla scuola
dell’infanzia senza attendere i risultati della fase di sperimentazione,
Sono, invece, accolte le doglianze
avverso gli articoli 12 e 13, per le parti relative alla «modulazione» delle
anticipazioni dell’età di accesso alle scuole, in quanto non prevedono alcuna
forma di partecipazione delle regioni nella fase decisionale.
Si assume, in sostanza, che, se si
conviene che la sperimentazione non è una funzione da svolgere necessariamente
in forma centralizzata ed anzi deve tenere conto, secondo lo stesso legislatore
statale, delle peculiari situazioni locali (come testimonierebbe il previsto
coinvolgimento dell’Anci),
dovrebbe allora concludersi che la relativa disciplina rientra nell’ambito
della competenza regionale, come è del resto coerente con la natura di materia
concorrente propria dell’istruzione.
Ritiene
La norma appare pertanto non
rispettosa, sotto tale profilo, del principio di leale collaborazione e va
dunque ricondotta a legittimità costituzionale sostituendo alla prevista
partecipazione consultiva dell’Anci
quella della Conferenza unificata Stato-Regioni.
Non essendovi alcuna ragionevole
giustificazione per limitare alla sola scuola dell’infanzia la partecipazione
delle regioni ai processi decisionali,
L’ultima questione riguarda l’art.
15, comma 1, secondo periodo, che, al fine di realizzare le attività educative
di cui agli articoli 7, commi 1, 2 e 3, e 10, commi 1, 2 e 3, del medesimo
decreto legislativo, affida la possibilità di attivare incrementi di posti per
le attività di tempo pieno e di tempo prolungato nell’ambito dell’organico del
personale docente, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Argomenta a tal proposito
Anche la sentenza n.
«a)
sviluppo delle tecnologie multimediali;
«b)
interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il
diritto-dovere di istruzione e formazione;
«c)
interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per
l’educazione degli adulti;
«d)
istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione».
In ordine ai finanziamenti di cui
alle lettere a), b) e c), le doglianze
regionali si appuntano soprattutto sulla circostanza che le disposizioni
suindicate abbiano autorizzato la spesa pur in assenza del piano programmatico,
la cui approvazione, secondo quanto stabilito dalla legge n. 53 del 2003 (che
già prevedeva i finanziamenti in questione), comporterebbe l’intesa con
Di diverso avviso
Con precipuo riguardo al
finanziamento sub d),
Sempre in tema di istruzione, deve
menzionarsi la sentenza n. 37, nella quale si disattende una censura regionale
relativa ad una asserita compressione dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche. Oggetto del giudizio è l’art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, il quale disciplina le modalità di riconduzione dell’orario di
insegnamento a quello obbligatorio di servizio dei docenti. La norma denunciata
si limita a ricondurre l’orario di insegnamento a quello obbligatorio di
servizio dei docenti per tutte le scuole del territorio nazionale, enunciando
così un principio al quale devono attenersi le istituzioni scolastiche,
ancorché dotate di autonomia, e non spiega comunque effetto sulla
determinazione del livello del servizio scolastico. Deve, pertanto, escludersi
la lesione delle attribuzioni legislative regionali e dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, la quale non può in ogni caso risolversi nella
incondizionata libertà di autodeterminazione, ma esige soltanto che a tali
istituzioni siano lasciati adeguati spazi che le leggi statali e quelle
regionali, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono
pregiudicare (sentenza n. 13 del 2004).
A più riprese,
Motiva
L’impianto generale, il contenuto e
lo scopo della legge inducono pertanto a ritenere che il suo oggetto debba
essere ricondotto alla materia concorrente delle «professioni» di cui all’art.
117, terzo comma, della Costituzione, ed in particolare delle professioni
sanitarie.
Parimenti, riafferma che, in materia
di professioni sanitarie, dal complesso dell’ampia legislazione statale già in
vigore si ricava il principio fondamentale per cui l’individuazione delle
figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è
riservata alla legislazione statale. Questo principio si pone quindi come un
limite invalicabile dalla potestà legislativa regionale.
La sentenza n. 355 riguarda
gli articoli 2, commi 2 e 3, e 3 della legge della Regione Abruzzo 19 novembre
2003, n. 17, nella parte in cui fissano i requisiti per l’iscrizione nel
registro regionale degli amministratori di condominio e dispongono che
l’attività di amministratore di condominio, nella regione, sia preclusa a chi
non sia iscritto nel registro.
Per
Al riguardo, dalla normativa vigente
– e segnatamente dall’art. 2229, primo comma, del codice civile, oltre che
dalle norme relative alle singole professioni – può trarsi il principio che
l’individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente
unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la
disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la
realtà regionale. Esula, pertanto, dai limiti della competenza legislativa
concorrente delle regioni in materia di professioni l’istituzione di nuovi e
diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l’esercizio
di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle
professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.
La sentenza n. 424 riguarda la
legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13, che ha regolamentato le
discipline bio-naturali, definite come le pratiche che si prefiggono il compito
di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualità della
vita della persona, mediante l’armonizzazione della persona con se stessa e con
gli ambienti sociale, culturale e naturale che la circondano. Al riguardo,
osserva
La potestà legislativa delle regioni
in materia di «professioni» deve allora rispettare il principio secondo cui
l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed
ordinamenti didattici, e l’istituzione di nuovi albi (sentenza n. 355 del 2005)
è riservata allo Stato. Tale principio, al di là della particolare attuazione
che recano i singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di
ordine generale, invalicabile dalla legge regionale.
Al riguardo,
Nel caso di specie, la legge
regionale, oggetto di censura, ha individuato, fra le diverse «professioni
turistiche di accompagnamento», la «guida-ambientale escursionistica», figura
essenzialmente finalizzata ad illustrare «gli aspetti ambientali e
naturalistici» dei diversi territori (montani, collinari, di pianura ed
acquatici) e con esplicita esclusione di percorsi di particolare difficoltà ed
in ogni caso di quelli che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche
alpinistiche.
Pertanto, non si erode l’area della
figura professionale della guida alpina, ma si opera del tutto legittimamente
nell’area lasciata alla discrezionalità del legislatore regionale dalla vigente
legislazione di cornice in materia turistica.
In talune decisioni,
Nella sentenza n. 95,
Il ricorrente Presidente del Consiglio
sostiene che queste disposizioni, eliminando l’obbligo del libretto di idoneità
sanitaria, di cui all’art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per il
personale addetto alla produzione e vendita di alimenti e per il personale
delle farmacie, violerebbero un principio fondamentale stabilito dalla
legislazione statale a tutela della salute, violando, altresì, l’esclusiva
competenza legislativa statale in tema di «ordine pubblico e sicurezza», di cui
al secondo comma, lettera h),
dell’art. 117 della Costituzione, dal momento che tale obbligo sarebbe
qualificabile come vincolo di ordine pubblico, anche sulla base di alcune
sentenze della Corte di cassazione.
In tal modo, ben può la legislazione
regionale scegliere fra le diverse possibili specifiche modalità per garantire
l’igiene degli operatori del settore. Ciò che resta, invece, vincolante è
«l’autentico principio ispiratore della disciplina in esame, ossia il precetto
secondo il quale la tutela igienica degli alimenti deve essere assicurata anche
tramite la garanzia di alcuni necessari requisiti igienico-sanitari delle
persone che operano nel settore, controllabili dagli imprenditori e dai
pubblici poteri» (sentenza n. 162 del 2004).
La scelta delle Regioni di sopprimere
l’obbligo del libretto di idoneità sanitaria, pertanto, non determina di per sé
la violazione di tale principio fondamentale, dal momento che deve comunque
essere considerata implicitamente fatta salva l’applicazione del diverso
sistema di tutela dell’igiene dei prodotti alimentari disciplinata dai decreti
legislativi, attuativi delle direttive comunitarie, n. 156 del 1997, n. 155 del
1997 e n. 123 del 1993.
All’esame della Corte è, nella
sentenza n. 200, l’art. 37, comma 3, della legge della Regione Marche 17
luglio 1996, n. 26, il quale dispone che, fino alla definizione degli accordi
di cui all’art. 5, comma 4, di detta legge, in via provvisoria, resta fermo
l’obbligo della preventiva autorizzazione per l’accesso alle prestazioni alle
strutture sanitarie non pubbliche.
La censura del Tar per le Marche si incentra
essenzialmente sulla violazione dell’art. 117 della Costituzione, in quanto la
disposizione regionale non avrebbe attribuito all’assistito, in contrasto con i
principî fondamentali della legislazione statale, la facoltà di «libera scelta»
della struttura sanitaria, subordinandola, invece, nell’attesa di appositi
accordi, al rilascio di un’autorizzazione per l’accesso alle strutture private
accreditate, che abbiano accettato il budget imposto dalla Usl territorialmente competente.
Sottolinea
Tali ultime disposizioni si
configurano come norme di principio dirette a garantire ad ogni persona il
diritto alla salute come «un diritto costituzionale condizionato
dall’attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento
dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi
costituzionalmente protetti», tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso
legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse
organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (sentenze nn. 304 del
1994, 247 del 1992).
Dall’orientamento giurisprudenziale
della Corte (sentenze nn. 304 del 1994, 247 del 1992), si ricava che anche nel
sistema dell’accreditamento permangono i poteri di controllo, indirizzo e
verifica delle Regioni e delle Usl,
tanto che «la libertà di scegliere, da parte dell’assistito, chi chiamare a
fornire le prestazioni sanitarie non comporta affatto una libertà sull’an
e sull’esigenza delle prestazioni», in quanto resta confermato il principio
fondamentale che l’erogazione delle prestazioni soggette a scelte
dell’assistito è subordinata a formale prescrizione a cura del servizio
sanitario nazionale (sentenza n. 416 del 1995).
Non sussiste, quindi, la violazione
dell’indicato parametro costituzionale, poiché la norma censurata si conforma a
quei principî. Oltretutto, la disposizione in esame ha carattere transitorio, e
proprio nella stessa legge regionale impugnata si prevedono forme di
contrattazione che intercorrono tra Giunta regionale e Usl, da un lato, ed i vari soggetti accreditati, pubblici e
privati, erogatori delle prestazioni, dall’altro.
Nella sentenza n. 467,
Dall’esame della normativa statale in
materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare,
emerge, infatti, con chiarezza la distinzione tra una finalità di assistenza
sanitaria curativa e una finalità di prevenzione, concernente soggetti sani (i
lattanti figli di madri sieropositive per Hiv),
che occorre preservare dal pericolo di contagio veicolato dal latte materno,
per cui la diversità di fini di tutela e di soggetti beneficiari si riflette
inevitabilmente sulle modalità di erogazione e sui contesti istituzionali e
organizzativi nei quali questa viene effettuata.
Pertanto, l’introduzione in questo
contesto normativo di prodotti alimentari destinati ai lattanti si sarebbe
collocata fuori dal dichiarato ambito operativo della legge regionale, limitato
alla tutela dei soggetti portatori delle patologie già individuate dalla
normativa statale, richiamati integralmente al solo scopo di individuare i
fruitori della ristorazione differenziata. Tanto, peraltro, non preclude
l’assistenza ai nati da madri sieropositive, che rimane garantita dalla
normativa statale, in cui è stabilito pure che l’esistenza del presupposto
della prestazione venga accertata e certificata da uno specialista del Servizio
sanitario nazionale, spettando poi alla Regione l’adozione di una normativa di
carattere organizzativo che non può essere certo sostituita da una pronunzia
della Corte.
Anche la censura riferita all’art. 4,
che, disponendo l’obbligo di fornire pasti differenziati ai soggetti aventi
problemi connessi all’alimentazione a carico di tutte le amministrazioni
pubbliche e non soltanto di quelle regionali, avrebbe travalicato l’ambito di
competenza riservato all’ente territoriale, viene respinta.
Al riguardo,
A tutt’altro proposito, nella
sentenza n. 147,
Osserva
La previsione della legge statale è
all’origine delle limitazioni poste dalla legge regionale in questione allo
svolgimento dell’attività libero-professionale dei veterinari, nonché di una
differenziata disciplina nei diversi settori di attività libero-professionale;
limitazioni le quali non determinano alcuna illegittima preclusione allo
svolgimento dell’attività lavorativa, dal momento che, come già affermato
proprio in relazione alla disciplina del pubblico impiego nell’ambito
dell’organizzazione sanitaria pubblica, «dal riconoscimento dell’importanza
costituzionale del lavoro non deriva l’impossibilità di prevedere condizioni e
limiti per l’esercizio del relativo diritto, purché essi siano preordinati alla
tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali parimenti fatti oggetto,
come nella fattispecie, di protezione costituzionale» (sentenza n. 330 del
1999; si veda, altresì, sentenza n. 457 del 1993). Con riguardo alla norma in questione,
le limitazioni all’attività libero-professionale dei veterinari, oltre a non
essere assolute, perché operanti solo nel territorio della Usl presso la quale il veterinario
svolge il proprio servizio come pubblico dipendente e, inoltre, perché riferite
alle sole strutture ambulatoriali private per la cura degli animali
d’affezione, appaiono connesse all’esigenza di garantire che non siano
compromesse le finalità istituzionali nel settore della assistenza e della
vigilanza zooiatrica che
Non è dunque affatto contraddittorio
che il legislatore regionale abbia ritenuto di porre limitazioni allo
svolgimento di tale attività a tutela delle esigenze delle finalità
istituzionali delle strutture pubbliche, in misura tale da non svuotare del
tutto il contenuto del diritto e proprio in ossequio ai principî fondamentali
stabiliti dal legislatore statale.
Anche la censura mossa con riguardo
all’art. 120 della Costituzione è infondata, in quanto il limite territoriale
posto dall’art. 2 della legge piemontese con riguardo all’attività sugli
animali d’affezione si riferisce unicamente al «territorio di competenza della
A.S.R. presso la quale il medico veterinario svolge il proprio servizio di
pubblico dipendente».
Il divieto posto dall’art. 120, primo
comma, Cost., d’altra parte, è stato sempre interpretato come riferito
esclusivamente al divieto per la legge regionale di porre limiti alla
possibilità per i cittadini di svolgere attività di lavoro nel territorio della
Regione (cfr. sentenze n. 207 del 2001, n. 168 del 1987, n. 13 del 1961 e n. 6
del 1956) e non invece di individuare limitazioni all’interno di esso sulla
base di specifiche esigenze.
3.2.5. «Governo del territorio»
Per quanto attiene alla materia
«governo del territorio»,
Al riguardo,
Nel giudizio concluso con la sentenza
n. 71,
L’intervenuto mutamento del quadro
normativo ha fatto venir meno l’attualità dell’interesse al ricorso, in quanto
la ricorrente non potrebbe più, allo stato attuale, lamentare la mancata
assegnazione, da parte dello Stato, delle risorse necessarie alla riqualificazione
urbanistica, dal momento che rientra espressamente nel potere delle Regioni
determinare – entro limiti fissati dalla legge statale – tipologie ed entità
degli abusi condonabili. Tale potere, congiuntamente alla possibilità, prevista
dall’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003, per la legge regionale di
incrementare sia la misura dell’oblazione, fino al 10% (art. 32, comma 33), sia
la misura degli oneri di concessione, fino al 100% (art. 32, comma 34), al fine
di fronteggiare i maggiori costi che le amministrazioni comunali devono
affrontare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, e, in generale,
per gli interventi di riqualificazione delle aree interessate dagli abusi
edilizi (si veda, ancora, sentenza n. 196 del 2004), consente alla Regione di
valutare le conseguenze del condono sulle finanze regionali e locali e
determinare, anche in ragione delle risorse necessarie agli eventuali
interventi di riqualificazione, l’ampiezza della sanatoria.
Tale potere, peraltro, è già stato
esercitato dalla Regione Emilia-Romagna con la legge regionale 21 ottobre 2004,
n. 23, la quale ha individuato gli interventi edilizi suscettibili di sanatoria
ed ha incrementato nella misura massima consentita sia l’entità dell’oblazione
da corrispondere per la definizione degli illeciti edilizi, sia l’ammontare del
contributo di concessione.
Di maggior rilievo è la sentenza n. 343,
che reca la declaratoria di incostituzionalità della legge della Regione Marche
5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto
del territorio), per violazione del principio fondamentale dettato dall’art. 24
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi, per i
quali non è prevista l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla
Regione.
La disposizione statale prevede che,
in sede di piano territoriale di coordinamento, l’attuazione di strumenti
urbanistici regionali non è soggetta ad approvazione regionale, fermo restando
che i comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta
giorni, copia degli strumenti attuativi, e che sulle eventuali osservazioni
della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali. Tale
disposizione non è derogabile dalle leggi regionali: se, da una parte, si
istituzionalizza il disegno di semplificazione delle procedure in materia
urbanistica, eliminando l’approvazione degli strumenti attuativi, dall’altra,
però, si accentuano le forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti
pubblici e privati. In effetti, l’invio degli strumenti attuativi comunali alla
Regione è chiaramente preordinato a soddisfare un’esigenza, oltre che di
conoscenza per l’ente regionale, anche di coordinamento dell’operato delle
amministrazioni locali e, in questo senso, la legge statale riserva alla
Regione la potestà di formulare «osservazioni» sulle quali i Comuni devono
«esprimersi».
Il contrappeso all’abolizione
dell’approvazione regionale è costituito dall’obbligo imposto al Comune di
inviare alla Regione il piano attuativo, al fine di sollecitarne osservazioni,
riguardo alle quali il Comune stesso è tenuto a puntuale motivazione.
Il meccanismo istituito dall’art. 24
della legge n. 47 del 1985, dunque, in relazione allo scopo perseguito, assume
il carattere di principio fondamentale.
La legge urbanistica della regione
Marche abolisce l’approvazione regionale degli strumenti attuativi e, pur ammettendo
opposizioni e osservazioni da parte di «chiunque», non prevede specificamente
l’invio alla Regione al fine di sollecitare le osservazioni sulle quali la
legge statale impone al Comune l’obbligo (non già di recepirle, ma) di motivare
puntualmente (eventualmente, quindi, anche in senso difforme all’accoglimento):
l’obbligo di invio, nell’impianto della legge statale, è un quid pluris rispetto
alle forme partecipative consentite a soggetti privati e pubblici (art. 25),
tanto da esigere una motivazione puntuale, che non è richiesta nei confronti
delle osservazioni degli altri soggetti. È indubbio che la mancata previsione
dell’obbligo di trasmissione contrasta con un principio fondamentale della
legge statale e determina, conseguentemente, l’incostituzionalità delle norme
denunciate, nella parte in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per
i quali non è richiesta l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla
Regione. Al riguardo,
La materia «governo del territorio»
viene in considerazione, sia pure incidentalmente, anche nella sentenza n. 383,
dove
Nel 2005,
Con precipuo riguardo alla promozione
della cultura, nella sentenza n. 160
Dal rilievo che la costruzione della
sede principale di un istituto di cultura, finalità perseguita dal
finanziamento disposto con la norma censurata, è strumentale alla
«organizzazione di attività culturali», materia inclusa nell’art. 117, terzo
comma, Cost., e quindi di competenza legislativa concorrente, consegue la
illegittimità costituzionale della norma in questione, la quale non soltanto ha
stabilito l’erogazione in oggetto, ma ha anche attribuito a un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di disciplinarne l’attuazione.
Del resto l’esiguità della somma
stanziata esclude la necessità di una sua gestione unitaria in applicazione del
principio c.d. di sussidiarietà ascendente ai sensi dell’art. 118, primo comma,
della Costituzione.
La sentenza n. 205, invece,
richiama sostanzialmente quanto statuito con la sentenza 255 del 2004 – e cioè
che la materia concernente la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali», affidata alla legislazione
concorrente di Stato e Regioni ricomprende nella sua seconda parte, e
nell’ambito delle più ampie attività culturali, anche le azioni di sostegno
degli spettacoli – per respingere la questione di costituzionalità, promossa
dalla Regione Toscana, nei confronti dell’art. 10, comma 2, lettera e, della legge delega 6 luglio 2002, n.
137, che detta principî e criteri direttivi per il riordino del settore dello
spettacolo, sollevata sul presupposto che la materia «spettacolo», non essendo
menzionata tra quelle elencate nell’art. 117, secondo e terzo comma,
rientrerebbe tra quelle di competenza residuale.
La sentenza n. 336 – in cui
Le competenze più frequentemente
evocate, nel loro operare congiunto, sono la «tutela della salute» ed il
«governo del territorio».
Le prime censure formulate dalle
ricorrenti coinvolgono l’intera disciplina contenuta nel Capo V del Titolo II
del Codice, in quanto recherebbero «una disciplina dettagliata,
autoapplicativa, non cedevole» e «direttamente operante nei confronti dei
privati», tanto da non lasciare «alcuno spazio all’intervento legislativo
regionale». In particolare, la disciplina di un procedimento unitario e
dettagliato per l’autorizzazione all’installazione degli impianti,
predeterminando anche i tempi di formazione degli atti e della volontà delle
amministrazioni locali coinvolte, lederebbe la competenza legislativa delle
Regioni.
A tal riguardo, osserva
Nella fase di attuazione del diritto
comunitario, la definizione del riparto interno di competenze tra Stato e
Regioni in materie di legislazione concorrente e, dunque, la stessa
individuazione dei principî fondamentali, non può prescindere dall’analisi
dello specifico contenuto e delle stesse finalità ed esigenze perseguite a
livello comunitario. In altri termini, gli obiettivi posti dalle direttive
comunitarie, pur non incidendo sulle modalità di ripartizione delle competenze,
possono di fatto richiedere una peculiare articolazione del rapporto norme di
principio – norme di dettaglio. Nella specie, la puntuale attuazione delle
prescrizioni comunitarie, secondo cui le procedure di rilascio del titolo
abilitativo per la installazione degli impianti devono essere improntate al
rispetto dei canoni della tempestività e della non discriminazione, richiede di
regola un intervento del legislatore statale che garantisca l’esistenza di un
unitario procedimento sull’intero territorio nazionale, caratterizzato,
inoltre, da regole che ne consentano una conclusione in tempi brevi. Da questi
rilievi si deduce l’infondatezza della questione sollevata dalle regioni.
La ulteriore censura, con la quale le
ricorrenti lamentano che le disposizioni attribuirebbero direttamente
l’esercizio di funzioni amministrative agli enti locali, disciplinando il
relativo procedimento (laddove tali funzioni dovrebbero essere conferite con
legge statale o regionale, sulla base delle rispettive competenze, secondo
quanto prescritto dall’art. 118 della Costituzione), viene respinta perché
basata su un erroneo presupposto interpretativo.
Al tal proposito,
L’art. 86, comma 3, del Codice, che
prevede che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione siano
assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria (d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380), pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, non
risulta lesivo della competenza regionale relativa al governo del territorio,
né pone norme di dettaglio senza lasciare alcuno spazio alla competenza
concorrente regionale.
Ad avviso di una delle Regioni
ricorrenti, la norma in esame introdurrebbe «una classificazione che incide in
termini stringenti sulle possibilità delle Regioni di definire la disciplina di
queste particolari infrastrutture».
Neppure l’art. 86, comma 7, il quale
impone alle Regioni di uniformarsi ai limiti di esposizione ai valori di
attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dall’art. 4, comma 2, lettera
a), della legge 22 febbraio 2001, n.
36, viola le attribuzioni spettanti alle Regioni, e ciò sia per quanto concerne
la materia del «governo del territorio», sia per quanto attiene a quella della
«tutela della salute».
Al riguardo,
Orbene, la norma impugnata rispetta
l’indicato riparto di competenze. Essa, infatti, stabilisce che per gli
obiettivi di qualità «si applicano le disposizioni di attuazione di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera a),
della legge n. 36 del 2001», che opera, però, un rinvio al comma 1, lettera a), del medesimo art. 4, il quale
riserva allo Stato le funzioni relative alla determinazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e anche degli obiettivi di qualità, solo
«in quanto valori di campo come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), n. 2». Deve, dunque, ritenersi che
rimanga ferma la competenza delle Regioni nella determinazione dei diversi
«obiettivi di qualità», consistenti, appunto, negli indicati criteri
localizzativi, standards urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni per
l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.
Viene, poi, censurato dalle
ricorrenti il primo comma dell’art. 87 del Codice, il quale prevede che
l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, l’installazione
di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi
di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni
elettroniche mobili Gsm/Umts, per reti di diffusione,
distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre sono
autorizzate dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell’organismo
competente ad effettuare i controlli (Arpa),
della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione
e gli obiettivi di qualità.
A ciò si aggiunga che il comma 8
della disposizione impugnata prevede un meccanismo di operatività della
conferenza nel caso in cui il dissenso sia espresso da un’amministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, che assicura comunque un adeguato coinvolgimento delle
Regioni.
Ancora in ordine all’art. 87 del
Codice, viene censurata la disposizione del comma 9, che disciplina una ipotesi
di silenzio-assenso, prevedendo che «le istanze di autorizzazione e le denunce
di attività», «nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di
emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora entro
novanta giorni non sia stato comunicato un provvedimento di diniego». Il medesimo
comma precisa che gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti, ovvero ulteriori forme di
semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dallo
stesso comma.
Le ricorrenti deducono che la
disciplina impugnata sarebbe di dettaglio e, non lasciando spazio alcuno alle
Regioni per stabilire forme diverse di semplificazione amministrativa,
impedirebbe al legislatore regionale di prevedere modalità di contemperamento
delle esigenze di celerità del procedimento autorizzatorio con le
imprescindibili garanzie di tutela dell’ambiente, della salute e di governo del
territorio.
Sotto due diversi profili viene, poi,
censurato l’art. 93, il quale, dopo aver previsto che le pubbliche amministrazioni
non possono imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di
comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano fissati per legge,
stabilisce che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica
hanno l’obbligo di tenere indenne l’ente locale, ovvero l’ente proprietario,
dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche
coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, nonché l’obbligo di
ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’ente
locale.
Le ricorrenti deducono che l’articolo
de quo detterebbe, in ambiti materiali attribuiti alla competenza
regionale, una disciplina «uniforme» delle infrastrutture per le quali, invece,
si dovrebbe tener conto dello specifico contesto territoriale e normativo di
ciascuna Regione. Vi sarebbe inoltre un contrasto con l’art. 119 Cost., nelle
parti in cui si fissano in modo puntuale – per gli operatori – gli oneri
connessi alle attività di installazione, scavo ed occupazione di suolo
pubblico.
Una delle censure su cui
3.3.
Le materie di competenza residuale delle Regioni
In un n. non irrilevante di
occasioni,
3.3.1. «Formazione professionale»
Nella sentenza n. 50,
Sulla base di questo assunto
Attiene, invece, alla competenza
esclusiva delle Regioni in materia di formazione professionale la disciplina
dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con
rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni.
Sulla questa base,
La materia «formazione professionale»
viene in considerazione anche con la sentenza n. 51, dove si dichiara la
incostituzionalità dell’art. 47 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
prevede, al comma 1, che «nell’ambito delle risorse preordinate sul fondo per
l’occupazione […] con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell’importo aggiuntivo
di 1 milione di euro, per il finanziamento degli interventi in materia di
formazione professionale».
La norma impugnata disciplina
interventi destinati alla formazione professionale: questa materia appartiene,
nell’assetto definito dal nuovo art. 117 della Costituzione, alla competenza
residuale delle Regioni, in quanto non è inclusa nell’elenco delle materie
attribuite dal secondo comma alla legislazione dello Stato ed è nel contempo
espressamente esclusa dall’ambito della potestà concorrente in materia di
istruzione, sancita dal successivo terzo comma (v. sentenza n. 13 del 2004).
Con riferimento ai finanziamenti
disposti da leggi statali in favore di soggetti pubblici o privati (mediante la
costituzione di appositi fondi o il rifinanziamento di fondi già esistenti), è
stato più volte affermato che – dopo la riforma costituzionale del 2001 ed in
attesa della sua completa attuazione in tema di autonomia finanziaria delle
Regioni (cfr. sentenze nn. 320 e 37 del 2004) – l’art. 119 della Costituzione
pone, sin d’ora, al legislatore statale precisi limiti in tema di finanziamento
di funzioni spettanti al sistema delle autonomie (sentenza n. 423 del 2004).
Anzitutto, non è consentita
l’erogazione di nuovi finanziamenti a destinazione vincolata in materie
spettanti alla competenza legislativa, esclusiva o concorrente, delle Regioni
(sentenze nn. 16 del 2004 e 370 del 2003). Infatti, il ricorso a questo tipo di
finanziamento può divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza
dello Stato nell’esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali,
nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a
quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria
competenza.
In secondo luogo – giacché «le
funzioni attribuite alle Regioni ricomprendono pure la possibilità di
erogazione di contributi finanziari a soggetti privati, dal momento che in
numerose materie di competenza regionale le politiche pubbliche consistono
appunto nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti che vi
operano e nella disciplina delle modalità per la loro erogazione» (sentenza n.
320 del 2004) – questa Corte ha ripetutamente chiarito che il tipo di
ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all’art. 117 Cost.,
«vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea
generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a
soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà
legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto
delle rispettive competenze» (sentenze nn. 320, 423 e 424 del 2004).
Preliminarmente, per rinvenire
l’ambito di competenza della materia,
L’ambito materiale nel quale
interviene la disposizione denunciata è l’artigianato. L’art. 117 della
Costituzione, non annoverando l’artigianato tra le materie tassativamente
riservate alla legislazione statale o a quella concorrente, implicitamente
demanda questa materia alla potestà legislativa residuale delle Regioni, nella
quale rientra l’adozione delle misure di sviluppo e sostegno del settore, e, in
questo ambito, la disciplina dell’erogazione di agevolazioni, contributi e
sovvenzioni di ogni genere.
Peraltro, ciò non comporta
l’incostituzionalità dell’art. 4, comma 82, della legge n. 350 del
Invero, l’art. 37 della legge n. 949
del 1952, nel contesto di un più ampio provvedimento per lo sviluppo
dell’economia e l’incremento dell’occupazione, ha previsto la formazione di un
fondo, presso
Provvedimenti legislativi successivi
hanno di volta in volta conferito al fondo in questione ulteriori assegnazioni
per i vari esercizi finanziari.
La legge 5 marzo 2001, n. 57, nel
dettare disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, ha
assegnato al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane una nuova finalità, il
sostegno all’internazionalizzazione. L’art. 21, comma 7, di tale legge prevede
infatti che le disponibilità del fondo in questione «possono essere utilizzate
anche per agevolare il sostegno finanziario ai processi esportativi delle
imprese artigiane e ai programmi di penetrazione commerciale e di
internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export
a queste collegati, secondo finalità, forme tecniche, modalità e condizioni da
definire con decreto del Ministro del commercio con l’estero, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».
Su questa linea si pone il denunciato
comma 82 dell’art. 4 della legge n. 350 del 2003: esso pertanto si giustifica,
in via transitoria e fino all’attuazione del nuovo modello delineato dall’art.
119 della Costituzione, in conseguenza del principio di continuità
dell’ordinamento, più volte richiamato da questa Corte dopo la modifica del
Titolo V (cfr., da ultimo, sentenza n. 255 del 2004), attesa l’esigenza di non
far mancare finanziamenti ad un settore rilevante e strategico dell’economia
nazionale, quello dell’impresa artigiana, al quale
Le censure della ricorrente vanno
invece accolte con riferimento al comma 83 dell’art. 4, là dove viene lamentata
la mancanza di forme di raccordo e di leale collaborazione con le Regioni.
Il principio di continuità giustifica
infatti, ancora in via provvisoria, ed in vista di una considerazione
complessiva del settore dell’artigianato e delle iniziative da finanziare,
l’attribuzione al Ministro delle attività produttive della potestà di definire,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, modalità, condizioni
e forme tecniche delle attività ammesse al sostegno finanziario (cfr. sentenza
n. 255 del 2004).
E tuttavia, l’articolazione della
normativa esige forme di cooperazione con le Regioni e di incisivo
coinvolgimento delle stesse, essendo evidente che l’intervento dello Stato
debba rispettare la sfera di competenza spettante alle Regioni in via residuale.
La norma censurata, invece, non
prende minimamente in considerazione le Regioni per ciò che attiene
all’emanazione del decreto ministeriale di attuazione. Deve pertanto essere
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 83, della legge n.
350 del 2003, nella parte in cui, in contrasto con il principio di leale
collaborazione, non prevede che il decreto del Ministro delle attività
produttive sia emanato previa intesa con
Quanto all’ulteriore denuncia concernente
la mancanza di forme di raccordo con le Regioni nell’attività di gestione delle
risorse,
3.3.3. «Trasporto pubblico locale»
Con la sentenza n. 222, viene
dichiarata la illegittimità costituzionale parziale dell’art. 4, comma 157,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che prevede la costituzione di «un
apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» per il
generico fine di assicurare il conseguimento di «risultati di maggiore efficienza
e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale». La disposizione
prevedeva altresì che la ripartizione del fondi avvenisse tramite «decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
L’iter
argomentativo sul quale la decisione si basa prende le mosse dalla preliminare
constatazione secondo cui «non vi è dubbio che la materia del trasporto
pubblico locale rientra nell’ambito delle competenze residuali delle Regioni di
cui al quarto comma dell’art. 117 Cost.».
Ciò posto, si rileva, peraltro, come,
nella perdurante situazione di mancata attuazione delle prescrizioni
costituzionali in tema di garanzia dell’autonomia finanziaria di entrata e di
spesa delle Regioni e degli enti locali, e del vigente finanziamento statale
nel settore del trasporto pubblico locale, la disciplina di riferimento sia
contenuta nel citato art. 20 del d.lgs. n. 422 del 1997, il cui comma 5
stabilisce le modalità di trasferimento delle risorse erogate dallo Stato. Il
fondo previsto dalla disposizione oggetto di scrutinio risulta sostanzialmente
analogo al meccanismo di finanziamento appena richiamato: ad avviso della
Corte, «ciò appare, al momento, sufficiente a giustificare l’intervento
finanziario dello Stato e la sua relativa disciplina legislativa».
Tuttavia, «proprio perché tale
finanziamento interviene in un ambito di competenza regionale», viene
sottolineata la necessità di assicurare il rispetto delle attribuzioni
costituzionalmente riconosciute alle Regioni attraverso un loro pieno
coinvolgimento nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi
(sentenze nn. 49 e 16 del 2004); ciò tenendo altresì conto del «limite
discendente dal divieto di procedere in senso inverso a quanto oggi prescritto
dall’art. 119 della Costituzione, e così di sopprimere semplicemente, senza
sostituirli, gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in
vigore alle Regioni e agli enti locali, o di procedere a configurare un sistema
finanziario complessivo che contraddica i principî del medesimo art. 119»
(sentenza n. 37 del 2004).
Sulla scorta di queste
considerazioni, è stato ritenuto insufficiente il meccanismo previsto dalla
disposizione censurata, rendendosi di contro necessario che il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato sulla base di una vera e
propria intesa con
Si noti che la materia «trasporto
pubblico locale» è venuta in considerazione anche nella sentenza n. 432,
nella quale, però, non si è posto un problema competenziale bensì di violazione
dell’art. 3 della Costituzione (v. supra, cap. II, par. 2).
Contrariamente a quanto ritiene il
giudice rimettente, la previsione di un potere regionale di controllo
sostitutivo sulle Comunità montane non è in contrasto con il riconoscimento
«della parità di rango costituzionale tra Regione e Comuni» di cui all’art. 114
della Costituzione e con la «riserva di legge statale» in materia di
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni ex art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione. Al riguardo,
motiva
Anche la mancata previsione di un limite
temporale di durata della supplenza dell’organo commissariale straordinario,
nonché la mancanza di una «scansione procedimentale» e di «particolari
garanzie» non risultano in contrasto con «il principio della riserva di legge
in materia di organizzazione amministrativa» e con i principî di imparzialità e
buon andamento, di cui all’art. 97 della Costituzione. Il commissario
straordinario dovrà, infatti, esercitare i poteri conferitigli con il decreto
di nomina entro il termine stabilito dalla stessa amministrazione regionale,
ovvero, in sua assenza, entro il termine e secondo le modalità di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il sistema conosce,
inoltre, rimedi attivabili da parte dei soggetti interessati in caso di mancata
osservanza di tali termini (cfr. sentenze n. 220 e n. 176 del 2004). Una volta
esercitate le attribuzioni e/o venute meno le cause di scioglimento si potrà
procedere, nel rispetto della normativa di settore e dei tempi ivi previsti, al
rinnovo del consiglio comunitario.
La norma impugnata, d’altra parte,
affidando «ad un organo monocratico politico della Regione il controllo sugli
organi collegiali di un ente territoriale di diritto pubblico, autonomo ed a
base comunitaria, espressione dell’autonomia dei Comuni montani e del loro
potere di associarsi per il perseguimento di fini comuni» non risulta, perciò
stesso, in contrasto con i principî di ragionevolezza (art. 3 della
Costituzione) e di autonomia degli enti locali (art. 5 della Costituzione).
Motiva
Non fondata è, infine, la doglianza
relativa alla mancata previsione della consultazione, ad opera della Regione,
dei Comuni facenti parte della Comunità montana, in forza di quanto previsto
dall’ultimo comma dell’art. 123 della Costituzione, prima dell’adozione del
provvedimento di commissariamento.
La norma impugnata, infatti, prevede
casi di scioglimento e di commissariamento degli organi comunitari, dai quali
esula ogni profilo di discrezionalità, atteso il loro collegamento ad eventi
oggettivamente rilevanti, quali: a) la mancata elezione del Presidente e
della Giunta entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti, dalla vacanza
comunque verificatesi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione
delle stesse; b) le dimissioni contestuali o la decadenza di almeno la
metà dei consiglieri comunitari nominati dai consigli comunali; c) la
mancata approvazione del bilancio di previsione; d) la mancata
approvazione dello statuto nei termini previsti dall’art. 8 della stessa legge.
Tenuto conto del contenuto della
disposizione censurata, può ritenersi non necessaria la previsione di
meccanismi di preventiva consultazione dei Comuni interessati, poiché il
carattere oggettivo degli eventi cui la norma si riferisce è sufficiente a giustificare
l’adozione dell’atto di controllo sostitutivo. Pertanto, l’accertamento in
fatto della sussistenza di una o più delle fattispecie previste dalla norma
comporta automaticamente l’adozione, in via vincolata, del provvedimento di
commissariamento dell’ente.
La sentenza n. 456 torna sulla
materia de qua.
Rifacendosi a quanto stabilito nella
sentenza n. 244,
Pertanto, le disposizioni della legge
della Regione Toscana n. 68 del 2004 (articoli 1 e 4) relative, da un lato,
alla composizione dell’organo di governo delle Comunità montane e, dall’altro,
alle norme transitorie specificamente dettate per quella dell’Area Lucchese, si
sottraggono alla censura di violazione degli indicati parametri costituzionali.
Per le medesime ragioni deve
ritenersi non fondata la questione relativa all’art. 16, comma 1, della legge
della Regione Puglia n. 20 del 2004, la quale ha disposto la incompatibilità
della carica di presidente dell’organo esecutivo delle Comunità montane
pugliesi con quelle di consigliere regionale o sindaco.
3.4.
La «concorrenza di competenze»
Come si ricava già da alcune
decisioni passate in rassegna, non sempre è agevole individuare, per le singole
discipline, titoli competenziali unici. In taluni casi, addirittura, una
siffatta individuazione risulta impossibile, venendo a creare una situazione di
«concorrenza di competenze» di natura diversa.
Nella sentenza n. 50 del 2005
Conseguentemente, «se è vero che la
formazione all’interno delle aziende inerisce al rapporto contrattuale, sicché
la sua disciplina rientra nell’ordinamento civile, e che spetta invece alle
Regioni e alle Province autonome disciplinare quella pubblica, non è men vero
che nella regolamentazione dell’apprendistato né l’una né l’altra appaiono allo
stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti
dell’istituto. Occorre perciò tener conto di tali interferenze». Sulla base di
questa ricostruzione
In applicazione dei principî posti
nella sentenza n. 50,
Al riguardo,
I «fondi interprofessionali per la
formazione continua» disciplinati dalla norma impugnata, pur operando in
materia di formazione professionale, appartenente alla competenza residuale
della Regione, dal punto di vista strutturale, (a) hanno carattere
nazionale (pur se possono articolarsi regionalmente o territorialmente) e sono
istituiti da soggetti privati attivi sul piano nazionale; (b) possono
essere istituiti e conseguentemente agire, alternativamente, o come soggetto
giuridico di natura associativa ai sensi dell’art. 36 cod. civ., o come
soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del
d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Inoltre essi, dal punto di vista funzionale, (c)
gestiscono i contributi dovuti dai datori di lavoro ad essi aderenti, ai sensi
della legislazione in materia di assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione.
Ne discende che, in relazione alla
loro natura ed alle relative forme di costituzione di cui sub (a)
e (b), la disciplina dell’istituzione dei fondi in esame incide
sulla materia dell’«ordinamento civile» spettante alla competenza esclusiva
dello Stato e in relazione all’attività indicata sub (c), sulla
materia della «previdenza sociale», devoluta anch’essa alla medesima competenza
esclusiva.
Perciò, la riserva alla competenza
legislativa regionale residuale della «formazione professionale» non può
precludere allo Stato la competenza di riconoscere a soggetti privati la
facoltà di istituire, in tale materia, fondi operanti sull’intero territorio
nazionale, di specificare la loro natura giuridica, di affidare ad autorità
amministrative statali poteri di vigilanza su di essi, anche in considerazione
della natura previdenziale dei contributi che vi affluiscono.
È evidente, peraltro, che un tale
intervento legislativo dello Stato – a tutela di interessi specificamente
attinenti a materie attribuite alla sua competenza legislativa esclusiva – deve
rispettare la sfera di competenza legislativa spettante alle Regioni in via
residuale (o, eventualmente, concorrente).
Nella specie, viceversa, la normativa
impugnata è strutturata come se dovesse disciplinare una materia integralmente
devoluta alla competenza esclusiva dello Stato.
Infatti, il sistema da essa delineato
lascia le Regioni sullo sfondo, prendendo in considerazione la loro posizione
(e le loro rispettive competenze) solo per proclamare un generico intento di
«coerenza con la programmazione regionale» ovvero per riservare ad esse una
posizione di mere destinatarie di comunicazioni.
Pertanto, il legislatore statale –
qualora ritenga, nella sua discrezionalità, di prevedere che le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale possano istituire fondi interprofessionali di formazione
continua, a carattere nazionale – ben potrà regolare la loro natura giuridica,
i poteri su di essi spettanti ad autorità amministrative statali, e i
contributi ad essi affluenti. Ma dovrà articolare siffatta normativa in modo da
rispettare la competenza legislativa delle Regioni a disciplinare il concreto
svolgimento sul loro territorio delle attività di formazione professionale, e
in particolare prevedere strumenti idonei a garantire al riguardo una leale
collaborazione fra Stato e Regioni.
La norma impugnata viene quindi
dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede
strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.
Ricostruita l’evoluzione normativa
concernente la disciplina dei lavori socialmente utili, nella sentenza si
evidenzia come questa, «concernendo la tutela del lavoro e le politiche
sociali, nel contesto di particolari rapporti intersoggettivi di prestazione di
attività», si collochi «all’incrocio di varie competenze legislative, di cui ai
commi secondo, terzo e quarto dell’art. 117 della Costituzione».
In primo luogo, la disciplina dei
lavori socialmente utili, «in quanto mira ad agevolare l’accesso all’occupazione,
attiene in senso lato al collocamento, e quindi si inscrive nella tutela del
lavoro attribuita alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni».
In secondo luogo, la normativa sui
lavori socialmente utili tende «ad alleviare le difficoltà di inserimento nel
mondo del lavoro e a fronteggiare situazioni di bisogno conseguenti alla
perdita dell’occupazione, prevedendo la corresponsione ai soggetti impiegati in
lavori socialmente utili di somme di danaro […], che ben possono essere
accostate, sotto il profilo della natura latamente previdenziale, all’indennità
di disoccupazione o di mobilità o al trattamento di integrazione salariale»: di
talché, viene in rilievo «sia la materia delle politiche sociali, di sicuro
compresa nella competenza regionale residuale (sentenza n. 427 del 2004), sia
quella della «previdenza sociale», attribuita invece alla competenza esclusiva
dello Stato. Infine, i lavori socialmente utili si ricollegano alla competenza
residuale regionale pure sotto l’ulteriore profilo della «formazione
professionale» dei soggetti assegnati a questo tipo di lavori, nella misura in
cui siffatta assegnazione persegua anche finalità formative.
Ora, constatata la «concorrenza di
competenze»,
Da questa enunciazione di principio
In tal senso, si rileva che, in un
contesto costituzionale di accresciute competenze legislative regionali, le
disposizioni in esame ammettono solo convenzioni stipulate dallo Stato
direttamente con i Comuni ed escludono del tutto le Regioni.
A giustificare tale assetto normativo
non possono addursi istanze unitarie che giustifichino l’attrazione in
sussidiarietà della competenza in capo allo Stato, se è vero che «le funzioni
amministrative relative all’assegnazione di soggetti a lavori socialmente utili
ed alla loro stabilizzazione – lungi dal trascendere l’ambito regionale – si collegano al contrario ad
esigenze decisamente locali, di dimensioni addirittura comunali».
Né, d’altro canto, può invocarsi il
quinto comma dell’art. 119 della Costituzione, riferendosi la normativa in
esame non a finanziamenti in favore di «determinati Comuni» bensì ad «un
sistema generale di finanziamento», tale da riguardare potenzialmente tutti
indistintamente i Comuni italiani.
In definitiva, i commi 76 e 82
dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel prevedere convenzioni
stipulate dallo Stato direttamente con i Comuni per il finanziamento statale di
attività rientranti (anche) in materie di competenza legislativa regionale,
devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non
contemplavano alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra
Stato e Regioni.
Un altro caso nel quale si riscontra
una concorrenza di competenze normative è rappresentato dalla sentenza n.
Con il predetto decreto ministeriale
sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del fondo (comma 113),
modificabili, con successivi decreti, sulla base del recepimento di eventuali
accordi interconfederali o di avvisi comuni delle parti sociali, anche in
attuazione degli indirizzi dell’Unione europea (comma 114).
D’altra parte, vero è che «la
complessità della realtà sociale da regolare comporta che di frequente le
discipline legislative non possano essere attribuite nel loro insieme ad
un’unica materia, perché concernono posizioni non omogenee ricomprese in
materie diverse sotto il profilo della competenza legislativa. In siffatti casi
di concorso di competenze,
Operata questa premessa, e constatato
che le disposizioni oggetto di scrutinio nel caso di specie trovavano il loro
fondamento, sul piano interno, nell’art. 46 della Costituzione e, nel diritto
comunitario, in una serie di provvedimenti susseguitisi nel tempo,
Viene parimenti sottolineato che le
norme impugnate ed i progetti da esse previsti «si ricollegano anche ad atti
comunitari che concernono lo statuto della società europea, con la previsione
di organi decisionali e non solo destinatari di informazione o autori di atti
consultivi»: sotto tale angolo visuale, dunque, «i progetti concernenti il
coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle aziende finiscono per
riguardare, da un lato, le strategie ed alcuni profili strutturali delle
imprese, dall’altro, con l’attribuzione ai lavoratori componenti di determinati
organi di garanzie assimilabili a quelle riconosciute ai rappresentanti
sindacali, la stessa disciplina del rapporto di lavoro».
In ragione di questi rilievi, si
constata che le disposizioni censurate non esauriscono la loro efficacia nella
materia della tutela del lavoro, ma attengono anche – e in misura non
secondaria – all’ordinamento civile, collocandosi «all’incrocio di materie
rispetto alle quali la competenza legislativa è diversamente attribuita dalla
Costituzione: esclusiva dello Stato in tema di ordinamento civile, concorrente
in materia di tutela del lavoro».
Ora, se la competenza esclusiva
giustifica «la legittimazione dello Stato a dettare norme primarie e quindi
l’emanazione del decreto attuativo e di quelli successivi (comma 114) sotto il
profilo dell’esigenza di un progetto unitario di disciplina della società
europea», è parimenti da rilevare che l’esistenza della competenza concorrente
«rende illegittima, anche ai sensi dell’art. 119 Cost., l’esclusione delle
Regioni da ogni coinvolgimento, in violazione del principio di leale
collaborazione».
Proprio su questo punto viene
rintracciata una fattispecie di invalidità, che, nel condurre ad una pronuncia
caducatoria dei commi 113 e 114 dell’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, chiama il legislatore ad intervenire onde predisporre «regole che
comportino il coinvolgimento regionale».
Nella sentenza n. 384, invece,
Di contro, si esclude la concorrenza
di competenze in ordine alle attività formative e di aggiornamento predisposte
dal datore di lavoro per il personale dipendente, poiché esse non rientrano
(anche) nell’ambito della formazione professionale, materia di competenza
residuale delle regioni. Sulla base di questo assunto si dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124, che delinea i contenuti dei processi di formazione
permanente destinati al personale ispettivo, lasciando alla direzione generale
il compito di definire programmi di formazione e di aggiornamento.
Sulla base di precedenti statuizioni,
Nella sentenza n.
La ricerca scientifica e tecnologica,
nel nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione, è inclusa tra le materie
appartenenti alla competenza concorrente.
Tuttavia,
Sulla base di tali premesse
Al di fuori di questo ambito lo Stato
conserva, inoltre, una propria competenza in relazione ad attività di ricerca
scientifica strumentale e intimamente connessa a funzioni statali, allo scopo
di assicurarne un migliore espletamento, sia organizzando direttamente le
attività di ricerca, sia promuovendo studi finalizzati (cfr. sentenza n. 569
del 2000).
Infine, il legislatore statale – come
Alla luce delle osservazioni che
precedono, la disposizione censurata deve essere interpretata nel senso che la
stessa è finalizzata a finanziare esclusivamente quei progetti di ricerca in
relazione ai quali è configurabile, nei limiti indicati, un autonomo titolo di
legittimazione del legislatore statale. Da ciò consegue che tale disposizione,
così interpretata, non determina alcun vulnus a competenze regionali.
3.6.
Le materie attratte in sussidiarietà dallo Stato
Sulla scorta dei principî enucleati a
far tempo dalla sentenza n. 303 del 2003, anche nel 2005 si sono verificati
casi di «chiamata in sussidiarietà» relative a discipline che, non rientranti
in ambiti di competenza esclusiva dello Stato, necessitino, comunque, di un
esercizio unitario. In particolare, siffatte attrazioni hanno riguardato (a)
la disciplina di fondi previdenziali, (b) la previsione di contributi
per l’acquisto di tecnologie, (c) il potenziamento del capitale di
imprese medio-grandi, (d) la normativa in materia di Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs),
(e) il sostegno alle attività cinematografiche, (f) i porti e (g)
l’energia elettrica.
a) Nella sentenza n. 50,
b) Con la sentenza n. 151,
L’assunto secondo cui tali norme
ineriscono a materie, quali l’innovazione tecnologica e l’ordinamento della
comunicazione, nelle quali spetterebbe allo Stato la sola legislazione di
principio, con la conseguente illegittimità dei previsti interventi di
carattere amministrativo, non viene condiviso dalla Corte, sulla considerazione
che le norme impugnate intendono favorire la diffusione della tecnica digitale
terrestre di trasmissione televisiva, quale strumento di attuazione del
principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli
imperativi ineludibili in materia di emittenza televisiva (sentenza n. 466 del
2002), esprimendo l’informazione una condizione preliminare per l’attuazione
dei principî propri dello Stato democratico (così le sentenze n. 312 del 2003 e
n. 29 del 1996).
Ne deriva che le disposizioni impugnate
attingono a una pluralità di materie e di interessi (tutela della concorrenza,
sviluppo tecnologico, tutela del pluralismo di informazione), appartenenti alla
competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato, senza che alcuna
tra esse possa dirsi prevalente così da attrarre l’intera disciplina.
Ciò posto, avuto anche riguardo
all’eccezionalità della situazione caratterizzata dal passaggio alla tecnica
digitale terrestre, l’assunzione diretta di una funzione amministrativa da
parte dello Stato, nella forma dell’erogazione di un contributo economico in
favore degli utenti, previa adozione di un regolamento che ne stabilisca
criteri e modalità di attribuzione, appare giustificata – alla stregua del
principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118, primo comma, della
Costituzione – da una evidente esigenza di esercizio unitario della funzione
stessa, non potendo un intervento a sostegno del pluralismo informativo non
essere uniforme sull’intero territorio nazionale.
L’intervento appare d’altro canto
«ragionevole e proporzionato» in relazione al fine perseguito, a prescindere
dalla sua relativa modestia dal punto di vista finanziario (cfr.sentenza n. 272
del 2004), atteso che l’incentivazione economica all’acquisto del decoder
appare uno strumento non irragionevole di diffusione della tecnica digitale
terrestre di trasmissione televisiva.
c) La sentenza
n.
La normativa è stata impugnata, in
primo luogo, per la sua non riconducibilità in ambiti di competenza normativa
statale: la materia della «tutela della concorrenza», in particolare, non
sarebbe invocabile in quanto la relativa modestia delle risorse previste
escluderebbe che il Fondo istituito possa essere configurato «tra gli
“strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell’intero
Paese”, “finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite
nel circuito economico” e giustificati per la loro “rilevanza macroeconomica”».
In secondo luogo, dalla
regolamentazione delle modalità di gestione delle misure previste emergerebbe
una «pretermissione totale» delle Regioni, in violazione del principio di leale
cooperazione.
Basandosi sulla definizione delle
competenze statali e regionali in tema di politica economica contenute nella
sentenza n. 14 del 2004,
Con riferimento al Fondo rotativo
nazionale, si constata che «non si opera nell’ambito della “tutela della
concorrenza”, poiché gli interventi previsti hanno una ricaduta necessariamente
limitata e solo indiretta sull’attività economica nei tanti e diversi settori
produttivi che potranno essere interessati».
Tuttavia,
Con riferimento alla disciplina nella
specie impugnata, «dirimente è la considerazione dell’esplicita finalizzazione
del Fondo rotativo nazionale alla crescita e allo sviluppo del tessuto
produttivo nazionale, in quanto per il raggiungimento di tale finalità appare
strutturalmente inadeguato il livello regionale, al quale inevitabilmente
sfugge una valutazione d’insieme». In questo senso, del resto, va sottolineato
che il Fondo si riferisce «alle sole imprese medie e grandi “come qualificate
dalla normativa nazionale e comunitaria”» e che le condizioni e le modalità di
attuazione dei singoli interventi è affidato al Comitato interministeriale per
la programmazione economica.
La rilevata dimensione sovraregionale
delle funzioni si deve peraltro coniugare al necessario coinvolgimento
sostanziale delle Regioni da parte dello Stato, «poiché l’esigenza di esercizio
unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella
legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale
solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e
di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte
in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003).
Di talché, ove non sussistano ancora
adeguati strumenti di partecipazione delle Regioni ai procedimenti legislativi
statali, quanto meno debbono essere previsti «adeguati meccanismi di
cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in
capo agli organi centrali» (sentenza n. 6 del 2004).
Sulla scorta di queste
considerazioni, l’analisi della disciplina impugnata ha condotto al
riconoscimento di un vizio di costituzionalità derivante dall’assenza di «alcun
tipo di coinvolgimento delle Regioni nell’ambito dell’attività meramente
gestoria affidata a Sviluppo Italia s.p.a.»: da ciò deriva la declaratoria di
incostituzionalità dell’art. 4, comma 110, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
La declaratoria si presenta,
tuttavia, nella forma di una additiva di procedura, ed il ruolo normativo in
materia riconosciuto al Cipe
costituisce la sede idonea per un coinvolgimento delle Regioni, adeguato ad
equilibrare le esigenze di leale collaborazione con quelle di esercizio
unitario delle funzioni attratte in sussidiarietà al livello statale»: donde la
necessità che i poteri del Cipe
in materia di determinazione delle condizioni e delle modalità di attuazione
degli interventi di gestione del Fondo rotativo nazionale per gli interventi
nel capitale di rischio possano essere esercitati solo di intesa con
d) Con la sentenza n. 270,
Le Regioni ricorrenti,
sostanzialmente, censurano l’eccessiva analiticità dei principî e criteri
direttivi contenuti nelle disposizioni di delega, e l’inserimento in essa di
disposizioni di dettaglio, fonti di conseguente compressione dei poteri
legislativi regionali in materia; contestano, inoltre, l’attribuzione di
numerosi e rilevanti poteri amministrativi ad organi statali in materie di
competenza delle Regioni.
Preliminarmente,
Quanto appena esposto implicitamente
esclude che la normativa oggetto del presente giudizio possa essere ricondotta
al titolo di legittimazione della potestà legislativa statale costituito dall’art.
117, secondo comma, lettera g),
Cost., con la conseguenza di una radicale esclusione delle Regioni dalla
disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
La competenza dello Stato a
legiferare nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa degli
enti pubblici nazionali», contemplata nella lettera g) del secondo comma
dell’art. 117 Cost., non può assumere le caratteristiche di un titolo
«trasversale» in grado di legittimare qualsivoglia intervento legislativo
indipendentemente dalle specifiche funzioni che ad un determinato ente pubblico
vengano in concreto attribuite e dalle materie di competenza legislativa cui
tali funzioni afferiscano.
Come accennato, infatti, la profonda
modificazione dei criteri di riparto fra le competenze legislative dello Stato
e delle Regioni comporta, in via di principio, che la scelta di prevedere e
disciplinare enti pubblici strumentali al conseguimento delle diverse finalità
pubbliche perseguite spetti al legislatore competente a disciplinare le
funzioni ad essi affidate e che, dunque, lo Stato possa prevedere e
disciplinare enti pubblici nazionali in tutti i casi in cui disponga di una
competenza legislativa non limitata ai principî fondamentali. In altre parole,
il legislatore statale può istituire enti pubblici – e conseguentemente
utilizzare la lettera g) del secondo
comma dell’art. 117 Cost. per dettarne la relativa disciplina ordinamentale e
organizzativa – solo allorché affidi a tali enti funzioni afferenti a materie
di propria legislazione esclusiva, oppure nei casi in cui, al fine di garantire
l’esercizio unitario di determinate funzioni che pur sarebbero di normale
competenza delle Regioni o degli enti locali (avendole valutate come non
utilmente gestibili a livello regionale o locale), intervenga in sussidiarietà
proprio mediante la previsione e la disciplina di uno o più appositi enti
pubblici nazionali. Peraltro, un intervento come quello appena accennato, al
fine di evitare un improprio svuotamento delle nuove prescrizioni costituzionali,
esige non solo l’attenta valutazione dell’effettiva sussistenza delle
condizioni legittimanti (necessarietà dell’attrazione al livello statale della
funzione e della relativa disciplina regolativa, nonché idoneità, pertinenza
logica e proporzionalità di tale disciplina rispetto alle esigenze di
regolazione della suddetta funzione), ma anche la previsione di adeguate forme
di coinvolgimento delle Regioni interessate, secondo i moduli di leale
collaborazione più volte indicati come ineliminabili da questa Corte (cfr., fra
le altre, le sentenze. n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).
Il n. degli istituti pubblici di
ricovero e cura a carattere scientifico attualmente esistenti, i loro risalenti
rapporti con il sistema delle autonomie territoriali dovuti alla localizzazione
sul territorio, nonché la relativa eterogeneità delle attività in concreto
svolte, mettono in evidenza che in questo settore ben difficilmente potrebbe
essere superato lo stretto controllo di ragionevolezza sulla effettiva
esistenza di una situazione tale da giustificare la attrazione a livello
statale delle funzioni e della relativa disciplina. Lo stesso legislatore
statale non sembra aver compiuto una scelta del genere, dal momento che le
disposizioni di delega rendono evidente che era consapevole di intervenire in
una materia caratterizzata da un intreccio di competenze statali e regionali
(cfr. art. 42, comma 1, lettera a, e
comma 2 della legge n. 3 del 2003).
D’altra parte, queste valutazioni
sono confermate anche dai lavori preparatori del decreto di attuazione della
delega, che ha seguito il procedimento prescritto dal secondo comma dell’art.
42 della legge n. 3 del 2003.
Sempre in via preliminare,
La stessa titolazione dell’art. 42
della legge n. 3 del 2003 indica che la normativa di cornice delegata dal
legislatore nazionale concerne «la trasformazione degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico in fondazioni», e cioè un procedimento del tutto
innovativo e che per di più opera con riferimento ad un nuovo tipo di soggetto
giuridico (
In particolare, la delega legislativa
contiene alcuni principî e criteri concernenti la previsione di fondamentali
caratteristiche organizzative comuni di questo nuovo tipo di fondazioni, i
rapporti fra di esse, necessitati dalla loro complessiva funzione di assicurare
«la ricerca nazionale ed internazionale» nel settore sanitario, nonché il
regime giuridico degli Irccs non
trasformati.
La legittima disciplina da parte del
legislatore statale del processo di trasformazione degli Irccs pubblici in apposite fondazioni
di diritto pubblico a sua volta giustifica (diversamente da quanto asserito
dalle ricorrenti) che venga prevista nella delega anche la disciplina
dell’assetto giuridico degli Irccs
non trasformati o degli Irccs di
diritto privato, in quanto parte di un complessivo processo di trasformazione,
che non può non riguardare anche le figure affini o residuali.
Alla luce di tali considerazioni,
Innanzitutto, motiva
Tanto permette anche di superare i
dubbi rlativi alla lettera m) del primo comma dell’art. 42 della legge
n. 3 del 2003, che delega il Governo a disciplinare «i criteri generali per il
riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la
revisione e la eventuale revoca dei ricoscimenti già concessi»). Le
disposizioni delegate, infatti, non potranno che riprodurre, negli specifici
contesti previsti dalla delega legislativa, i ruoli fondamentali previsti dalla
disposizione relativa alla trasformazione degli Irccs esistenti, con particolare riferimento al ruolo del
Ministro ed alla necessaria intesa della Regione interessata.
Anche la previsione, contenuta
nell’art. 43 della legge n. 3 del 2003, secondo cui spetta al Ministro della
salute la determinazione dell’«organizzazione a rete degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline», seppur
«sentita
Proprio in questo ruolo particolare
riconosciuto al Ministro in tema di garanzia di una visione unitaria sul piano
della ricerca scientifica dell’intera rete degli Irccs, trovano giustificazione sia il potere del Ministro di
affidare «diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca» ai diversi Irccs, sia il potere del Ministro di
nominare, «sentita
Fondate risultano, invece, le censure
concernenti l’art. 42, comma 1, lettera b) e lettera p),
limitatamente alla parte in cui contengono vincoli relativi alla composizione
del consiglio di amministrazione delle Fondazioni ed alla rappresentanza paritetica
in questo Consiglio «del Ministero della salute e della Regione interessata»,
nonché alla composizione paritetica fra rappresentanti regionali e ministeriali
del Consiglio di indirizzo degli Irccs
non trasformati e alla nomina da parte del Ministro della salute del Presidente
dell’Istituto non trasformato.
Infatti, il riconoscimento di una
competenza legislativa di tipo concorrente delle Regioni sia in tema di
«ricerca scientifica» che di «tutela della salute», non legittima una presenza
obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di
gestione di enti pubblici che non appartengono più all’area degli enti statali,
né consente di giustificare, sotto il profilo del rispetto della competenza a
dettare i principî fondamentali, che il legislatore statale determini quali
siano le istituzioni pubbliche che possano designare la maggioranza del
consiglio di amministrazione delle fondazioni.
Sono, invece, in parte fondate le
questioni proposte avverso le disposizioni relative alla composizione e
designazione dei consigli di amministrazione, dei Presidenti e dei collegi sindacali
delle Fondazioni (art. 3, commi 2 e 3, e art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 288 del
2003), le quali appaiono ingiustificatamente dettagliate e quindi invasive, ad
un tempo, sia dell’area di autonomia statutaria riconosciuta alle Fondazioni,
che dell’ambito lasciato all’eventuale esercizio della potestà legislativa
regionale. Al tempo stesso, queste disposizioni sono incostituzionali nella
parte in cui pretendono di riservare, mediante obblighi legislativi, alcune
designazioni ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti
pubblici che non appartengono più all’area degli enti statali.
Per quanto riguarda le funzioni
amministrative affidate al Ministro della salute (art. 1, comma 2, del d.lgs.
n. 288 del 2003),
In effetti, il riconoscimento degli Irccs come enti autonomi, dotati di
propri statuti ed organi di controllo interni, ed operanti nell’ambito della
legislazione regionale di tipo concorrente, rende manifesto come non sia
conforme a Costituzione attribuire al Ministro della salute veri e propri poteri
di controllo amministrativo su di essi. In particolare, appare estranea alla
ricostruzione della natura e della posizione giuridica degli Irccs la previsione (commi 1 e 2
dell’art. 16 del d.lgs. n. 288 del 2003) di un vero e proprio controllo
amministrativo di tipo preventivo sugli atti fondamentali degli Irccs, controllo affidato ad appositi
organi statali (i Comitati periferici di vigilanza) operanti su scala
regionale.
Un controllo del genere, peraltro, è
ormai escluso sia per le Regioni che per gli enti locali dalla intervenuta
abrogazione degli stessi articoli 125 e 130 della Costituzione.
Infondata è, invece, la censura
concernente l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003, con cui si lamenta
la totale compressione della potestà legislativa regionale in tema di
disciplina delle Fondazioni Irccs,
che scaturirebbe dalla disposizione impugnata, la quale stabilisce, che «alle
Fondazioni Irccs si applicano,
per quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo, le
disposizioni di cui al Libro I, Titolo II del Codice civile».
Di quest’ultima disposizione,
sottolinea
Quanto alla censura concernente
l’art. 5, comma 1, nella parte in cui prevede che l’atto di intesa, da assumere
in sede di Conferenza fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano, deve determinare «le modalità di organizzazione, di gestione e di
funzionamento degli Irccs non
trasformati in Fondazioni», una Regione ricorrente, considerando questa intesa
come una vera e propria fonte normativa, ne rileva la profonda anomalia e comunque
rivendica in alternativa la possibilità di disciplinare la materia mediante la
legge regionale.
Replica
Immune da censure, infine, risulta
l’art. 4, comma 236, della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui autorizza
le Fondazioni Irccs e gli
Istituti non trasformati ad alienare i beni immobili del proprio patrimonio al
fine di ripianare i debiti pregressi, stabilendo che «le modalità di attuazione
sono autorizzate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze». Per
e) Con la sentenza
n. 285,
In via preliminare,
Ad avviso della Corte, le prime due
materie citate non sono scorporabili dalle «attività culturali» di cui all’art.
117, terzo comma, Cost., che «riguardano tutte le attività riconducibili alla
elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per
ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo»; ed impropri appaiono anche
i richiami alle materie dell’industria e del commercio, poiché la disciplina in
esame si connota come strumentale alla realizzazione di attività consistenti in
rappresentazioni artistiche e di comunicazione culturale propriamente
riconducibili al settore della cultura.
Con particolare riferimento alla
disciplina concernente l’apertura di sale cinematografiche, continua
In altre parole, ritiene
Del pari infondata è l’affermazione
secondo la quale, in relazione al livello di rappresentatività degli interessi
pubblici della materia, continua ad operare l’interesse nazionale, imponendo il
superamento della ripartizione costituzionale delle materie attraverso un
trattamento uniforme su tutto il territorio dello Stato. Una tesi del genere,
sottolinea
Passando all’esame delle specifiche
censure, viene respinta quella formulata nei confronti dell’art. 6 del d.lgs.
n. 28 del 2004, che configurerebbe gli accordi internazionali in materia di
coproduzioni come accordi solo statali, «in violazione dell’art. 117, nono
comma, Cost., che attribuisce alle Regioni il potere di concludere accordi con
Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato». Motiva
Al riguardo rileva che, per la
maggior parte, le disposizioni impugnate del decreto legislativo riguardano una
materia di competenza legislativa ripartita fra Stato e Regione, di talché la
legislazione statale dovrebbe limitarsi a definire i soli principî fondamentali
della materia, mentre le funzioni amministrative dovrebbero essere attribuite
normalmente ai livelli di governo substatali in base ai principî di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza indicati nell’art. 118 Cost. La
disciplina in esame, invece, appare essenzialmente caratterizzata, sul piano
legislativo, da una normativa completa ed autoapplicativa, senza distinzione
tra principî e dettagli, e, sul piano amministrativo, da un modello di gestione
accentuatamente statalistico ed essenzialmente fondato su poteri ministeriali,
con una presenza del tutto marginale di rappresentanti delle autonomie
territoriali.
Tutto ciò parrebbe contrastante, non
solo con l’art. 117, terzo comma, Cost., ma anche con il primo comma dell’art.
118 Cost., dal momento che, ove si fosse voluto intervenire in questa
particolare materia mediante una «chiamata in sussidiarietà» delle funzioni
amministrative da parte dello Stato, ciò avrebbe richiesto, ormai per consolidata
giurisprudenza, quanto meno «una disciplina che prefiguri un iter in cui
assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento
orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al
principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003; sentenze n. 242 del 2005, n.
255 e n. 6 del 2004).
Deve tuttavia essere considerato come
il livello di governo regionale – e, a maggior ragione, quello infraregionale –
appaiano strutturalmente inadeguati a soddisfare, da soli, lo svolgimento di
tutte le tipiche e complesse attività di disciplina e sostegno del settore
cinematografico. Ciò in quanto tali attività – diversamente opinando –
risulterebbero esposte al rischio di eccessivi condizionamenti localistici
nella loro gestione, a fronte, invece, della necessità di sostenere anche
iniziative di grande rilevanza culturale prescindendo da questi ultimi. In tal
senso depone, altresì, la stessa preesistenza, rispetto alla riforma di cui al
decreto impugnato, di una organizzazione operante, almeno in larga parte, a
livello nazionale.
Ciò giustifica, di conseguenza, un
intervento dello Stato che si svolga, anzitutto, mediante la posizione di norme
giuridiche che siano in grado di guidare – attraverso la determinazione di
idonei principî fondamentali – la successiva normazione regionale,
soddisfacendo quelle esigenze unitarie cui si è fatto riferimento (e a questo
riguardo assume specifico rilievo la collocazione della materia de qua
tra quelle a competenza ripartita), ma anche, là dove necessario, mediante la
avocazione in sussidiarietà sia di funzioni amministrative che non possano
essere adeguatamente svolte ai livelli inferiori, sia della relativa potestà
normativa per l’organizzazione e la disciplina di tali funzioni.
Del resto, la sussistenza, nel
settore del sostegno alle attività culturali, di esigenze che rendevano
costituzionalmente legittima la allocazione allo Stato di alcune delle funzioni
ad esso relative era già stata espressamente segnalata nella sentenza n. 255
del 2004, relativa al Fondo unico per lo spettacolo.
Se, quindi, il legislatore statale –
in un settore di competenza legislativa ripartita, nel quale però esistono
forti e sicuri elementi che esigono una gestione unitaria a livello nazionale –
in astratto può realizzare una pluralità di modelli istituzionali per dare, nel
rispetto sostanziale del Titolo V, concretizzazione alla scelta di un modello
diverso da quello ordinariamente deducibile dagli articoli 117 e 118 Cost.,
Dal punto di vista del recupero in
termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è anzitutto
indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria
fra organi statali e Conferenza Stato-Regioni tutti quei numerosi poteri di
tipo normativo o programmatorio che caratterizzano il nuovo sistema di sostegno
ed agevolazione delle attività cinematografiche, ma che nel decreto legislativo
sono invece riservati solo ad organi statali.
In particolare, l’art. 3, comma 2, del
d.lgs. n. 28 del 2004, prevede che un decreto ministeriale definisca «gli
indicatori ed i rispettivi valori» relativi ai parametri indicati dal decreto
legislativo medesimo per determinare il punteggio da attribuire alle imprese
cinematografiche di produzione ai fini della individuazione della categoria di
appartenenza sulla cui base viene determinato il finanziamento delle imprese
medesime.
L’art. 4, comma 3, prevede che il
Ministro per i beni e le attività culturali approvi il «programma triennale»
predisposto dalla Consulta territoriale per le attività cinematografiche;
programma che – tra l’altro – individua le aree geografiche di intervento e
individua gli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche.
L’art. 12, comma 4, prevede che, «con
decreto ministeriale, sentita
L’art. 17, comma 4, prevede che «con
decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del
premio di cui al comma 3» fra le diverse categorie di soggetti che possono
aspirare ai «premi di qualità».
L’art. 19, comma 3, prevede che il
Ministro definisca annualmente gli obiettivi che contribuiscono a far
deliberare l’erogazione dei contributi alle attività cinematografiche.
L’art. 19, comma 5, prevede che «con
decreto ministeriale, sentita
In tutti questi casi appare
ineludibile che i previsti atti vengano adottati di intesa con
In altri casi, caratterizzati dalla
natura tecnica del potere normativo previsto o dall’esercizio di poteri di
nomina di particolare delicatezza, il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni
può limitarsi all’espressione di un parere obbligatorio.
Fondate sono anche le censure
concernenti l’art. 22, comma 5, e l’art. 4, comma 5, del decreto legislativo n.
28 del 2004, relativi all’autorizzazione all’apertura «di multisale con un n.
di posti superiori a milleottocento», che la disciplina in esame riserva al
Direttore generale competente del Ministero, mentre alla Consulta territoriale
è attribuito in materia un potere consultivo. Al riguardo,
f) Le questioni poste all’attenzione della Corte nei
giudizi definiti con la sentenza n. 378 concernono tutte la legittimità
costituzionale di norme che, incidendo sulla disciplina di cui all’art. 8 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale),
mirano a creare meccanismi volti a superare la situazione di stallo che si crea
quando, in fatto, non si realizza l’intesa che, per la nomina del Presidente
dell’Autorità portuale, il citato art. 8 prevede debba raggiungersi tra
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Regione interessata nell’ambito
di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale
nei settori dell’economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente
dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio. Qualora non pervenga
nei termini alcuna designazione, recita sempre l’art. 8, il Ministro nomina il
presidente, previa intesa con
Quest’ultima norma – richiedendo
l’intesa con
La inequivoca volontà originaria
della legge non può essere misconosciuta – qualificando come «debole» l’intesa
in questione – dopo che la riforma del Titolo V della Parte seconda della
Costituzione ha inserito la materia dei «porti e aeroporti civili» tra quelle
di «legislazione concorrente» previste dall’art. 117, terzo comma, Cost.: anzi,
deve dirsi che la norma statale de qua, in quanto attributiva al
Ministro di funzioni amministrative in materia contemplata dall’art. 117, terzo
comma, Cost., è costituzionalmente legittima proprio perché prevede una
procedura che, attraverso strumenti di leale collaborazione, assicura
adeguatamente la partecipazione della Regione all’esercizio in concreto della
funzione amministrativa da essa allocata a livello centrale (sentenza n. 6 del
2004).
Ne discende che ab origine l’art. 8
della legge n. 84 del 1994 esigeva, ed a fortiori esige oggi – alla luce
della sopravvenuta legge costituzionale n. 3 del 2001 – «una paritaria
codeterminazione del contenuto dell’atto» di nomina, quale «forma di attuazione
del principio di leale cooperazione tra lo Stato e
In presenza di tale situazione
normativa, sia lo Stato sia
A tale proposito,
Tali meccanismi, quale che ne sia la
concreta configurazione, debbono in ogni caso essere rispettosi delle esigenze
insite nella scelta, operata dal legislatore costituzionale, con il
disciplinare la competenza legislativa in quella data materia: e pertanto deve
trattarsi di meccanismi che non stravolgano il criterio per cui alla legge
statale compete fissare i principî fondamentali della materia, che non
declassino l’attività di codeterminazione connessa all’intesa in una mera
attività consultiva, che prevedano l’allocazione delle funzioni amministrative
nel rispetto dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di
cui all’art. 118 Cost.
La legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia 24 maggio 2004, n. 17, dopo aver pedissequamente trascritto l’art. 8,
comma 1, della legge statale n. 84 del 1994 – ma attribuendo al Presidente
della Regione i poteri che la norma statale riconosce al Ministro – prevede
che, «qualora nei termini previsti non pervenga alcuna designazione, il
Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, nomina comunque il Presidente dell’Autorità portuale di Trieste
tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione
professionale nei settori dell’economia, dei trasporti e portuale».
Al riguardo,
Motiva
È in tale contesto che va inquadrata
la previsione normativa circa la spettanza al Ministro del potere di nomina del
Presidente dell’Autorità portuale, la cui costituzione è prevista per i porti
aventi rilevanza economica internazionale o nazionale.
Il Presidente, in sintesi, è posto al
vertice di una complessa organizzazione che vede coinvolti, e soggetti al suo
coordinamento, anche organi schiettamente statali, e gli è assegnato un ruolo
fondamentale, anche di carattere propulsivo, perché il porto assolva alla sua
funzione comunque interessante l’economia nazionale.
Ne discende che, se la scelta,
operata dal legislatore statale nel 1994, di coinvolgere
In breve, l’originaria previsione in
tema di potere di nomina si coordina con l’insieme della legge contribuendo,
quale sua organica articolazione, all’equilibrio che essa realizza tra istanze
centrali, regionali e locali; sicché tale previsione continua a costituire
principio fondamentale della materia, alla pari delle altre sulla composizione
degli organi e sui loro compiti e poteri.
Nulla, peraltro, si oppone a che, laddove
vi sia un intreccio di interessi locali, regionali, nazionali ed
internazionali, armonicamente coordinati in un sistema compiuto, possa
qualificarsi principio fondamentale della materia anche l’allocazione, ex lege statale, a livello centrale del
potere di nomina di chi tali interessi deve coordinare e gestire.
Ciò è sufficiente per dichiarare
costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 2, della legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia, in quanto contrastante con il principio fondamentale
secondo il quale il potere di nomina del Presidente dell’Autorità portuale
(qui, di Trieste) compete, previa intesa con
Fondati sono, viceversa, gli altri
motivi di ricorso. Infatti, la norma impugnata si risolve nel rompere, a danno
della Regione, l’equilibrio tra istanze ed esigenze di vario livello assicurato
dalla legge n. 84 del 1994, nella sua originaria formulazione, e nel degradare
l’intesa, prevista dall’art. 8, comma 1, della medesima legge, al rango di mero
parere non vincolante, in quanto attribuisce al Ministro il potere – quali che
siano le ragioni del mancato raggiungimento dell’intesa e per ciò solo che
siano decorsi trenta giorni – di chiedere che la nomina sia effettuata dal
Consiglio dei ministri, e cioè da un organo del quale il Ministro fa parte.
Il meccanismo escogitato è tale da
svilire il potere di codeterminazione riconosciuto alla Regione, dal momento
che la mera previsione della possibilità per il Ministro di far prevalere il
suo punto di vista, ottenendone l’avallo dal Consiglio dei ministri, è tale da
rendere quanto mai debole, fin dall’inizio del procedimento, la posizione della
Regione che non condivida l’opinione del Ministro e da incidere sulla
effettività del potere di codeterminazione che, ma (a questo punto) solo
apparentemente, l’art. 8, comma 1, continua a riconoscere alla Regione.
Conseguentemente,
g) Di particolare rilievo è, infine, la sentenza n. 383,
resa dalla Corte in occasione dei ricorsi proposti dalla Regione Toscana e
dalla Provincia autonoma di Trento avverso numerose disposizioni contenute nel
decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella
legge 27 ottobre 2003, n. 290,concernenti la sicurezza ed il risparmio di
energia elettrica, e nella legge 23 agosto 2004, n. 239, che riordina il
sistema elettrico nazionale. I rilievi di costituzionalità riguardano
precipuamente la ripartizione di competenze legislative tra lo Stato e le
regioni in materia di energia elettrica, ulteriormente integrati dalle
doglianze della Provincia di Trento, che evoca la violazione dei parametri
statutari e delle relative norme di attuazione nonché dell’art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Altre doglianze riguardano l’intervento
del legislatore statale nella allocazione di funzioni amministrative presso
organi dello Stato, che sarebbe avvenuto in assenza dei presupposti
costituzionali richiesti. Oggetto di contestazione anche la previsione di un
potere sostitutivo statale in affermato contrasto con i presupposti
costituzionali per l’attribuzione e l’esercizio di un simile potere.
In via preliminare,
Affrontando le questioni sollevate
dalla Regione Toscana con riferimento ad alcune disposizioni della legge n. 239
del 2004,
Al riguardo, motiva
In secondo luogo, la «distribuzione
locale dell’energia» è nozione utilizzata dalla normativa comunitaria e
nazionale, ma solo come possibile articolazione a fini gestionali della rete di
distribuzione nazionale. Si tratta quindi di una nozione rilevante a livello
amministrativo e gestionale, ma che non può legittimare l’individuazione di una
autonoma materia legislativa sul piano del riparto costituzionale delle
competenze fra Stato e Regioni.
Il problema fondamentale attiene alla
relazione intercorrente fra le disposizioni impugnate ed i modelli di rapporto
fra Stato e Regioni configurabili in base al Titolo V della Costituzione, nella
consapevolezza che la disciplina legislativa oggetto di censura è riferibile
prevalentemente alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia», di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.
Le norme legislative in esame sono il
frutto, per ciò che riguarda il decreto legge n. 239 del 2003 e la relativa
legge di conversione n. 290 del 2003, di un intervento normativo originato da
alcune urgenti necessità di sviluppo del sistema elettrico nazionale e di
recupero di potenza, con una considerazione solo parziale del ruolo delle
Regioni in materia, peraltro accresciuta nella fase della conversione in legge
dell’originario decreto legge. La legge n. 239 del 2004 si configura, invece,
come una legge di generale riordino dell’intero settore energetico, necessaria
anche per dare attuazione allo stesso art. 117, terzo comma, Cost. in un
settore in precedenza largamente di competenza statale. In tutte queste norme,
per l’area appartenente alla competenza legislativa regionale di tipo
concorrente, il legislatore statale dispone la «chiamata in sussidiarietà» di
una buona parte delle funzioni amministrative concernenti il settore
energetico, con l’attribuzione di rilevanti responsabilità ad organi statali e
quindi con la parallela disciplina legislativa da parte dello Stato di settori
che di norma dovrebbero essere di competenza regionale ai sensi del terzo comma
dell’art. 117 Cost.
D’altra parte, ciò emerge
espressamente anche dallo stesso art. 1, comma 1, della legge n. 239 del 2004,
il quale afferma che «gli obiettivi e le linee della politica energetica
nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello
territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei
meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previsti
dalla presente legge».
In quella occasione, la valutazione
da parte di questa Corte della effettiva sussistenza dei presupposti che
giustificassero la chiamata in sussidiarietà dell’amministrazione statale fu
positiva, sulla base del riconoscimento della preminente esigenza di evitare il
pericolo di interruzione della fornitura dell’energia elettrica a livello
nazionale, attraverso una accentuata semplificazione del procedimento
necessario per «la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia
elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici» ed opere connesse.
Esigenze analoghe sono sicuramente
individuabili anche per le impugnate disposizioni del decreto legge n. 239 del
2003, quale convertito nella legge n. 290 del 2003 (si veda, in particolare,
l’art. 1-sexies, nella parte in cui si riferisce alla riforma e
semplificazione del procedimento di «autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti, dei gasdotti, facenti parti
delle reti nazionali di trasporto dell’energia»).
Esaminando la legge n. 239 del 2004,
Sulla base delle esposte premesse,
Queste disposizioni, sul presupposto
della loro riconducibilità alla materia di legislazione concorrente
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», priverebbero le
Regioni della potestà di esercitare le proprie competenze legislative in
materia. Sarebbe altresì violato l’art. 118 Cost., perché, trattandosi di
materia rientrante nella competenza legislativa concorrente, spetterebbe alla
Regione e non già all’amministrazione centrale allocare l’esercizio delle
funzioni amministrative. In secondo luogo, anche ove si ritenessero sussistenti
esigenze unitarie tali da consentire l’attrazione delle funzioni in capo allo
Stato, non sarebbe prevista alcuna forma di intesa, in violazione del principio
di leale collaborazione.
In ordine alla impugnativa della
Provincia autonoma di Trento avverso l’art. 1-ter, comma 2, del decreto
legge n. 239 del 2003, nel testo risultante dalla conversione nella legge n.
290 del 2003, il quale stabilisce che «il Ministro delle attività produttive
emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell’energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo
predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto»,
Non fondata risulta, invece,
l’impugnativa della Provincia di Trento avverso il comma 5 dell’art. 1-sexies
del decreto legge n. 239 del 2003, nel testo risultante dalla conversione nella
legge n. 290 del 2003, nella parte in cui stabilisce che «le Regioni
disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio
di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principî e ai
termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che
ricadono nel territorio di più Regioni, le autorizzazioni siano rilasciate
d’intesa tra le Regioni interessate».
Ritiene
Infondata risulta l’impugnativa della
Regione Toscana avverso l’art. 1, comma 4, lettera c), della legge n.
239 del 2004, il quale, nel prevedere che Stato e Regioni assicurano
l’omogeneità delle modalità di fruizione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti l’energia e dei criteri di formazione delle tariffe e
dei prezzi conseguenti, stabilisce che essi garantiscono – tra l’altro –
«l’assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o
indiretti ricadenti al di fuori dell’ambito territoriale delle autorità che li
prevedono». Tale disposizione contrasterebbe con gli articoli 117 e 118 Cost.,
in quanto la nozione di «effetto economico indiretto» sarebbe così ampia e vaga
da impedire ogni politica regionale nel settore energetico e bloccherebbe o
limiterebbe fortemente l’esercizio delle competenze regionali in materia di
energia.
Motiva
Se dunque lo Stato ha legittimamente
posto un principio fondamentale della materia, l’asserita illegittima
limitazione dei poteri amministrativi della Regione potrebbe derivare soltanto
da un illegittimo esercizio in concreto delle competenze amministrative
spettanti agli organi dello Stato; rischio solo eventuale, e, nell’ipotesi che
si concretizzasse in termini ritenuti contrastanti con le disposizioni
costituzionali in tema di autonomia regionale, non mancherebbero alle Regioni
interessate idonee forme di tutela, anche in sede giurisdizionale.
Illegittimo si rivela l’art. 1, comma
4, lettera f), della legge n. 239 del 2004, impugnato dalla Regione
Toscana, il quale esclude gli impianti alimentati da fonti rinnovabili dalle
misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, qualora
esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni
territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale.
Ad avviso della Corte, la
disposizione in questione si risolve, infatti, nella imposizione al legislatore
regionale di un divieto di prendere in considerazione una serie di
differenziati impianti, infrastrutture ed attività per la produzione energetica,
ai fini di valutare il loro impatto sull’ambiente e sul territorio regionale
(che, in caso di loro concentrazione sul territorio, può anche essere
considerevole) solo perché alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Tale
previsione eccede il potere statale di determinare soltanto i principî
fondamentali della materia e determina una irragionevole compressione della
potestà regionale di apprezzamento dell’impatto che tali opere possono avere
sul proprio territorio, in quanto individua puntualmente una categoria di fonti
di energia rispetto alla quale sarebbe preclusa ogni valutazione da parte delle
Regioni in sede di esercizio delle proprie competenze costituzionalmente
garantite.
Parimenti, viene dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, lettera i), della
legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che l’individuazione
delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, al fine di garantire la
sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e
del relativo utilizzo, avvenga d’intesa con le Regioni e le Province autonome
interessate. Al riguardo,
Egualmente illegittima risulta le
disposizione, impugnata dalla Regione Toscana, di cui all’art. 1, comma 8,
lettera a), punto 3, della legge n. 239 del 2004, che attribuisce allo
Stato i poteri amministrativi di determinazione delle linee generali di
sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica, poiché
non vi è dubbio che tali disposizioni ineriscano alla materia «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» e che la chiamata in
sussidiarietà da parte dello Stato delle funzioni amministrative debba essere
accompagnata dalla previsione di idonei moduli collaborativi nella forma
dell’intesa in senso forte fra gli organi statali e
Illegittimo è anche l’art. 1, comma
8, lettera b), punto 3, della legge n. 239 del 2004, impugnato sempre
dalla Regione Toscana, il quale prevede che lo Stato assuma le «determinazioni
inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento». Anche qui la chiamata in
sussidiarietà da parte dello Stato di un delicato potere amministrativo, per di
più connesso con una molteplicità di altre funzioni regionali, quanto meno in
tema di tutela della salute e di governo del territorio, deve essere
accompagnato dalla previsione di un’intesa in senso forte fra gli organi
statali e le Regioni e le Province autonome direttamente interessate.
Parzialmente fondate sono, poi, le
questioni sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento
avverso l’art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239 del 2004, che
(1) ha mantenuto al Ministro delle attività produttive l’emanazione degli
«indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia
elettrica e di gas naturale», disponendo inoltre che (2) il Ministro «verifica
la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle
reti di trasporto con gli indirizzi medesimi».
Per un verso,
Nell’attuale situazione, infatti,
tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la
legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la
«chiamata in sussidiarietà» di una funzione amministrativa in materie affidate
alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie
intese «in senso forte», ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale,
come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In
questi casi, pertanto, deve escludersi che, ai fini del perfezionamento
dell’intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da
una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l’unico attore
di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi
all’esercizio di un potere unilaterale.
L’esigenza che il conseguimento di
queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla
reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di
stallo, potrà certamente ispirare l’opportuna individuazione, sul piano
legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l’adozione
dell’atto finale nei casi in cui siano insorte difficoltà a conseguire
l’intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere dalla
permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte. E nei casi
limite di mancato raggiungimento dell’intesa, potrebbe essere utilizzato, in
ipotesi, lo strumento del ricorso alla Corte in sede di conflitto di
attribuzione fra Stato e Regioni.
Non fondata risulta la questione
sollevata dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dell’art. 1, comma
26, della legge n. 239 del 2004, secondo cui il soggetto che ha richiesto la
autorizzazione può chiedere di concludere il procedimento autorizzatorio
secondo la normativa previgente, fatta eccezione per i procedimenti per i quali
sia completata la procedura di Via,
ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione».
Motiva
Viene altresì respinta l’impugnativa
della Regione Toscana avverso l’art. 1, comma 33, della legge n. 239 del 2004,
il quale prevede che «sono fatte salve le concessioni di distribuzione di
energia elettrica in essere, ed aggiunge che «il Ministro delle attività
produttive, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, anche al fine
di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle
clausole contenute nelle relative convenzioni».
Per
Quanto alle specifiche censure
concernenti le previsioni di cui ai commi 57 e 58, occorre prendere atto della
ineludibilità dell’evidente impatto sul territorio di molte delle scelte che
caratterizzano il settore delle politiche riconducibili alla materia
dell’energia. Tali conseguenze, tuttavia, debbono ritenersi adeguatamente
bilanciate dal doveroso coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali
all’interno dei processi decisionali di elaborazione e realizzazione delle
politiche energetiche.
Non fondata anche l’impugnativa della
Regione Toscana avverso i commi 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 dell’art. 1 della
legge n. 239 del 2004, che prevedono il procedimento di rilascio del permesso
di ricerca e della concessione degli idrocarburi, e che ciò avvenga in seguito
a un procedimento unico, nel rispetto dei principî di semplificazione e con le
modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
La ricorrente, pur rilevando che le
disposizioni impugnate non escludono espressamente la necessità dell’intesa
della Regione interessata, tuttavia sostiene che il mancato richiamo
dell’intesa potrebbe essere interpretato come espressione della volontà del
legislatore di disciplinare il settore in modo diverso. In particolare, la
norma non chiarirebbe le modalità con cui dovrebbe essere acquisita l’intesa, e
non chiarirebbe se l’intesa debba essere acquisita in sede di conferenza di
servizi, né quali siano le conseguenze del suo mancato raggiungimento.
L’interpretazione prospettata appare,
ad avviso della Corte, errata, poiché essa condurrebbe anche a negare
irragionevolmente lo stesso potere ministeriale di autorizzazione in questo
specifico settore. D’altra parte, per quanto concerne il rapporto tra intesa e
richiamo delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241
del 1990, ed in particolare alla conferenza di servizi, osserva che lo stesso
art. 1-sexies del decreto legge n. 239 del 2003 stabilisce che
l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte
della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sia rilasciata dal
Ministro delle attività produttive d’intesa con
La ricorrente ritiene che queste
disposizioni inciderebbero, con disposizioni di dettaglio, in materia sia di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», sia di «governo
del territorio», di competenza legislativa concorrente.
Al contrario, la determinazione nella
legge statale delle conseguenze della mancata sottoscrizione degli accordi e,
in particolare, l’esclusione che quest’ultima possa fondare la sospensione dei
lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti o per il rinvio
dell’inizio della coltivazione, restringe impropriamente la discrezionalità
legislativa regionale attraverso la previsione di una normativa che non può in
alcun modo essere qualificata come principio fondamentale.
Il principio di leale cooperazione
connota fortemente il regionalismo italiano: nella disamina relativa al riparto
competenziale se ne sono avute molteplici conferme, segnatamente in riferimento
agli ambiti normativi caratterizzati da una «concorrenza di competenze» e da
quelli «attratti in sussidiarietà» dallo Stato (con riferimento alla
compenetrazione tra contenuti della normazione ed applicazione del principio
cooperativo, può ulteriormente menzionarsi, a titolo esemplificativo, la sentenza
n.
Rinviando a quanto sin qui detto per
l’analisi dell’incidenza del principio sulla ripartizione delle funzioni tra i
livelli territoriali, giova qui soffermarsi su alcune statuizioni che hanno
avuto precipuamente riguardo allo scrutinio inerente ad aspetti procedimentali.
A tal riguardo, di particolare
importanza è la sentenza n. 272, nella quale, ribadendo quanto affermato
nella sentenza n. 196 del 2004,
Sempre per quanto riguarda il
principio di leale cooperazione,
Allo stesso modo si giustifica la
scelta statale, effettuata senza un coinvolgimento delle Regioni, di escludere
dall’assegnazione di quote i produttori che in precedenza hanno venduto, ovvero
affittato, in tutto o in parte, la quota di propria spettanza. Infatti,
sottolinea
Anche per la rideterminazione delle
quote, a seguito della verificata non compatibilità tra la quantità di latte
commercializzato e la consistenza di stalla accertata,
Parimenti,
Non è costituzionalmente necessario
garantire un coinvolgimento delle Regioni neppure in relazione alla possibilità
attribuita all’AIMA di valutare comparativamente i risultati della
compensazione nazionale e per APL. Secondo
L’acquisizione di tale parere in
ordine ai criteri di priorità individuati permette alla Corte di ritenere
esente dai profili di incostituzionalità anche un’altra disposizione censurata,
con la quale il legislatore, «nell’esercizio non irragionevole della sua
discrezionalità modulata in attuazione degli obblighi comunitari, ha esteso la
validità di tali criteri anche al periodo 1999-2000».
Sempre in tema di compensazione,
Problematiche concernenti
l’applicazione del principio di leale cooperazione sono state affrontate anche
in sede di conflitto intersoggettivo, ciò che è testimoniato dalle sentenze nn.
133 e 339.
Nella sentenza n. 133,
Tale normativa, rileva
L’autonomia speciale è infatti
limitata al territorio regionale, e sarebbe contrastante con l’impianto
costituzionale e con i principî ad esso sottesi di parità istituzionale e di
leale collaborazione tra gli enti territoriali l’attribuzione di effetti
extraterritoriali ad una norma di attuazione dello statuto regionale (cfr.
sentenze n. 743 del 1988 e n. 55 del 1997).
È viceversa conforme ai principî
costituzionali ritenere che nei casi di Regioni finitime trovi applicazione il
d.lgs. n. 112 del 1998, che ha conferito alle regioni competenti per territorio
l’intera gestione del demanio idrico, comprensivo di tutte le funzioni
amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, ed ha previsto,
all’art. 89, comma 2, che le concessioni che interessano il territorio di più
regioni sono rilasciate d’intesa tra le regioni coinvolte.
Si tratta di una norma che risponde
ad esigenze unitarie ed al principio di leale collaborazione, e che certamente
è applicabile anche ai rapporti tra Regioni ordinarie e Regioni a statuto
speciale (sentenza n. 353 del 2001).
In relazione alla Provincia di Trento,
occorre inoltre sottolineare che si tratta di funzioni delegate e non di una
competenza statutaria, sicché ancora più agevole diventa l’estensione a detta
Provincia di una norma originariamente prevista per le Regioni a statuto
ordinario.
In conclusione,
Pertanto, non spetta alla Provincia
di Trento, in difetto della necessaria intesa di cui all’art. 89, comma 2, del
d.lgs. n. 112 del 1998, l’esercizio delle funzioni relative alle concessioni di
derivazioni di acqua pubblica che interessino, oltre alla Provincia di Trento,
anche
Con la sentenza n. 339
Motiva, in proposito
L’intesa è, dunque, procedimento
intermedio e strumentale all’adozione dell’atto deliberativo, il quale
rappresenta il frutto di una necessaria compartecipazione fra gli enti od
organi tra i quali l’intesa stessa deve svilupparsi, anche – ove occorra –
attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino
il raggiungimento di un accordo.
Nel caso di specie, «l’illegittimità
della condotta dello Stato non risiede […] nella nomina in sé di un Commissario
straordinario senza la previa intesa con il Presidente della Regione Toscana»,
ma nel mancato concreto sviluppo della procedura della intesa per la nomina del
Presidente dell’Autorità portuale di Livorno: procedura la quale esige «lo
svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del
principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che
ostacolino il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina del
primo» (sentenza n. 27 del 2004).
Come, infatti, evidenzia il ricorso,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 10 marzo 2003,
ricevute le designazioni dei vari enti, richiedeva alla Regione Toscana la
prescritta intesa sul nominativo proposto dalla Camera di Commercio, quale
candidato all’incarico di Presidente della Autorità portuale di Livorno.
Tale richiesta di incontro, peraltro
ignorata, veniva reiterata con successiva nota del Presidente della Regione
Toscana del 7 maggio 2003, ove si rappresentava l’urgenza in vista della
prossima scadenza del mandato del Presidente in carica. Anche tale richiesta
rimaneva, però, priva di effetti.
A questo punto, il Ministro
designava, quale Commissario della Autorità portuale di Livorno, il candidato
sul quale
Da ciò la giusta doglianza relativa
alla sostanziale elusione della procedura della intesa, con il corollario della
illegittimità di una procedura «alternativa» destinata a consentire, nei fatti,
alla amministrazione statale la scelta unilaterale della persona cui affidare
la presidenza della Autorità portuale di Livorno.
5.
Il potere estero delle Regioni
Con riferimento ai limiti entro i
quali le Regioni possono svolgere attività che si proiettino oltre i confini
nazionali, è da sottolineare la sentenza n. 387, nella quale
Nelle decisioni passate in rassegna
relativamente al riparto di competenze legislative sono presenti numerose,
anche significative, affermazioni precipuamente concernenti le funzioni
amministrative (si pensi, ad esempio, alla attrazione in sussidiarietà).
Non mancano, tuttavia, passaggi
argomentativi che possono in questa sede essere analizzati, anche per la loro
«autonomia» rispetto al riparto di competenze normative.
A tal proposito, viene in particolare
rilievo il principio di continuità nell’esercizio delle funzioni
amministrative. Nella sentenza n. 50,
In applicazione dei medesimi
principî, la sentenza n.
Precipuamente riguardanti l’esercizio
di funzioni amministrative sono anche le questioni decise con la sentenza n.
In particolare, il ricorrente censura
anzitutto le disposizioni che disciplinano la formazione e i contenuti del
piano dei tratturi, assumendo che tale normativa «si pone in contrasto con gli
articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto può
determinare una utilizzazione delle aree tratturali in deroga al regime di
tutela loro imposto ed una conseguente successiva alienazione o destinazione ad
altri fini pubblici non precisati», e che «l’esercizio della tutela è
prerogativa dello Stato e può essere oggetto di intesa e coordinamento con le
regioni solo entro i limiti fissati dalla legge statale, che nel caso è stata
violata con l’effetto che la disposizione risulta in contrasto anche con l’art.
118, terzo comma, Cost.».
Le disposizioni regionali vengono,
inoltre, censurate perché consentono la realizzazione di opere in zone di
interesse archeologico e sottoposte a vincolo paesaggistico senza le prescritte
autorizzazioni, mediante il solo parere della Soprintendenza, ed inoltre perché
prevedono la regolarizzazione di opere edilizie abusive, in violazione
dell’art. 117, secondo comma, lettere l) e s), Cost., «potendo la
sanatoria comportare il venir meno delle sanzioni penali collegate all’abuso».
Tutto ciò, secondo il ricorrente, sul
presupposto che la normativa attenga alla tutela dei beni culturali in
questione, ma – sempre ad avviso del ricorrente – se si volesse far riferimento
alla materia di competenza ripartita della valorizzazione dei detti beni, le
disposizioni sarebbero egualmente illegittime perché in contrasto con il
principio fondamentale fissato nell’art. 97 del t.u. n. 490 del 1999, secondo
il quale le norme sulla valorizzazione dei beni culturali devono essere in
armonia con quelle sulla loro tutela.
Se dunque ciò di cui il ricorrente si
duole non è il fatto in sé che
Sulle censure relative al contenuto
specifico delle disposizioni,
Il Piano dei tratturi, nella cui
formazione lo Stato, mediante il giudizio vincolante dei suoi organi a ciò
deputati per la loro competenza, ha una parte decisiva, costituisce la base
dell’ulteriore disciplina dei tratturi, distinti nel modo che si è detto.
La previsione della costruzione di
opere pubbliche e di pubblico interesse da parte di enti pubblici, disciplinata
dall’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 29 del 2003, per quanto riguarda
i tronchi tratturali va messa in relazione con quanto disposto dal comma 1
dello stesso articolo (non impugnato), nella parte in cui attribuisce alla
Regione la valorizzazione dei detti beni anche mediante forme di gestione
indiretta.
Ma ciò che più conta è che la
costruzione delle suindicate opere è subordinata al parere favorevole della
Soprintendenza, alla quale perciò spetta il potere di impedirla qualora ne
possa venir compromessa la consistenza originaria del tratturo.
A conclusioni simili si deve
pervenire riguardo alla regolarizzazione delle opere già esistenti, ma
successive alla imposizione del vincolo.
È vero che in questo caso il parere
della Soprintendenza non è definito «né vincolante né favorevole», ma la
lettura corretta della disposizione nel contesto della complessa normativa in
cui è inserita – e nella quale i pareri finora esaminati sono tutti da
considerare «vincolanti» (il termine «favorevole» assume lo stesso significato)
– comporta che anche per la regolarizzazione delle opere già edificate, come
per quelle da costruire, il parere della Soprintendenza deve ritenersi
vincolante. Sarebbe illogico ritenere che
A quanto detto
Non fondata, infine, è altresì la
censura che si appunta sul comma l, lettera b), dell’art. 4 della stessa
legge regionale, che disciplina l’alienazione all’utilizzatore possessore di
tronchi tratturali inclusi sotto le lettere b) e c) del comma 2
dell’art. 2.
Trattasi, infatti, di tronchi dei quali,
con il parere vincolante delle Soprintendenze, è stata già accertata la perdita
irreversibile della originaria consistenza, cioè della loro caratteristica di
tratturi e, come tale, di beni di interesse archeologico, per i quali
l’alienazione è subordinata alla sdemanializzazione.
In varie occasioni,
Sulla base della giurisprudenza
pregressa,
Ribadisce, infatti,
Anche le norme che fissano l’obbligo
di trasmissione agli organi interni di revisione contabile delle delibere di
acquisto in via autonoma vanno ricondotte agli stessi principî fondamentali di
coordinamento, in ragione del loro «carattere strumentale» rispetto al suddetto
obbligo di adottate i parametri previsti da dette convenzioni.
Non viene, inoltre, ravvisato alcun
contrasto con le norme statutarie che attribuiscono alla ricorrente Regione
Valle d’Aosta la potestà legislativa esclusiva e le correlative funzioni
amministrative nelle materie dell’«ordinamento degli uffici e degli enti
dipendenti dalla regione» e «dell’ordinamento degli enti locali» (articoli 2,
primo comma, lettere a e b, e 4 dello statuto speciale), poiché
le attività dirette all’acquisto di beni o servizi da parte delle
amministrazioni non sono riconducibili a tali materie, dovendo esse
considerarsi, al più, strumentali al funzionamento di detti uffici ed enti.
La disposizione secondo la quale,
nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione sugli enti locali, la
struttura operativa cui è assegnata la funzione del controllo di gestione
fornisce la conclusione del controllo stesso, oltre che agli amministratori e
ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei conti, non crea,
contrariamente a quanto sostiene
A tale finalità dell’azione di
coordinamento finanziario consegue che «a livello centrale si possono collocare
non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia», ma
altresì la determinazione di norme e puntuali, quali quelle relative alla
disciplina degli obblighi di invio di informazioni sulla situazione finanziaria
dalle regioni e dagli enti locali alla Corte dei conti. La fissazione di dette
norme da parte del legislatore statale è diretta, infatti, a realizzare in
concreto la finalità del coordinamento finanziario – che per sua natura eccede
le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali – e, proprio
perché viene «incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di
rispetto del patto di stabilità interno», è idonea a realizzare l’ulteriore
finalità del buon andamento delle pubbliche amministrazioni (sentenza n. 64 del
2005).
Pertanto, va escluso che la norma
impugnata, determinando un puntuale obbligo di comunicazione di dati a carico
degli enti locali, si ponga in contrasto con gli evocati parametri
costituzionali.
Ne discende che non sussiste alcuna
irragionevole interferenza tra controllo interno di gestione e accertamenti
della Corte dei conti, perché proprio la finalità del coordinamento finanziario
giustifica il raccordo tra i due tipi di controllo, operato dalla norma
censurata attraverso la fissazione dell’obbligo di comunicazione alla Corte dei
conti dell’esito del controllo interno, realizzando così quella finalità
collaborativa cui fa espresso riferimento l’art. 7, comma 7, della legge n. 131
del 2003.
Sempre nella sentenza n. 417,
In particolare, il comma 9 limita,
per l’anno 2004, la spesa di Regioni ed enti locali, relativa a «studi ed
incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione»;
prevede che «l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di
consulenze a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti
rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, deve essere
adeguatamente motivato» e limitato ai soli casi previsti dalla legge o
all’ipotesi di eventi straordinari, previa comunicazione – a pena di illecito
disciplinare e conseguente responsabilità erariale – agli organi di controllo
ed agli organi di revisione di ciascun ente; stabilisce che le pubbliche
amministrazioni adottano le direttive – comunicate in via preventiva alla Corte
dei conti – conseguenti all’applicazione dei suddetti vincoli di spesa,
«nell’esercizio dei diritti dell’azionista nei confronti delle società di capitali
a totale partecipazione pubblica».
Ad avviso delle ricorrenti, che le
norme in questione non si limiterebbero a fissare l’entità massima del
disavanzo o del complesso della spesa corrente di Regioni ed enti locali, ma
specificando ed elencando le singole tipologie delle spese che gli enti
territoriali devono contenere nell’ambito delle percentuali previste dalle
stesse norme, porrebbero vincoli non riconducibili a principî fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica.
Nel dichiarare le questioni fondate,
Secondo tale giurisprudenza, il
legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle
politiche di bilancio (ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni
indirette all’autonomia di spesa degli enti), ma solo, con «disciplina di
principio», «per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi
nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari». Perchè detti vincoli
possano considerarsi rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli enti
locali debbono avere ad oggetto o l’entità del disavanzo di parte corrente
oppure – ma solo «in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di
riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale» – la
crescita della spesa corrente degli enti autonomi; in altri termini, la legge
statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi
ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di
spesa» (sentenza n. 36 del 2004).
Nella specie,
Infine, sulla base di principî
giurisprudenziali ormai consolidati,
La distinzione tra «principî
fondamentali» e «norme di dettaglio», che disegna il riparto di competenze
nelle materie di legislazione concorrente, peraltro, non sempre è agevolmente
percepibile. In tal senso, giova dar conto dell’iter argomentativo
seguito dalla Corte nella sentenza n. 30,
là dove sono state rintracciate entrambe le due categorie di norme. L’art. 25
della legge 23 dicembre 2002, n. 289, oggetto del giudizio, che disciplina il
pagamento e la riscossione delle somme di modesto ammontare, operando anche un
rinvio a regolamenti ministeriali, di cui fissa il contenuto «in modo specifico
e preciso», viene ricondotto pianamente all’ambito competenziale del
«coordinamento della finanza pubblica».
Atteso che, con riferimento ai
destinatari, la disciplina dettata dalla norma è applicabile a tutte le
amministrazioni pubbliche,
A diverse conclusioni si perviene per
la parte in cui la norma si indirizza anche ad enti non statali (Regioni,
Province, Comuni, Comunità montane). A tal proposito, si è opera una
distinzione tra la disciplina rimessa ai regolamenti e la disciplina positiva
direttamente dettata.
La disposizione legislativa rinvia
alla normazione secondaria, della quale al primo comma si indica l’oggetto, che
è appunto quello della «disciplina del pagamento e della riscossione di crediti
di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria», e al secondo
comma se ne fissa il contenuto imprescindibile, costituito da: a) gli
importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare; b)
le modalità di considerazione di detti importi (nel senso che occorrerà
stabilire quali somme dovranno considerarsi onnicomprensive di interessi o
sanzioni comunque denominate); c) le norme riguardanti l’esclusione di
qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Per quanto riguarda
questa disciplina, rimessa a regolamenti di delegificazione, si sottolinea che
la legge «non può spogliarsi della funzione regolativa affidandola a fonti
subordinate, neppure predeterminandone i principî che orientino l’esercizio
della potestà regolamentare per circoscriverne la discrezionalità […], con la
conseguente illegittimità costituzionale della norma che prevede
l’applicabilità degli emanandi regolamenti anche alle Regioni».
Per altro verso, la norma reca
disposizioni direttive per le emanande norme secondarie, stabilendo che: a)
esse possono riguardare anche periodi d’imposta precedenti; b) non
devono in ogni caso intendersi come franchigia, nel senso che, per debiti di
maggior ammontare rispetto agli importi fissati come modesti, l’importo modesto
non può essere previsto come riduzione del debito o del credito (ultima parte
del secondo comma); c) gli importi vanno arrotondati all’unità euro
(quarto comma, prima parte); d) in sede di prima applicazione dei
decreti, l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro; e) non
possono ricomprendersi tra le somme considerate di modesto ammontare i
corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento
(terzo comma). Ad avviso della Corte, «la disciplina positiva introdotta deve essere
intesa non soltanto come complesso di direttive per la redazione della
normativa secondaria, che riguarderà la sola organizzazione statale, ma anche
come nucleo di principî fondamentali cui deve ispirarsi l’esercizio della
legislazione concorrente delle Regioni». Per quanto il carattere della
«modestia» del credito debba essere stabilito caso per caso – e questo può
essere oggetto d’intervento regolamentare per lo Stato e di legislazione
concorrente per le Regioni – la seconda parte dell’art. 25 pone regole di cui,
pur nell’applicabilità a quanto sarà via via considerato «somma di modesto
ammontare», non si può non riconoscere il carattere di legislazione di
principio.
Dalla così ricostruita
compenetrazione di principî e norme di dettaglio,
Dalla giurisprudenza costituzionale,
emerge una frequente compenetrazione del titolo competenziale inerente al
coordinamento della finanza pubblica con altri. In particolare, nella sentenza
n. 35 viene in rilievo il
collegamento con la competenza relativa al «coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e
locale» (art. 117, secondo comma, lettera r).
Oggetto del giudizio della Corte è l’art. 28 della legge 27 novembre 2002, n.
289, che disciplina l’attività di acquisizione, da parte del Ministero
dell’economia, delle informazioni concernenti la gestione finanziaria delle
amministrazioni pubbliche, mirando in tal modo ad assicurare al Ministero gli
strumenti conoscitivi necessari per seguire le complessive dinamiche della
finanza pubblica, così da facilitare la verifica del rispetto degli obblighi
derivanti, in via diretta (art. 104 TCE) o mediata (alla stregua del cosiddetto
«Patto di stabilità interno»), dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea
(commi 1-4). Il medesimo articolo, ai commi 5 e 6, abilita lo Stato, con
decreti ministeriali, a determinare le caratteristiche uniformi nella
rappresentazione dei dati contabili delle amministrazioni pubbliche, nonché le
modalità di invio dei bilanci da parte degli enti locali alla competente
sezione di controllo della Corte dei conti.
I primi quattro commi dell’articolo
impugnato sono ritenuti espressione della competenza legislativa concorrente in
tema di «coordinamento della finanza pubblica»; materia che, «come [la] Corte
ha avuto modo di chiarire (sentenza n. 36 del 2004), legittima l’imposizione di
vincoli agli enti locali quando lo rendano necessario ragioni di coordinamento
finanziario connesse ad obiettivi nazionali (comprensivi, dunque, della
cosiddetta “finanza pubblica allargata”), a loro volta condizionati dagli
obblighi comunitari». I poteri di determinazione, rispettivamente, della
cosiddetta «codificazione» dei dati contabili e delle modalità di invio da
parte degli enti locali dei propri bilanci alla Corte dei conti sono, in tal
senso, pienamente partecipi della finalità di coordinamento e insieme di
regolazione tecnica, rilevazione dati e controllo, che connotano la
legislazione in tema di coordinamento della finanza pubblica.
In ordine al denunciato carattere
puntuale della disciplina statale,
Con specifico riguardo ai commi 5 e 6
(relativi, rispettivamente, alla predisposizione di modalità uniformi di
codificazione di dati di rilievo contabile e di trasmissione dei bilanci degli
enti locali alla competente sezione della Corte dei conti), viene individuato
un puntuale titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato nel
coordinamento statistico ed informatico dei dati dell’amministrazione statale,
regionale e locale: la predisposizione di modalità uniformi di rappresentazione
(comma 5) e di trasmissione (comma 6) di dati contabili (incassi e pagamenti)
ha la funzione di rendere omogenei e, quindi, di aggregare questi dati, «per
poter così predisporre la base informativa necessaria al controllo delle
dinamiche reali della finanza pubblica».
Ora, versandosi in un ambito
riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, deve dichiararsi
non fondata la denunciata violazione del riparto costituzionale della potestà
regolamentare, per avere le disposizioni impugnate affidato a decreti
ministeriali la concreta predisposizione delle modalità di «codificazione»: «in
una materia rimessa alla propria competenza legislativa esclusiva, lo Stato ben
può, infatti, esercitare, nelle forme che ritenga più opportune, la potestà
regolamentare».
«Neppure – prosegue la sentenza – si
può sostenere che, pur in una materia ascritta alla competenza legislativa
esclusiva, il rispetto del principio di leale collaborazione imporrebbe allo
Stato di garantire alle Regioni, quando esso regoli attività di queste ultime,
una forma di codeterminazione paritaria del contenuto dell’atto». Peraltro, la
previsione, nel comma 5, di un parere della Conferenza unificata «appare del
tutto idonea ad assicurare il necessario coinvolgimento delle Regioni e degli
enti locali, tanto più in considerazione della natura eminentemente tecnica
della disciplina di coordinamento statale».
L’autonomia finanziaria degli enti
infrastatuali conosce limitazioni in relazione agli interessi che sono in gioco
in determinate discipline. Ciò è particolarmente evidente nella sentenza n. 36, concernente alcune disposizioni in
materia di sanità pubblica.
Il comma 4 dell’art. 52 della legge
n. 289 del 2002, il quale prevede un adeguamento del finanziamento del servizio
sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004, 2005, cui le Regioni possono
accedere subordinatamente a specifici adempimenti e condizioni, non risulta –
ad avviso della Corte –lesivo dell’autonomia regionale, né determina, in
violazione dell’art. 119, comma quarto, della Costituzione, uno «squilibrio
strutturale» tra risorse finanziarie ed obbligazioni di spesa delle Regioni,
incompatibile con il principio dell’integrale finanziamento delle funzioni
pubbliche attribuite alle Regioni.
Al riguardo,
La disposizione in esame va dunque
inserita in questo articolato quadro normativo, dal quale emerge costante il
carattere «incentivante» del finanziamento statale ai fini del conseguimento
degli obiettivi di programmazione sanitaria e del connesso miglioramento del
livello di assistenza. Pertanto, gli ulteriori adempimenti richiesti alle
Regioni costituiscono condizione necessaria per «l’accesso all’adeguamento del
finanziamento del S.s.n.», in conformità al consolidato schema – perdurando l’attuale regime
transitorio di applicazione dell’art. 119 della Costituzione (cfr. sentenza n.
36 del 2004) – di regolazione
finanziaria tra Stato e Regioni nel settore sanitario.
Altresì non fondata risulta la
censura concerne concernente l’art. 52, comma 4, lettera c), della legge
n. 289 del 2002, nella parte in cui subordina l’accesso delle Regioni al
finanziamento integrativo alla condizione che siano eliminate o
significativamente contenute le liste di attesa, mediante lo svolgimento,
presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera
continuativa, fino alla copertura del servizio per i sette giorni della
settimana.
Rileva
Né la norma impugnata vincola
l’autonomia regionale nel settore dell’organizzazione sanitaria, tenendo, a
tale scopo, presenti (cfr. sentenza n. 88 del 2003) gli accordi in materia,
sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e indirizzi applicativi
sulle liste di attesa, iniziative dirette al conseguimento di obiettivi, senza
maggiori oneri per lo Stato e neppure per le Regioni, dovendosi fare fronte a
tali spese con il recupero di risorse inutilizzate e conseguenti forme di
risparmio.
Rileva, in proposito,
Non fondata risulta pure la censura
avente ad oggetto il medesimo art. 52, comma 19, della legge n. 289 del 2002,
nella parte in cui limita la possibilità per le imprese farmaceutiche di
contribuire ad organizzare, mediante finanziamenti anche indiretti, convegni,
congressi o riunioni, nella misura massima del 50% di quelli notificati al
Ministro della salute, esonerando da tale limitazione solo gli eventi
espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione
continua.
La norma in esame, sottolinea
7.2.
La disciplina dei tributi
In ordine alla disciplina dei
tributi, si segnalano due decisioni, entrambe relative a disposizioni
legislative regionali o provinciali.
La sentenza n. 431, nell’ambito del giudizio sulla legge della Provincia autonoma
di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, recante disposizioni per la valorizzazione
nella Provincia del servizio civile,
Nella sentenza n. 455,
Al riguardo,
Sulla base di tale principio,
conclude
7.3.
Gli interventi finanziari diretti dello Stato
Uno dei temi sui quali
In due occasioni, peraltro, più che sulla
precisa individuazione della competenza materiale,
Con la sentenza n. 77, si accolgono le doglianze della
regione ricorrente avverso l’art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, che reca incentivi agli investimenti delle imprese
marittime per il rinnovo e l’ammodernamento della flotta nonché per la
costruzione e trasformazione di unità navali.
Motiva
In primo luogo, la legge statale non
può – in tali materie – prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata,
che possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello
Stato nell’esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché
di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli
legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria
competenza.
In secondo luogo – poiché le funzioni
attribuite alle Regioni comprendono la possibilità di erogazione di contributi
finanziari a soggetti privati, dal momento che in numerose materie di
competenza regionale le politiche pubbliche consistono appunto nella
determinazione di incentivi economici ai soggetti in esse operanti e nella
disciplina delle modalità per loro erogazione – il tipo di ripartizione delle
materie fra Stato e Regioni di cui all’art. 117 Cost. vieta comunque che in una
materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano
interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò
equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative
sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze.
I finanziamenti in esame non
concernono materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato.
Non si può invocare, al riguardo, la
giurisprudenza di questa Corte sulla portata della «tutela della concorrenza»,
attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione (sentenze nn. 14 e 272 del 2004).
Questa norma, infatti, «evidenzia
l’intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo
allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo
dell’intero Paese; strumenti tutti finalizzati ad equilibrare il volume di
risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L’intervento statale si
giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica: solo in tale quadro è
mantenuta allo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante
entità, sia regimi di aiuto ammessi dall’ordinamento comunitario (fra i quali
gli aiuti de minimis), purché siano in ogni caso idonei ad incidere
sull’equilibrio economico generale» (sentenza n. 14 del 2004).
L’esame delle norme impugnate
dimostra invece che i finanziamenti in questione sono inidonei «ad incidere
sull’equilibrio economico generale», essendo privi tanto del requisito
soggettivo dell’«accessibilità a tutti gli operatori», quanto di quello
oggettivo dell’«impatto complessivo».
Il primo requisito manca per la
limitatezza dell’ambito dei soggetti beneficiari, circoscritto alle sole
imprese che abbiano effettuato investimenti di un certo tipo nell’anno 2003; il
secondo per l’esiguità dei mezzi economici impegnati nel quadro della
complessiva manovra disposta con la legge finanziaria del 2004.
La manovra mira piuttosto ad
incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, non tutto il
sistema armatoriale ma taluni investimenti effettuati dalle imprese marittime,
per il rinnovo e l’ammodernamento della flotta, nonché per la costruzione e la
trasformazione delle unità navali.
Le norme in esame non possono neppure
essere ricondotte alla materia della «tutela dell’ambiente», evocata
dall’Avvocatura nel senso che gli interventi in esame sarebbero giustificati
(anche) dalla finalità di promuovere la costruzione di navi cisterna a basso
impatto ambientale.
Infatti la «tutela dell’ambiente» è
estranea (o, comunque, assolutamente marginale) rispetto alle specifiche
finalità dei finanziamenti in esame, che quindi non possono, sotto tale
profilo, essere ricondotti ad una materia di competenza statale.
Pertanto le norme impugnate – non
essendo riconducibili alle materie attribuite dall’art. 117, secondo comma,
della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed
essendo come tali lesive della sfera di competenza costituzionalmente garantita
alle Regioni – devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime.
Nella sentenza n. 107, si dichiara l’illegittimità
costituzionale, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dell’art. 4,
commi 215, 216 e 217, della legge 24 dicembre 2003, n.
In definitiva, la peculiarità dei
requisiti e l’esiguità delle somme globalmente stanziate escludono in radice la
possibilità di qualificare le disposizioni impugnate come volte a favorire la
concorrenza ovvero anche di ricondurle alla facoltà, riconosciuta allo Stato
dall’art. 119, comma quinto, Cost., di destinare risorse al fine di promuovere
lo sviluppo economico; tanto meno è possibile sostenere che il finanziamento di
«imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto,
che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno
cinquecento posti barca» rientri in taluna delle materie di cui all’art. 117,
comma secondo, della Costituzione.
Consegue da ciò che va dichiarata
l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.
Nella sentenza n. 302,
In quest’ambito, infatti, lungi dal
configurare competenze accessorie o ulteriori della ricorrente, come dalla
ricorrente dedotto sulla base di una errata interpretazione dell’art. 3, comma
1, del decreto legislativo n. 265 del 2001, viene, dalla medesima norma, specificato
il contenuto delle funzioni trasferite alla Regione speciale ai sensi del
precedente art. 2, salvaguardando, non diversamente da quanto è avvenuto in
relazione alle Regioni a statuto ordinario, l’esercizio unitario dei compiti di
indirizzo e di programmazione.
L’esercizio di poteri sostitutivi nei
confronti degli enti territoriali minori è stato oggetto di due importanti
statuizioni, l’una relativa al potere disciplinato all’art. 120, secondo comma,
della Costituzione, l’altra ad una fattispecie in esso non contemplata.
Con la sentenza n. 383,
Contrariamente all’assunto della
ricorrente, secondo cui si estenderebbe il potere sostitutivo statale al di là
delle ipotesi previste dalla norma costituzionale,
Nella sentenza n. 167, invece,
Al contrario,
9.
I ricorsi decisi sulla base del Titolo V nel testo anteriore alla riforma del 2001
Nel corso del 2005 si è esaurito il
contenzioso tra Stato e Regioni radicatosi anteriormente alla riforma del
Titolo V della Parte seconda della Costituzione, contenzioso che ha visto
l’applicazione – per le ultime volte – dei parametri costituzionali nella
formulazione oggi non più vigenti.
Vengono in rilievo, in questa sede,
tre decisioni, di cui due rese in giudizi di legittimità costituzionale in via
principale ed una in sede di conflitto intersoggettivo.
Con
la sentenza n. 33,
In
particolare, viene ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, censurato in quanto
detterebbe criteri irragionevolmente ristretti e incongruamente vincolanti per
il riconoscimento della parità scolastica, impingendo sulla capacità di
programmazione della rete scolastica delle Regioni, e non coinvolgerebbe
Non
fondata risulta anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1,
commi 9 e 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62, censurato nella parte in cui
(comma 9) prevede un piano straordinario di finanziamento delle Regioni e delle
Province autonome a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie
per l’istruzione mediante l’assegnazione di borse di studio, affidando al
Presidente del Consiglio dei ministri il potere di stabilire con decreto i
criteri per la ripartizione di tali somme tra le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, i criteri per l’individuazione dei beneficiari e le
modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo,
e nella parte in cui (comma 10) stabilisce direttamente una delle modalità di
fruizione dei benefici, disponendo che i soggetti aventi i requisiti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di cui al comma 9,
possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma
equivalente dall’imposta lorda riferita all’anno in cui la spesa è stata
sostenuta, ed attribuendo alle Regioni e alle Province autonome il compito di
disciplinare le modalità con cui sono annualmente comunicati al Ministero delle
finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione
fiscale. Dalla mancata previsione di una consultazione in sede di adozione del
decreto previsto dall’art. 1, comma 9, non può farsi discendere automaticamente
la illegittimità della disposizione censurata, trovando comunque applicazione
le disposizioni generali che quella consultazione impongono prima
dell’esercizio delle funzioni di competenza dello Stato in materie di
concorrente interesse delle Regioni e delle autonomie locali; né la ricorrente
ha dedotto la lesione delle proprie competenze a causa della intervenuta
consultazione della Conferenza unificata in luogo della Conferenza permanente,
essendosi limitata ad osservare in proposito che il Governo ha ritenuto
sussistente in materia anche un concorrente interesse delle autonomie locali.
La disposizione censurata, inoltre, non contiene norme di dettaglio invasive
delle competenze regionali, poiché, al contrario, stabilisce un principio
fondamentale della materia, valido per tutte le scuole inserite nel sistema
nazionale di istruzione, volto a rendere effettivo il diritto allo studio anche
per gli alunni iscritti alle scuole paritarie, da essa legge disciplinate.
Nella sentenza n. 272
Nella sentenza si affrontano
molteplici aspetti della disciplina.
In questa materia, nel vigore del
vecchio Titolo V, pur sussistendo una competenza legislativa concorrente delle
Regioni, nondimeno era configurabile un titolo di legittimazione dello Stato ad
intervenire. In particolare, «l’intervento del legislatore statale rinveniva la
propria legittimazione a livello costituzionale, nella necessità di adottare
una normativa di carattere uniforme sull’intero territorio nazionale, e ciò
soprattutto in vista della conformazione delle regole dell’ordinamento, nella
materia oggetto dell’intervento, alla normativa comunitaria. In altri termini,
la sussistenza di un interesse nazionale (categoria all’epoca, certamente rilevante
agli effetti del riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni) rendeva
costituzionalmente legittimo l’intervento della legge statale, pur nel rispetto
dell’esigenza di assicurare, nelle forme e nei modi necessari o opportuni, il
coinvolgimento delle singole Regioni e delle Province autonome, e giustificava
nella materia in questione anche la competenza amministrativa dello Stato».
Il fine di garantire l’interesse
unitario all’accertamento tempestivo sull’intero territorio nazionale della
effettiva quantità di latte prodotta e commercializzata, per assicurare la
corretta esecuzione del regime comunitario delle quote latte, ha giustificato –
ad avviso della Corte – l’istituzione da parte dello Stato di una Commissione
di garanzia con il compito di verificare la conformità alla vigente
legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la
determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi
1995-1996 e 1996-1997.
Sempre in considerazione della
presenza di un interesse nazionale sotteso a verifiche necessariamente
unitarie,
La medesima ratio giustifica
sia la determinazione statale di alcuni «criteri obiettivi» per la
riassegnazione ai produttori delle quote resesi disponibili, sia la scelta di
escludere dall’assegnazione di quote i produttori che in precedenza hanno
venduto, ovvero affittato, in tutto o in parte, la quota di propria spettanza.
Così, in attesa della riforma
organica del settore, non è irragionevole ed è strettamente proporzionata allo
scopo di garantire il corretto funzionamento del complessivo regime delle quote
latte l’assegnazione all’AIMA di funzioni amministrative in materia di aggiornamento
del bollettino 1997-1998, di riserva nazionale e di programmi volontari di
abbandono. Ciò anche in considerazione della natura dichiaratamente provvisoria
di tale assegnazione.
Esigenze di celere attuazione degli obblighi
comunitari e la necessità di determinare l’effettivo quantitativo di produzione
lattiera sono alla base anche dell’attribuzione all’AIMA del potere di
rideterminare le quote a seguito della verificata non compatibilità tra la
quantità di latte commercializzato e la consistenza di stalla accertata.
Allo stesso modo, non è lesiva delle
attribuzioni regionali la competenza della Commissione governativa di indagine
in ordine alla individuazione delle tipologie contrattuali di circolazione
delle quote latte da considerarsi anomale ai fini della determinazione degli
effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato. Come sottolinea
Funzionale ad una efficace
operatività del prelievo supplementare sul latte, nonché in generale ad una
applicazione corretta della normativa comunitaria sull’intero territorio
nazionale, è poi l’attribuzione all’AIMA delle funzioni di accertamento ed
aggiornamento dei dati anche in relazione a campagne lattiere già concluse.
In relazione, poi, alla
compensazione, vale a dire alla possibilità, consentita a ciascuno Stato membro
dalla normativa comunitaria, di compensare i quantitativi di latte assegnati e
non utilizzati da taluni produttori per ridurre o eliminare le sanzioni a
carico di produttori che, al contrario, hanno prodotto latte in misura
eccedente la quota agli stessi concessa,
Per quanto attiene, invece, alla
retroattività delle rettifiche della compensazione nazionale per il periodo
1995-1996, ci si rifà all’interpretazione seguita dalla Corte di giustizia
europea, secondo la quale i regolamenti n. 3950/92 e n. 536/93 consentono alle
autorità nazionali, successivamente alla campagna lattiera interessata, di
effettuare le rettifiche necessarie a far sì «che la produzione esonerata da
prelievo supplementare di uno Stato membro non superi il quantitativo globale
garantito assegnato a tale Stato».
Da questa interpretazione della
normativa statale censurata dalle Regioni discende anche la non fondatezza
della questione sollevata in relazione all’attribuzione al Governo del potere
di comunicare all’Unione europea l’esatta produzione delle annate 1995-1996 e
1996-1997 per la rettifica dei prelievi dovuti. Secondo
In questo quadro, il potere di
aggiornamento dei quantitativi individuali – attribuito in via transitoria
all’AIMA – ai fini dell’esecuzione della compensazione nazionale, si
giustifica, sul piano costituzionale, per l’esigenza di perseguire interessi
territorialmente infrazionabili. Allo stesso modo, «rientra nella
discrezionalità del legislatore nazionale determinare le concrete modalità di
gestione delle funzioni assegnate all’AIMA nei limiti in cui le stesse siano
strettamente funzionali al raggiungimento delle suddette finalità. Né assume
rilevanza la natura retroattiva di talune previsioni, in quanto le stesse si
giustificano, in ossequio alle prescrizioni comunitarie e di quanto già
riconosciuto dalla Corte di giustizia, alla luce della necessità di adeguare i
quantitativi individuali e il sistema di compensazione alle risultanze delle
verifiche svolte dagli organi a ciò preposti».
Ancora, secondo
Analogamente non irragionevole
risulta la previsione di un potere sostitutivo conferito al Presidente del
Consiglio dei ministri, che agisce su proposta del Ministro per le politiche
agricole e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di
inadempienza nel rispetto dei termini relativi alla decisione dei ricorsi.
Infatti, tale potere si fonda sull’esigenza di assicurare il rispetto di un
termine da considerare congruo, nonché strettamente necessario a garantire
l’interesse nazionale ad una celere definizione dei procedimenti in esame.
Sempre per quanto riguarda le
operazioni di riesame,
Ad altro proposito,
Relativamente al c.d. ripristino di
liquidità,
Parimenti, secondo
Secondo
Per quanto attiene al regime delle
quote latte,
Peraltro, osserva ancora
Finalmente, si dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 01, comma 2, del decreto legge n.
11 del 1997, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 81 del 1997, il
quale prevede che al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
rimangono assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché le azioni
sostitutive nel caso di eventuale inadempienza delle Regioni e delle Province
autonome. Secondo
Anche per quanto riguarda il potere
sostitutivo,
Strettamente connesso alla sentenza
n. 272 è il rigetto – con la sentenza n. 324 – del ricorso per
conflitto proposto dalla Regione Lombardia avverso il regolamento del Ministro
delle politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, concernente le competenze
dell’AIMA in ordine alla determinazione dei quantitativi individuali e delle
produzioni commercializzate, in riferimento a campagne lattiere già concluse o
in via di esaurimento, con l’assegnazione in via retroattiva di quantitativi,
destinata a costituire l’unico presupposto per l’effettuazione delle operazioni
di compensazione e di determinazione del prelievo supplementare. Tale
disposizione viene impugnata perché non sarebbe stato preceduta da una valida
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e sarebbe inoltre lesiva delle
competenze regionali in materia di agricoltura. Al riguardo,
Anche l’ulteriore censura concernente
la funzione ministeriale di coordinamento, al fine di garantire l’uniforme
applicazione del regolamento su tutto il territorio nazionale (art. 5, commi 2
e 3 del regolamento), viene respinta: il potere di cui si discute non va,
infatti, confuso con il tradizionale potere di indirizzo e coordinamento
all’epoca vigente, ma attiene al più limitato potere di assicurare la uniforme
applicazione delle norme in questione, riconosciuto al Ministero d’intesa con
10.
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome
Sono state molte le decisioni che,
nel 2005, hanno avuto riguardo alle Regioni a statuto speciale ed alle Province
autonome di Trento e di Bolzano. In buona parte dei casi, le problematiche
affrontate hanno riguardato l’applicazione del Titolo V della Parte seconda
della Costituzione, in ragione della disposizione di cui all’art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001, ai termini del quale «sino all’adeguamento
dei rispettivi statuti, le disposizioni della […] legge costituzionale si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province di Trento e di
Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomie più ampie rispetto a
quelle già attribuite».
Siffatta disposizione ha veicolato,
in effetti, l’applicazione alle autonomie differenziate di molti parametri
costituzionali dettati con precipuo riferimento alle Regioni ordinarie (tra i
vari esempi, può citarsi la sentenza n.
a) L’ambito
numericamente più cospicuo di decisioni è quello riconducibile all’esercizio,
da parte delle Province autonome, della competenza statutaria in materia di
assistenza pubblica.
Nella sentenza n. 106,
Tale intervento, continua
La circostanza che la legge non preveda
automaticamente la sostituzione della Provincia a colui che è obbligato al
mantenimento del minore, ed anzi la considerazione che essa disciplina le
condizioni particolari per beneficiare dell’anticipazione dell’assegno di
mantenimento non crea alcun automatismo, ma concorre a definire un’area di
intervento della «assistenza pubblica» che appare legittima alla luce della
competenza legislativa esclusiva spettante alla Provincia di Bolzano in
materia.
Inoltre, una volta ritenuta priva di
fondamento la tesi del Governo, secondo la quale la diretta applicabilità della
legge alla Provincia deriverebbe dalla competenza esclusiva dello Stato in
materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali»,
Pertanto, l’art. 7, comma 2, della
legge n. 4 del 2004, comportando la diretta applicabilità alla Provincia delle
disposizioni di tale legge, è dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Considerazioni analoghe valgono per l’art.
10 della legge, in quanto la potestà regolamentare dello Stato non può essere
esercitata riguardo a materie che appartengono alla competenza legislativa
della Provincia autonoma di Trento.
Né può in contrario assumere
rilevanza alcuna la previsione dell’intesa con
Con la sentenza n. 263,
Rileva
L’art. 5, comma 2, della legge 386
del 1989 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto
Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma
tributaria) stabilisce che, in materie provinciali, lo Stato con legge può
istituire fondi per scopi determinati, i quali devono essere utilizzati,
nell’ambito del settore definito dalla legge statale stessa, secondo normative
provinciali, e quindi esclude che condizioni e modalità per l’utilizzo di detti
fondi possano essere stabiliti con regolamento statale.
Appare evidente, pertanto,
l’illegittimità del regolamento statale, nella parte in cui si applica alla
Provincia autonoma di Trento.
Motivazioni sostanzialmente analoghe
a quelle della sentenza n. 263 sono
alla base dell’accoglimento, con la sentenza n. 287, del ricorso per conflitto di attribuzione proposto sempre
dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione al
regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
13 dicembre 2001, n. 470, concernente criteri e modalità per la concessione e
l’erogazione dei finanziamenti di cui all’art. 81 della legge 23 dicembre 2000,
n.
Sottolinea
La riconduzione della disciplina in
questione alla materia dell’assistenza e beneficenza pubblica implica, quindi,
una diretta interferenza, da parte del regolamento impugnato, nella competenza
legislativa esclusiva della Provincia autonoma in tale materia, in palese
violazione del principio per cui un decreto ministeriale non può comunque
disciplinare materie di competenza legislativa delle Province autonome (si
vedano, fra le altre, le sentenze nn. 267 del 2003 e 371 del 2001).
In conseguenza delle esposte
considerazioni,
b) La sentenza
n. 407 accoglie il ricorso del
Governo avverso l’art. 4, comma 1 della legge della Provincia di Trento 17
giugno 2004, n. 6, che prevede che il personale insegnante temporaneo ed il
restante personale con contratto a termine di durata non superiore ad un anno o
con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo
pieno, possa, previa autorizzazione della competente struttura, svolgere «altra
attività» a condizione che ciò non determini conflitto di interessi con
l’amministrazione di appartenenza o sia incompatibile con il rispetto degli
obblighi di lavoro. Al riguardo,
c) Con una
interpretazione adeguatrice della norma impugnata,
Lamentava la ricorrente la
limitazione alle sole popolazioni di lingua ladina a fronte del più ampio
obbligo a carico del gestore del servizio pubblico radiotelevisivo stabilito
dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di
tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di
Trento), secondo cui (art. 3-quater,
comma 1) «la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
anche mediante apposite assicura tutte le necessarie misure e condizioni per la
tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento».
Nella specie, la norma statale
impugnata non presenta alcun indice testuale o sistematico che si opponga ad
una lettura in linea con la garanzia della sfera di attribuzioni propria della
provincia autonoma ricorrente, fondata sulle evocate disposizioni dello statuto
speciale di autonomia ed in particolare sulle relative norme di attuazione in
materia di doverosa tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e
cimbra, anche a mezzo di trasmissioni radiotelevisive (art. 3-quater, comma 1, del d. lgs. n. 592 del
1993).
Tale conclusione si giustifica in
ragione, non tanto della salvezza delle competenze provinciali, espressa
dall’art. 26 della stessa legge n. 112 del 2004, quanto piuttosto della
naturale cedevolezza (anche nel momento interpretativo) della legge ordinaria
statale rispetto sia alle disposizioni dello statuto speciale che alle relative
norme di attuazione. Queste ultime infatti – essendo emanate con l’osservanza
di speciali procedure – sono dotate di forza prevalente, anche per la loro
valenza integrativa del precetto statutario (sentenze n. 406 e n. 341 del 2001;
n. 520 del 2000; n. 213 e n. 137 del 1998).
La conseguente inidoneità
dell’impugnato precetto normativo statale a menomare le specifiche garanzie
delle minoranze linguistico-culturali insediate nel territorio provinciale,
predisposte dalle evocate disposizioni dello statuto di autonomia e dalle
relative norme di attuazione, conduce pertanto alla declaratoria di non
fondatezza della questione.
d) Con
riferimento alle tematiche ambientali, è da segnalare la sentenza n. 214, che dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 77, comma 4 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento, in
riferimento allo Statuto speciale di autonomia nonché alle «relative norme di
attuazione». La disposizione censurata prevede che l’autorizzazione integrata
ambientale sia rilasciata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, «sentite le regioni interessate», senza alcun richiamo alle
Province autonome. Peraltro, come rilevato dalla ricorrente, la legge n. 289
del 2002 contiene, all’art. 95, comma 2, una clausola di salvaguardia per le
attribuzioni delle autonomie speciali, essendo espressamente sancito che «le
disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti».
La ricorrente, pur dichiarando di
privilegiare una diversa soluzione ermeneutica, solleva la questione di
legittimità costituzionale per la denegata ipotesi che la disciplina contenuta
nel summenzionato art. 77, comma 4, debba intendersi nel senso di portare alla
competenza statale autorizzazioni in materia ambientale che già appartengano
alla competenza provinciale o di ridurre il ruolo delle determinazioni
provinciali nell’ambito delle procedure di competenza statale.
Al riguardo,
Nella specie, appare agevole ricavare
una interpretazione rispettosa della posizione costituzionalmente garantita
alla ricorrente, in assenza di un espresso riferimento nella norma censurata
alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome e in presenza della
richiamata clausola di salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali
contenuta nell’art. 95, comma 2. La disposizione impugnata non può pertanto intendersi
nel senso di trasferire alla competenza statale autorizzazioni in materia
ambientale che già appartengano alla competenza provinciale o di ridurre il
ruolo delle determinazioni provinciali nell’ambito delle procedure di
competenza statale.
e) Ancora con
riguardo alle Province autonome, nella sentenza n. 321 si dichiara l’incostituzionalità della legge della Provincia
autonoma di Bolzano 18 dicembre 2002, n. 15 (Testo unico dell’ordinamento dei
servizi antincendi e per la protezione civile), nella parte in cui attribuisce
al Centro operativo provinciale il compito di dirigere e coordinare l’attività
di pronto intervento, non solo «dell’amministrazione provinciale dei comuni e
dei servizi antincendio e per la protezione civile», ma anche dell’amministrazione
«dello Stato». A tale conclusione
Non fondata risulta, invece, l’altra
questione, concernente l’attribuzione al Presidente della Provincia del potere di
provvedere, per l’attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione
dello stato di calamità, a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni
vigenti relative alle materie di competenza provinciale, nel rispetto dei
principî generali dell’ordinamento giuridico. La norma impugnata, infatti, come
si desume dalla sua formulazione letterale, limita l’ambito delle ordinanze in
esame alle sole «materie di competenza provinciale» e prescrive la loro
emanazione «nel rispetto dei principî generali dell’ordinamento giuridico».
Pertanto, il potere derogatorio da essa previsto non può estendersi a materie
(come la tutela dell’ordine pubblico) estranee alle competenze provinciali.
Parimenti infondata è l’impugnativa
della disposizione che conferisce al Presidente della Provincia il potere di
requisire beni mobili ed immobili: la formulazione della norma non rivela alcun
elemento che ne giustifichi un’interpretazione tanto estensiva da far ritenere
i beni dello Stato inclusi fra quelli assoggettabili a requisizione.
f) La sentenza
n.
g) Due
decisioni, rese in sede di conflitto di attribuzione tra enti, riguardano un
indebito uso dei poteri di controllo da parte della Corte dei Conti nei
confronti di enti ad autonomia differenziata (rispettivamente,
Con la sentenza n. 171,
Sulla base di questi rilievi,
Con la sentenza n. 337,
h) Tra le
decisioni riguardanti le Regioni speciali, resta da segnalare la sentenza n. 173, avente ad oggetto una disposizione
legislativa della Regione Friuli – Venezia Giulia relativa alla disciplina
delle elezioni comunali. Ad essa già si è avuto modo di far riferimento supra, cap. II, sez. IV, par. 1).