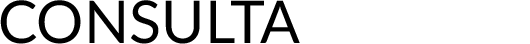La giustizia costituzionale nel 2004
Relazione del Presidente della Corte costituzionale Valerio Onida
20 gennaio 2005
1.1. Il totale delle decisioni
Il totale delle decisioni (numerate) rese dalla Corte
costituzionale nel 2004 è di 446, cui dovrebbero aggiungersi le ordinanze non
numerate (quali, ad esempio, quelle che si pronunciano in merito all’ammissibilità
di interventi di terzo).
Il valore si pone considerevolmente al di sopra delle 382
decisioni registrate nel 2003 (con un incremento del 16,75%), ma al di sotto di
quelli dei cinque anni precedenti, in cui i dati sono oscillati tra i massimi
degli anni 2000 e 2002, rispettivamente con 592 e 536 decisioni,ed i minimi del
1999 e del 2001, rispettivamente con 471 e 447 (la media complessiva del periodo
si attesta a 485,60 decisioni annue). Sebbene il dato sia relativamente basso
(escludendo il 2003, per trovare un numero di decisioni inferiore a quello del
2004, dobbiamo risalire alle 437 del 1996), ciò che pare da segnalare è come,
dopo la netta flessione dell’anno precedente, si sia tornati su valori
assimilabili a quelli medi degli ultimi anni (il dato di 485,60 decisioni annue
per il periodo 1999-2003 viene sostanzialmente confermato da quello di 486,73
per il periodo 1993-2003).
Più del totale, a rivestire un particolare interesse ai fini
dell’inquadramento dell’attività della Corte costituzionale è tuttavia la suddivisione
delle pronunzie per tipi di giudizi. All’uopo, le 446 decisioni possono essere
così suddivise: 286 nel giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale; 97 nel giudizio in via principale; 18 nel giudizio per conflitto
di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni, che salgono a 19 includendo
una ordinanza resa in sede di giudizio sulla sospensione dell’atto impugnato (i
riferimenti statistici che seguono si basano su quest’ultimo dato);
Questi dati confermano la preponderanza numerica del giudizio
in via incidentale, le cui decisioni coprono il 64,13% del totale; il giudizio
in via principale occupa il 21,75%, mentre i due conflitti si assestano,
rispettivamente, a quota 4,26% e 9,19%, dato, quest’ultimo, che scende al
2,47%, se si escludono le ordinanze in tema di ammissibilità del conflitto.
Già questo primo dato è indicativo di un trend che, avvertibile nel
Discorso analogo ma inverso è da farsi per il giudizio in via
principale, il quale, ancorato, per il periodo 1983-2002, ad una media del
7,29% (il 2002 si è posto leggermente al di sotto, con una percentuale di
5,61), con un picco negativo di 2,76% (nel 1998) ed uno positivo di 11,14% (nel
1988), ha conosciuto un notevole incremento nel 2003, giungendo al 14,92%, in
relazione al quale il dato del 21,75% proprio del 2004 costituisce un incremento
– invero ragguardevole – pari al 45,78%.
Meno significativi sono i valori relativi ai due giudizi per
conflitto. In ordine al conflitto tra Stato e Regioni e tra Regioni, il 4,26%
del 2004 segna una flessione rispetto al 2003, quando la percentuale sul totale
delle decisioni aveva raggiunto il 6,02, in netta crescita rispetto al 2002
(2,24%), ma non troppo distante dalla media relativa al periodo 1983-2002, di
5,08% (con picchi del 2,19%, nel 2000, e dell’11,06%, nel 1988). Rispetto a questa
media, il valore del 2004 si pone, dunque, leggermente al di sotto.
Per quanto attiene ai conflitti tra poteri dello Stato,
escludendo le decisioni relative all’ammissibilità dei conflitti, il dato del
2,47% è superiore rispetto alla media degli undici anni precedenti (il
ritardato sviluppo di questo tipo di contenzioso rende pleonastici i riferimenti
a periodi anteriori al 1993), dell’1,87%, ma inferiore rispetto a quella dei
cinque anni precedenti (nel periodo 1999-2003, la media è stata del 2,88%). Con
precipuo riferimento all’anno precedente, il confronto vede prevalere il dato
del 2004 rispetto al 2,09% del 2003.
Il dato aggregato derivante dalla somma delle decisioni sui
conflitti interorganici e sull’ammissibilità (9,19%) denota, invece, per il
2004 una certa flessione rispetto al 2003, quando la percentuale era stata dell’11,51%.
L’estrema volatilità dei valori relativi al giudizio di
ammissibilità del referendum abrogativo
sconsiglia valutazioni in termini di trend,
mentre le 2 ordinanze di correzione di errori materiali (sul totale delle
decisioni, lo 0,45%) possono essere validamente confrontate con le 3 ordinanze
pronunciate ogni anno tra il 2001 ed il 2003.
1.2. Il rapporto tra decisioni ed
atti di promuovimento
Per quanto il numero di decisioni non sia particolarmente
elevato, l’anno 2004 sembra manifestare una inversione di tendenza nel saldo
tra cause sopravvenute e cause definite. Dopo un 2003 reso difficile dal già
ricordato sviluppo del contenzioso tra lo Stato e le Regioni, ma anche dall’alto
numero di ordinanze di rimessione pervenute alla cancelleria della Corte, nel
2004 si è assistito all’inizio dello smaltimento di un arretrato che, pur senza
assurgere a livelli di guardia, deve essere comunque tenuto sotto osservazione.
Le ordinanze di rimessione emesse dai giudici a quibus, che nel 2003 erano giunte a
quota 1.196, sono rimaste molto elevate, ma si sono ridotte a 1.094 (con un
saldo negativo pari all’8,53% rispetto all’anno precedente).
Contemporaneamente, le cause sollevate in via incidentale decise sono passate
dalle 435 del 2003 alle 1174 del 2004 (con un saldo positivo del 169,89%
rispetto all’anno precedente), assicurando una differenza tra cause definite e
cause sopravvenute di 80, ossia il 7,31% in rapporto alle cause sopravvenute
(nel 2003, il saldo era di -761, e la percentuale era del -63,63%).
In ordine al giudizio di legittimità costituzionale in via
principale, i risultati sono meno positivi, quanto meno qualora vengano letti
in termini assoluti: a fronte delle 116 sopravvenienze, sono 115 i ricorsi
decisi, di cui peraltro 8 decisi soltanto parzialmente (in conseguenza della
prassi seguita di separare le cause: di essa si dirà conto nella sedes materiae). Il saldo tra i ricorsi
promossi ed i 107 interamente definiti è dunque di -9 (il 7,76% rispetto alla
sopravvenienza); il dato negativo viene ad essere meno marcato se confrontiamo
i ricorsi promossi con quelli anche parzialmente definiti: -1 (ossia il 0,87%
rispetto alla sopravvenienza). Se si confrontano questi dati con quelli del 2003,
un certo ottimismo si impone, poiché allora ai 98 ricorsi promossi hanno
corrisposto 88 ricorsi decisi anche parzialmente, con un saldo di -10
(corrispondente al 10,20% rispetto alla sopravvenienza).
Indiscutibilmente positivi sono, invece, i dati relativi ai
conflitti intersoggettivi, che hanno visto 16 ricorsi promossi e 22 ricorsi
decisi, con un saldo positivo di 6 ricorsi (vale a dire il 37,50% della
sopravvenienza); nel 2003, ai 15 ricorsi promossi avevano fatto riscontro 36
ricorsi decisi, con un saldo di 21 (il 140% della sopravvenienza).
Un ambito nel quale la sopravvenienza ha superato nettamente
il numero di decisioni è stato quello dei conflitti tra poteri dello Stato: gli
11 ricorsi decisi sono infatti rimasti ben al di sotto dei 17 ricorsi promossi,
con un saldo di -6 (ossia il 35,29% della sopravvenienza). I dati del 2003
erano, peraltro, ben più negativi, se è vero che a fronte di 22 ricorsi
promossi, erano stati solo 8 i ricorsi decisi, con un saldo di -14 (il 63,64%
della sopravvenienza).
Finalmente, deve ricordarsi che la pendenza inerente ai
ricorsi per conflitto tra poteri dello Stato ancora da delibare in sede di
giudizio di ammissibilità ammonta a 12 ricorsi (alla fine del 2003 erano 22).
Delle 446 decisioni, le sentenze sono state 167 e le
ordinanze 279, pari, rispettivamente, al 37,44% ed al 62,56%.
Il dato, leggermente più elevato rispetto al 2003 (in cui le
134 sentenze rappresentano il 35,08% sul totale delle decisioni), lascia
intuire un mutamento del trend rispetto
agli anni 1994-2002, allorché la percentuale di sentenze, dall’iniziale 58,01
(picco massimo degli ultimi due decenni), era costantemente scesa (riducendosi,
in un solo anno, dal 51,38% del 1997 al 36,94% del 1998) sino al 25,19%. L’inversione
di tendenza è ancora lontana dal riportare il saldo percentuale delle sentenze
sui livelli propri di buona parte degli anni novanta (tra il 1991 ed il 1997,
la percentuale ha oscillato tra il 49,71% ed il 58,01%), assestandosi su
livelli assimilabili a quelli degli anni 1987-1990, largamente coincidenti con
la fase c.d. dello «smaltimento dell’arretrato» (i cui valori sono compresi tra
il 40,50% del 1990 ed il 37,25% del 1989).
Al di là di queste considerazioni di ordine generale, una
particolare attenzione meritano i dati del 2004 disaggregati per tipo di
giudizio: nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, 63
sono le sentenze e 223 le ordinanze (percentuali: 22,03 e 79,97); nel giudizio
in via principale, 81 le sentenze e 16 le ordinanze, di cui quattro rese in
sede di sospensione dell’atto impugnato (percentuali: 83,51 e 16,49); nel
conflitto tra enti territoriali, 14 le sentenze e 5 le ordinanze, di cui una
resa in sede di sospensione dell’atto impugnato (percentuali: 73,68 e 26,32);
nel conflitto tra poteri dello Stato, infine, 8 le sentenze e 33 le ordinanze,
di cui trenta rese in sede di ammissibilità (percentuali: 19,51 e 80,49).
Più che la comparazione diacronica in termini percentuali
(invero scarsamente significativa, a tal riguardo, potendosi constatare, con
poche eccezioni, una sostanziale omogeneità dei dati rispetto agli ultimi
anni), ciò che rileva è soprattutto il rapporto tra i tipi di giudizio. Avendo
come riferimento le decisioni adottate con la forma della sentenza, deve
sottolinearsi che, per la prima volta nella cinquantennale storia della Corte
costituzionale, il giudizio nell’ambito del quale è stato reso il maggior
numero di sentenze non è il giudizio in via incidentale. Già nel 2003 la
distanza tra i due tipi di giudizi di legittimità costituzionale si era
fortemente assottigliata (54 sentenze nell’incidentale contro 48 nel
principale); nel 2004, il giudizio in via principale ha superato – e nettamente
– il giudizio in via incidentale. In termini percentuali, le sentenze sono
state rese nel 37,72% dei casi in sede di giudizio in via incidentale, contro
il 48,50% del giudizio in via principale (nel 2003, le percentuali erano,
rispettivamente, il 40,29% ed il 35,92%); a completare il quadro, le sentenze
nei conflitti si assestano sull’8,38% per quello tra enti territoriali e sul
4,79% per quello tra poteri, mentre l’unica sentenza di ammissibilità della
richiesta di referendum abrogativo
copre lo 0,60% del totale.
Con riguardo alle ordinanze, il giudizio in via incidentale
mantiene una assoluta centralità, coprendo il 79,93%, contro il 5,73% del
giudizio in via principale, l’1,79% del conflitto intersoggettivo, l’11,83% del
conflitto interorganico e lo 0,72% rappresentato dalle due ordinanze di
correzione di errori materiali.
Nel corso del 2004,
Rispetto al 2003, si è assistito ad una consistente crescita
della percentuale di pronunce adottate a seguito di udienza pubblica rispetto a
quelle adottate a seguito di camera di consiglio: nel 2003, delle 382
pronunzie, 126 erano seguite ad una udienza pubblica e 256 ad una camera di
consiglio (percentuali rispettive: 32,98 e 67,02); nel 2004, le 446 pronunzie
si sono ripartite tra le 167 adottate dopo una udienza pubblica e 279 dopo una
camera di consiglio (percentuali rispettive: 37,44 e 62,56).
Questi dati – con, in particolare, la crescita del 4,46%
delle decisioni adottate a seguito di udienza pubblica – non sembra indicare
mutamenti in ordine alla scelta del rito, ma appare piuttosto come il logico
corollario della crescita in termini numerici dei giudizi diversi da quelli in
via incidentale, ché è in quest’ultimo che, generalmente, si fa ricorso alla
camera di consiglio.
In tal senso, possono validamente confrontarsi i valori
relativi ai due giudizi di legittimità costituzionale per gli anni 2003 e 2004.
Nel 2003, le pronunce rese in sede di giudizio in via
incidentale erano così ripartite:
Anche con riferimento al giudizio in via principale, le
percentuali sono tendenzialmente assimilabili, giacché le pronunzie a seguito
di udienza pubblica hanno coperto, nel 2003, il 94,74% e, nel 2004, il 92,78%
(correlativamente, le pronunzie a seguito di camera di consiglio sono passate
dal 5,26% al 7,22%); a mutare sono stati, però, i valori assoluti, di talché le
decisioni adottate a seguito di udienza pubblica sono passate dalle 54 del 2003
(con 3 decisioni a seguito di camera di consiglio) alle 90 del 2004 (con 7
decisioni a seguito di camera di consiglio).
Al di là di questi riferimenti, che certo aiutano a spiegare
i dati riscontrati, ciò che pare da sottolineare è quanto la crescita del peso
dell’udienza pubblica rispetto alla camera di consiglio incida sul carico di
lavoro della Corte costituzionale. In tal senso, può citarsi il dato –
indubbiamente opinabile nella sua genericità, ma probabilmente non del tutto
privo di rilievo – inerente alla media dei giorni che intercorrono tra la data
della trattazione della causa e la data del deposito della decisione: per le
cause di camera di consiglio la media è di 54,01 giorni, mentre per le cause di
udienza pubblica la media sale ad 81,73 giorni.
In buona sostanza, il periodo che occorre, mediamente, per
decidere una causa trattata in udienza pubblica è pari a circa una volta e
mezzo (esattamente, al 151,32%) rispetto a quello necessario per decidere una
causa trattata in camera di consiglio.
L’anno 2004 difficilmente può essere definito come un anno
«di transizione»: molti sono, in effetti, gli elementi che contribuiscono a
renderlo un anno importante.
Innanzi tutto, si segnala un duplice avvicendamento all’interno
del collegio. Alla fine del mese di gennaio, il Pres. Riccardo Chieppa ha
terminato il suo mandato ed è stato sostituito dal Pres. Alfonso Quaranta; alla
metà di settembre, a subentrare al Pres. Gustavo Zagrebelsky è stato il Prof.
Franco Gallo.
Nel 2004,
Durante la presidenza di Gustavo Zagrebelsky, è stata
approvata, con deliberazione del 10 giugno 2004, anche la modifica di alcuni
articoli delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale. La riforma ha riguardato molteplici aspetti dei
giudizi di fronte alla Corte costituzionale.
In particolare, si è inserita la previsione secondo cui, nel
giudizio in via incidentale, eventuali interventi di soggetti terzi debbono
seguire la forma e le modalità che sono proprie degli interventi del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Presidente della Giunta regionale (art. 4).
Altre modifiche hanno riguardato la procedura di acquisizione degli atti al
giudizio (art. 7), il potere presidenziale di convocazione (art. 8) e la
pubblicazione delle decisioni della Corte (art. 20).
Per quanto attiene al giudizio di legittimità costituzionale
in via principale, le modifiche sono consistite essenzialmente in
«aggiornamenti» normativi resisi necessari a seguito del mutamento del quadro
costituzionale (art. 23 e, con riguardo all’attività di pubblicazione degli
atti di promuovimento, art. 24).
In riferimento al conflitto di attribuzione tra Stato e
Regioni e tra Regioni, si è introdotta la necessità di notificare il ricorso
anche «all’organo che ha emanato l’atto, quando si tratti di autorità diverse
da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo» (art. 27).
Altra modifica è stata quella relativa alla pubblicazione dei
ricorsi per conflitto, che, nel caso dei conflitti tra poteri dello Stato, debbono
essere pubblicati unitamente all’ordinanza che decide sulla ammissibilità (art.
29).
Infine, è stata introdotta la previsione secondo cui il
deposito dei ricorsi «può essere effettuato avvalendosi del servizio postale»
(«in tal caso, ai fini dell’osservanza dei termini per il deposito,vale la data
di spedizione postale»: art. 30).
Con precipuo riguardo all’attività giurisdizionale, può
rilevarsi che, secondo una tendenza ampiamente radicata, vi è una pressoché
costante congruenza tra giudici relatori e giudici redattori delle decisioni,
nel senso che sono episodici i casi in cui si abbia una discrepanza. Nel 2004,
si sono avuti, in particolare, tre casi: l’uno relativo alla decisione del
giudizio promosso in via diretta avverso la deliberazione legislativa
statutaria della Regione Calabria (sentenza n. 2); il secondo attinente ad una
questione sollevata in via incidentale relativa ai soggetti esonerati dall’esame
per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili (sentenza n. 35); il terzo concernente una
questione sollevata, di nuovo, in via incidentale, avente ad oggetto il procedimento
di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale (ordinanza n. 169).
Venendo ad alcune considerazioni di ordine più generale, dal
quadro statistico che è stato sopra tratteggiato emergano alcuni dati che
rendono l’attività svolta particolarmente interessante. Si è detto della
consistenza del contenzioso tra lo Stato e le Regioni manifestatosi in sede di
giudizio di legittimità costituzionale in via principale (assai più che in
quella di conflitto intersoggettivo): l’avvenuta riforma del Titolo V della
Parte seconda della Costituzione ha continuato ad alimentare una conflittualità
che, dalla fine del 2001, non accenna, almeno per il momento, a scemare,
nonostante la (parziale) attuazione legislativa (segnatamente con la legge 5
giugno 2003, n. 131, c.d.
La crescita di questo tipo di contenzioso ha enfatizzato il
ruolo arbitrale che
Il numero di ricorsi e di decisioni non è, di per sé,
sufficiente a rendere ragione dell’importanza assunta da questo tipo di
giudizi. È solo andando ad analizzare le questioni che
La funzione arbitrale non è stata declinata esclusivamente
nell’ottica dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, ché, anzi, non mancano –
pur nella loro esiguità numerica – decisioni di grande rilievo rese nel quadro
della garanzia degli equilibri tra i poteri dello Stato: a tal riguardo, oltre
alle sempre importanti decisioni dei conflitti in tema di insindacabilità delle
opinioni espresse da parlamentari, si segnalano, in particolare, il tema dei
limiti che si pongono alla perquisizione nelle sedi di partito ed il c.d. «caso
Cossiga», in cui
Queste considerazioni, qualora assolutizzate, rischiano però
di essere fuorvianti. Se è vero, infatti, che
La funzione di garanzia, d’altra parte, non è stata
esercitata soltanto allorché
Un cenno, infine, merita anche una prospettiva destinata a
diventare, nel volgere di breve tempo, uno degli aspetti più importanti nella
vita, non solo della Corte, ma di tutti gli attori istituzionali. Il 2004 è
stato l’anno della firma del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa.
Questa Carta non potrà non avere incidenza anche sulla posizione e sulle funzioni
della Corte costituzionale: la necessità e la volontà di disegnare per
Per queste ragioni, e per molte altre che sono state qui
pretermesse, appare dunque ampiamente confortata l’idea che il 2004 sia stato
per
Il giudizio di legittimità
costituzionale in via incidentale
1. Considerazioni introduttive
Il giudizio in via incidentale è stato, anche nel 2004, il
giudizio che, sul piano puramente quantitativo, ha più impegnato
Sul piano processuale, sono riscontrabili alcuni spunti di un
certo interesse che saranno oggetto dei prossimi paragrafi.
2. La legittimazione a sollevare
questione di legittimità costituzionale
Nel corso del 2004, sono state decise per la prima volta
questioni sollevate dal Consiglio di Stato in sede consultiva, nel quadro del
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Con la sentenza n. 254
(poi confermata dalle ordinanze numeri 357 e 392), è
stata negata la legittimazione del rimettente a porsi quale giudice a quo,
sulla base della natura non giurisdizionale dell’organo. Rigettando gli
argomenti in contrario addotti dal Consiglio di Stato (e segnatamente
rilevando, da un lato, le diversità procedurali che caratterizzano il giudizio
in via incidentale rispetto al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
delle Comunità europee e, dall’altro, la non assimilabilità – ai fini della
legittimazione – della funzione consultiva del Consiglio di Stato a quella di
controllo della Corte dei conti), è stato sottolineato come
Nessun problema di ammissibilità si è posto, invece, per la
questione sollevata dall’Ufficio centrale per il referendum presso
3. Il nesso di pregiudizialità tra
giudizio a quo e giudizio di legittimità costituzionale
Nella giurisprudenza dell’ultimo anno trovano conferma gli
orientamenti ormai consolidati della Corte in tema di pregiudizialità tra giudizio
comune e giudizio in via incidentale.
In particolare, una eccezione di inammissibilità della
questione per difetto del carattere incidentale, sull’assunto che l’eventuale
pronuncia di accoglimento sarebbe venuta a concretare di per sé la tutela
chiesta al giudice a quo, è stata respinta, una volta
constatato che il petitum dell’azione
proposta di fronte al rimettente era distinto e separato dalla questione di
legittimità costituzionale, la quale concorreva a formare esclusivamente la causa petendi dell’azione stessa ed a
consentirne l’accoglimento (ordinanza n. 361).
Eventuali illegittimità del giudizio a quo non si
riverberano sulla questione di costituzionalità: nell’ordinanza n. 297
si è sottolineato, a tal riguardo, che l’asserito vizio dell’ordinanza
di rimessione, emessa malgrado la pretesa illegittimità della estromissione dal
giudizio di una delle parti, non incideva sull’ammissibilità del giudizio di
costituzionalità.
Circa il momento nel quale la questione di legittimità
costituzionale deve essere proposta, è stata dichiarata l’inammissibilità
(manifesta) di questioni sollevate prematuramente, tanto da rendere la
rilevanza «puramente ipotetica ed eventuale» (ordinanza n. 374;
conformemente, ordinanza
n. 434).
Del pari, sono state decise nel senso della manifesta
inammissibilità le questioni sollevate tardivamente, quindi in difetto del
carattere della pregiudizialità, in quanto il rimettente aveva
oramai esaurito la sua cognizione in relazione alla disposizione oggetto di censura (ordinanze numeri 213, 268, 395 e 405).
La irrilevanza della questione è stata altresì pronunciata
allorché la norma censurata non risultava applicabile nel caso di specie (sentenza n. 114,
ordinanze numeri 88 e 266), in
quanto – ad esempio – non in vigore al momento dei fatti da cui la causa
originava (ordinanze numeri 289 e 318),
oppure perché dalla ordinanza di rimessione si evinceva che nel giudizio a
quo si procedeva per reati diversi da quelli contemplati nella disposizione
impugnata (ordinanza
n. 94).
Ad analogo esito hanno condotto le constatazioni che altro
giudice rispetto al rimettente era l’unico legittimato a sollevare la questione
(ordinanza n. 105)
oppure che l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma, nel
senso voluto dal rimettente, non avrebbe avuto alcuna influenza nel giudizio a quo (ordinanza
n. 276 e, in
senso conforme, ordinanze numeri 127 e 375).
Numerose sono le decisioni che si sono soffermate sulla forma
e sui contenuti delle ordinanze di rimessione.
Ad impedire una decisione di merito sono state in varie
occasioni la carenza – assoluta o, in ogni caso, insuperabile – di descrizione
della fattispecie oggetto del giudizio a
quo (ex plurimis, sentenza n. 257
e ordinanze numeri 122, 146, 149, 188, 189, 251, 252, 291, 373 e 393) o
comunque il difetto riscontrato in ordine alla motivazione della rilevanza (ad
es., ordinanze numeri 63, 79, 89, 99, 126, 143, 182, 339, 366 e 415) o
della manifesta infondatezza (ad es., ordinanze numeri 81, 169 e 234) o di
entrambe (ad es., ordinanze numeri 51, 53 e 164). Anche
a proposito della motivazione, tuttavia, si è ritenuto sufficiente che essa
fornisse – pur se succintamente – riferimenti sufficienti per cogliere il proprium della questione (ordinanza n. 141).
Altra ragione di inammissibilità della questione
ripetutamente evidenziata è stato il mancato esperimento di un tentativo di
interpretazione conforme alla Costituzione della disposizione censurata (sul punto
specifico, v., peraltro, infra, par. 8).
Ordinanze di rinvio pur complete nei loro elementi
indefettibili sono state – in base ad un orientamento consolidato – ritenute inidonee
ad instaurare l’incidente di costituzionalità allorché esse erano motivate in
maniera perplessa (sentenza n. 315 ed ordinanza n. 193),
contraddittoria (ordinanze numeri 50, 81 e 94) o
proponendo questioni di legittimità costituzionale in alternativa (sentenza n. 382 ed ordinanza n. 192).
Parimenti inammissibili sono state dichiarate quelle
questioni promosse con ordinanze motivate per
relationem, in quanto, secondo una giurisprudenza ormai nutrita di
precedenti, la motivazione dell’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente,
«non potendosi il giudice a quo
limitare a richiamare per relationem
il contenuto di altri atti o provvedimenti, anche se, in ipotesi, acquisiti
agli atti del procedimento principale» (ordinanza n. 59):
l’insufficienza della motivazione è stata in concreto riscontrata con riguardo
ad una ordinanza di rimessione che, in ordine alla non manifesta infondatezza,
si limitava a fare rinvio alle argomentazioni svolte da altro giudice (ordinanza n. 59)
e con riguardo ad una ordinanza la cui parte motiva era costituita «da passi
estrapolati dagli atti difensivi delle parti nel giudizio a quo» (ordinanza n. 156).
I vizi dell’ordinanza di rimessione non possono essere sanati
attraverso un «atto integrativo» trasmesso alla Corte successivamente alla
trasmissione degli atti del giudizio a
quo. In tal senso, l’ordinanza n. 391 ha dichiarato la manifesta
inammissibilità di una questione sollevata con ordinanza
priva dei requisiti minimi indispensabili ai fini dell’individuazione della norma
censurata e del fatto oggetto del giudizio, oltre che assolutamente carente di
motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, non producendo
l’atto successivamente depositato effetti ai fini del giudizio di legittimità
costituzionale, «in quanto le “integrazioni” alla precedente ordinanza
risulta[va]no effettuate quando il processo a
quo era già stato sospeso e il giudice rimettente aveva quindi consumato il
suo potere in ordine alla questione di legittimità costituzionale».
Da segnalare è, infine, la sentenza n. 76,
che ha deciso nel merito una questione sollevata con ordinanza facendo propria
una questione in precedenza sollevata, nel corso dello stesso giudizio, ma mai
regolarmente pervenuta alla Corte a causa di un disguido postale.
5. La riproposizione della questione
In alcune occasioni,
Per solito, tali riproposizioni hanno fatto seguito ad
ordinanze della Corte con cui si restituivano gli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza (si
vedano, ad esempio, i giudizi conclusi con le ordinanze numeri 183 e 263), sull’implicito
presupposto della possibilità del giudice medesimo di risollevare la questione,
se del caso, una volta operato il riesame.
Parzialmente diverso è il caso risolto con l’ordinanza n. 371, in cui erano state riproposte,
nell’ambito del medesimo procedimento, due delle quattro questioni di legittimità
costituzionale già dichiarate manifestamente inammissibili.
Irriducibile alla categoria della riproposizione è,
ovviamente, la proposizione, nell’ambito dello stesso giudizio a quo, di una seconda questione di
costituzionalità, affatto diversa rispetto a quella già scrutinata dalla Corte.
Tale è stato, ad esempio, il caso dell’ordinanza n. 88, in cui, a seguito di una prima
decisione di manifesta inammissibilità, il giudice a quo ha proposto una ulteriore questione avente ad oggetto una
disposizione legislativa altra rispetto a quella della prima ordinanza di
rinvio.
Nel corso del 2004, alcuni giudizi sono stati definiti con
una decisione processuale in conseguenza dell’inidoneità dell’atto oggetto
della questione ad essere scrutinato ad opera della Corte costituzionale. Così,
con l’ordinanza
n. 66, la manifesta inammissibilità è stata motivata alla luce della
circostanza che la censura aveva riguardo ad una norma regolamentare sottratta
al sindacato di legittimità costituzionale di questa Corte.
Ad esiti analoghi si è giunti allorché non sussisteva tra le
disposizioni legislative, da un lato, e le disposizioni regolamentari
richiamate dal remittente, dall’altro lato, quel rapporto di integrazione e
specificazione – ai fini dell’oggetto del quesito di costituzionalità proposto
– che avrebbe consentito l’impugnazione delle disposizioni legislative «come
specificate» dalle norme regolamentari, con il che la censura si appalesava
come «il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo
di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate:
norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato
di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo
[della] Corte» (ordinanza
n. 389).
Ad altro proposito, nella sentenza n. 76
si è rilevato che gli eventuali vizi da cui si facevano derivare le conseguenze
pregiudizievoli lamentate non erano da imputare alle norme denunciate, bensì
alla loro difettosa o mancata applicazione, che non avrebbe dunque potuto
essere addotta come motivo di illegittimità costituzionale delle stesse norme
legislative.
Con riferimento alle fonti che integrano il parametro di
legittimità costituzionale, non si riscontrano novità di rilievo rispetto alla
giurisprudenza degli anni precedenti. Possono segnalarsi, per la loro peculiarità,
tre casi.
Nel primo, che ha dato origine all’ordinanza n. 78, il giudice rimettente censurava
una disposizione legislativa, tra l’altro, perché essa avrebbe contraddetto una
«prassi interpretativa» formata tra tutti gli Stati firmatari di una convenzione
internazionale, affermando che tale prassi sarebbe stata «da ricondurre nell’ambito
delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, alle quali,
in virtù del principio contenuto nell’art. 10 della Costituzione, l’ordinamento
giuridico deve conformarsi». La questione, identica ad altre sulle quali
Con l’ordinanza n. 216, è stato affrontato il tema
della distinzione tra norme-parametro e norme che pongono meri criteri
ermeneutici della legislazione. In particolare, il giudice a quo qualificava (implicitamente) come norme interposte i principi
enunciati negli articoli 1, 6 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
«Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», all’uopo
valendosi della disposizione dell’art. 1 della legge, ai sensi della quale «le
disposizioni della […] legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della
Costituzione, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e
possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi
speciali». Rifacendosi alla qualificazione prevalente nella giurisprudenza di
legittimità e nella dottrina,
Giova menzionare, in terzo luogo, l’ordinanza n. 419, che ha rigettato una questione
nella quale una disposizione costituzionale (quella di cui all’art. 68, primo
comma, della Costituzione) era indicata quale tertium comparationis.
Infine, relativamente ai limiti entro cui la violazione degli
articoli 76 e 77 della Costituzione sono invocabili, si rinvia a quanto verrà
detto infra, parte II, cap. II, par. 2.5.
8. La questione di legittimità
costituzionale ed i poteri interpretativi dei giudici comuni
Uno dei profili maggiormente caratterizzanti del giudizio in
via incidentale è costituito certamente dai rapporti che intercorrono tra la
facoltà di sollevare questione di legittimità costituzionale ed i poteri
interpretativi propri dei giudici comuni e della Corte costituzionale. Nel
corso del 2004 sono state molteplici, su questo tema, le prese di posizione
della Corte, generalmente collocabili in linea di stretta continuità con il
recente passato.
Parimenti censurate sono state le questioni sollevate senza
aver previamente esperito un tentativo di interpretazione delle disposizioni
impugnate in modo tale da renderle conformi al dettato costituzionale: ciò in
quanto «il giudice deve privilegiare [in ogni caso] l’interpretazione idonea a
superare i dubbi di costituzionalità» (ordinanza n. 214),
in ottemperanza ad un canone esegetico che è stato definito come di portata «generale»
(sentenza n. 44
ed ordinanza n. 433).
Si sono quindi conclusi con una pronuncia in rito quei giudizi
nei quali «i rimettenti, avendo omesso di verificare la possibilità di seguire
una interpretazione diversa da quella da essi acriticamente accolta, [erano]
venuti meno all’onere del giudice di esplorare eventuali interpretazioni
conformi a Costituzione prima di sollevare questione di legittimità costituzionale»
(sentenza n. 219).
In applicazione di tale
principio, è stata dichiarata la manifesta inammissibilità di questioni
sollevate da rimettenti che, nel dubitare della legittimità costituzionale
della norma, non avevano tenuto conto della integralità dell’elaborazione
giurisprudenziale e dottrinale in materia, onde esplorare nuovi canali ermeneutici
(ordinanze numeri 208 e 215). Ad
esiti identici hanno condotto quei «palesati dubbi di incostituzionalità [che]
si basa[va]no essenzialmente su un’apodittica affermazione dell’impossibilità
di dare alla norma impugnata una diversa lettura» (ordinanza n. 235).
Tale conclusione si è imposta – verrebbe da dire, a fortiori – anche
allorché il giudice a quo, «pur consapevole della possibilità
di una esegesi della norma diversa da quella risultante dal suo tenore
letterale», avesse comunque omesso «di verificare se [fossero] consentite interpretazioni
tali da porre la norma stessa al riparo dai prospettati dubbi di
costituzionalità» (ordinanza n. 242).
Nella giurisprudenza del
2004, è stata inoltre ribadita l’inammissibilità di questioni sollevate da
rimettenti che, magari anche consapevoli «dell’esistenza di due contrapposti
indirizzi giurisprudenziali e convint[i] della maggiore plausibilità di uno di
essi», chiedevano, nella sostanza, alla Corte «una pronuncia di
incostituzionalità cui [sarebbe conseguita] la stessa disciplina risultante
dalla tesi interpretativa accolta dall’altro indirizzo, senza né verificare la
possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, idonea a
sottrarre la norma al contrasto con i parametri evocati, né (in alternativa)
motivare sull’impossibilità di essa» (ordinanza n. 305).
Immuni da questo tipo di vizi sono state, invece, quelle
questioni che, «lungi dal risentire del mancato assolvimento da parte del
rimettente dell’onere di tentare un’interpretazione costituzionalmente conforme
delle norme impugnate», si erano basate «proprio sulla motivata impossibilità
di leggere» la disposizione in modo conforme alle previsioni costituzionali
(così, tra le altre, l’ordinanza n. 350).
L’obbligo per il giudice di esercitare i propri poteri
interpretativi implica che lo stesso non possa chiedere una «collaborazione»
alla Corte costituzionale che si traduca sostanzialmente in un «avallo» dell’opzione
ermeneutica prescelta (ordinanze numeri 92 e 142).
Un ruolo centrale nella ricostruzione dei rapporti tra
Sui margini entro i quali l’attività interpretativa del
giudice rimettente può svolgersi, la sentenza n. 91
ha sottolineato che, «in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato
che abbia acquisito i caratteri del “diritto vivente”, la valutazione se
uniformarsi o meno a tale orientamento è una mera facoltà» del giudice, potendosi
configurare in tal caso una parziale deroga al sopra menzionato dovere del
giudice comune di ricercare la prospettiva ermeneutica che consenta alla
disposizione di risultare conforme ai parametri costituzionali.
Sui presupposti in presenza dei quali può parlarsi di
«diritto vivente», la sentenza n. 106
ha rilevato come essi non siano integrati da pochi precedenti giudiziari di
merito, tanto più ove la dottrina dominante sostenga una soluzione
interpretativa diversa; l’ordinanza n. 214,
invece, registra un caso «classico» di «diritto vivente» allorché si
riscontrino «numerose pronunce delle sezioni unite della Corte di cassazione»
univoche nel tratteggiare un orientamento interpretativo recepito anche dal Consiglio
di Stato.
La sussistenza di un «diritto vivente» non è di per sé
esclusa neppure quando, «anche nella più recente giurisprudenza di legittimità,
emergano “dubbi e perplessità” riguardo alla coerenza con l’ordinamento vigente
dell’indirizzo interpretativo» prevalente (sentenza n. 206).
L’istituto della riunione, previsto dall’art. 15, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi di fronte alla Corte
costituzionale, ha avuto nel 2004 una assai frequente applicazione, come
dimostra il dato di 94 decisioni, sulle 286 totali (pari, dunque, a quasi un terzo),
che definiscono i giudizi instaurati da più di una ordinanza di rimessione.
La motivazione alla base della riunione è stata, nella
maggior parte dei casi, quella della identità delle questioni (sentenze numeri 91, 168, 178, 207, 282, 339, ed
ordinanze numeri 10, 11, 47, 52, 53, 55, 57, 59, 66, 90, 104, 108, 141, 143, 165, 188, 189, 194, 212, 235, 293, 299, 309, 317, 332, 351, 352, 363, 398, 399, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 411, 417, 420, 422, 442), in
qualche caso veicolata anche dall’identità del giudice rimettente (si vedano,
in particolare, le ordinanze numeri da
In questo ambito, merita una particolare segnalazione la sentenza n. 120, resa a seguito della riunione
di questioni affidate, per l’istruzione, a due diversi giudici relatori: corrispondentemente,
la sentenza è stata redatta congiuntamente da questi due giudici, recando le
firme di entrambi.
Non mancano, poi, casi di riunione basati sulla (per lo più
«evidente») connessione (sentenze numeri 114, 161, 222, ed
ordinanze numeri 266, 310) o
sulla semplice analogia dalle questioni (ordinanze numeri 79,
275, 302, 393, 402, 408 e 409).
In qualche caso, a condurre alla riunione è stata l’identità
dell’oggetto (sentenze numeri 219, 223, 430, ed
ordinanze numeri 197, 226, 268, 349), o
anche la parziale identità (sentenza n. 426), nonché l’identità dell’oggetto
e, per altra parte, la connessione delle questioni (sentenza n. 257). In un caso (sentenza n. 316), la riunione è stata disposta
alla luce della sostanziale omogeneità delle questioni sollevate.
Oltre ai casi di riunione, deve ricordarsi l’unico caso di
separazione della causa, verificatosi in relazione ad una ordinanza di
rimessione che, ponendo diverse questioni, è stata all’origine dell’ordinanza n. 23 e della sentenza n. 24. La tecnica della separazione,
ampiamente sperimentata a partire dal 2003 nel giudizio in via principale, ha
dunque iniziato a trovare applicazione anche nel giudizio in via incidentale.
10. Il contraddittorio di fronte alla
Corte (in particolare, l’intervento di terzi)
Nel 2004 è stata pienamente confermata la propensione all’intervento
del Presidente del Consiglio «a difesa» delle disposizioni impugnate, analogamente
a quanto constatabile per le Regioni le cui leggi fossero oggetto di una questione
in via incidentale.
Da segnalare è un caso di intervento dell’Avvocatura generale
dello Stato in rappresentanza «congiunta» del Presidente del Consiglio dei
ministri e della Regione Siciliana, in un giudizio che aveva ad oggetto tanto
disposizioni legislative statali quanto disposizioni di fonte regionale (sentenza n. 76).
Meno frequente, ma comunque cospicua nel numero, è stata la
costituzione di fronte alla Corte (di alcune) delle parti dei giudizi a quibus. Quando la costituzione è
avvenuta ritualmente, la causa è stata trattata in udienza pubblica, fatte
salve relativamente poche eccezioni (si vedano, ad esempio, le ordinanze numeri
149 e 396).
Per quel che attiene all’intervento di soggetti diversi dalla
difesa erariale o regionale e dalle parti del giudizio a quo, quattro sono stati i giudizi in cui ciò è avvenuto.
In quello concluso con la sentenza n. 281, l’intervento della Federconsumatori
di Bologna è stato spiegato in uno dei giudizi a quibus, in relazione ad una ordinanza di rimessione che ha posto
una questione rivelatasi inammissibile per «l’evidente, e perciò
stesso assorbente, improponibilità della domanda» presentata nel giudizio
principale.
Sono stati invece ammessi, con ordinanza letta in udienza pubblica,
gli interventi di terzo spiegati nei giudizi conclusi con le ordinanze numeri 50 e 389.
Nel primo, relativo alla legittimità costituzionale della
disciplina delle quote di prelievo sulle scommesse sportive spettanti al
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, è stato ritenuto ammissibile l’atto di
intervento del Coni,
in quanto, appunto, «destinatario per legge del provento della prestazione
della cui costituzionalità si discute[va] e […] quindi […] titolare di una
posizione giuridica specifica coinvolta nel giudizio» (ordinanza letta all’udienza
pubblica del 25 novembre 2003).
Nel secondo giudizio, avente ad oggetto la legittimità
costituzionale della normativa concernente l’esposizione del Crocifisso nelle
aule scolastiche, sono intervenuti, con unico atto, il sig. Paolo
Bonato, in proprio e quale genitore di un’alunna della stessa scuola, e il sig.
Linicio Bano, in qualità di presidente dell’associazione italiana genitori di
Padova.
Un ulteriore caso di intervento di terzo, pur se parzialmente
sui generis (non fosse altro per il
soggetto intervenuto), è quello verificatosi nella causa definita con l’ordinanza n. 99. In un giudizio in via
incidentale avente ad oggetto una disposizione legislativa regionale, ha infatti
depositato un atto di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, al
fine di sostenere la fondatezza della questione di legittimità, all’uopo richiamando
quanto già esposto in relazione ad altra questione riguardante il medesimo atto
legislativo sollevata in via diretta dal Presidente del Consiglio dei ministri
medesimo.
11.1. Le decisioni processuali
A] Nel corso del 2004, tra le sentenze di inammissibilità
adottate, alcune sono state motivate in ragione dell’irrilevanza della
questione (sentenze numeri 85, 114, 120, 161, 281 e 316). Il
difetto constatato nella motivazione dell’ordinanza è stato alla base delle
inammissibilità di cui alle sentenze numeri 107
e 315, il
mancato esperimento dell’interpretazione adeguatrice ha fondato la decisione
contenuta nella sentenza n. 219, mentre
l’erroneità del tertium comparationis invocato è stato il profilo
centrale dell’argomentazione che ha condotto alla sentenza n. 206.
Inammissibile è stata altresì dichiarata la questione di
legittimità costituzionale sollevata da un rimettente non legittimato ai sensi
dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (sentenza n. 254).
Infine, sono state ritenute inammissibili le questioni
attraverso le quali i rimettenti, «postulando […] una operazione di “riempimento”
dei contenuti della norma», giungevano ad una richiesta di modifica del diritto
positivo che «si palesa[va] estranea, per il suo carattere apertamente “creativo”,
ai poteri [della] Corte, rimanendo eventualmente affidata alla discrezionalità
del legislatore» (sentenza
n. 382; analogamente, la sentenza n. 175 ha censurato l’«abnormità»
della richiesta formulata dal giudice a quo).
B] Nel novero delle decisioni processuali, le più numerose
sono peraltro state quelle di manifesta inammissibilità.
Un siffatto dispositivo è stato adottato in conseguenza del
sussistere di vizi nell’ordinanza di rimessione, principalmente dovuti a
carenze nella motivazione (sentenze numeri 161, 222, 257 e 382,
ordinanze numeri 45, 50, 51, 53, 59, 60, 61, 63, 79, 81, 89, 96, 99, 122, 126, 127, 130, 133, 143, 146, 149, 156, 159, 164, 169, 170, 174, 182, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 210, 234, 235, 251, 252, 262, 264, 268, 291, 294, 302, 309, 333, 336, 343, 349, 352, 361, 362, 365, 366, 370, 371, 385, 391, 393, 415 e 418).
Altre decisioni di manifesta inammissibilità sono state
motivate dall’irrilevanza della questione (sentenza n. 223 e ordinanze numeri 23, 88, 94, 105, 130, 214, 265, 268, 271, 276, 289, 299, 305, 310, 318, 332 e 375) e dall’erroneo
utilizzo dei propri poteri interpretativi da parte dei giudici a quibus
(ordinanze numeri 92, 100, 142, 208, 215, 242, 279 e 305).
In altri casi, le ordinanze di manifesta inammissibilità sono
state originate dal difetto di legittimazione del rimettente, derivante dalla
natura dell’organo o dallo stadio del giudizio in cui si versava (ordinanze
numeri 213, 357, 374, 392, 395, 405 e 434). Manifestamente
inammissibili sono poi state dichiarate questioni viziate dall’inidoneità delle
norme invocate a fungere come parametri (ordinanza n. 216) o dall’inidoneità delle norme
impugnate ad essere oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale di
fronte alla Corte costituzionale (ordinanze numeri 66,
193 e 389).
Ancora, la manifesta inammissibilità ha colpito quelle
questioni nelle quali si chiedeva alla Corte di esercitare la propria funzione
attraverso soluzioni non definibili – con formula ormai classica – come «a rime
obbligate» (ordinanza
n. 359), o di incidere su sfere
riservate alla discrezionalità legislativa (ordinanze numeri 121 e 368).
Infine, una identica sorte hanno avuto le questioni giunte
allo scrutinio della Corte che fossero già «coperte» da precedenti decisioni di
manifesta inammissibilità (ordinanza n. 78) o di incostituzionalità (ordinanza n. 19).
C] Cospicuo è stato anche il numero di decisioni di
restituzione degli atti ai giudici a quibus, sostanzialmente
riconducibili a tre categorie: la prima concerne la restituzione motivata da
sopravvenienze legislative (sentenza n. 316 e ordinanze numeri 54, 64, 68, 79, 183, 184, 263, 293 e 299), la
seconda l’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme
censurate o di parte di esse (rispettivamente, ordinanze numeri 152, 266, 351, ed
ordinanze numeri 47, 77, 93, 111, 197, 363), la
terza i casi (tutti relativi alla medesima fattispecie, quella cioè relativa
alla convalida dell’arresto per il reato di trattenimento dello straniero sul
territorio italiano) in cui alla sopravvenienza della decisione della Corte
costituzionale è seguito un intervento legislativo di modifica della disciplina
della materia (ordinanze numeri da
Da notare è, poi, che con l’ordinanza n. 125 si è pronunciata la restituzione
degli atti per il sopravvenire, non solo di una nuova normativa, ma anche di
una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.
D] Tra le decisioni processuali è sicuramente da annoverare
anche l’ordinanza n. 165, con la
quale sono state rinviate a nuovo ruolo alcune cause pendenti, in accoglimento
della «richiesta di rinvio formulata dall’Avvocatura generale dello Stato, in
vista della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle
cause C-387/02, C-391/02 e C-403/02», a tale decisione essendosi giunti in
considerazione de «la sostanziale coincidenza fra il quesito di
costituzionalità, attinente all’asserito contrasto delle norme impugnate con il
diritto comunitario, e quello che costitui[va] oggetto delle predette cause».
A] Le decisioni di rigetto sono state adottate, in grande
maggioranza, con la forma dell’ordinanza di manifesta infondatezza. Tali
pronunzie sono state motivate soprattutto attraverso il riferimento all’erroneo
presupposto interpretativo o all’erronea ricostruzione del quadro normativo o,
ancora, alla impossibilità di incidere su ambiti riservati alla discrezionalità
del legislatore (ordinanze numeri 83, 95, 97, 101, 108, 110, 123, 124, 130, 132, 133, 144, 145, 150, 151, 153, 158, 201, 202, 211, 214, 264, 265, 275, 277, 289, 290, 294, 317, 344, 346, 358, 383, 386, 396, 417, 418, 419, 433, 438 e 439); in
questo tipo di decisioni, sono state frequenti le occasioni in cui
Meno numerose, ma comunque non esigue, sono state le
ordinanze di manifesta infondatezza che hanno fatto seguito a precedenti
declaratorie di infondatezza (ordinanze numeri 41,
67, 80, 84, 121, 170 e 420) oppure
di manifesta infondatezza di identiche o analoghe questioni (rispettivamente,
ordinanze numeri 10, 20, 61, 65, 90, 102, 139, 141, 157, 171, 212, ed ordinanze
numeri 11, 52, 55, 56, 57, 82, 128, 209, 292, 301, 302, 377, 387, 422, 443).
B] Delle decisioni di rigetto adottate nella forma di sentenze,
soltanto cinque hanno presentato il dispositivo tipico delle decisioni
interpretative (sentenze numeri 44, 62, 86, 148 e 413). Delle
restanti sentenze, peraltro, molte si sono articolate attraverso una
(re)interpretazione delle disposizioni impugnate, giungendo in tal modo ad
esiti sostanzialmente analoghi a quelli propri di una decisione interpretativa
di rigetto (si segnalano, ex plurimis,
le sentenze numeri 28, 120, 230 e 231).
Nell’ambito delle decisioni di rigetto, merita una
segnalazione la sentenza
n. 155, con la quale
Un (ulteriore) invito al legislatore affinché intervenga al
fine di modificare il diritto positivo è contenuto, invece, nell’ordinanza n. 377, che richiama alcuni precedenti
statuizioni in tema di sanzioni disciplinari pecuniarie a carico dei notai.
11.3. Le decisioni di accoglimento
A] Nel corso del 2004, sono state pronunciate ventitré
sentenze che contengono una o più declaratorie di illegittimità costituzionale.
Di queste, sono soltanto cinque quelle che si pronunciano in senso caducatorio
di una intera disposizione (sentenze numeri 24,
114, 204, 282 e 315). Per
quanto peculiare, appare sostanzialmente riconducibile al genus dell’accoglimento tout
court anche la sentenza n. 147, la quale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 30-bis,
primo comma, del codice di procedura civile, «ad eccezione della parte relativa
alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da
reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all’art. 11 del
codice di procedura penale».
Più numerose sono le decisioni manipolative, e segnatamente
quelle additive, id est quelle che
nel dichiarare l’incostituzionalità di una disposizione «nella parte in cui non
prevede» un determinato contenuto, «aggiungono» ad essa significati normativi
(sentenze numeri 35, 98, 113, 206, 222, 245, 253 e 367). Quasi
equivalenti, sul piano numerico, sono state le decisioni di tipo ablatorio (o
di accoglimento parziale), che cioè dichiarano l’incostituzionalità della
disposizione «nella parte in cui prevede» un certo contenuto (sentenze numeri 135, 186, 223, 334, 335 e 339).
Sono state altresì rese alcune sentenze sostitutive, che
censurano una disposizione «nella parte in cui prevede [un contenuto] anziché
[un altro]» (sentenze numeri 204, 224 e 426); una
decisione sostitutiva leggermente diversa rispetto al modello classico è quella
contenuta nella sentenza
n. 281, nella
quale la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, è stata pronunciata «nella
parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale
materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad
oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento
del danno».
B] Con precipuo riguardo agli effetti nel tempo delle
pronunzie di illegittimità costituzionale, da segnalare, per la sua peculiarità,
è la sentenza n.
426, la quale ha dichiarato l’incostituzionalità
dell’art. 171-octies della legge 22
aprile 1941, n. 633.
Tale articolo è stato introdotto dalla legge n. 248 del 2000;
originariamente, esso puniva con sanzione penale la
condotta di chi, a fini fraudolenti, produceva, poneva in vendita, importava,
promuoveva, installava, modificava, utilizzava per uso pubblico e privato
apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive
ad accesso condizionato, effettuate via etere, via satellite, via cavo, in
forma sia analogica sia digitale. Il successivo decreto legislativo n. 373 del
2000, tuttavia, aveva previsto, limitatamente ai comportamenti attinenti alla
commercializzazione dei dispositivi illeciti, non più la sanzione penale, ma la
sanzione amministrativa, lasciando la sanzione penale per la sola utilizzazione
dei dispositivi.
Questa situazione
di distonia del sistema è poi stata eliminata dalla legge n. 22 del 2003, la
quale ha previsto che ai comportamenti illeciti di cui all’art. 6 del decreto
legislativo n. 373 del 2000 «si applicano altresì le sanzioni penali e le altre
misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli 171-bis
e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni».
È residuata, però,
la situazione di distonia per i fatti commessi sotto la disciplina del decreto
legislativo n. 373 del 2000 (che regola anche i fatti anteriormente puniti dall’art.
171-octies della legge n. 633 del 1941, introdotto dalla legge n. 248
del
C] Per quanto attiene alle dichiarazioni di illegittimità
costituzionale consequenziali rese ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del
1953, consta, nel 2004, una sola decisione:
Su questo specifico aspetto, si rinvia a quanto verrà detto infra, al cap. V, in merito alla sentenza n. 25.
Il giudizio di legittimità
costituzionale in via principale
In sede introduttiva, si è avuto modo di sottolineare l’incremento
del numero di ricorsi in via principale che ha caratterizzato il 2004; ciò che
più appare rilevante, peraltro, è che nelle decisioni sono state trattate
complessivamente oltre 700 questioni di legittimità costituzionale (nella cifra
sono considerate nella loro autonomia le questioni identiche trattate congiuntamente,
come – ad esempio – nelle sentenze numeri
4, 26 e 425, mentre
risultano aggregate le questioni che, seppure poste in atti introduttivi
diversi,
Delle 97 decisioni, 16 sono state rese con ordinanza, e ben
81 con sentenza.
Tra le prime, 2 pronunciano l’estinzione del giudizio per
rinunzia (ordinanze numeri 31 e 243) ed
altrettante la cessazione della materia del contendere a causa della
promulgazione parziale della legge oggetto del giudizio promosso dal
Commissario dello Stato per
Le ordinanze numeri 116, 117, 118 e 119,
invece, dispongono il rinvio della trattazione delle domande di sospensione
dell’atto legislativo impugnato – istituto introdotto dall’art. 9 della legge
n. 131 del 2003 – alla data già fissata per la trattazione del merito.
Delle 97 decisioni del 2004, 51 risultano rese a seguito di
ricorsi regionali, mentre
Nessuna decisione ha avuto ad oggetto questioni costruite su
parametri individuati nel testo del Titolo V della Parte seconda della
Costituzione anteriore alla riforma del 2001.
2. La separazione e la riunione delle
cause
Nel corso dell’anno la giurisprudenza costituzionale ha avuto
modo di consolidare alcune prassi che – sul versante processuale – erano già
emerse nell’anno precedente. In particolare, è stata utilizzata in più
occasioni la tecnica della separazione delle questioni proposte con il medesimo
ricorso e del loro contestuale accorpamento «trasversale» con questioni
omogenee proposte da altri ricorsi.
A tale tecnica
Con questo sistema le pronunce del 2004 hanno deciso
complessivamente 115 ricorsi in via principale, di cui 59 di iniziativa
regionale, 46 di iniziativa statale, 3 del Commissario dello Stato per
La «separazione-riunione» delle questioni è stata utilizzata,
ad esempio, nelle decisioni concernenti le leggi finanziarie per il 2002, per
il 2003 e per il 2004 (si tratta delle sentenze
numeri 1,
3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 36, 37, 49, 201, 236, 260, 307, 308, 320, 345, 353, 381, 390, 423, 424 e 425),
nelle sentenze con le quali sono stati risolti i dubbi di costituzionalità riguardanti
la c.d. «legge
In altri casi – caratterizzati da una struttura più semplice
del contenzioso –
3. La corrispondenza tra delibera e
ricorso
Sul versante della corretta instaurazione del giudizio, si
ribadisce innanzi tutto – con le sentenze
numeri 238
e 286 –
la necessaria corrispondenza tra delibera dell’organo politico e contenuto del
ricorso, almeno per quel che concerne la individuazione delle disposizioni
asseritamente incostituzionali, con conseguente inammissibilità delle censure
proposte avverso le disposizioni non contemplate dalla delibera (sentenze numeri 134 e 425).
Si noti peraltro che nella sentenza n. 286
è stato esplicitamente affermato che la delibera della Giunta regionale
concernente l’impugnazione di una determinata disposizione è idonea a «reggere»
l’impugnazione della disposizione dalla quale essa sia stata successivamente
sostituita, purché essa sia sostanzialmente riproduttiva della prima.
È interessante notare, altresì, come il contenuto della
delibera governativa è individuato dalla Corte, nella sua esatta consistenza,
mediante il riferimento alla relazione del Ministro per gli affari regionali,
che vale a delimitarne il contenuto (cfr., esplicitamente, le sentenze numeri 43,
70 e 134).
L’importanza della delibera, al fine di giudicare della
ammissibilità del ricorso, è determinante. Al riguardo, peraltro, si può notare
come
Va segnalata, infine, anche la sentenza
n. 229, nella quale si esclude che possa valere ad estendere
l’ambito di impugnazione – rispetto a quanto indicato nella delibera – la «comunicazione»
dell’Avvocatura che, secondo il Governo, l’impugnativa dovrebbe ritenersi estesa
a tutto l’impianto della legge.
Quanto ai parametri di costituzionalità invocabili dai
soggetti ricorrenti,
5. L’individuazione del parametro
invocato e la motivazione delle censure
Anche sul versante dell’onere di motivazione delle censure
proposte dai ricorrenti, le decisioni del 2004 offrono numerose conferme. Così,
ad esempio, si ritrova l’affermazione della inammissibilità di censure
costruite sulla mera indicazione del parametro asseritamente violato, senza
offrire alcuna motivazione al riguardo (sentenza n. 7,
ove si evidenzia come il ricorso non individua gli specifici dei profili di
contrasto con il parametro, che rimane semplicemente enunciato, nonché sentenze numeri 196, 198, 376, 416 e 425),
ovvero offrendone una assolutamente generica (sentenza
n. 73, ove si evidenzia la carente individuazione dei
principi fondamentali asseritamente violati in un caso di invocazione dell’art.
117, terzo comma, Cost., nonché sentenze numeri 176,
196, 354 e 424);
con la precisazione, inoltre, secondo la quale il difetto di motivazione non è
sanabile nella memoria presentata nell’imminenza dell’udienza (sentenze numeri 286 e 423).
In senso analogo dispone la sentenza n. 70,
che dichiara l’inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale
relativa a disposizione del tutto estranea «rispetto alle ragioni della pretesa
incostituzionalità fatte valere nell’atto introduttivo» del giudizio. Nella
medesima logica, ancora, si pone la sentenza n. 167,
ove si evidenzia come il «trasferimento del parametro» richiesto dal ricorrente
su una normativa sopravvenuta alla proposizione del ricorso – rispetto alla disciplina
invocata quale parametro interposto e caducata da una dichiarazione di
incostituzionalità nelle more del giudizio costituzionale – lederebbe il
diritto di difesa della parte resistente in quanto quest’ultima non potrebbe
essere gravata dell’onere di verificare per quali profili il parametro
«vecchio» risulti sostanzialmente riprodotto nel parametro «nuovo».
Ancorché succintamente argomentate, comunque, le censure
devono ritenersi ammissibili quando siano chiare e determinate, e non lascino
dubbi sull’oggetto della contestazione (sentenza n. 34;
analogamente, sentenza n. 162).
Viceversa, sono inammissibili le censure formulate «in modo oscuro e perplesso»
(sentenza n. 75).
In conformità a quanto già affermato nella sentenza n. 213 del
2003,
Anche i ricorsi delle Regioni speciali, naturalmente, sono
inammissibili ove invochino norme del nuovo Titolo V senza argomentare circa la
applicabilità, ex art. 10 legge cost. n. 3 del 2001, di tali
disposizioni (sentenza
n. 424). A ciò fa eccezione il parametro
costituito dal quinto comma dell’art. 117 Cost., il quale fa esplicito riferimento
– tra i suoi destinatari – anche alle Regioni speciali (sentenza
n. 239).
6. L’individuazione dell’oggetto
La adeguata motivazione deve sorreggere, naturalmente, non
solo i parametri, ma anche la individuazione delle disposizioni che il ricorrente
intende censurare. Quando il corpus normativo individuato quale oggetto
del giudizio sia costituito da più disposizioni dal contenuto eterogeneo, le censure
devono essere pertinenti a ciascuna delle disposizioni in questione a pena di
inammissibilità (cfr., ad esempio, la sentenza n. 320).
Al riguardo, è significativa anche la sentenza
n. 162, nella quale tale «interpretazione» del ricorso viene
compiuta «anche in base alla delibera del Consiglio dei ministri». In senso
analogo si collocano altresì le sentenze
numeri 112
e 134.
7. L’impugnazione dell’intera legge
Rimane in linea di massima inammissibile l’impugnazione di un’intera
legge, anche se talvolta – come appena richiamato –
In relazione a tale profilo, è particolarmente significativa
soprattutto la sentenza
n. 196, nella quale si afferma
la legittimazione delle Regioni – sotto il profilo dell’interesse al ricorso –
a far valere le competenze degli enti locali nei giudizi avverso le leggi dello
Stato.
La mancanza di interesse al ricorso è inoltre alla base della
decisione di manifesta inammissibilità adottata con la sentenza
n. 17, nella quale si afferma che «non può essere configurata
alcuna lesione della sfera di competenza regionale, in quanto trattasi di
disciplina di imposte esclusivamente statali». Analogamente – nel senso della
carenza di interesse – dispongono le sentenze
numeri 228
e 236
(la quale ultima si fonda sulla rilevata carenza di attualità dell’interesse),
nonché la sentenza n. 414,
nella quale
In un caso in cui la norma impugnata aveva ricevuto
definitiva attuazione attraverso la adozione di due decreti ministeriali,
supportati dal parere unanime dei rappresentanti delle Regioni, compresa la
ricorrente, con conseguente venir meno dell’interesse ad una pronunzia di
accoglimento,
Quanto al termine per l’impugnazione di una legge in via
diretta, può essere segnalato come in più di una decisione
Sempre a proposito della perentorietà del termine del
ricorso, l’ordinanza n. 42
ribadisce l’inapplicabilità al giudizio costituzionale dell’istituto della
sospensione feriale dei termini.
10. La notifica ed il deposito del
ricorso
Anche nell’anno 2004
11. L’intervento di terzi in giudizio
In più di un’occasione
12. La sospensiva nel giudizio sulle
leggi
Nei giudizi aventi ad oggetto la disciplina del «condono
edilizio»,
Sia alcune Regioni che ricorrevano contro la disciplina
statale, sia lo Stato che aveva impugnato alcune leggi regionali hanno avanzato
formali istanze di applicazione del citato art. 35 della legge n. 87 del 1953.
Tuttavia, nell’imminenza della camera di consiglio del 24 marzo, fissata per la
decisione su tali richieste di sospensione, l’Avvocatura dello Stato ha depositato
un atto con il quale, «in considerazione […] della prossimità dell’udienza
stabilita per la trattazione del merito dei ricorsi» (11 maggio), il Presidente
del Consiglio dei ministri rinunciava «alla immediata decisione» circa i
richiesti provvedimenti cautelari; le Regioni, dal canto loro, sulla base della
rinuncia statale, aderivano alla richiesta di differimento della trattazione
«delle istanze cautelari auspicata dall’Avvocatura contestualmente alla propria
rinuncia».
A causa della intervenuta decisione di merito,
13.1. Le sentenze «interpretative»
Anche nel corso del 2004
In questo schema si inquadrano senza dubbio le sentenze
numeri 3,
4, 13, 238, 345, 353 e 423, che
recano nel dispositivo la decisione di non fondatezza «nei sensi di cui in
motivazione».
Interpretativa è anche la sentenza n. 280, che affronta le questioni concernenti
i commi 4, 5 e 6 dell’art. della legge n. 131 del 2003, meglio nota come «legge
A fianco di tali sentenze meritano inoltre di essere
richiamate alcune decisioni nelle quali la decisione di infondatezza è sorretta
non già da una differente interpretazione della disposizione impugnata, ma da
una più adeguata – o più completa – ricostruzione del quadro normativo
complessivamente inteso rispetto a quella su cui era basato il ricorso. Al
riguardo, si vedano le sentenze numeri 7, 8 (dove si fa
riferimento all’interpretazione sistematica) e 172.
Può essere richiamata, infine, la sentenza n. 6,
nella quale la decisione di infondatezza è basata – tra l’altro – sulla
considerazione secondo la quale l’intesa menzionata dalla normativa impugnata
«va considerata come un’intesa “forte”, nel senso che il suo mancato raggiungimento
costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento». Tale
interpretazione, come nota la stessa sentenza n. 6, era avallata anche dall’Avvocatura
dello Stato.
13.2. Le sentenze «manipolative»
Non sono mancate, nel corso dell’ultimo anno, neppure le
sentenze c.d. «manipolative».
Le sentenze numeri 13, 196 e 308 possono essere inquadrate come contenenti
decisioni «additive». Nella sentenza n. 196, in particolare,
Alcune sentenze contengono invece dispositivi «riduttivi» (o
«ablativi»). Tra queste, si segnalano: la sentenza n. 196, a proposito della
illegittimità costituzionale dell’Allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003;
la sentenza n. 380,
che dichiara l’incostituzionalità di una disposizione «nella parte in cui» si
applica a determinate fattispecie; la sentenza n. 423, che individua specificamente
le parti della disposizione da colpire mediante le formule «limitatamente alle
parole», «limitatamente all’inciso»; la sentenza n. 390
mediante la dicitura «limitatamente alla parte in cui dispone che […]».
Nella già menzionata sentenza n. 196,
inoltre, sono presenti alcuni dispositivi qualificabili come «sostitutivi».
13.3. Le altre tecniche decisorie
La sentenza n. 43 si segnala perché
individua nella disposizione impugnata una «incompletezza» rispetto a quello
che dovrebbe essere lo standard costituzionalmente prescritto; la
decisione, tuttavia, è nel senso della infondatezza, evidenziandosi che «la
rilevata incompletezza non [è] tale da inficiare la legittimità costituzionale
della norma medesima», e che il suo «completamento» deve essere ritenuto
condizione di applicabilità della norma stessa.
La sentenza n. 196
dichiara la illegittimità costituzionale di numerose disposizioni, nella parte
in cui non assegnano alle Regioni un ruolo nel «completamento» della normativa
medesima, intervenendo direttamente con disposizioni di dettaglio. Nel testo
della decisione, tuttavia, si evidenzia che, ove le Regioni non provvedessero a
compiere le proprie scelte normative entro un termine stabilito dallo Stato, ma
comunque «congruo», dovrebbero ritenersi applicabili le norme statali anche
nelle parti dichiarate incostituzionali.
La sentenza n. 255
è nel senso della infondatezza. Tuttavia, dal testo della decisione emerge che
la normativa impugnata appare sostanzialmente incompatibile con l’assetto costituzionale
risultante dalla riforma del 2001, e che la sua «salvezza» dipende esclusivamente
dal suo carattere di temporaneità.
14. Le pronunzie di illegittimità
costituzionale consequenziale
Anche nel corso del
In particolare, ciò è avvenuto nella sentenza
n. 166, nell’ambito della quale la consequenzialità deriva
dalla strumentalità delle norme colpite ex art. 27 rispetto a quelle
dichiarate incostituzionali in accoglimento del ricorso, nonché nella sentenza n. 272.
Si vedano, inoltre, le sentenze numeri 2 e 378 (infra, par. 19).
15. Lo «statuto» della «cessazione
della materia del contendere» per ius superveniens
L’ordinanza n. 137
individua in modo esplicito i passaggi argomentativi necessari a dichiarare la
cessazione della materia del contendere a seguito di sopravvenienze normative
intervenute nel corso del giudizio. A tal fine, per prima cosa, deve valutarsi
se la normativa in questione sia effettivamente «sopravvenuta», in quanto pertinente
rispetto all’oggetto del giudizio.
In secondo luogo, è necessario verificare se lo ius
superveniens sia caratterizzato da una effettiva innovatività, ovvero se
«dalla disposizione legislativa sopravvenuta [sia] desumibile una norma
sostanzialmente coincidente con quella impugnata nel ricorso». In tal caso «la
questione – in forza del principio di effettività della tutela costituzionale
delle parti nei giudizi in via d’azione – dovrebbe essere trasferita sulla
nuova norma».
In terzo luogo, si deve accertare «il carattere satisfattivo
o meno» dello ius superveniens «rispetto
alle censure fatte valere nell’atto introduttivo del giudizio».
Tuttavia, anche nel caso in cui le pretese della parte ricorrente
risultino soddisfatte dalla modifica normativa, affinché possa addivenirsi ad
una dichiarazione di cessazione della materia del contendere sarà necessario
verificare se la disposizione oggetto del giudizio «abbia ricevuto una qualche
attuazione medio tempore». Ciò in quanto, ove così fosse, permarrebbe l’interesse
al ricorso e
Allorché si verifichino le suddette condizioni, può essere
dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che risulta
venuta meno «la necessità di una pronunzia della Corte».
Al di fuori dei casi in cui la mancata attuazione della
disposizione impugnata emerga con chiarezza (si pensi ad esempio alla sentenza n. 12), per l’accertamento di tale circostanza,
nell’ordinanza n. 203
vengono utilizzate ad esempio le dichiarazioni provenienti da soggetti
qualificati (quali il Difensore civico della Regione Abruzzo, evidenziando come
la valutazione di quest’ultimo sia «condivisa dalla stessa ricorrente»).
Nell’ordinanza n. 274
si dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge n. 448 del
Ancora nel senso della (parziale) cessazione della materia
del contendere, per effetto di sopravvenienze normative sostanzialmente
satisfattive delle pretese del ricorrente, sono le sentenze numeri 8, 15, 17, 36, 196, 345 e 424.
Per due casi di trasferimento della questione sulla nuova
norma, in quanto sostanzialmente riproduttiva o comunque non modificativa del
contenuto della disposizione censurata, si segnalano le sentenze numeri 286 e 431.
La sopravvenienza normativa in corso di giudizio fonda anche
la dichiarazione di cessata materia del contendere dell’ordinanza n. 432, nella quale
Da segnalare, infine, è la sentenza n. 14,
nella quale
Anche nel corso dell’anno 2004 non mancano alcune decisioni
con le quali
L’ordinanza n. 31
pronuncia l’estinzione del giudizio. Della vicenda sottesa a tale provvedimento
possono essere evidenziate le seguenti particolarità.
Innanzi tutto che – da un punto di vista sostanziale – la
rinunzia al ricorso da parte dello Stato è basata su una nota proveniente dal
Presidente della Regione che fornisce, secondo quanto affermato nello stesso
atto di rinuncia, «un’adeguata interpretazione della norma che sembra poter far
superare l’eccezioni sollevate dal Governo».
In secondo luogo, che il deposito dell’atto di rinuncia,
successivo allo svolgersi dell’udienza pubblica, precede di ben sei mesi il
deposito dell’atto formale di accettazione da parte della Regione.
Altre decisioni che pronunciano l’estinzione per rinunzia
sono l’ordinanza
n. 243 e le sentenze numeri 390 e 424.
Merita infine di essere richiamata la sentenza
n. 134, nella quale si evidenzia come il potere di rinunziare
al ricorso sia attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri, e non ai
singoli ministri.
Con la sentenza n. 74
La sentenza n. 167,
invece, dichiara la inammissibilità della questione a causa del venir meno, in
seguito ad una precedente sentenza di illegittimità costituzionale, dei
principi fondamentali della materia invocati come parametro interposto a
sostegno della presunta violazione della competenza statale in materia di
potestà legislativa concorrente. Né può valere ad evitare tale esito il
sopravvenire di una nuova normativa, sostanzialmente riproduttiva delle norme
abrogate, in quanto nessuna continuità normativa può ritenersi sussistente tra
le due fonti, poiché con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle
precedente disciplina, questa viene rimossa con effetto ex tunc, ciò che
impedisce di operare qualunque «saldatura» tra le due fonti.
Nella sentenza n. 286
19. Il giudizio ex art. 123, secondo
comma, della Costituzione
Con le quattro sentenze numeri 2, 372, 378 e 379,
Nella sentenza n. 378,
chiamata a decidere anche sul ricorso presentato da un Consigliere regionale di
minoranza avverso la delibera statutaria della Regione Umbria,
Conseguenza naturale della inammissibilità del ricorso e dell’intervento
del Consigliere regionale è poi la inconoscibilità, da parte della Corte, delle
censure e delle deduzioni ivi prospettate (in particolare, era stato sollevato
un vizio di conformità della seconda deliberazione statutaria rispetto alla
prima non rilevato nell’impugnazione governativa); l’oggetto del giudizio in
via diretta in ordine alla legittimità costituzionale delle delibere statutarie
resta imprescindibilmente fissato nel ricorso introduttivo del Governo. Al
riguardo, però, vale anche qui il potere della Corte, ampiamente utilizzato nel
giudizio sugli atti legislativi, di valutare le motivazioni addotte nel ricorso
al fine di «delimitare» l’oggetto delle censure; ed è così che, in qualche
caso, censure rivolte genericamente a disposizioni nel loro complesso, vengono
circoscritte solo ad alcuni commi escludendone altri (sentenza n. 2).
Sempre sul piano dell’oggetto del giudizio,
Una particolare ragione di inammissibilità di alcune
questioni proposte nei ricorsi governativi è stata affermata nelle sentenze
numeri 372,
378 e
379,
dove
Quanto agli esiti di questo tipo di giudizi, va segnalato l’uso
non infrequente che
Il giudizio per conflitto di
attribuzione
tra Stato e Regioni e tra Regioni
Delle 18 pronunzie rese, nel corso del 2004, nei giudizi sui
conflitti di attribuzioni intersoggettivi, solo 4 sono state rese nella forma
dell’ordinanza, a fronte di 14 sentenze; quale diciannovesima pronunzia deve
citarsi l’ordinanza
n. 195, che ha deciso una
domanda di sospensione dell’atto impugnato. Tra le 4 ordinanze, 3 pronunciano
la cessazione della materia del contendere (si tratta delle ordinanze numeri 21, 160 e 244),
mentre l’ultima (l’ordinanza n. 319) dichiara l’estinzione del
giudizio.
Nel 2004 si conferma il trend già rilevato negli anni
precedenti, secondo il quale il giudizio su conflitti intersoggettivi è
originato soprattutto da ricorsi delle Regioni o delle Province autonome. In
particolare, sono solo 3 le decisioni originate da ricorsi statali (si tratta
dell’ordinanza
n. 160 e delle sentenze numeri 199 e 258).
Delle 18 decisioni, 7 risolvono conflitti originati da atti
adottati nella vigenza del vecchio parametro di costituzionalità (sentenze
numeri 27, 103, 179, 273, 283, 288, ed ordinanza n. 244), mentre le restanti
concernono ricorsi proposti dopo la modifica costituzionale del 2001.
Viene ribadita anche nel corso del 2004 l’inapplicabilità
dell’istituto dell’acquiescenza al giudizio per conflitto di attribuzioni tra
Stato e Regioni, e ciò a causa della indisponibilità delle competenze delle
quali si controverte. Tali affermazioni, in particolare, si trovano nell’ordinanza n. 195, con la quale si decide circa
la richiesta di sospensione dell’atto impugnato.
In quella sede
Nella medesima decisione, peraltro, si conferma che, ai fini
della valutazione della tempestività del ricorso, la avvenuta conoscenza dell’atto
impugnato viene in considerazione solo quale criterio sussidiario, quando manchino
la pubblicazione o la notificazione (che la legge assume, agli effetti che qui
interessano, come equipollenti), di talché il termine per la proposizione del
ricorso per conflitto di attribuzione avverso un atto del quale sia prescritta
la pubblicazione come condizione di efficacia, deve in ogni caso essere
individuato avendo riferimento alla data della medesima.
Nella sentenza n. 9 viene inoltre ribadita la
inammissibilità di censure proposte, nel contesto del conflitto
intersoggettivo, avendo come riferimento parametri differenti da quelli
concernenti il riparto di competenze. Nel caso di specie si trattava degli
artt. 3 e 97 Cost.
Nel senso dell’inammissibilità è anche la sentenza n. 258, in ragione del riferimento a
parametri costituzionali individuati nel nuovo Titolo V Cost., per le Regioni
speciali, senza alcuna argomentazione riferita all’applicazione dell’art. 10
della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Quanto ai soggetti ricorrenti, non è individuabile alcuna
particolare novità nel corso del 2004.
In relazione alla individuazione degli atti idonei a far
sorgere conflitto di attribuzioni, nel 2004
Un cenno particolare merita inoltre la sentenza n. 129, con la
quale
Se da un punto di vista formale non sussistono particolari
restrizioni all’ammissibilità dei conflitti, determinante risulta invece la
valutazione della idoneità dell’atto ad arrecare effettivamente una lesione
alla sfera di competenza del ricorrente.
Da questo punto di vista, non sono mancate anche nel 2004 le
decisioni di inammissibilità. Ad esempio, la sentenza n. 288 – concernente una Convenzione per l’esercizio 2001 stipulata tra il
Ministro delle finanze e l’Agenzia delle entrate, nonché una nota dell’Agenzia
delle entrate – ritiene
tali atti non idonei «a produrre lesione della sfera di
competenza costituzionale della ricorrente», in quanto vi si disciplinano «i
rapporti tra il Ministro e l’Agenzia, senza alcun riferimento alle competenze regionali»,
né contengono «alcun profilo che in qualche modo possa dar luogo ad una compressione
dei poteri regionali in materia di riscossione dei tributi».
Da questo punto di vista, è significativa anche la sentenza n. 199, nella quale invece si ritiene
ammissibile il conflitto proposto avverso la delibera della Giunta regionale
della Campania che disponeva che «al fine di salvaguardare l’identità e l’integrità
del territorio regionale, non è ammessa la sanatoria delle opere edilizie
realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi, ovvero in difformità o
con variazioni essenziali rispetto a questi ultimi, e che siano in contrasto
con gli strumenti urbanistici generali vigenti», evidenziando come tale atto
«contiene addirittura un rifiuto di riconoscere efficacia ad un’intera
normativa statale, pur disponendo
Sempre nel solco della giurisprudenza ormai consolidata si
colloca l’affermazione della inammissibilità di ricorsi che si sostanzino in
una mera vindicatio rei, in quanto privi del necessario «tono
costituzionale», non lamentandosi con essi la lesione di alcuna sfera di
competenze costituzionalmente garantita (sentenza n. 179).
4. La definizione del giudizio
Delle 18 decisioni adottate, solo 7 sono nel senso dell’accoglimento
del ricorso (sentenze numeri 27, 129, 177, 199, 233, 283 e 306), o
contengono comunque (tra gli altri) dispositivi di accoglimento (sentenza n. 258).
In 4 casi si pronuncia la cessazione della materia del contendere (ordinanze numeri
21, 160 e 244 e sentenza n. 256), mentre in un solo caso si
pronuncia la estinzione del processo per rinunzia (ordinanza n. 319).
Nel caso dell’ordinanza n. 160, la cessazione è derivata dal
formarsi del giudicato amministrativo sull’atto impugnato, confermando in tal
modo la possibilità di una concreta sovrapposizione tra giudizio costituzionale
e giudizio amministrativo.
La sentenza n. 256
pronunzia la cessazione della materia del contendere, invece, in quanto i
regolamenti impugnati «hanno dato luogo a provvedimenti attuativi di erogazione
per l’anno 2003» che non possono essere posti nel nulla poiché ciò
determinerebbe «il sacrificio di valori che non solo sono evocati dalle
suddette norme costituzionali, ma che permeano di sé la prima parte della Costituzione».
Di qui, secondo la citata sentenza, la carenza di interesse della Regione.
La sentenza n. 273 è invece nel senso della
inammissibilità per erroneità del presupposto interpretativo, e ciò in quanto l’atto
impugnato è ritenuto dalla Corte applicabile nei confronti della Provincia
autonoma di Trento ricorrente, solo per quanto concerne l’obiettivo in esso
stabilito.
Viene confermata poi – in ragione della identità della
posizione costituzionale delle Province autonome di Trento e Bolzano – l’estensione
delle decisioni di accoglimento dei ricorsi dell’una nei confronti dell’altra (sentenza n. 283).
Il giudizio per conflitto di
attribuzione
1. Considerazioni introduttive
Come negli anni precedenti, anche nel 2004 la maggior parte
dei ricorsi esaminati dalla Corte in sede di conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato è rappresentata da quelli promossi dall’autorità giudiziaria
(ben 36 i casi, pari all’87,8% del totale dei conflitti) ed hanno avuto ad
oggetto il modo in cui i singoli rami del Parlamento (in 14 casi il Senato ed
in 22
A tale proposito, se si escludono le 28 occasioni in cui tale
problema è stato affrontato nella fase preliminare del giudizio sull’ammissibilità
del conflitto (fase in cui, notoriamente, non viene preso in esame il merito
della controversia), nei restanti 8 casi
I cinque giudizi che non hanno avuto ad oggetto il tema dell’insindacabilità
delle opinioni espresse dai membri del Parlamento nell’esercizio delle loro
funzioni hanno invece riguardato, rispettivamente, la problematica dell’inviolabilità
della residenza e del domicilio del parlamentare, come garantita dall’art. 68,
secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 58), la prerogativa
della irresponsabilità presidenziale sancita dall’art. 90 della Costituzione (sentenza n. 154), la mancanza di
legittimazione dei singoli ministri ad essere parte di un conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato (ordinanza n. 221), il bilanciamento
dell’interesse allo svolgimento del processo con l’interesse della Camera alla
partecipazione del suo componente ai lavori parlamentari (sentenza n. 284), i limiti oggettivi
di ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dai
promotori dei referendum abrogativi (ordinanza n. 384).
Nel corso del 2004 due sono le pronunce che appaiono
maggiormente significative per il profilo che qui interessa: la prima afferma
la legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione dell’ex Capo dello Stato; la seconda,
viceversa, nega tale legittimazione in capo ai singoli ministri.
In particolare, nel caso di un giudizio per conflitto tra
poteri dello Stato avente ad oggetto pronunce dell’autorità giudiziaria
asseritamente lesive della prerogativa della irresponsabilità del Presidente
della Repubblica, come garantita dall’art. 90 della Costituzione,
Sempre sotto il profilo della legittimazione soggettiva a
sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
Sotto il profilo oggettivo, di particolare interesse appaiono
le pronunce che hanno avuto ad oggetto conflitti insorti tra poteri dello Stato
in relazione a provvedimenti di natura giurisdizionale.
A tale proposito,
Sono stati ribaditi, infine, attraverso il richiamo all’ordinanza n. 195
del 2003, i confini entro cui sono circoscritti gli interessi tutelabili
dai comitati promotori dei referendum abrogativi attraverso lo strumento
del conflitto (ordinanza
n. 384).
Per quanto riguarda i problemi di natura processuale
affrontati dalla Corte nel corso dell’anno passato, se ne segnalano, in
particolare: taluni attinenti al tempus
ed alle modalità di proposizione del conflitto (mancanza di un dies ad quem
per proporre ricorso, inammissibilità di un conflitto già dichiarato
inammissibile e/o improcedibile, tardività del deposito del ricorso dovuta a
disservizi postali e all’inerzia dell’ufficiale giudiziario); altri relativi al
rapporto intercorrente tra i giudizi in corso e la legge n. 140 del 2003,
recante disposizioni di attuazione dell’art. 68 della Costituzione; e,
soprattutto, alcuni relativi all’ammissibilità dell’intervento di terzi nei giudizi
su conflitti di attribuzione tra poteri.
Il primo ordine di problemi di natura processuale ha trovato
composizione principalmente attraverso il richiamo a quanto già affermato nella
sentenza n. 116 del 2003.
In particolare,
Passando ora alle problematiche sollevate dalla tardività del
deposito del ricorso, giova ricordare che, al temine del giudizio preliminare
di ammissibilità di un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato (c.d. giudizio di ammissibilità),
L’elemento di maggior interesse è dato, peraltro, dal fatto
che
Va aggiunto, concludendo sul punto, che a seguito delle
modifiche apportate alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale con deliberazione della Corte costituzionale del 10 giugno 2004,
pubblicata sulla G.U. n. 151 del 30 giugno 2004, l’art. 30 delle norme
integrative prevede ora la possibilità di effettuare il deposito dei ricorsi
avvalendosi del servizio postale.
Chiamata poi a valutare gli effetti – nelle more del giudizio
su conflitto di attribuzione in materia di insindacabilità – della
sopravvenienza della legge n. 140 del 2003, recante disposizioni di attuazione
dell’art. 68 della Costituzione,
Certamente da segnalare è, infine, la sentenza n. 154 che, in un conflitto
tra poteri insorto tra l’ex Presidente della Repubblica e l’autorità
giudiziaria in relazione a due provvedimenti giurisdizionali asseritamente
lesivi delle prerogative di insindacabilità garantite al Capo dello Stato dall’art.
90 Costituzione, richiamandosi al precedente costituito dalla sentenza n. 76
del 2001 (resa in sede di conflitto intersoggettivo), ha dichiarato ammissibili
gli interventi spiegati dalle parti attrici nei giudizi civili in cui sono
state rese le sentenze impugnate, affermando che «negare ingresso alla difesa
delle parti del giudizio comune, in cui si controverte sull’applicazione della
immunità, significherebbe esporre tali soggetti all’eventualità di dover
subire, senza possibilità di far valere le proprie ragioni, una pronuncia il
cui effetto potrebbe essere quello di precludere definitivamente la
proponibilità dell’azione promossa davanti alla giurisdizione», ciò che «contrasterebbe
con la garanzia costituzionale del diritto al giudice e ad un pieno contraddittorio,
che discende dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, ed è protetto altresì
dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, come applicato dalla giurisprudenza della Corte europea
di Strasburgo».
Il giudizio di ammissibilità delle
richieste
di referendum abrogativo
1. Referendum per l’abrogazione di
norme di legge riguardanti le alte cariche dello Stato
Nel 2004,
Nel momento in cui veniva decisa l’ammissibilità della
richiesta referendaria, l’art. 1 della legge n. 140 del 2003 era, peraltro, già
stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 24. Nella sentenza n. 25 si aveva dunque cura di
precisare che «la competenza a valutare, alla luce dell’art. 136 della
Costituzione, gli effetti del sopravvenire [della] pronunzia [di
incostituzionalità] all’ordinanza con cui l’Ufficio centrale ha dichiarato la legittimità
del quesito referendario, non appartiene a questa Corte, essendo estranea all’oggetto
del giudizio affidatole dall’art. 75 della Costituzione, come individuato dalla
giurisprudenza costituzionale».
Principi e diritti fondamentali
1. I principi di eguaglianza e
ragionevolezza
Il ruolo di preminenza che da sempre assume nei giudizi di
tipo incidentale il parametro di cui all’art. 3 della Costituzione è attestato
dal numero di questioni sollevate davanti alla Corte che ad esso fanno diretto
riferimento (si pensi che nel 2004, su 286 giudizi in via incidentale, ben 241,
pari all’84,2 % del totale, annoveravano l’art. 3 tra i parametri invocati dai
giudici a quibus).
In questa sede saranno prese in esame solamente alcune tra le
numerosissime pronunce che hanno vagliato le più diverse questioni di
legittimità costituzionale sotto il profilo della pretesa lesione del parametro
in parola.
E ciò per l’ovvia considerazione che in numerose ipotesi la
norma o le norme sospettate di illegittimità costituzionale erano sottoposte
allo scrutinio della Corte sotto diversi profili, coinvolgenti diverse norme
del dettato costituzionale, per cui l’esame di tali pronunce, benché condotto dalla
Corte anche alla stregua dell’art. 3 della Costituzione, troverà spazio nei successivi
paragrafi.
Di conseguenza, le decisioni cui si farà ora accenno non
esauriscono di certo i casi in cui
Ciò premesso, va ricordato come dal principio di eguaglianza,
a seguito delle storiche decisioni n. 15 del 1960 e n. 10 del 1980, vengano
tradizionalmente tratti due diversi moduli di giudizio: quello di parità
(ovvero di eguaglianza in senso stretto) e quello di ragionevolezza.
1.2. Il principio di eguaglianza
Benché le decisioni della Corte assumano spesso a pari titolo
entrambi i moduli, il giudizio di parità si distingue da quello di
ragionevolezza per le sue caratteristiche formali, trattandosi di confrontare
tra loro due o più situazioni o discipline sostanzialmente indicate come
omogenee dal giudice a quo (il termine di raffronto viene definito come tertium
comparationis), onde censurarne la difformità di trattamento, se
considerata priva di ragionevole giustificazione.
In particolare, la regola di giudizio seguita dalla Corte in
tali ipotesi può riassumersi nel seguente enunciato: «si ha violazione dell’art.
3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano
disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale
contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non
sostanzialmente identiche, essendo insindacabile in tali casi la
discrezionalità del legislatore» (sentenza n. 340).
In prevalenza, la ragione che induce
Per cui, a titolo di esempio, non sono costituzionalmente
illegittime per violazione dell’art. 3 della Costituzione:
- (a) la norma della legge n. 47 del 1985 (art. 18)
che prevede una disciplina di maggiore rigore, quanto al regime delle nullità
sanabili, per il trasferimento dei terreni, rispetto a quanto previsto per il
trasferimento di edifici (artt. 17 e 40), posto che tali norme sono «ispirate
ad un diverso sistema di accertamento e di contrasto all’abusivismo», per cui
la «diversità della regolamentazione non appare […] né illogica né irragionevole,
attesa la differenza strutturale degli illeciti urbanistici riguardanti gli
edifici da un lato, per i quali l’abuso è già stato perpetrato al momento dell’attività
negoziale,» e «i terreni dall’altro, per i quali l’abuso è in via di consumazione
per effetto di trasferimenti parziali» (sentenza n. 38);
- (b) la disciplina della sospensione delle procedure
di sfratto recata dall’art. 80, comma 20, della legge n. 388 del 2000, rispetto
a quella dettata dall’art. 6, comma 5, della legge 431 del 1998, sotto il
particolare profilo della diversa configurazione normativa dei requisiti
richiesti all’inquilino per potere usufruire della sospensione stessa, stante
la diversa natura e finalità delle due norme, essendo ispirata la seconda «al
sistema della graduazione, con conseguente previsione di un potere discrezionale
del giudice dell’esecuzione quanto alla fissazione del momento del rilascio
entro un termine determinato nel massimo dalla legge, laddove la prima norma –
prevedendo la sospensione automatica delle procedure per il tempo fissato dalla
legge – risponde alla logica propria del (nominalmente) cessato regime c.d.
vincolistico» (sentenza
n. 62);
- (c) la norma che non consente al traente di un
assegno bancario protestato, che abbia pagato capitale, interessi, penale e
spese nel termine di cui all’art. 8 della legge n. 386 del 1990, di ottenere la
cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, a
differenza di quanto invece previsto a favore di colui nei cui confronti sia
stato levato protesto per mancato pagamento di una cambiale o di un vaglia
cambiario, posto che la «peculiare natura di mezzo di pagamento conservata dall’assegno
giustifica la diversa disciplina che, quanto alle conseguenze del protesto, il
legislatore ha dettato rispetto alla cambiale» (ordinanza n. 84);
- (d) la disciplina di maggior favore recata da una
norma transitoria in materia di concessione di benefici penitenziari rispetto a
quanto previsto nel quadro di analoga disciplina dettata anni prima, stante «la
non omogeneità degli interventi legislativi» considerati dal rimettente, che
rende «non comparabili i due testi normativi sotto il profilo dell’art. 3
Cost., e rivela l’incongruità della pretesa del rimettente di estendere la
disciplina intertemporale introdotta dalla norma censurata a un decreto-legge risalente
ad oltre un decennio» (ordinanza n. 108);
- (e) la norma che, nel quadro del riordino delle
graduatorie permanenti degli abilitati all’insegnamento di cui al decreto-legge
n. 255 del 2001, faceva salve le già conferite nomine in ruolo dei docenti che,
in mancanza di detta nomina, non sarebbero più stati in posizione utile ai fini
delle nomine stesse, posto che «ben diversa consistenza sono le ragioni che
giustificano la salvaguardia di una situazione (l’acquisizione di un posto di
ruolo) caratterizzata nella attualità dal diritto alla sua permanenza – jus
in officio – rispetto a quelle che possono essere addotte per rivendicare
la conservazione di una posizione per sua natura virtuale (collocamento in una
graduatoria)» (sentenza
n. 168);
- (f) la differente disciplina normativa recata dalla
legge n. 124 del 1999 per i docenti delle accademie e dei conservatori, da un
lato, e i docenti aspiranti ad insegnamenti nella scuola secondaria e media,
dall’altro, quanto ai requisiti richiesti per l’inserimento nelle graduatorie
nazionali permanenti, previste dal decreto legislativo n. 297 del
- (g) la norma che prevede l’esonero dal divieto di
cumulo della pensione di anzianità con la retribuzione per i soli dipendenti
delle Comunità europee in servizio all’estero e non anche per quelli in
servizio in Italia, alla luce del fatto che non sussiste «la denunciata lesione
del principio di eguaglianza, ove si consideri che la categoria dei lavoratori
dipendenti in servizio fuori del territorio nazionale non è, in via generale,
omogenea a quella dei lavoratori in servizio in Italia, per l’evidente maggior
disagio, anche economico, che il trasferimento all’estero comporta, cosicché
non può dirsi manifestamente irragionevole la scelta legislativa di derogare
solo per gli uni, e non per gli altri, al generale principio del divieto di
cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione» (ordinanza n. 346).
Va tuttavia precisato che talvolta
Così, a proposito della comparabilità o meno della situazione
di convivenza more uxorio a quella originata da un legame matrimoniale
Sempre nella richiamata ottica dell’esistenza di differenti
prospettive da cui si può muovere nel valutare la legittimità o meno della
disparità/parità di trattamento tra diverse discipline o situazioni,
Essa, inoltre, avendo rilevato, da un lato, una «una
illegittima disparità di trattamento fra figli legittimi e figli naturali
riconosciuti ed in pregiudizio dei secondi, in quanto le ragioni di indole
morale e patrimoniale, che consentono ai primi di opporsi all’adozione, valgono
anche per i figli naturali», ed avendo altresì escluso, dall’altro lato, che
«nella situazione presa in esame [siano] ipotizzabili profili di
incompatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima che
giustifichino un trattamento normativo differenziato», ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 291 del codice civile nella parte in cui non prevede
che l’adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli
naturali, riconosciuti dall’adottante, minorenni o, se maggiorenni, non
consenzienti (sentenza
n. 245).
In ultimo, va aggiunto che l’eccezionalità di una dettato
normativo costituisce di norma ragione sufficiente per escludere che ad esso
possano fare riferimento i giudici a quibus come tertium comparationis,
con la conseguenza che «la normativa inerente alle sessioni riservate di esami
di idoneità o abilitazione all’insegnamento ha carattere eccezionale e di
favore e quindi le singole disposizioni non possono essere estese al di là dei
casi espressamente previsti a meno che le esclusioni che ne conseguono siano
prive di giustificazione, e perciò irragionevoli» (sentenza n. 136).
Tuttavia, nonostante la natura derogatoria del sistema delle
cause di prelazione rispetto al principio della par condicio creditorum,
1.3. Il principio di ragionevolezza
Il principio di ragionevolezza viene tradizionalmente inteso
nella specifica accezione di ragionevolezza-razionalità. E sotto tale profilo
il controllo della Corte costituzionale verte non sulle scelte operate dal
legislatore, quanto sulla ragionevolezza delle medesime, con la conseguente
possibilità di verificare che la decisione assunta dal legislatore di
differenziare o parificare determinate fattispecie astrattamente configurate
non sia espressione di mero arbitrio ma abbia dietro di sé una ragione giustificatrice
coerente con l’intrinseca causa legis.
Un caso in cui
In tale occasione
Pertanto, avendo «il legislatore […] dato alla nuova
disciplina, per questa parte, un contenuto quasi “provvedimentale”, di proroga
di un precedente regime, esso non poteva, senza incorrere in un vizio di
manifesta irragionevolezza, ignorare i connotati concreti della situazione nella
quale interveniva»; in particolare, non poteva ignorare «la circostanza che vi
era una sessione di esami ancora parzialmente in corso in quel momento, e che
quindi lo “sbarramento” temporale rigido che si intendeva introdurre avrebbe
prodotto una discriminazione ingiustificata fra coloro che avevano o avrebbero
sostenuto lo stesso esame, nella stessa sessione annuale, prima o dopo la data
indicata, in base alla casuale durata delle prove».
Conclude pertanto
Fanno sempre applicazione del canone della ragionevolezza le
sentenze numero 135 e 339 che, in
materia di edilizia residenziale pubblica, hanno dichiarato l’illegittimità
costituzionale delle disposizioni di altrettante leggi regionali che
individuavano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell’assegnazione
dell’alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di
locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. Invero, «l’irragionevolezza
di tale scelta legislativa risiede nel fatto che il valore locativo così
configurato non può oggi costituire un adeguato parametro di valutazione del cespite
immobiliare, di cui sia titolare l’interessato (sentenza n. 299 del 2000), dopo
che l’abrogazione dell’art. 12 della citata legge n. 392, che stabiliva le
diverse basi di calcolo del valore locativo, ai fini dell’equo canone per le
locazioni abitative, ha sostanzialmente privato di significato i precedenti
indici convenzionali e coefficienti correttivi di valutazione su cui appunto
tale valore si basava. Il regime delle locazioni urbane introdotto dalla legge
9 dicembre 1998, n. 431 è infatti profondamente mutato nell’impostazione e
nella disciplina rispetto a quello stabilito dalla ricordata legge n. 392 del
1978» (sentenza
n. 135).
Viceversa, sempre in materia di edilizia residenziale
pubblica, non contrastano con il canone di ragionevolezza:
- (a) una norma che «attribuisce rilevanza, ai fini della
esclusione dall’assegnazione degli alloggi, alla titolarità di un diritto reale
su uno o più immobili che abbiano una determinata rendita catastale,
indipendentemente dalla valutazione della idoneità abitativa degli stessi in
relazione alle esigenze del nucleo familiare del richiedente, in quanto la
titolarità di tali diritti costituisce indice oggettivo di ricchezza – espresso
in termini di rendita catastale – rappresentativo della disponibilità di un
reddito utilizzabile per il soddisfacimento di dette esigenze» (ordinanza n. 104);
- (b) una norma che imponga all’assegnatario di un alloggio
di edilizia residenziale pubblica l’obbligo di produrre, su richiesta degli
enti gestori, a fini di accertamento periodico del reddito, la documentazione
necessaria entro il 30 giugno di ogni biennio e che, qualora tale
documentazione non venga prodotta entro tale data, prevede l’applicazione della
misura massima del canone; invero, «l’onere della comunicazione posto a carico
dell’assegnatario va valutato in corrispondenza del beneficio dell’assegnazione
dell’alloggio, cosicché non irragionevolmente la norma censurata stabilisce
che, nei confronti degli assegnatari che non abbiano prodotto la documentazione
richiesta entro il termine previsto, si applica – a parità di reddito – la
misura massima del canone, tanto più che il predetto onere di comunicazione è
disciplinato dalla legge regionale in modo tale da non renderne
ingiustificatamente gravoso l’adempimento, risultando anche agevolato il
perseguimento dell’interesse pubblico all’accertamento del reddito degli
assegnatari» (ordinanza
n. 150).
1.4. La sospensione dei processi
penali in corso nei confronti delle alte cariche dello Stato
Con la sentenza n. 24,
L’iter
argomentativo seguito dalla Corte ha preso avvio dalla definizione di quali
fossero la natura, la funzione e la portata della normativa impugnata. Essa,
nel prevedere una sospensione del processo penale, faceva riferimento ad un
istituto che è solitamente contemplato «per situazioni oggettive» ed è
funzionale al regolare proseguimento del processo.
La situazione cui si riconnetteva la sospensione nella specie
disposta era costituita dalla coincidenza delle condizioni di imputato e di
titolare di una delle cinque più alte cariche dello Stato: il bene che la
misura in esame intendeva tutelare doveva, dunque, essere ravvisato «nell’assicurazione
del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni» inerenti a quelle cariche (interesse,
questo, che nella sua apprezzabilità può essere tutelato in armonia con i
principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto
la protezione è strumentale).
Ciò detto sul piano generale,
Sulla scorta di questa disamina, la sentenza ha evidenziato
due profili di illegittimità costituzionale, che hanno condotto alla relativa
declaratoria (poi estesa in via consequenziale dal comma 2 all’intero art. 1).
In ordine al primo profilo, la misura predisposta dalla
normativa creava «un regime differenziato riguardo all’esercizio della
giurisdizione, in particolare di quella penale». Una siffatta differenziazione
non poteva essere giustificata sulla base dei valori rispetto ai quali il
legislatore aveva ritenuto prevalente l’esigenza di protezione della serenità
dello svolgimento delle attività connesse alle alte cariche dello Stato, se è
vero che «alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio
della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel
nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali».
Ora, l’automatismo generalizzato della sospensione incideva,
menomandolo, sul diritto di difesa dell’imputato, al quale era posta l’alternativa
tra il continuare a svolgere l’alto incarico sotto il peso di un’imputazione
(magari concernente anche reati gravi e particolarmente infamanti), oppure il dimettersi
dalla carica ricoperta.
Del pari, ad essere sacrificato era il diritto della parte
civile, la quale, anche ammessa la possibilità di trasferimento dell’azione in
sede civile, doveva soggiacere alla sospensione prevista dal comma 3 dell’art.
75 del codice di procedura penale.
Con riferimento al secondo profilo, l’art. 3 della
Costituzione risultava violato in quanto la normativa impugnata accomunava in
unica disciplina cariche diverse, non soltanto per le fonti di investitura, ma
anche per la natura delle funzioni, e distingueva, «per la prima volta sotto il
profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione», i
Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale
rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti.
Inoltre, mentre venivano fatti salvi gli articoli 90 e 96
della Costituzione, nulla veniva detto a proposito del secondo comma dell’art.
3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che ha esteso a tutti i
giudici della Corte costituzionale il godimento dell’immunità accordata nel
secondo comma dell’art. 68 della Costituzione ai membri delle due Camere.
Alla luce di quanto riscontrato, la norma impugnata risultava
viziata anche da «gravi elementi di intrinseca irragionevolezza».
2. La potestà punitiva dello Stato ed
i suoi limiti
Secondo un consolidato orientamento della Corte «il potere di
configurare le ipotesi criminose, determinando la pena per ciascuna di esse, e
di depenalizzare fatti dianzi configurati come reati – come pure di abrogare le
singole previsioni punitive – rientra nella discrezionalità legislativa: discrezionalità
censurabile, in sede di sindacato di costituzionalità, solo nel caso in cui sia
esercitata in modo manifestamente irragionevole» (sentenza n. 364).
Alla luce di tale regola di giudizio,
Inoltre, dopo avere rilevato l’erroneità del presupposto
interpretativo da cui muoveva il rimettente, per cui tra il più mite reato di
cui all’art. 316-ter e quello di cui all’art. 640-bis del codice
penale sussiste un rapporto di effettiva sussidiarietà e non di specialità, a
fronte del quale la prima norma è destinata a colpire unicamente fatti che non
rientrino nel campo di operatività della seconda,
Gran parte delle questioni scrutinate dalla Corte si fonda
normalmente sul confronto, condotto dai giudici a quibus, tra la norma
censurata e altra o altre disposizioni che contemplano fattispecie analoghe,
prevedendo, di regola, sanzioni più miti o addirittura di tipo diverso. In
questi casi, e le questioni che seguono ne costituiscono un esempio,
- (a) dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1193, primo comma, del codice
della navigazione, che prevede la sanzione relativa alla fattispecie, ora
depenalizzata, della navigazione senza documenti di bordo, rilevando che non
può affermarsi una disparità di trattamento con quanto previsto per le
imbarcazioni da diporto, stante «la sostanziale eterogeneità delle situazioni
poste a confronto» – resa evidente dal carattere di sistema a sé stante delle
norme del codice della navigazione rispetto alla natura speciale delle norme
sulla navigazione da diporto – «e, dunque, l’inidoneità del tertium comparationis
a fungere da termine di riferimento onde verificare la pretesa lesione del
principio di uguaglianza» (ordinanza n. 109);
- (b) ritiene non irragionevole né arbitraria la
perdurante rilevanza penale del reato di omesso versamento delle ritenute
previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti dal datore di lavoro, nonostante l’intervenuta abrogazione, ad opera
dell’art. 25 del decreto legislativo n. 74 del 2000, del reato di omesso
versamento delle ritenute fiscali da parte del datore di lavoro quale sostituto
di imposta, «data la disomogeneità della fattispecie oggetto della norma
censurata rispetto al tertium comparationis individuato dal
remittente», resa evidente dalla duplice considerazione che «gli obblighi
tributari e gli obblighi previdenziali di cui si tratta, pur rientrando nell’ampia
categoria delle obbligazioni pubbliche, sono correlativi a interessi diversi,
rispettivamente presi in considerazione dai due diversi precetti costituzionali
di cui agli articoli 53 e 38 della Costituzione», e che «per assicurare il
rituale adempimento dei suddetti obblighi sono prevedibili diversi e specifici
sistemi nell’ambito di ciascuno dei quali la sanzione penale rappresenta
soltanto uno dei mezzi cui il legislatore può ricorrere, sicché la valutazione
della ragionevolezza delle diverse opzioni sanzionatorie prescelte va
effettuata nell’ambito di ciascun sistema» (ordinanza n. 139);
- (c) non ritiene manifestamente irragionevole la
scelta legislativa di punire in modo più severo il reato di detenzione di
munizioni relative alle armi da collezione, rispetto all’ipotesi generale della
detenzione abusiva di munizioni, di cui all’art. 697 del codice penale, nonché
a quella della detenzione di munizioni da guerra (art. 2 della legge 2 ottobre
1967, n. 895), allorché ricorra la circostanza attenuante speciale del fatto di
lieve entità, posto che la condotta di chi detiene munizioni avendo la contestuale
disponibilità di una pluralità di armi – che è autorizzato a detenere ma non ad
usare – crea una situazione di maggior pericolo ed allarme sociale rispetto a
quella ingenerata da chi detiene illecitamente soltanto delle munizioni (ordinanza n. 158);
- (d) non censura - a fronte dell’intervenuta riforma
del diritto penale societario, attuata dal decreto legislativo n. 61 del 2002 -
la scelta del legislatore di non abrogare l’art. 136 del decreto legislativo n.
385 del 1993, che, salvo casi eccezionali, vieta a chi svolge funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso una banca, di contrarre
obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente
o indirettamente, con la banca amministrata, diretta o controllata, posto che,
a prescindere «da valutazioni di merito sul piano politico-criminale — estranee
al sindacato di costituzionalità — l’opzione in parola si giustifica alla luce
della specificità dell’attività bancaria», le cui caratteristiche, anche alla
luce «[de]gli interessi in essa coinvolti», «rendono non irragionevole la
previsione di forme particolari e più intense di protezione penale — anche sul
piano dell’”avanzamento” della linea di tutela sul versante considerato —
rispetto a quelle contemplate per la generalità delle società commerciali» (sentenza n. 364).
Non solo la definizione delle fattispecie, ma anche la configurazione
delle pene e delle sanzioni rientra nel campo riservato alla discrezionalità
del legislatore, con la conseguenza che, pur dovendosi prendere atto dell’esiguità
e della mancanza di afflittività delle sanzioni disciplinari pecuniarie a
carico dei notai, sussistendo una evidente disparità di trattamento rispetto
alle previsioni sanzionatorie stabilite per altre categorie di professionisti,
Sotto tale ultimo profilo, poi, va aggiunto che «non è
precluso in linea di principio al legislatore includere in una medesima
previsione punitiva una pluralità di fattispecie diverse per struttura e
disvalore: restando affidato in tal caso al giudice il compito di far emergere
la differenza tra le varie ipotesi criminose, tramite la graduazione della pena
da irrogare in concreto nell’ambito della cornice edittale» (ordinanza n. 158);
per cui, mutatis mutandis, anche nella definizione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, «l’ampiezza della “forbice” tra minimo e massimo esclude ancora un’irrazionalità
della previsione, e viceversa consente l’applicazione di una sanzione
amministrativa concretamente determinabile in rapporto alla gravità della
violazione, differenziandola a seconda che sia commessa dai comandanti di navi
minori o di navi maggiori» (ordinanza n. 109).
Anche in rapporto alla tematica delle cause di non punibilità
Allo stesso modo conclude
In un caso, tuttavia,
Infine, in materia di sanzioni amministrative, appare del
tutto inconferente invocare il parametro di cui all’art. 5 della Costituzione,
in quanto esso «non vincola la discrezionalità del legislatore nella scelta
dell’organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative in materia di
circolazione stradale» (ordinanza n. 294).
2.2. (Segue:) Il principio di
determinatezza della fattispecie penale
Secondo un tradizionale insegnamento richiamato dalla storica
sentenza n. 364 del 1988, nel quadro del moderno Stato di diritto, il principio
di legalità, consacrato in materia penale dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione,
è espressione della contropartita (d’origine contrattualistica) che lo Stato
offre ai consociati in cambio dell’obbligatorietà della legge penale: in altri
termini, lo Stato assicura i cittadini che non li punirà senza preventivamente
informarli, attraverso la formulazione di precetti sufficientemente chiari e
precisi, su ciò che e’ vietato o comandato, ma richiede dai medesimi l’adempimento
di particolari doveri di informazione mirati alla realizzazione dei precetti
principali relativi ai fatti penalmente rilevanti.
Il principio di determinatezza della fattispecie penale,
quale naturale corollario del principio di legalità, è stato più volte evocato
in giudizio nel corso del
In particolare,
Nel corso di altro giudizio è stato impugnato, per violazione
del principio di tassatività della fattispecie penale, l’art. 187 del codice
della strada dal momento che assoggetta a sanzione penale la condotta di chi
guida in stato di alterazione fisica e psichica per uso di sostanze
stupefacenti, senza stabilire alcun limite per la individuazione dello stato di
alterazione.
Sono state viceversa giudicate inammissibili, seppure con
argomentazioni diverse, altre due questioni di legittimità costituzionale
fondate sulla presunta violazione del principio di determinatezza da parte di
fattispecie incriminatrici per la cui integrazione è richiesta una aggressione
«sensibile» del bene giuridico da esse tutelato.
In un primo caso, con la sentenza n. 161,
In un secondo caso, venendo in rilievo un presunto difetto di
determinatezza del reato di abuso di informazioni privilegiate (insider trading)
di cui all’art. 180 del decreto legislativo n. 58 del 1998, connesso alla
asserita genericità del requisito dell’idoneità dell’informazione privilegiata
ad influenzare «sensibilmente» il prezzo di strumenti finanziari,
2.3. La pena, le misure di sicurezza
Con la sentenza n. 367
L’ordinanza n. 433, rilevato che la diversità di
natura delle sanzioni penali, e dunque delle pene pecuniarie, rispetto alle
altre entrate dello Stato, «comporta che, ai sensi dell’art. 79 della
Costituzione, l’estinzione delle pene possa essere disposta solo con “legge
deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in
ogni suo articolo e nella votazione finale”», esclude che l’art. 12 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, nel prevedere la definizione dei carichi di ruolo pregressi
mediante il pagamento di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo,
nonché delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute
per le procedure esecutive da lui eventualmente effettuate, possa trovare
applicazione altresì alle pene pecuniarie, come erroneamente ritenuto dal rimettente.
2.4. Il trattamento penitenziario
In materia penitenziaria si segnalano due pronunce, la prima
della quali si è occupata del generale divieto di ammissione a determinati
benefici penitenziari previsto per i condannati nei cui confronti sia stata
disposta la revoca di talune misure alternative alla detenzione, mentre con la
seconda si è esaminata la procedura di proroga del regime di cui all’art. 41-bis
dell’ordinamento penitenziario.
In particolare, con l’ordinanza n. 87
Con l’ordinanza n. 417,
invece,
3. La tutela dei diritti nella
giurisdizione
Numerose sono state nel 2004 le pronunce di rilievo in
materia processuale civile, a cominciare dalla sentenza n. 28,
che, in tema di procedimento notificatorio, ha affermato che – per effetto
della sentenza n. 477 del 2002 – «risulta ormai presente nell’ordinamento processuale
civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio
secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè
come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere
per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata
per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il
destinatario», con la conseguenza che, alla luce di tale principio, le norme in
tema di notificazioni di atti processuali vanno ora interpretate, senza necessità
di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso che «la
notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, (…), al momento
della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario» (sentenza n. 28;
ma anche ordinanze numeri 97, 132
e 153).
Si consideri poi che, «poiché la notificazione si perfeziona
per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, ne discende
che da quel momento possono essere da lui compiute le attività (tra cui,
appunto, l’iscrizione a ruolo) che presuppongono la notificazione dell’atto
introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del
termine finale dalla consegna al destinatario» (sentenza n. 107).
3.1.2. Introduzione del giudizio e competenza
Un’altra sentenza di rilievo è stata la n. 98,
in tema di deposito del ricorso in opposizione contro le ordinanze-ingiunzione
che irrogano sanzioni amministrative.
Preso atto del consolidato indirizzo di legittimità secondo
cui detto ricorso non può essere inoltrato al giudice competente con plico
postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria, con consegna a mani
del cancelliere,
Essa infatti, dopo avere rilevato come «il procedimento di
opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento, quale disciplinato dagli
artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, si caratterizzi per una semplicità
di forme del tutto peculiare, all’evidenza intesa a rendere il più possibile
agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia», ha affermato
che «in relazione a tale semplificata struttura processuale, la previsione del
necessario accesso dell’opponente (o del suo procuratore) alla cancelleria del
giudice competente al fine di depositare personalmente il ricorso – con esclusione
della possibilità di utilizzo, a tale scopo, del servizio postale, viceversa
largamente impiegato dalla parte pubblica per le proprie comunicazioni e
notifiche – appare non solo incongrua nel suo formalismo, e perciò lesiva del
generale canone di ragionevolezza, ma altresì tale da rappresentare – in palese
contrasto con la ratio legis – fattore di dissuasione anche di natura
economica dall’utilizzo del mezzo di tutela giurisdizionale, in considerazione
tra l’altro dei costi, del tutto estranei alla funzionalità del giudizio, che l’intervento
personale può comportare nei casi, certamente non infrequenti, in cui il foro
dell’opposizione non coincida con il luogo di residenza dell’opponente» (sentenza n. 98).
La possibilità di inoltrare il ricorso a mezzo del servizio
postale, introdotta dalla sentenza n. 98, costituisce ora un ulteriore
argomento impiegato dalla Corte per ritenere infondata la più volte esaminata
questione di legittimità costituzionale dell’art. l’art. 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689, censurato nella parte in cui attribuisce la cognizione
dell’opposizione in materia di sanzioni amministrative alla competenza per
territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, anziché
di quello di residenza dell’opponente (ordinanza n. 130;
ma vedi anche ordinanza
n. 61). La scelta – tutt’altro che irragionevole – di radicare la
competenza territoriale in materia di opposizione a sanzioni amministrative nel
luogo della commessa violazione si risolve nell’applicazione del tradizionale
criterio del locus commissi delicti, ancorato ad un riferimento
oggettivo desunto dalla vicenda oggetto di giudizio, e costituisce inoltre
espressione della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione
della competenza in generale ed in particolare di quella territoriale.
D’altro canto, in riferimento alle
norme del decreto legislativo n. 168 del 2003 che hanno istituito sezioni
specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso
alcuni tribunali e corti d’appello, «deve escludersi che la attribuzione alle
sezioni specializzate presso il Tribunale di Roma della competenza in ordine
alle controversie sorte nel territorio della Regione Sardegna determini l’impossibilità
o l’estrema difficoltà nell’esercizio dei diritti garantiti dall’art. 24 Cost.,
come è agevolmente dimostrato dall’esistenza in Roma degli organi
giurisdizionali di ultima istanza, competenti per tutto il territorio
nazionale», mentre la diversità di trattamento che si volesse ravvisare tra i
soggetti coinvolti, in qualità di parte, in procedimenti aventi ad oggetto
materie riservate alla cognizione delle sezioni specializzate «va ricondotta
all’esercizio della discrezionalità del legislatore nella conformazione degli
istituti processuali» (ordinanza n. 386).
In tema di chiamata in causa del terzo, come disciplinata
dall’art. 269 del codice di rito, e di conseguente asserita disparità di
trattamento che da tale disposizione conseguirebbe riguardo alle posizioni dell’attore
e del convenuto, nel senso che solo il primo, e non anche il secondo, sarebbe
soggetto ad un termine perentorio entro il quale notificare la citazione al
terzo chiamato in causa,
3.1.3. Imparzialità-terzietà del giudice
Ribadita la ricorrente premessa che «l’art. 111, secondo
comma, Cost. non ha introdotto sostanziali elementi di novità circa la portata
del principio di imparzialità del giudice già desumibile dagli artt. 3 e 24
Cost., così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di
incompatibilità» (ordinanza
n. 90), su tale argomento si segnalano in particolare tre pronunce
rese dalla Corte nel
Occorre in primo luogo segnalare la sentenza n. 147,
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-bis
del codice di procedura civile, escludendo dalla declaratoria di illegittimità
la parte della norma relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e
il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato.
Per comprendere la portata della decisione, si consideri che
la legge n. 420 del 1998, che ha disciplinato la competenza territoriale per i
procedimenti riguardanti i magistrati sia in materia penale che civile,
introducendo l’art. 30-bis ha attribuito tutte indistintamente le
cause civili, in cui fossero comunque parti magistrati del distretto dell’ufficio
giudiziario ordinariamente competente, al giudice del capoluogo del diverso
distretto determinato secondo l’art. 11 cod. proc. pen., coevamente modificato;
e ciò nonostante
Passando alla seconda pronuncia, resa in un giudizio di
legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 51 del codice di procedura
civile, disposizione che disciplina i casi di astensione del giudice, si
ricorda che
Infine, si segnala in materia di processo del lavoro, l’ordinanza n. 317,
che ha respinto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 420,
161, secondo comma, e 429, primo comma, del codice di procedura civile, impugnati
perché, nel non prevedere l’obbligo di riassunzione delle prove nell’ipotesi di
mutamento del giudice, pena la nullità della sentenza pronunciata in violazione
di quest’ultimo, determinerebbero una irragionevole disparità di disciplina
rispetto al processo penale, risultando altresì lesive dei principi del giusto
processo e del diritto di difesa. A fronte di tali censure
3.1.4. Il giudizio di equità e la correzione di errori materiali
Si prendono ora in esame due pronunce della Corte, rese su
argomenti affatto diversi come il giudizio di equità e la disciplina del
procedimento di correzione di errori materiali, accomunate tuttavia dal comune
esito, consistito, in entrambi i casi, nella declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma del codice di rito da esse esaminata.
Nel primo caso, ad essere impugnata era la norma di diritto
vivente secondo la quale l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura
civile, nella sua attuale formulazione seguita all’intervento della legge n.
374 del 1991, andava interpretato nel senso che il giudice, nel decidere
secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, non era
tenuto alla previa individuazione della norma di diritto astrattamente
applicabile alla fattispecie.
Con la sentenza n. 335,
invece,
Pertanto «l’eccezionalità della disciplina del procedimento
di correzione nei suoi rapporti con la previa pendenza del procedimento d’appello,
e l’eccezionale regime della sentenza di primo grado al quale esso dà luogo,
determinano, con il loro sommarsi e combinarsi, una manifesta irragionevolezza
della disciplina dettata dall’art. 287 cod. proc. civ. allorché sottrae al
procedimento di correzione, davanti al giudice che le ha pronunciate, le
sentenze contro le quali sia stato proposto appello. Tale irragionevolezza si
risolve altresì in una ingiustificabile compressione del diritto di agire esecutivamente
della parte vittoriosa, e pertanto – costituendo l’azione esecutiva strumento
essenziale dell’effettività della tutela giurisdizionale – in una violazione
dell’art. 24 Cost.» (sentenza n. 335).
3.1.5. Il procedimento monitorio e le ordinanze-ingiunzione
In riferimento alla perentorietà del termine assegnato dall’art.
644 del codice di rito per la notifica del decreto ingiuntivo, pena l’inefficacia
dello stesso senza che il creditore possa invocare il caso fortuito o la forza
maggiore,
Ancora in tema di procedimento monitorio, con l’ordinanza n. 163
Infine, in tema di ordinanze-ingiunzione, l’art. 186-ter,
primo comma, del codice di procedura civile, censurato nella parte in cui,
attraverso il richiamo al secondo comma dell’art. 634 cod. proc. civ.,
considera gli estratti autentici delle scritture contabili quale prova scritta
idonea all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna, non
comporta alcuna inversione dell’onere della prova, «ma soltanto l’attribuzione
di una ben circoscritta valenza probatoria» – da apprezzare comunque alla luce
del quadro complessivo delle emergenze processuali – «attribuita a determinati
documenti in ragione della natura dei crediti sui quali si controverte, in deroga
alla regola generale secondo cui le scritture in argomento fanno prova contro l’imprenditore»
(ordinanza n. 180).
La circostanza che gli artt. 104 del regio decreto 14
dicembre 1933, n. 1669 e 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 subordinino l’acquisizione,
nella cambiale, della qualità di titolo esecutivo alla condizione che la stessa
sia stata regolarmente bollata sin dall’origine, incide soltanto sulla
idoneità, da parte della cambiale, di acquisire la qualità di titolo esecutivo
di origine e natura stragiudiziale, «laddove il creditore cambiario può
esercitare, anche in assenza di quella osservanza, “i diritti cambiari inerenti
al titolo” (art. 20 del d.P.R. n. 642 del 1972) ed inoltre adire il giudice sia
in via monitoria sia in via di cognizione ordinaria». Di conseguenza, non
sussistendo «alcun irragionevole ostacolo a che il creditore cambiario possa
far valere i suoi diritti in giudizio, […] utilizzando una pluralità di strumenti
processuali, bensì esistendo esclusivamente un limite all’acquisizione della
qualità di titolo esecutivo eccezionalmente riconosciuta dalla legge ad un atto
stragiudiziale, è manifestamente infondata la questione sollevata in relazione
all’art. 24 della Costituzione» (ordinanza n. 133).
Il capo della sentenza che definisce le spese di lite
costituisce corollario e non accessorio nel senso di cui all’art. 31 cod. proc.
civ. della sentenza stessa, atteso che la pronuncia sulle spese non presuppone,
affinché il giudice possa adottarla, una domanda di parte, ma essa ha il suo
titolo esclusivamente nel contenuto della decisione sul merito della
controversia, in applicazione del principio della soccombenza, di cui all’art.
91 cod. proc. civ.; «Di qui la conseguenza che il capo sulle spese, quando
costituisce corollario (più che “accessorio”) di una pronuncia di merito non
suscettibile per il suo contenuto di vedere anticipata la sua efficacia
rispetto alla definitività, non chiama in gioco, nonostante sia un capo di
condanna, l’art. 282 cod. proc. civ., il quale, si ripete, riguarda di per sé
esclusivamente la decisione di merito» (sentenza n. 232).
3.2. Il processo penale
In materia di libertà personale
3.2.2. Intercettazioni telefoniche e ambientali
Chiamata nuovamente a scrutinare le norme del codice di rito
in forza delle quali – a pena di inutilizzabilità dei risultati conseguiti – il
pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, che le operazioni
di intercettazione siano compiute mediante impianti di pubblico servizio o in
dotazione alla polizia giudiziaria unicamente quando gli impianti
installati nella procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei ed
esistano eccezionali ragioni di urgenza,
All’ulteriore argomento consistente nella denunciata
disparità di trattamento, in parte qua, delle intercettazioni a
fini di ricerca della prova rispetto alle intercettazioni preventive, di cui
all’art. 226 disp. att. cod. proc. pen., che si eseguono «con impianti
installati presso la procura della Repubblica o presso altre strutture idonee
individuate dal procuratore che concede l’autorizzazione», senza peraltro
esigere affatto, ai fini dell’impiego di queste ultime, una particolare
urgenza,
3.2.3. La testimonianza, la testimonianza assistita e l’interrogatorio
Investita della questione di legittimità costituzionale dell’art.
497, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non pone il
divieto di esaminare come testimone la persona offesa dal reato costituita
parte civile, consentendo così che la prova della colpevolezza dell’imputato si
fondi esclusivamente su tale deposizione e determinando in tal modo una situazione
processuale di squilibrio tra le parti,
Con l’ordinanza n. 202
Quanto, poi, al diverso regime processuale che secondo il
rimettente irragionevolmente caratterizzerebbe – ai sensi dell’art. 513 del
codice di rito – la possibilità di utilizzare mediante lettura le dichiarazioni
erga alios rese dal coimputato nel medesimo procedimento e raccolte
attraverso lo strumento dell’incidente probatorio, rispetto all’opposto divieto
che, invece, preclude una simile possibilità per le omologhe dichiarazioni rese
nel corso della udienza preliminare,
I diversi principi sussumibili sotto la più ampia locuzione
del “giusto processo”, cui è specificamente dedicato l’art. 111 della
Costituzione, non costituiscono necessariamente una prerogativa assoluta del
processo penale, benché in questo abbiano trovato il proprio naturale campo di
elezione.
Al principio di ragionevole durata del processo hanno fatto
espresso riferimento tre questioni aventi ad oggetto la disciplina transitoria
dettata, in tema di c.d. “patteggiamento allargato”, dall’art. 5 della legge n.
134 del 2003 e decise con la sentenza n. 219
ribadendo che «il legislatore gode di ampia discrezionalità nel regolare
nei processi in corso gli effetti temporali di nuovi istituti processuali o
delle modificazioni introdotte in istituti già esistenti, e che le relative
scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di
illegittimità costituzionale» (ordinanza n. 420).
In particolare,
- (a) che l’art. 5, comma 1, della legge n. 134 del 2003, nel
consentire all’imputato o al suo difensore munito di procura speciale, con il
consenso del pubblico ministero, di formulare la richiesta di cui all’articolo
444 del codice di procedura penale, come modificato dalla citata legge, nella
prima udienza utile successiva alla data della sua entrata in vigore anche nei
casi in cui l’istruzione dibattimentale sia già in fase avanzata, «non si pone
in contraddizione né con le finalità deflative che ispirano questo rito
alternativo, né con il principio della ragionevole durata del processo», posto
che anche «nei casi in cui l’istruzione dibattimentale sia già in fase
avanzata, il ricorso all’istituto del patteggiamento è infatti in grado di
assicurare una notevole accelerazione rispetto alle cadenze del procedimento
ordinario […], sia perché l’accordo tra le parti ne provoca l’immediata
conclusione, sia per i consistenti limiti all’appellabilità della sentenza»;
- (b) che l’art. 5, comma 2, della legge n. 134 del 2003,
censurato nella parte in cui impone al giudice, su richiesta dell’imputato, di
sospendere il dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni
per consentire a quest’ultimo di valutare l’opportunità di formulare la
richiesta di applicazione della pena, pur assegnando all’imputato uno spatium
deliberandi molto ampio, è «di per sé, nonostante la sua inusitata
ampiezza, frutto di una scelta affatto ingiustificata, tale da incidere significativamente
sulla ragionevole durata del processo»; e ciò a maggior ragione se si considera
che, come ripetutamente affermato dalla Corte, «la richiesta di applicazione
della pena da parte dell’imputato costituisce una modalità di esercizio del
diritto di difesa […] e che il principio della ragionevole durata del processo
deve essere contemperato con la tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti,
a cominciare dal diritto di difesa»;
- (c) che la possibilità di proporre patteggiamento anche nei
processi in corso di trattazione in dibattimento per reati che sarebbero già
stati patteggiabili in base alla disciplina previgente, ma per i quali l’imputato
non aveva formulato la relativa richiesta, si giustifica – oltre che per
evidenti finalità deflative - alla luce delle modifiche contestualmente
apportate dalla legge n. 134 del 2003 alla disciplina della sostituzione delle
pene detentive brevi, con l’evidente conseguenza che anche in relazione alle
pene patteggiabili non superiori a due anni di detenzione «la riforma apr[e]
nuove prospettive all’imputato, che può ora avere interesse e convenienza a
concordare l’applicazione di una pena sostitutiva in luogo di una pena che,
alla stregua della precedente disciplina, sarebbe stata detentiva» (sentenza n. 219).
Fondata sulla presunta lesione del principio di ragionevole
durata del processo è poi la “ricorrente” questione di legittimità
costituzionale delle norme del codice di rito (artt. 70-72 cod. proc. pen.)
che, in caso di incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al
processo, prevedono la sospensione del procedimento con obbligo per il giudice,
con cadenza semestrale, di svolgere ulteriori accertamenti sul suo stato di
mente, anche nella ipotesi in cui esso risulti affetto da una patologia
reputata come irreversibile.
Al contrario, tale disciplina della sospensione obbligatoria
del procedimento appare altresì applicabile a tutti quei casi in cui, per
infermità fisica di qualsiasi natura, oltre che psichica, l’imputato non sia in
grado di esprimersi in modo compiuto né verbalmente, né attraverso la scrittura,
né utilizzando un linguaggio convenzionale che sia traducibile avvalendosi di
un interprete, e quindi sia impossibilitato a partecipare attivamente al processo,
esercitando validamente la propria autodifesa. Invero, «anche se l’art. 70
letteralmente si riferisce ad ipotesi di “infermità mentale”, il sistema
normativo è chiaramente volto a prevedere la sospensione ogni volta che lo “stato
mentale” dell’imputato ne impedisca la cosciente partecipazione al processo.
Partecipazione che non può intendersi limitata alla consapevolezza dell’imputato
circa ciò che accade intorno a lui, ma necessariamente comprende anche la sua
possibilità di essere parte attiva nella vicenda e di esprimersi, esercitando
il suo diritto di autodifesa. Ciò significa che quando non solo una malattia
definibile in senso clinico come psichica, ma anche qualunque altro stato di
infermità renda non sufficienti o non utilizzabili le facoltà mentali
(coscienza, pensiero, percezione, espressione) dell’imputato, in modo tale da
impedirne una effettiva partecipazione – nel senso ampio che si è detto – al
processo, questo non può svolgersi. Alla verifica di tale situazione è diretto
l’accertamento peritale, sulle cui risultanze si esercita il controllo del giudice,
ispirato ai principi ora enunciati» (sentenza n. 39).
Il più volte citato principio di ragionevole durata del
processo non appare neppure violato «dalla necessità di rinnovare l’istruzione
dibattimentale in precedenza svolta da un giudice poi sostituito, [dovendo]
essere contemperato con le esigenze di tutela di altri diritti e interessi
costituzionalmente garantiti rilevanti nel processo penale e […] tale
contemperamento, ove risulti, come nel caso di specie, non irragionevolmente
realizzato, non si presta a censure sul terreno costituzionale» (ordinanza n. 418).
Non appare lesiva del c.d. principio della parità delle armi
tra accusa e difesa l’esclusione dell’appello incidentale del pubblico
ministero contro le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio
abbreviato (artt. 443, comma 3, e 595 cod. proc. pen.).
In materia di tutela del principio di imparzialità-terzietà
del giudice, l’assorbente rilievo che
In riferimento al diritto della persona accusata di un reato
di essere avvisata nel più breve tempo della natura e dei motivi dell’accusa,
come sancito dall’art. 111, terzo comma, della Costituzione, l’ordinanza n. 292
ricorda come esso «possa essere variamente modulato dal legislatore ordinario
in relazione ai singoli riti alternativi».
Quanto poi alla portata dell’art. 111, quinto comma, della
Costituzione,
In tema di procedimento di archiviazione si segnalano due
pronunce, che ne evidenziano la natura di sede processuale deputata al
controllo dell’operato del pubblico ministero, con l’eventuale contraddittorio
della persona sottoposta all’indagine, senza tuttavia trasmodare in un analisi
sul merito dell’accertamento di responsabilità.
Premesso che «la funzione dell’avviso di conclusione delle
indagini, di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., [è] chiaramente
quella di consentire una “fase di contraddittorio” tra l’indagato ed il
pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini», e che, peraltro,
qualora «l’esercizio dell’azione penale consegua all’ordine del giudice di
formulare l’imputazione, previsto dall’art. 409, comma 5, cod. proc. pen. nel
caso di mancato accoglimento [della richiesta di archiviazione], il contraddittorio
sulla eventuale incompletezza delle indagini si esplica necessariamente nell’udienza
in camera di consiglio che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, il giudice
è tenuto a fissare ove non accolga la richiesta di archiviazione del pubblico
ministero», non appare configurabile una lesione del diritto di difesa dell’imputato
nel caso in cui, nella predetta ipotesi di c.d. imputazione coatta, non sia
previsto l’obbligo per il pubblico ministero di inviare l’avviso di conclusione
delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis del codice di rito
(ordinanza n. 441).
Inoltre, sempre in tema di archiviazione, alla luce della
natura «interlocutoria e sommaria» della decisione che il giudice è chiamato ad
assumere, essendo la stessa «finalizzata ad un semplice controllo di legalità
sull’esercizio dell’azione penale e non già ad un accertamento sul merito dell’imputazione»,
non appare affatto irragionevole che l’art. 411 del codice di procedura penale
non consenta al giudice, in sede di decisione sulla richiesta di archiviazione,
di tener conto delle circostanze attenuanti generiche e di effettuare il
giudizio di comparazione tra circostanze di cui all’art. 69 cod. pen., per
desumerne l’intervenuta prescrizione del reato, stante la natura di giudizio di
merito sottesa ad una siffatto tipo di accertamenti, «che presuppongono una
valutazione contenutistica sulle caratteristiche oggettive e soggettive del
fatto criminoso e sulla personalità del suo autore» (ordinanza n. 138).
Per quanto invece riguarda la diversa tematica dei riti
alternativi la decisione senz’altro più importante è costituita dalla sentenza n. 219
sul c.d. patteggiamento allargato, con la quale
Due decisioni hanno poi interessato il rito alternativo del
giudizio immediato.
Con la prima di esse, l’ordinanza n. 52,
Una seconda questione avente ad oggetto l’art. 456 del codice
di rito, impugnato nella parte in cui non prevede la nullità del decreto che ha
disposto il giudizio immediato nel caso di mancanza, insufficienza o inesattezza
dell’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione
della pena, è stata risolta dalla Corte in via interpretativa. Invero, dopo
avere ribadito che «la richiesta di riti alternativi costituisce una modalità
di esercizio del diritto di difesa», essa ha osservato che «non è esatto
ritenere, come fa il rimettente, che l’ordinamento vigente non preveda, nell’ipotesi
in esame, la nullità del decreto per mancanza o insufficienza dell’avviso», in
quanto, rappresentando l’effettivo esercizio della facoltà di chiedere i riti
alternativi «una delle più incisive forme di “intervento” dell’imputato, cioè
di partecipazione “attiva” alle vicende processuali», ogni illegittima menomazione
di tale facoltà si risolve «nella violazione del diritto sancito dall’art. 24,
secondo comma, Cost., integra[ndo] la nullità di ordine generale sanzionata
dall’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. » (sentenza n. 148).
Con l’ordinanza n. 115
Investita della richiesta di estendere con pronuncia additiva
l’ambito di applicazione dell’art. 83 del codice di procedura penale, censurato
dal rimettente nella parte in cui non riconosce all’imputato la facoltà di
chiedere la citazione del responsabile civile allorché si tratti di
responsabile civile ex lege in base alla normativa in materia di infortuni
sul lavoro e di previdenza sociale, ovvero in forza dell’art. 28 della Costituzione,
3.3. I procedimenti nei confronti di
minori
In materia di processo penale minorile si segnala l’ordinanza n. 110,
con cui è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre
1988, n. 448, come modificato dall’art. 22 della legge n. 63 del 2001, censurati
nella parte in cui precludono al giudice dell’udienza preliminare di
pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono
giudiziale o per irrilevanza del fatto, ovvero sentenza di condanna a pena
pecuniaria o a sanzione sostitutiva, in mancanza di consenso dell’imputato.
Come già indicato dalla sentenza n. 195 del 2002,
infatti, la disposizione impugnata segna un ragionevole punto di equilibrio tra
le contrapposte esigenze di favorire una rapida fuoriuscita dell’imputato
minorenne dal circuito processuale, da un lato, e di garantirgli nel contempo
le più complete opportunità difensive connesse alla possibilità di ottenere in
dibattimento una formula di proscioglimento più vantaggiosa, dall’altro,
riconoscendo al minorenne la facoltà di non prestare il consenso alla pronuncia
in udienza preliminare di sentenze che comunque presuppongono un accertamento
di responsabilità.
Con una pronuncia intervenuta in materia di adozione ed
affidamento dei minori
3.4. Il procedimento davanti al
giudice di pace
Numerose anche nel 2004 sono le questioni sollevate dai
giudici di pace, tra le quali molte sono quelle che hanno avuto ad oggetto
norme che ne disciplinano il procedimento [tra cui va annoverata anche la sentenza n. 98,
per la quale si rinvia supra 3.1.1].
Va detto che la più importante appare senz’altro la sentenza n. 114,
con cui
In tale occasione
Una serie di questioni, che in gran parte risultavano già
decise con la precedente ordinanza n. 231 del 2003, hanno investito l’art. 20
del decreto legislativo n. 274 del 2000, censurato per violazione degli artt. 3
e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che nell’atto di
citazione a giudizio davanti al giudice di pace siano indicate la facoltà dell’imputato
di ricorrere a riti alternativi, di fruire dell’istituto dell’oblazione, di
chiedere l’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie avvenute
prima dell’udienza di comparizione, e le sanzioni conseguenti a tale carenza.
Più significative, per il contributo che offrono ad una
migliore comprensione della peculiare natura del procedimento penale che si
svolge davanti al giudice di pace, appaiono le ordinanze numero 201 e 349.
In particolare, nella prima delle due ordinanze,
- (a) «l’omessa previsione dell’avviso di conclusione delle
indagini preliminari non è costituzionalmente illegittima, [posto] che le forme
di esercizio del diritto di difesa possono essere modulate in relazione alle
caratteristiche dei singoli riti speciali ed ai criteri di massima celerità e
semplificazione che li ispirano»;
- (b) «il dettato costituzionale, da un lato, non impone che
il contraddittorio si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di
procedimento e, soprattutto, che debba essere sempre collocato nella fase
iniziale del procedimento stesso, dall’altro non esclude che il diritto dell’indagato
di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell’accusa a suo
carico possa essere variamente modulato in relazione alla peculiare struttura
dei singoli riti alternativi»;
- (c) «nel procedimento davanti al giudice di pace le
esigenze di informazione dell’imputato prima dell’udienza di comparizione sono
comunque assicurate dall’avviso, contenuto nella citazione a giudizio disposta
dalla polizia giudiziaria, che il fascicolo relativo alle indagini preliminari
è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i
loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, nonché
dall’indicazione, contenuta sempre nel medesimo atto, delle fonti di prova di
cui il pubblico ministero chiede l’ammissione» (ordinanza n. 201).
Oltre a ribadire quanto già affermato nella precedente ordinanza n. 201,
la successiva ordinanza
n. 349 ha altresì precisato che «in relazione alla mancata
previsione a carico della polizia giudiziaria dell’onere di svolgere
accertamenti anche a favore dell’indagato,
Infine,
In tema di procedimento per l’applicazione di misure di
prevenzione, facendo leva sulla propria consolidata giurisprudenza secondo la
quale «le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente
modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di
tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione»,
L’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non è
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui – alla stregua di un
indirizzo della giurisprudenza di legittimità – consente l’applicazione della
misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza
anche nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena e ciò anche
quando si tratti di pena superiore alla durata massima della predetta misura di
prevenzione, inflitta per reato la cui commissione sia posta altresì a fondamento
della prognosi di pericolosità sociale del soggetto. Infatti, deve essere
distinto il momento deliberativo dal momento esecutivo della misura in
questione, poiché l’esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale potrà avere inizio solo quando lo stato di detenzione sia venuto a
cessare; fatta salva la possibilità di chiedere la revoca della misura stessa
nel caso in cui l’obiettivo della rieducazione, che l’art. 27, terzo comma,
della Costituzione assegna alla pena, si sia in concreto realizzato. Né la
ritenuta “afflizione aggiuntiva” può recare vulnus al parametro costituzionale
invocato, attesa la distinta funzione della misura di prevenzione non assimilabile
a quella della pena, posto che, peraltro, la stessa Carta costituzionale,
consentendo il sistema del “doppio binario” tra pene e misura di sicurezza,
riconosce la possibilità del concorso fra due diversi strumenti di intervento,
caratterizzati da fini eterogenei, pure in presenza di una medesima situazione
di fatto (ordinanza
n. 124).
3.5.2. Riparazione per l’ingiusta detenzione.
Con tre sentenze pronunciate nel
- (a) che non vi sono ostacoli a fare rientrare il
caso della custodia cautelare disposta per un fatto per il quale era già
intervenuta una sentenza passata in giudicato nell’ambito dell’art. 314, comma
2, cod. proc. pen., non essendo riscontrabile alcuna differenza tra l’ipotesi
di misura cautelare disposta in presenza di scriminanti o nei confronti di persona
non punibile (situazioni previste dall’art. 273, comma 2, cod. proc. pen., a
sua volta richiamato dall’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.) e il caso di chi
abbia subito la custodia cautelare per un reato per il quale l’azione penale
non avrebbe potuto essere esercitata per la preclusione del ne bis in idem prevista
dall’art. 649 cod. proc. pen. (sentenza n. 230);
- (b) che una lettura costituzionalmente orientata del
complesso normativo che regola la materia estradizionale impone di riconoscere
in via interpretativa il diritto alla riparazione per la detenzione
ingiustamente sofferta anche nel caso di arresto provvisorio e di applicazione
provvisoria della custodia cautelare su domanda di uno Stato estero di cui
venga successivamente accertata la carenza di giurisdizione (sentenza n. 231);
- (c) l’art. 314, comma 3, cod. proc. pen. va
interpretato nel senso che il diritto alla riparazione per l’ingiusta
detenzione opera anche in favore degli eredi dell’indagato la cui posizione sia
stata archiviata per ‘morte del reo’, qualora nella sentenza irrevocabile di
assoluzione pronunciata nei confronti dei coimputati risulti accertata l’insussistenza
del fatto a lui addebitato (sentenza n. 413).
3.5.3. Fallimento e procedure concorsuali.
Occupandosi di una questione di legittimità costituzionale
degli artt. 137, 184 e 186 della legge fallimentare in materia di concordato
preventivo omologato,
Sempre in materia fallimentare, poi,
Come noto, con la sentenza n. 376 del 2001
Ciò premesso, non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 819, secondo comma, del codice di procedura civile,
nella parte in cui non consente agli arbitri – come, invece, sarebbe consentito
al giudice in casi in casi simili in forza dell’art. 295 del codice di
procedura civile – di disporre la sospensione del giudizio arbitrale nel caso
in cui il giudice dello Stato debba risolvere una controversia dalla cui
definizione dipende la decisione della controversia arbitrale. Invero, il remittente
muove «dall’esplicito presupposto che l’art. 295 cod. proc. civ., assunto quale
tertium comparationis, pur sotto la rubrica “sospensione necessaria”
offre al giudice una vasta gamma di facoltà, inclusa quella di disporre la
sospensione del giudizio civile fino al passaggio in giudicato della sentenza
penale avente ad oggetto i medesimi fatti, cosicché sussisterebbe una
ingiustificata disparità di trattamento, sotto il profilo considerato, tra il
giudice statuale e l’arbitro, al quale siffatta facoltà sarebbe negata»;
viceversa tale «presupposto interpretativo non trova, tuttavia, conforto nel
diritto vivente, essendosi la giurisprudenza di legittimità, dopo talune oscillazioni
iniziali, ormai consolidata, in sede di regolamento di competenza avverso i
provvedimenti con i quali è disposta dal giudice la sospensione del processo
(art. 42 cod. proc. civ.), nel senso che non sussiste una discrezionale, e non
sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice
fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria» (sentenza n. 207).
Numerose sono anche nel 2004 le questioni che hanno
investito, sotto vari aspetti, la disciplina dell’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, anche se, nella maggior parte dei casi, si trattava della
riproposizione di questioni già decise in passato.
In particolare, investita della questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 96, comma 4, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
sollevata in riferimento all’articolo 97, primo comma, della Costituzione,
nella parte in cui stabilisce che il giudice deve provvedere in ordine all’istanza
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche quando lo stesso abbia
richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo,
Con l’ordinanza n. 387
Infine, meritano una particolare menzione le ordinanze n. 439 e n. 144, a
proposito delle quali, tuttavia, trattandosi di temi che coinvolgono altresì la
condizione giuridica dello straniero, si rinvia a quanto detto infra.
4. La condizione giuridica dello
straniero
La rassegna degli atti di promuovimento di questioni in via
incidentale degli ultimi due anni mostra come la disciplina della condizioni
giuridica degli stranieri costituisca l’ambito nel quale i giudici comuni più
massicciamente richiedono (recte,
hanno richiesto) l’intervento della Corte costituzionale.
Per corrispondere a questa esigenza diffusa,
Volendo qui fornire un quadro illustrativo della
giurisprudenza dell’anno, possono essere individuate alcune decisioni che
affrontano aspetti della normativa non affrontati in pronunzie degli anni
precedenti; ad esse, si aggiungono quelle concernenti le questioni per le quali
– in ragione di motivi diversi – non si è giunti ad una pronuncia di merito.
4.1. Il reato di trattenimento «senza
giustificato motivo»
La sentenza n. 5 ha deciso alcune questioni
sollevate in ordine all’art. 14, comma 5-ter,
del decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiunto dall’art. 13, comma 1, della
legge n. 189 del 2002, il quale punisce con l’arresto da sei mesi ad un anno
«lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello
Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis» del medesimo articolo, id est dell’ordine di lasciare il territorio dello Stato entro
cinque giorni.
La disposizione veniva denunciata essenzialmente con riguardo
alla utilizzazione, nella descrizione della fattispecie criminosa, della
formula «senza giustificato motivo», la quale, per la sua indeterminatezza, si
riteneva che rimettesse di fatto «all’arbitrio dell’interprete» l’identificazione
del comportamento incriminato.
La asserita violazione del principio di determinatezza della
fattispecie penale, che rappresentava il fulcro delle censure, è stata tuttavia
negata, da parte della Corte costituzionale, in quanto la valenza della
clausola «senza giustificato motivo» è da ritenersi sufficientemente precisato
alla luce della finalità dell’incriminazione e del quadro normativo su cui essa
si innesta.
Sotto il primo profilo, la norma incriminatrice, mirando a
rendere effettivo il provvedimento di espulsione, persegue l’obiettivo di
«rimuovere situazioni di illiceità o di pericolo correlate alla presenza dello
straniero nel territorio dello Stato, nella cornice del più generale potere –
che al legislatore indubbiamente compete – di regolare la materia dell’immigrazione,
in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi
problemi connessi a flussi migratori incontrollati».
Sotto il secondo profilo, l’istituto dell’espulsione si
colloca in un quadro sistematico che, pur nella tendenziale indivisibilità dei
diritti fondamentali, vede regolati in modo diverso l’ingresso e la permanenza
degli stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di
asilo o rifugiati, per i quali l’espulsione o il respingimento sono preclusi,
ovvero di c.d. «migranti economici», ai quali soli la clausola in questione si
applica. Così, essa, sebbene non possa essere ritenuta evocativa delle sole
cause di giustificazione in senso tecnico, ha tuttavia «riguardo a situazioni
ostative di particolare pregnanza, che incidano sulla stessa possibilità,
soggettiva od oggettiva, di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero rendendola
difficoltosa o pericolosa», e non anche ad esigenze che riflettano
approssimativamente la condizione tipica del «migrante economico».
Di talché, ad esempio, i motivi che legittimano la pubblica
amministrazione a non procedere all’accompagnamento coattivo dello straniero
alla frontiera – necessità di soccorso; difficoltà nell’ottenimento dei
documenti per il viaggio; indisponibilità di vettore o di altro mezzo di
trasporto idoneo – non possono non costituire sicuri indici di riconoscimento
di situazioni nelle quali può ravvisarsi, per lo straniero, la sussistenza di
«giustificati motivi» per non ottemperare all’ordine del questore (e ciò, in
specie, quando l’inadempienza dipenda dalla condizione di assoluta impossidenza
dello straniero, che non gli consenta di recarsi nel termine alla frontiera e/o
di acquistare il biglietto di viaggio).
Alla luce di tali considerazioni, appare altresì chiaro che
la disposizione impugnata non delinea – a differenza di quanto prospettato da
uno dei giudici rimettenti – una ipotesi di responsabilità oggettiva, derivante
dall’inesigibilità, in determinate circostanze, del comportamento richiesto
allo straniero.
La decisione di rigetto contenuta nella sentenza n. 5 ha costituito il precedente cui
si sono rifatte le ordinanze numeri 80 e 302, onde
dichiarare la manifesta infondatezza di questioni sostanzialmente identiche.
4.2. L’arresto obbligatorio per il
reato di trattenimento
Con la sentenza n. 223,
Onde giungere a tale conclusione,
La norma censurata dai giudici rimettenti prevedeva, invece,
l’arresto obbligatorio per un reato contravvenzionale, per di più sanzionato
con una pena detentiva – l’arresto da sei mesi ad un anno – di gran lunga
inferiore a quella per cui il codice ammette la possibilità di disporre misure
coercitive.
Da tale «anomalia» conseguiva che «il giudice chiamato a
pronunciarsi sulla convalida dell’arresto per il reato di cui all’art. 14,
comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 286 del 1998, [doveva] comunque disporre l’immediata liberazione dell’arrestato
ex art. 391, comma 6, del codice di
procedura penale, ove non vi [avesse] già provveduto il pubblico ministero a
norma dell’art. 121 delle norme di attuazione», posto che l’ordinamento
processuale impediva di disporre la custodia cautelare in carcere e, più in
generale, «qualsiasi misura coercitiva».
L’arresto obbligatorio era dunque privo di qualsiasi sbocco
sul terreno processuale: era «una misura fine a se stessa», che non poteva
trovare, come tale, alcuna «copertura costituzionale». Ciò in quanto, a norma
dell’art. 13, terzo comma, della Costituzione, all’autorità di polizia è
consentito adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà
personale «solo quando abbiano natura servente rispetto alla tutela di esigenze
previste dalla Costituzione, tra cui in primo luogo quelle connesse al
perseguimento delle finalità del processo penale, tali da giustificare, nel
bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio
della libertà personale in vista dell’intervento dell’autorità giudiziaria».
Ora, nel caso previsto dalla disposizione impugnata, non era
dato riscontrare alcun rapporto di strumentalità tra il provvedimento
provvisorio di privazione della libertà personale ed il procedimento penale,
risultando, in definitiva, «manifestamente irragionevole» la misura
«precautelare» prevista.
A dar giustificazione alla disciplina predisposta non poteva
addursi neppure l’esigenza di assicurare l’espulsione amministrativa dello
straniero che non avesse ottemperato all’ordine di allontanarsi dal territorio
dello Stato: l’arresto in flagranza per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, non poteva costituire, infatti, un
presupposto indefettibile del procedimento amministrativo di espulsione,
«atteso che l’accompagnamento alla frontiera e il trattenimento in un centro di
permanenza temporanea sono autonomamente previsti nei commi 5-ter e 5-quinquies dell’art. 14, che fanno riferimento alle discipline
descritte nell’art. 13, commi 4 e 5-bis,
e nello stesso art. 14, comma 1, operanti a prescindere dal previo arresto
dello straniero».
La declaratoria di illegittimità costituzionale che è seguita
ad una siffatta argomentazione ha definito alcune cause riunite, in tutto
simili ad altre centinaia di cause radicatesi tra il 2003 ed il 2004. Non a
caso, successivamente alla sentenza n. 223,
4.3. Il diritto di difesa e l’accompagnamento
dello straniero alla frontiera
La sentenza n. 222 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis,
del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall’art. 2 del decreto
legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno
2002, n. 106, nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di convalida del
decreto di espulsione dello straniero dovesse svolgersi in contraddittorio
prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con
le garanzie della difesa.
Il «percorso» della decisione è stato «interamente segnato
dalla sentenza
n. 105 del 2001». In quell’occasione,
La sentenza n. 105 del
2001 non aveva, dunque, riguardato l’accompagnamento alla frontiera in sé e
per sé, ma lo aveva comunque considerato quale istituto strettamente connesso,
sul piano fattuale (oltre su quello logico), al trattenimento.
Quanto affermato in quella decisione, peraltro, «già
preannunciava la soluzione di una eventuale questione di legittimità
costituzionale che avesse avuto ad oggetto l’accompagnamento alla frontiera
quale autonoma misura non legata al trattenimento presso i centri di permanenza
temporanei».
Ora, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art.
13, comma 5-bis,
Ne risultava quindi vanificata la garanzia contenuta nel
terzo comma dell’art. 13 della Costituzione, e cioè la perdita di effetti del
provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera dell’autorità
giudiziaria nelle successive quarantotto ore. Al contempo, risultava violato il
diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incomprimibile, nella misura
in cui non si prevedeva che questi dovesse essere ascoltato dal giudice, con l’assistenza
di un difensore.
Da tali rilievi discendeva alla stregua di una inferenza
necessitata la declaratoria di illegittimità costituzionale, corredata da un
(implicito) invito al legislatore a configurare uno schema procedimentale che,
per quanto «caratterizzato da celerità e articolato sulla sequenza
provvedimento di polizia-convalida del giudice», sia in grado di garantire «i
principi della tutela giurisdizionale».
Le cause vertenti su questioni di legittimità costituzionale
analoghe a quelle che hanno dato luogo alla sentenza n. 222 sono poi state definite con l’ordinanza n. 351, di restituzione degli atti ai
giudici a quibus.
4.4. L’espulsione dello straniero che
debba scontare una pena detentiva non superiore a due anni
Altre questioni poste da alcuni
giudici a quibus hanno avuto ad
oggetto la disciplina dell’espulsione, a titolo di «sanzione alternativa» alla
detenzione, dello straniero che debba scontare una pena non superiore, anche
quale pena residua, a due anni di reclusione o di arresto, prevista dall’art.
16, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato
dalla legge n. 189 del 2002.
L’assunto da cui i rimettenti
muovevano era dato dalla «sicura ascrivibilità» dell’espulsione «al novero
delle sanzioni penali»; alla luce di tale configurazione, si desumeva che la
disciplina concreta dell’istituto (e segnatamente l’iniziativa officiosa e la
sua applicazione automatica ed obbligatoria in presenza dei presupposti formali
previsti dalla legge, a prescindere da ogni valutazione sul percorso
rieducativo e sulle possibilità di reinserimento del condannato) si ponesse in
contrasto con la funzione rieducativa della pena nonché con i principi di
ragionevolezza e di eguaglianza, posto che si sarebbe trattato dell’unica
misura alternativa alla detenzione o comunque dell’unica sanzione afflittiva
applicata dalla magistratura di sorveglianza senza tenere conto degli effetti
ai fini della rieducazione e della risocializzazione del condannato e delle sue
condizioni personali.
Con l’ordinanza n. 226,
Come è chiaro, la natura
amministrativa dell’istituto non può significare che esso non sia comunque
assistito da garanzie, ed in specie da quelle che accompagnano l’espulsione disciplinata
dall’art. 13: ne è una significativa conferma la circostanza che alcune di esse
siano previste tanto nell’art. 13 quanto nell’art. 16 (il riferimento va al
divieto di procedere all’espulsione dello straniero che si trovi in determinate
condizioni, all’impugnabilità del provvedimento di espulsione, alla garanzia
del decreto motivato).
Alla luce di siffatte considerazioni,
sistematiche ed interpretative, le questioni sollevate non potevano dunque che
ritenersi manifestamente infondate. La decisione è stata confermata anche dalla
successiva ordinanza
n. 422, che ha dichiarato
manifestamente infondate analoghe questioni.
4.5. La traduzione del decreto di
espulsione
Con talune ordinanze di rimessione, era stata sottoposta allo
scrutinio della Corte la questione inerente all’art. 13, comma 7, del decreto
legislativo n. 286 del 1998, sulla base della ritenuta necessità
che il provvedimento di espulsione, che viene comunicato allo straniero
unitamente all’indicazione delle modalità di impugnazione, venga sempre tradotto
in una lingua da questi effettivamente conosciuta: in sostanza, non sarebbe
stata sufficiente, in caso di impossibilità di traduzione nella lingua effettivamente
conosciuta dallo straniero, l’utilizzazione di una delle lingue maggiormente
diffuse previste dalla legge (francese, inglese o spagnola), perché in tal caso
si sarebbe determinata la presunzione di conoscenza dell’atto amministrativo
dalla cui violazione discende la commissione del reato di trattenimento sul
territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanamento.
Sulla scorta di tali affermazioni, che trovano significativi
riscontri nella giurisprudenza costituzionale precedente, la sentenza n. 257 ha rigettato le questioni sollevate.
4.6. Il gratuito patrocinio a
beneficio dello straniero
L’ordinanza n. 439 ha dichiarato manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 12 della legge n. 189
del 2002, e dell’art. 142 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113
(riprodotto nell’art. 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). La disciplina era
stata censurata per violazione del principio di eguaglianza e del canone della
ragionevolezza, «tenuto conto della “differente tipologia di trattamento
prevista per gli stranieri che richiedano l’accesso al patrocinio a spese dello
Stato in sede di udienza di convalida del trattenimento, nonché alla parimenti
differente tipologia di trattamento prevista per i cittadini e per gli
stranieri che richiedano analogo beneficio sia in ambito penale sia in ambito
civile”».
Replicando alle prospettazioni del giudice a quo,
La scelta operata, d’altra parte, «non appare né
irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la
peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero e la necessità di
non frapporre alcun ostacolo al perseguimento di questo fine».
Anteriormente a questa decisione,
Il presupposto da cui muoveva il rimettente, e cioè l’impossibilità
di un indirizzo interpretativo diverso da quello che esige la declaratoria di
inammissibilità dell’istanza diretta ad ottenere il beneficio del patrocinio a
spese dello Stato, anche nell’ipotesi in cui, per ragioni oggettive, l’interessato
non possa provvedere all’indicazione del codice fiscale, è stato ritenuto
erroneo dalla Corte, la quale, nell’ordinanza n. 144, ha sottolineato che, agli
effetti dell’ammissibilità dell’istanza diretta ad ottenere il beneficio in
questione, «nulla appare escludere la possibilità che lo straniero
extracomunitario, in luogo dell’indicazione del codice fiscale, fornisca i dati
di cui all’art. 4 [cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio
fiscale], oltre al proprio domicilio all’estero».
4.7. Le questioni non decise nel
merito
I vizi riscontrati nella ordinanza di rimessione
(segnatamente, l’insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del
giudizio a quo) hanno precluso la
decisione di merito della questione di legittimità costituzionale dell’art. 29,
comma 1, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo n. 286
del 1998, come modificato dall’art. 23, comma 1, della legge n. 189 del 2002,
nella parte in cui prevede il ricongiungimento familiare coi figli maggiorenni
nel solo caso in cui essi non possano provvedere al loro sostentamento a causa
di uno stato di salute che comporti una invalidità totale (ordinanza n. 187).
L’omissione della motivazione in ordine alla non manifesta
infondatezza è stata la ragione che ha indotto
Infine, la questione di legittimità costituzionale dell’art.
12, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall’art.
11, comma 1, della legge n. 189 del 2002, «nella parte in cui punisce chi “compie
atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”», ha dato
luogo ad una decisione di restituzione degli atti al giudice a quo, ai fini di una nuova valutazione
della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, alla luce
delle modifiche apportate alla disposizione impugnata da parte del decreto
legge n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 271 del
2004 (ordinanza
n. 445).
Oltre che in alcune decisioni concernenti il riparto di
competenze legislative tra lo Stato e le Regioni in tema di «tutela della
salute», il diritto di cui all’art. 32 della Costituzione è stato oggetto di
due ordinanze emesse nel corso di giudizi in via incidentale (ad esse può
aggiungersi la sentenza
n. 367, esaminata nel contesto
dell’analisi inerente alle misure di sicurezza).
L’ordinanza n. 262 ha dichiarato la manifesta
inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza, della questione
sollevata avverso la norma che sancisce l’obbligatorietà della vaccinazione
antitetanica per i nuovi nati, la cui costituzionalità era stata revocata in
dubbio nel corso di un processo originato dal rifiuto opposto dai genitori di
sottoporre il figlio ad una delle somministrazioni di vaccino.
Per quanto qui rileva,
Con l’ordinanza n. 366,
6. L’esposizione del Crocifisso nelle
aule scolastiche
Una tra le decisioni della Corte che più hanno attirato l’attenzione
dell’opinione pubblica è certamente quella resa con l’ordinanza n. 389, in tema di esposizione del
Crocifisso nelle aule scolastiche.
Il giudice rimettente aveva impugnato gli articoli 159 e 190
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sul presupposto che essi, «come
specificati», rispettivamente, dall’art. 119 (e allegata tabella C) del regio
decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e dall’art. 118 del regio decreto 30 aprile
1924, n. 965, fornissero fondamento legislativo ad un obbligo – contestato dal
ricorrente per contrasto con il principio di laicità dello Stato – di
esposizione del Crocifisso in ogni aula scolastica delle scuole elementari e
medie.
Veniva inoltre impugnato l’art. 676 del decreto legislativo
n. 297 del 1994 sul presupposto che a tale disposizione, che sancisce l’abrogazione
delle sole disposizioni non incluse nel testo unico che risultino incompatibili
con esso, dovesse farsi risalire la permanente vigenza delle due norme
regolamentari citate, dopo l’emanazione dello stesso testo unico.
I presupposti da cui il giudice a quo muoveva sono stati dalla Corte dichiarati erronei. I
precitati articoli 159 e 160, infatti, «si limitano a disporre l’obbligo a
carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici, rispettivamente per le
scuole elementari e per quelle medie», con il che nessun rapporto di
specificazione può essere rintracciato tra questi e le disposizioni regolamentari
indicate, che, dal canto loro, si riferiscono «alla presenza nelle aule del
Crocifisso e del ritratto del Re», ma non si occupano «dell’arredamento delle
aule».
In ordine all’altro profilo evocato nell’ordinanza di
rimessione,
In ragione di tali considerazioni, la questione di
costituzionalità sollevata è stata dichiarata manifestamente inammissibile, in
quanto «frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango
legislativo» di una questione di legittimità in realtà concernente norme prive
di forza di legge (sul punto, si veda anche supra,
parte I, cap. I, par. 6).
7. La previdenza e l’assistenza
In materia previdenziale si segnalano innanzitutto la sentenza n. 30
e l’ordinanza n.
383 che hanno ribadito principi ormai consolidati nella giurisprudenza
della Corte, chiamata più volte a scrutinare norme che, nell’attribuire
integrazioni salariali al personale in servizio, non provvedevano al
contestuale adeguamento delle pensioni spettanti al personale già collocato a
riposto.
A tale riguardo,
- (a) «che non esiste nel nostro ordinamento un principio
costituzionale che garantisca il costante adeguamento delle pensioni al
successivo trattamento economico dell’attività di servizio corrispondente, e
che il rispetto degli artt. 36 e 38 Cost. impone solo che siano individuati
meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni ai mutamenti
del potere di acquisto della moneta, sia al momento del collocamento a riposo,
sia successivamente» (ordinanza n. 383);
- (b) «che il rispetto dei principi di sufficienza ed
adeguatezza del trattamento pensionistico impone al legislatore «di individuare
un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei
trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita», di tal che il
verificarsi di irragionevoli scostamenti tra l’importo delle pensioni e le
variazioni del potere d’acquisto della moneta «sarebbe indicativo della
inidoneità del meccanismo in concreto prescelto» (ordinanza n. 383).
D’altro canto «il perdurante necessario rispetto dei principi
di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone al legislatore, pur nell’esercizio
del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica
economica e le disponibilità finanziarie, di individuare un meccanismo in grado
di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza
alle variazioni del costo della vita», con la conseguenza che solo «il
verificarsi di irragionevoli scostamenti dell’entità delle pensioni rispetto
alle effettive variazioni del potere d’acquisto della moneta, sarebbe
indicativo della inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare
al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e
dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli artt. 36 e 38
della Costituzione» (sentenza n. 30).
Inoltre, chiamata a valutare gli esiti del passaggio dall’ordinamento
gerarchico delle carriere a quello delle qualifiche funzionali,
Con la sentenza n. 91
Con la sentenza n. 267,
poi, si afferma che «avere riconosciuto la riscattabilità del periodo di studi
universitari […] non significa che il legislatore sia tenuto ad attribuire a
questi lo stesso valore del servizio effettivamente prestato e che non possa
trattare diversamente le due ipotesi secondo le sue scelte discrezionali. In
altri termini, non c’è nulla di irragionevole se il legislatore, con norma di
favore, ha ritenuto di concedere, come nel caso dell’art. 12 del d.P.R. 1092
del 1973, la ricongiunzione gratuita del servizio prestato e non anche del
periodo di studi già riscattato nella precedente gestione previdenziale».
In materia di pensioni privilegiate si segnala, infine, la sentenza n. 44,
che ha scrutinato l’art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, censurato
nella parte in cui prevede la concessione di un trattamento pensionistico
privilegiato per il caso di cittadini deceduti o resi invalidi dallo scoppio di
ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in
tempo di pace «in occasione di esercitazioni combinate o isolate».
8. L’accesso alle cariche elettive
Con l’ordinanza n. 145
In materia tributaria la sentenza n. 285
ha affermato che è «erroneo ritenere che un beneficio fiscale (nella specie,
quello della totale deducibilità dal reddito complessivo degli interessi
passivi pagati sui mutui in questione) previsto dalla pregressa disciplina
normativa di settore (nella specie, dall’art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986)
non possa giammai subire modificazioni in negativo per l’affidamento creato nei
contribuenti; di tal che al legislatore sarebbe impedito di effettuare nuove
valutazioni al fine di ripartire più equamente il carico fiscale».
Nella discrezionalità del legislatore rientra altresì
«prevedere se si debba o non si debba tenere conto degli effetti conseguenti ai
processi di svalutazione monetaria in sede di applicazione delle diverse
imposte dirette o indirette, conseguendone che tale scelta politica non può
considerarsi sindacabile da parte della Corte costituzionale, sempre che non
comporti la violazione di qualche principio costituzionale ovvero non determini
un travalicamento del normale ambito di discrezionalità» (ordinanza n. 289).
In riferimento al c.d. redditometro – che, come noto, è uno
strumento che permette all’amministrazione finanziaria di determinare
presuntivamente il reddito del contribuente sulla base di parametri che, alla
luce di consolidate massime di esperienza, sono indici rivelatori di reddito
del contribuente, e demanda ad un regolamento del Ministro delle finanze la
determinazione dei parametri in base ai quali determinare presuntivamente il
reddito –
Si segnala, infine, l’ordinanza n. 352,
con cui è stato ribadito «che il carattere perentorio di un termine
non deve risultare in modo esplicito dalla norma, ben potendo esso desumersi
dalla funzione che al termine chiaramente assegna la legge, e, dall’altro lato,
[…] che è conforme a Costituzione, e va dall’interprete ricercata, soltanto una
ricostruzione del sistema che non lasci il contribuente esposto, senza limiti
temporali, all’azione esecutiva del fisco».
10. La proprietà e la libertà di
iniziativa economica
La sentenza n. 315
ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3,
42 e 44 della Costituzione, l’art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo,
della legge 3 maggio 1982, n. 203. Tale disposizione, infatti, nel dettare i
criteri per la determinazione del canone per i contratti di affitto di fondi
rustici riguardanti i territori del catasto derivante dall’ex catasto
austro-ungarico, faceva riferimento ad meccanismo di determinazione dell’equo
canone – fondato sulle tabelle di cui alla legge n. 567 del
Viceversa, la sentenza n. 76
ha escluso una lesione del diritto di libertà di iniziativa economica di cui
all’art. 41 della Costituzione da parte dell’art. 24 del d.P.R. n. 43 del 1988,
cui rinvia integralmente l’art. 18 della legge della Regione Siciliana 5
settembre 1990, n. 35.
Tali disposizioni prevedevano che in caso di vacanza della
concessione del servizio di riscossione dei tributi, che si espleta in regime
di concessione amministrativa nei singoli ambiti territoriali, «in attesa del
nuovo conferimento della gestione del servizio» fosse nominato un «commissario
governativo delegato provvisoriamente alla riscossione», scelto fra i soggetti
abilitati che ne avessero fatto richiesta o, in mancanza, in persona del concessionario
di un ambito territoriale contiguo, disponendo inoltre che al commissario «si
applicano le norme stabilite per il concessionario, salvo quanto disposto» nei
successivi articoli. Da un esame dell’articolato normativo del d.P.R. n. 43 del
1988 non hanno trovato riscontro oggettivo le censure del rimettente, volte a
sostenere che le norme impugnate comportassero l’obbligo per il commissario di
gestire l’attività d’impresa con tutti gli oneri gravanti sul concessionario ma
senza averne i diritti, e pertanto anche in condizioni antieconomiche, e che
tale obbligo potesse essere imposto senza un ragionevole limite temporale.
1.1. L’insindacabilità delle opinioni
espresse dai parlamentari
Come noto, riconoscendo ai parlamentari la garanzia dell’insindacabilità
delle opinioni espresse «nell’esercizio delle funzioni», l’art. 68 della Costituzione
non mira certamente a creare un’area di immunità o privilegio a favore di
questi rispetto all’esercizio della giurisdizione, bensì mira «alla tutela dell’autonomia
delle funzioni parlamentari, quale area di libertà politica delle Assemblee
rappresentative» (ordinanza
n. 419).
Benché il naturale terreno di confronto tra funzione
parlamentare e funzione giurisdizionale sia stato e sia tuttora, sul piano
della giustizia costituzionale, quello dei conflitti tra poteri dello Stato, il
2004 si segnala per l’intervento della Corte altresì sul diverso piano del
giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Ad essere oggetto di scrutinio alla luce dell’art. 68 della
Costituzione è stato l’articolo 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140
(Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in
materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), norma
con la quale, secondo i giudici a quibus, il legislatore avrebbe
sostanzialmente inteso estendere l’area dell’insindacabilità al di fuori del
perimetro tracciato dalla norma costituzionale appena citata.
«Così intesa la disposizione censurata si sottrae ai vizi di
legittimità addebitati: essa, come già osservato, non elimina affatto il nesso
funzionale e non stabilisce che ogni espressione dei membri delle Camere, in
ragione del rapporto rappresentativo che li lega agli elettori, sia per ciò
solo assistita dalla garanzia dell’immunità. È pertanto nella dimensione funzionale
che le dichiarazioni in questione possono considerarsi insindacabili: “garanzia
e funzione sono inscindibilmente legate fra loro da un nesso che, reciprocamente,
le definisce e giustifica” (sentenza n. 219 del
2003). Né, d’altra parte, ai fini dell’insindacabilità, la prospettata
necessità della connessione tra attività di critica o di denuncia politica e
atti di funzione parlamentare può essere inficiata dalla precisazione che tali
attività possano essere state espletate “anche fuori del Parlamento”. Tale
precisazione, infatti, nulla aggiunge a quanto ormai è acquisito al patrimonio
giurisprudenziale di questa Corte, che non ha mai limitato la garanzia alla
sede parlamentare, giacché il criterio di delimitazione dell’ambito della
prerogativa non è quello della “localizzazione” dell’atto, ma piuttosto, come
già detto, quello funzionale, cioè riferibile in astratto ai lavori
parlamentari (cfr. sentenza n. 509 del
2002). Solo a queste condizioni l’opinione così manifestata e così qualificata
può essere considerata insindacabile anche quando dia luogo a forme di
divulgazione e riproduzione al di fuori dell’ambito delle attività parlamentari
(cfr. sentenze n.
10, n. 11
e n. 320 del
2000)» (sentenza
n. 120).
In sede di conflitto tra poteri il compito cui
Premesso che «non ogni opinione espressa da un parlamentare
rientra nella previsione dell’art. 68, primo comma, Cost., perché altrimenti l’immunità
si risolverebbe in un privilegio personale confliggente in modo irrimediabile
con principi costituzionali fondamentali e diritti di altri soggetti», occorre
tuttavia sottolineare che «non soltanto “rientrano nella sfera dell’insindacabilità
tutte le opinioni manifestate con atti tipici nell’ambito dei lavori parlamentari”,
ma pure che le attività non tipizzate “si debbono considerare ‘coperte’ dalla
garanzia di cui all’art. 68, nei casi in cui si esplicano mediante strumenti,
atti e procedure, anche ‘innominati’, ma comunque rientranti nel campo di
applicazione del diritto parlamentare, che il membro del Parlamento è in grado
di porre in essere e di utilizzare proprio solo e in quanto riveste tale carica”».
Di conseguenza, «non è decisiva la localizzazione dell’attività in questione
all’interno o all’esterno dei palazzi del Parlamento», proprio perché «per
quanto concerne la divulgazione delle opinioni espresse da parlamentari, quel
che rileva è la sostanziale identità di contenuti fra l’opinione come espressa
in un atto tipico inteso nei sensi suindicati, e quindi caratterizzata dal
nesso funzionale, ed il messaggio che siffatta opinione divulga» (sentenza n. 298).
La sentenza n. 347
si segnala all’attenzione per essersi posta per la prima volta alla Corte la
necessità di risolvere un duplice problema che in precedenza era stato solo
sfiorato da precedenti pronunce. Vale a dire:
(a) il problema della rilevanza, al sopra considerato
fine di individuare l’identità di contenuti tra l’atto funzionale e l’atto
divulgativo, di atti parlamentari posteriori alle dichiarazioni considerate
diffamatorie;
(b) il problema se le dichiarazioni rese da un
senatore o deputato fuori dell’ambito parlamentare, e ritenute da un cittadino
lesive della propria reputazione, possano considerarsi coperte dalla garanzia
prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, qualora divulghino e
riproducano atti posti, nell’esercizio di funzioni parlamentari, da membri del
Parlamento diversi dal loro autore.
Entrambe le questioni sono state risolte dalla Corte in senso
negativo.
In riferimento alla prima questione
Quanto al secondo quesito sopra considerato, quello relativo
alla rilevanza degli atti parlamentari posti in essere da membri del Parlamento
diversi dall’autore della dichiarazione divulgativa potenzialmente
diffamatoria,
La sentenza n. 348
ribadisce poi che «il luogo dove le dichiarazioni sono state rese (all’interno
della sede del Senato) [non] può, di per sé solo, conferire carattere di funzione
parlamentare ad un’intervista privata concessa da un parlamentare ad un
giornalista (sentenza
n. 509 del 2002), giacché anche tale circostanza può attenere semmai ad un “contesto
politico”, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può, di per se
stesso, fare presumere l’esistenza di un nesso funzionale idoneo a rendere
insindacabili le opinioni ivi espresse».
1.2. L’inviolabilità del domicilio
Ai sensi dell’art. 68, secondo comma, della Costituzione, «senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento
può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere
arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione,
salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia
colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza».
La norma, afferma
Tale particolare forma di garanzia del libero svolgimento
delle funzioni parlamentari è stata oggetto del sentenza n. 58, che ha dichiarato la non spettanza
all’autorità giudiziaria del potere di far eseguire, senza autorizzazione della
Camera di appartenenza, una la perquisizione del locale – situato all’interno
della sede di un partito politico – posto nella diretta disponibilità di un
parlamentare. Vicenda dalla quale, tra l’altro, aveva tratto origine un
procedimento penale per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 del codice
penale) nei confronti del parlamentare medesimo che si era opposto a tale perquisizione.
In tale occasione
Passando al merito della questione, ad avviso della Corte l’autorità
giudiziaria, che agiva tramite gli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell’art.
247, comma 3, del codice di procedura penale, una volta ravvisato che all’interno
della suddetta sede vi era un locale nella diretta disponibilità del
parlamentare, onde poteva costituirne domicilio, avrebbe dovuto sospendere l’esecuzione
della perquisizione e chiedere alla Camera la necessaria autorizzazione.
In alternativa – ove avesse nutrito dubbi sull’attendibilità
del contenuto dei cartelli che a tale disponibilità facevano riferimento – avrebbe
potuto disporre gli accertamenti del caso, per eventualmente procedere contro
chi quei cartelli aveva collocato. L’unica scelta sicuramente preclusa all’autorità
giudiziaria, afferma
1.3. Esercizio della giurisdizione e
svolgimento dei lavori parlamentari
Con la sentenza n. 284,
In tale occasione
2.1. Le leggi di interpretazione
autentica
La sentenza n. 168 ha ricapitolato i contorni
della giurisprudenza costituzionale a proposito delle c.d. leggi di
interpretazione autentica. Stabilito che «il legislatore può porre norme che
retroattivamente precisino il significato di altre norme preesistenti, ovvero
impongano una delle possibili varianti di senso del testo originario, purché
compatibile con il tenore letterale di esso», si è precisato che «in tali casi
il problema da affrontare riguarda non tanto la natura della legge, quanto
piuttosto i limiti che la sua portata retroattiva incontra alla luce del principio
di ragionevolezza e del rispetto di altri valori ed interessi
costituzionalmente protetti». Riguardo a questi ultimi, «l’affidamento del
cittadino nella sicurezza giuridica – essenziale elemento dello Stato di
diritto – non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in
regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori»
(nel caso di specie, peraltro, l’invocato affidamento trovava il suo fondamento
non sulla legge, bensì su una normativa secondaria).
La sentenza n. 376 ha, per parte sua, ripreso
precedenti affermazioni secondo cui «ben può il legislatore […] conferire […]
efficacia retroattiva ad una legge anche se essa non si autoqualifichi, né sia,
di interpretazione autentica»: coerentemente con questa premessa, la
giurisprudenza della Corte è da tempo univoca nel ritenere che «quello della
ragionevolezza e del non contrasto con altri valori e interessi
costituzionalmente protetti costituisce il limite della potestà del legislatore
di conferire efficacia retroattiva alla legge»; in effetti, «il divieto di
retroattività della legge – pur costituendo valore di civiltà giuridica e
principio generale dell’ordinamento, cui il legislatore deve in linea di
principio attenersi – non è stato tuttavia elevato a dignità costituzionale,
salva per la materia penale la previsione dell’art. 25 Cost.».
Da tali affermazioni, si
è dedotto che «l’asserita “distorsione della funzione della legge di interpretazione
autentica […] per mascherare norme effettivamente innovative dotate di
efficacia retroattiva” […] non determina, di per sé, l’illegittimità
costituzionale della legge […], ma può, al più, costituirne un indice, dal
momento che occorre pur sempre verificare se siano stati valicati i limiti
sopra indicati al potere del legislatore di conferire efficacia retroattiva
alla legge»; così come, per converso, anche ove la legge sia qualificabile come
di interpretazione autentica, occorre verificare se, esercitando il potere di
chiarire la portata della precedente norma, il legislatore abbia rispettato «i
principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell’affidamento
legittimamente posto sulla certezza dell’ordinamento giuridico e quello del
rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario».
Queste considerazioni,
estrapolate per la gran parte da decisioni degli anni precedenti, sono state
ritenute – ancora, in conformità a precedenti statuizioni – estensibili alle
leggi regionali aventi efficacia retroattiva, anche se non qualificabili come
di interpretazione autentica, all’uopo essendosi ripetuto che «l’art. 11 disp.
prel. cod. civ. non può assumere per il legislatore regionale altro e diverso
significato da quello che esso assume per quello statale, con la possibilità
per l’uno e per l’altro di emanare fuori della materia penale norme legislative
alle quali possa essere attribuita efficacia retroattiva».
2.2.
Le (altre) leggi retroattive
In ordine ai limiti entro i quali la legge può avere effetti
retroattivi, la sentenza
n. 285 ha evidenziato come non
fosse correttamente richiamato dal rimettente il tema della retroattività delle norme tributarie e
il limite di questa rappresentato dalla necessaria coerenza con la capacità
contributiva attuale e non pregressa, in una ipotesi in cui la norma censurata,
nel prevedere una limitazione della facoltà per i contribuenti di portare in
detrazione gli interessi sui mutui di miglioramento agrario, aveva di fatto
preso in considerazione una capacità contributiva attuale e non passata, pur
essendo entrata in vigore quando erano decorsi i primi cinque mesi dell’anno di
riferimento fiscale (infatti, «l’evenienza della retroattività si sarebbe potuta verificare [solo] se la
limitazione della detraibilità degli interessi passivi avesse avuto riguardo a
rapporti non più espressivi di una capacità contributiva attuale»).
2.3. Le leggi provvedimento
Pur senza occuparsi direttamente dello statuto proprio degli
atti legislativi aventi un contenuto provvedimentale,
2.4. La riserva di legge
Tra le statuizioni che hanno riguardato la nozione di
«riserva di legge», può segnalarsi la sentenza n. 316, che, fondandosi sulla natura
di fonti primarie propria dei decreti di attuazione degli statuti speciali, ha
negato che potesse configurarsi, in ordine alle disposizioni dagli stessi
recate, una violazione della riserva di legge prevista dall’art. 108 della
Costituzione.
Due decisioni hanno riguardato specificamente la violazione
del principio della riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione: l’una
si è rifatta alla costante giurisprudenza costituzionale secondo cui tale
riserva va intesa in senso relativo, ponendo al legislatore l’obbligo di
determinare preventivamente ed in misura congrua criteri direttivi di base e
linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa (l’ordinanza n. 297 ha conseguentemente
riconosciuto che, nella disciplina del c.d. «redditometro», la riserva era
stata rispettata, in quanto la legge impugnata stabiliva che il regolamento doveva
prendere in considerazione elementi e circostanze di fatto certi e fissava
delle linee direttive cui si doveva attenere, perché fosse valido, l’accertamento
compiuto tramite regolamento, facendo comunque salva la possibilità di prova
contraria da parte del contribuente); l’altra decisione ha evidenziato
come, stante la riserva di legge che copre tutto l’ambito delle prestazioni
patrimoniali imposte, e che comporta la necessità di disciplinare a livello
legislativo quanto meno gli aspetti fondamentali dell’imposizione, e data l’assenza
di poteri legislativi in capo agli enti sub-regionali, dovesse ben essere
definito, tra l’altro, l’ambito entro cui si sarebbe potuta esplicare la
potestà regolamentare degli enti medesimi in ordine ai tributi locali (sentenza n. 37).
2.5. La delegazione legislativa
Per quanto attiene all’esercizio della funzione legislativa
delegata, l’ordinanza
n. 355, riprendendo affermazioni
consolidate nella giurisprudenza precedente, ha stabilito che essa «si
esaurisce con l’emanazione del decreto presidenziale entro il termine fissato
dalla legge di delega», con il che la pubblicazione del decreto, «pur indispensabile
per l’entrata in vigore dell’atto legislativo, costituisce un fatto esterno e
successivo all’esercizio della funzione stessa e pertanto non necessariamente
deve avvenire nel termine suddetto».
Con specifico riguardo alla normativa costituzionale
invocabile allorché si faccia questione di un rapporto di delegazione, è stato
ribadito che gli articoli 76 e 77 della Costituzione sono parametri che
«reggono soltanto i rapporti fra legge delegante e decreto legislativo
delegato, […] ed è pertanto fuor d’opera assumerli quale stregua del giudizio
di costituzionalità […] qualora sia questione di una norma contenuta in un atto
estraneo a quei rapporti» (ordinanza n. 159). Di questo principio è stata
fatta applicazione allorché è stata dichiarata la manifesta inammissibilità di
una questione, sollevata in riferimento all’art. 76, con la quale il rimettente
poneva «un problema di mancato esercizio della delega in relazione non al
decreto delegato emanato in attuazione della delega stessa, bensì ad una norma
anteriore […] ed estranea al rapporto di delegazione legislativa» (ordinanza n. 294); il parametro costituito dall’art.
76 della Costituzione è stato ritenuto parimenti inconferente in relazione all’impugnazione
di una norma che non era stata emanata nell’esercizio della funzione
legislativa delegata (ordinanza n. 355). Il richiamo all’art. 76
(oltre che all’art. 70) è stato ritenuto precluso anche nei casi in cui
«oggetto di censura non [fosse] la violazione di uno specifico criterio
direttivo, ma il merito della scelta operata dal legislatore» (ordinanza n. 297).
Nel quadro del sindacato inerente alla delegazione
legislazione, è stato anche sottolineato che, «ai fini della valutazione del
vizio di eccesso di delega, le norme della legge di delegazione che determinano
i principi e i criteri direttivi devono essere interpretate tenendo conto del
complessivo contesto normativo e delle finalità ispiratrici della delega» (ordinanza n. 248); resta peraltro inteso che,
«anche ove dubiti del rispetto dei limiti della delega, il giudice deve
privilegiare […] l’interpretazione idonea a superare i dubbi di costituzionalità»
(ordinanza n. 214).
Alla luce di tali principi,
Sul tema in esame, tuttavia, la decisione di maggior
interesse nel corso dell’anno è, con ogni probabilità, costituita dalla sentenza n. 280, avente ad oggetto il conferimento
di una delega al Governo, ai termini dell’art. 1 della legge 5 giugno 2003, n.
131 (c.d. «legge
Sulla scorta di questo rilievo, la delega legislativa non può
non essere letta in funzione della mera predisposizione di «un quadro
ricognitivo di principi già esistenti, utilizzabile transitoriamente fino a
quando il nuovo assetto delle competenze legislative regionali, determinato dal
mutamento del Titolo V della Costituzione, andrà a regime, e cioè [appunto]
fino al momento della “entrata in vigore delle apposite leggi con le quali il
Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali”».
Alla luce di ciò,
Le stesse norme procedurali previste dalla delega sono state
poste a suffragio di questa ricostruzione, nella misura in cui «dispongono un’articolata
serie di pareri obbligatori della Conferenza Stato-Regioni, delle commissioni
parlamentari competenti e infine quello definitivo della Commissione parlamentare
per le questioni regionali sugli schemi dei decreti legislativi, al fine
esclusivo di rilevare se “non siano stati indicati alcuni dei principi
fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo
dei principi fondamentali […] ovvero si riferiscano a norme vigenti che non
abbiano la natura di principio fondamentale”».
La lettura «minimale» che della delegazione legislativa è
stata data (assimilabile, «date le reciproche implicazioni tra attività
ricognitiva e attività di coordinamento normativo, a quella di compilazione dei
testi unici […] per il coordinamento e la semplificazione di una pluralità di
disposizioni vigenti in una determinata materia») ha fatto sì che risultassero
costituzionalmente illegittimi i commi 5 e 6 dello stesso art. 1, che
indirizzavano, in violazione dell’art. 76 della Costituzione, l’attività
delegata del Governo in termini di «determinazione-innovazione» dei principi,
sulla base di forme di ridefinizione delle materie e delle funzioni, senza che
tale attività fosse astretta dall’indicazione di criteri direttivi: il comma 5
disponeva, infatti, che nei decreti legislativi di cui al comma 4 potevano
essere «individuate le disposizioni che riguarda[va]no le stesse materie, ma
che rientra[va]no nella competenza esclusiva dello Stato», estendendo in tal
modo l’oggetto della delega anche all’asserita ricognizione, nell’ambito delle
materie riservate al legislatore statale, della disciplina di quelle funzioni
che avevano natura trasversale; il comma 6, dal canto suo, indicava i criteri
direttivi della delega facendo espresso riferimento ai «settori organici della
materia», nonché ai criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e
da quelle «affini, presupposte, strumentali e complementari», allo scopo di
individuare i principi fondamentali vigenti, venendo così ad alterare il
carattere ricognitivo dell’attività delegata al Governo in favore di forme di
attività di tipo selettivo.
Infine, giova segnalare come, sempre nella sentenza n. 280, sia stato ribadito, per quanto
incidentalmente, che, «in determinate circostanze, l’enunciazione di principi
fondamentali relativi a singole materie di competenza concorrente può anche
costituire oggetto di un atto legislativo delegato senza ledere attribuzioni
regionali».
2.6. La decretazione d’urgenza
Per quanto attiene alle condizioni previste dall’art. 77,
secondo comma, della Costituzione ai fini del valido esercizio della funzione
legislativa attraverso l’emanazione di decreti legge, nella giurisprudenza
costituzionale del 2004 è stato ripetutamente affermato – in consonanza anche
con prese di posizione precedenti – che il sindacato sulla esistenza e sull’adeguatezza
dei presupposti per la decretazione di urgenza può essere esercitato solo in
presenza di una situazione di «evidente mancanza» dei requisiti stessi.
In applicazione di questo principio, più volte ribadito nella
giurisprudenza del 2004,
Analogamente, i presupposti non sono stati ritenuti carenti
per il caso in cui la decretazione d’urgenza dettava una disciplina transitoria
resasi necessaria ai fini della predisposizione di una disciplina attuativa –
assente nel diritto positivo – di un diritto quale quello alla difesa di
ufficio in favore di genitori e minori (sentenza n. 178).
Nella sentenza n. 196,
Infine, l’affermazione secondo cui il porsi di un decreto
legge «a conclusione di una serie di decreti legge non convertiti» avrebbe reso
«manifesta l’insussistenza […] della straordinaria necessità ed urgenza di
emanare disposizioni concernenti la semplificazione di talune disposizioni in
materia tributaria» è stata ritenuta inidonea a dimostrare la «evidente» la
mancanza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d’urgenza da parte
del Governo (sentenza
n. 285).
Sugli ambiti normativi che sono suscettivi di
regolamentazione mediante decreto legge, le sentenze numeri 6 e 196 hanno
chiarito che tale atto «può di per sé costituire legittimo esercizio dei poteri
legislativi che
Altro aspetto su cui la sentenza n. 196 è intervenuta è quello inerente
al requisito di omogeneità dell’oggetto del decreto legge: sul punto, è stato
chiarito che tale carattere, «seppur opportunamente previsto dal comma 3 dell’art.
15 della legge 23 agosto 1988, n. 400», non integra un requisito
costituzionalmente imposto.
3. Il Presidente della Repubblica
Con la sentenza n. 154
Tale pronuncia, i cui risvolti sul piano dei profili
processuali della vicenda sono stati già esaminati, ha consentito per la prima
volta di affrontare il tema dei limiti entro i quali le dichiarazioni per cui
era giudizio dovevano ritenersi coperte dalla immunità sancita dall’art. 90 della
Costituzione per gli atti del Presidente della Repubblica compiuti nell’esercizio
delle sue funzioni.
Nel merito,
«Infatti la giurisdizione costituzionale sui conflitti» -– ha
osservato
Ciò premesso,
Di conseguenza, appare «necessario tenere ferma la
distinzione fra atti e dichiarazioni inerenti all’esercizio delle funzioni, e
atti e dichiarazioni che, per non essere esplicazione di tali funzioni, restano
addebitabili, ove forieri di responsabilità, alla persona fisica del titolare
della carica, che conserva la sua soggettività e la sua sfera di rapporti
giuridici, senza confondersi con l’organo che pro tempore impersona»,
per cui «la possibilità che nell’ambito dell’esercizio delle funzioni possano
rientrare, in determinate ipotesi, attività o dichiarazioni intese a difendere
l’istituzione presidenziale non può mai tradursi automaticamente in una
estensione della immunità a dichiarazioni extrafunzionali per la sola circostanza
che esse siano volte a difendere la persona fisica del titolare della carica e,
come tali, possano indirettamente influire sul suo prestigio o sulla sua “legittimazione”
politica».
In conclusione, viene ribadita anche per l’insindacabilità, o
irresponsabilità delle dichiarazioni rese dal Presidente della Repubblica ex
art. 90 della Costituzione, la validità della teoria del “nesso funzionale”,
già elaborata a proposito delle dichiarazioni rese da parlamentari ai sensi
dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
4. La pubblica amministrazione ed il
pubblico impiego
Ai sensi dell’art. 97, primo comma, della Costituzione, «i
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione»,
mentre ai sensi del terzo comma «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».
A tali parametri costituzionali hanno fatto diretto
riferimento le due pronunce di illegittimità costituzionale che qui si
segnalano.
In primo luogo, la sentenza n. 186
ha dichiarato – in quanto giudicato irragionevole e lesiva del principio del
buon andamento – l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della
legge n. 97 del 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e
procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevedeva, per
i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge, l’instaurazione
dei procedimenti disciplinari entro centoventi giorni dalla conclusione del
procedimento penale con sentenza irrevocabile di condanna, anziché entro il
termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione
o all’ente competente per il procedimento disciplinare.
A tale conclusione
Per cui, ha osservato
In conclusione, «nel ponderare l’interesse del dipendente
pubblico ad ottenere una sollecita definizione della propria situazione
disciplinare e l’esigenza dell’amministrazione di instaurare tale procedimento,
il legislatore ha adottato una soluzione sbilanciata a vantaggio del dipendente
pubblico, nel senso che gioca a favore di quest’ultimo lo scorrere del tempo
necessario per venire in possesso di una notizia (sentenza penale di condanna)
che invece dovrebbe essere comunicata ab initio all’amministrazione»
In un secondo caso
5.1. I rapporti tra giurisdizioni
Partendo dalla ricorrente premessa che «non si può affermare,
in linea di principio, che dinanzi al giudice amministrativo sia offerta una
tutela meno vantaggiosa o appagante di quella che si avrebbe davanti al giudice
ordinario», l’ordinanza
n. 301 ha confermato la ragionevolezza di una scelta legislativa,
condizionata anche dalla specialità del rapporto, che riserva al giudice
amministrativo la cognizione delle controversie relative agli addebiti disciplinari
degli autoferrotranvieri.
Tuttavia proprio il confronto fra le due giurisdizioni,
quella ordinaria e amministrativa, ha dato origine a quella che è probabilmente
la pronuncia più importante, in materia, resa dalla Corte negli ultimi anni: la
sentenza n. 204,
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 33, comma 1, e
34, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998, come sostituiti dalla
legge n. 205 del 2000.
Con essa
Con essa
In particolare, poi, ha sottolineato che il «necessario
collegamento delle “materie” assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive – e cioè con
il parametro adottato dal Costituente come ordinario discrimine tra le
giurisdizioni ordinaria ed amministrativa – è espresso dall’art. 103 là dove
statuisce che quelle materie devono essere “particolari” rispetto a quelle
devolute alla giurisdizione generale di legittimità: e cioè devono partecipare
della loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la
pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è
accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo».
Alla luce di tale esegesi del dettato normativo dell’art.
103, primo comma, della Costituzione,
Con una decisione senza dubbio meno significativa, in quanto
limitata ad esaminare la censura di difetto di delega della norma impugnata nel
testo anteriore alla sua sostituzione ad opera della legge n. 205 del 2000,
In tema di rapporti tra giurisdizioni, merita, infine,
segnalare l’ordinanza
n. 214, con cui
5.2. Il Consiglio di giustizia
amministrativa per
Con la sentenza n. 316
Con essa
Inoltre,
L’aspetto forse più caratterizzante, nel complesso, della
giurisprudenza costituzionale del 2004 è dato dal gran numero di interventi che
Scorrendo i titoli dei paragrafi, si intuiscono alcuni dei
problemi su cui
2. Un regionalismo cooperativo
È unanime la constatazione dell’importanza assunta dalla
giurisprudenza costituzionale al fine di conformare al modello cooperativo il
regionalismo italiano. L’aderenza a questo modello, che ha ottenuto
significativi riscontri anche con la revisione del Titolo V operata con la
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
Nel corso del 2004 non mancano, ovviamente, esempi anche
molto pregnanti: il caso della sentenza n. 6, nella quale si è posta una
particolare enfasi sulla necessità di «intese forti», è probabilmente
paradigmatico. Su tale decisione, come su varie altre che affrontano, funditus o anche incidenter tantum, il tema della leale cooperazione, si rinvia a
quanto verrà detto trattando dei rapporti tra enti territoriali relativamente
al riparto delle competenze (v. infra,
par. 4 e seguenti; con particolare riferimento alla sentenza n. 6, v. par. 4.5).
In questa sede, per le affermazioni di ordine generale che
reca, merita una segnalazione la statuizione contenuta nella sentenza n. 27, con cui è stato risolto il
conflitto di attribuzione tra
Onde giungere alla declaratoria di non spettanza allo Stato
del potere esercitato, si rileva che, nell’applicazione del principio di leale
cooperazione in tema di intese,
Ora, l’intesa deve essere realizzata e ricercata anche
attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino
il raggiungimento di un accordo, «senza alcuna possibilità di un declassamento
dell’attività di codeterminazione connessa all’intesa in una mera attività
consultiva non vincolante». Nel caso di specie,
3.1. Statuti speciali, decreti di
attuazione e manifestazioni della specialità
Tra le pronunzie nelle quali
All’uopo si è rilevato che la peculiare struttura
organizzativa e la composizione di tale organo, delineata, da ultimo, con norma
di attuazione dello Statuto (decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373),
costituiscono espressione del principio di specialità, contenuto nell’articolo
23 dello Statuto, che riafferma una aspirazione, saldamente radicata nella
storia della Sicilia, ad ottenere forme di decentramento territoriale degli
organi giurisdizionali centrali.
Nella stessa decisione,
Con riferimento all’importanza dei decreti di attuazione
degli statuti ai fini di proteggere le prerogative proprie delle Regioni
speciali e delle Province autonome, deve sottolinearsi come la sentenza n. 236 abbia dichiarato
costituzionalmente illegittimo l’art. 10, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, il quale prevedeva che «ai commissariati del Governo di Trento e di
Bolzano si applicano le disposizioni del d.P.R. 17 maggio 2001, n. 287,
compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di
attuazione», in quanto con tale disposizione lo Stato aveva disciplinato le
funzioni del Commissario di Governo unilateralmente e rinviando ad una fonte
secondaria, non dando corso, in tal modo, alla procedura collaborativa diretta
all’approvazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale.
La sentenza n. 236 contiene un’altra affermazione di rilievo concernente la specialità
regionale. In un passaggio di questa,
3.2. La potestà statutaria delle
Regioni a statuto ordinario
Nel corso del 2004,
Nelle decisioni, articolate in base alla pluralità di censure
prospettate nei ricorsi statali, sono stati molteplici i profili analizzati.
Onde dare un quadro compiuto di questa giurisprudenza, di seguito si riporta
una sintesi delle rationes decidendi
argomentate sui singoli punti.
3.2.1. La potestà statutaria ed i suoi limiti
Nel giudizio concluso con la sentenza n. 2,
Dopo la eliminazione della approvazione dello statuto regionale
da parte del Parlamento, i limiti a questa rilevante autonomia normativa
possono derivare solo da norme chiaramente deducibili dalla Costituzione.
Peraltro, gli statuti regionali non solo debbono rispettare
puntualmente «ogni disposizione della Costituzione», ma debbono altresì
rispettarne lo spirito, in nome della «armonia con
3.2.2. Le enunciazioni di principio
Nelle sentenze numeri 372, 378 e 379 si
dichiara la inammissibilità delle censure formulate nei confronti delle
enunciazioni statutarie aventi ad oggetto proposizioni che rientrano tra i
principi generali e le finalità principali (esemplificando: estensione del diritto di voto agli
immigrati, riconoscimento delle altre forme di convivenza, tutela dell’ambiente
e del patrimonio culturale), in quanto, pur incidendo su materie
eccedenti la sfera di attribuzione regionale, esse risultano comunque prive di
idoneità lesiva.
Argomenta
D’altra parte, tali proclamazioni di obiettivi e di impegni
non possono certo essere assimilate alle c.d. norme programmatiche della
Costituzione, alle quali, per il loro valore di principio, sono stati
generalmente riconosciuti non solo un valore programmatico nei confronti della
futura disciplina legislativa, ma soprattutto una funzione di integrazione e di
interpretazione delle norme vigenti.
Avendo riguardo agli statuti regionali, però, non si è in
presenza di carte costituzionali, ma solo di fonti regionali «a competenza
riservata e specializzata», cioè di statuti di autonomia, i quali, anche se
costituzionalmente garantiti, debbono comunque «essere in armonia con i
precetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione» (sentenza n. 196
del 2003).
In definitiva, le enunciazioni statutarie in esame,
esplicando una funzione di natura culturale o anche politica, ma certo non
normativa, non comportano né alcuna violazione né alcuna rivendicazione di
competenze costituzionalmente attribuite allo Stato e neppure possono
costituire in alcun modo il fondamento dell’esercizio di poteri da parte delle
Regioni.
a) Chiamata a giudicare la forma di governo prescelta
dalla Regione Calabria,
Sulla base di tale premessa,
Trattasi, in altri termini, di un procedimento di elezione
diretta del Presidente e del Vice Presidente che è soltanto mascherato da una
sorta di obbligatoria «presa d’atto» da parte del Consiglio regionale.
A ciò si aggiunga che l’eliminazione del potere presidenziale
di fare eventualmente venir meno, tramite le proprie dimissioni, la permanenza
in carica dello stesso Consiglio regionale, riduce radicalmente i suoi poteri
di indirizzo a beneficio, in primis,
del Vice Presidente, che ne può disporre ove subentri nella presidenza.
In definitiva, il sistema configurato, che, al di là del dato
formale, resta connotato dall’elezione diretta, viola l’art. 122, quinto comma,
nella parte in cui prevede l’elezione diretta anche del Vice Presidente, e l’art.
126, terzo comma, della Costituzione, nella misura in cui riduce oltre il
consentito i poteri del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e
diretto.
b) Immune da censure (sentenza n. 372), perché coerente con il
sistema previsto dalla Costituzione circa i rapporti tra Consiglio regionale e
Presidente di Giunta eletto a suffragio universale e diretto si rivela, invece,
la previsione statutaria della Toscana, nella parte in cui stabilisce che «il
programma di governo è approvato entro 10 giorni dalla sua illustrazione». In
effetti, l’approvazione consiliare non appare affatto incoerente rispetto allo
schema elettorale «normale» accolto dall’art. 122, quinto comma, della Costituzione,
giacché la eventuale mancata approvazione consiliare può avere solo rilievo
politico, ma non determina alcun effetto giuridicamente rilevante sulla
permanenza in carica del Presidente della Giunta, ovvero sulla composizione di
quest’ultima.
c) Parimenti, la previsione statutaria della Regione
Emilia-Romagna, secondo cui il Consiglio regionale discute ed approva il
programma di governo predisposto dal Presidente della Regione ed annualmente ne
verifica l’attuazione, non introduce un rapporto diverso rispetto a quello che
consegue all’elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell’esecutivo.
Precisa, a tal riguardo,
a) Alle norme statutarie è preclusa la determinazione
del sistema elettorale regionale. Motiva
b) Non compete allo Statuto, ed è pertanto
costituzionalmente illegittima (sentenza n. 378), la previsione statutaria
della Regione Umbria che stabilisce l’incompatibilità della carica di
componente della Giunta con quella di consigliere regionale: ciò in quanto il
riconoscimento, nell’articolo 123 della Costituzione, del potere statutario in
tema di forma di governo regionale deve essere associato alla previsione dell’articolo
122 della Costituzione, che riserva espressamente alla legge regionale, «nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica», la
determinazione delle norme relative al «sistema di elezione» ed ai «casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali».
c) Con identica motivazione viene dichiarata (sentenza n. 379) la illegittimità costituzionale
della disposizione, contenuta nella delibera statutaria dell’Emilia-Romagna,
che prevede l’incompatibilità di assessore con quella di consigliere regionale.
La disposizione statutaria della Regione Toscana, nella parte
in cui, ai fini dell’abrogazione referendaria di una legge o di un regolamento
regionale, richiede che partecipi alla votazione la maggioranza dei votanti
alle ultime elezioni regionali, non contrasta con alcuna disposizione della
Costituzione né con il principio di ragionevolezza. Rileva a tal proposito
Né, d’altra parte, appare irragionevole, in un quadro di
rilevante astensionismo elettorale, stabilire un quorum strutturale che non sia rigido, ma che si connoti, invece,
di una certa flessibilità, tale da assicurare un adeguamento ai flussi
elettorali, tanto più allorché il parametro di riferimento sia costituito dalla
partecipazione del corpo elettorale alle ultime votazioni del Consiglio
regionale, i cui atti appunto costituiscono oggetto della consultazione
referendaria.
3.2.6. I diritti di partecipazione alle funzioni regionali
La delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, che
prevede la possibilità di una istruttoria in forma di contraddittorio pubblico,
indetta dalla assemblea legislativa ed alla quale possono prendere parte anche
associazioni ed altre formazioni sociali, per la formazione di atti normativi o
amministrativi di carattere generale, i quali dovranno poi essere motivati con
riferimento alle risultanze istruttorie, non comporta aggravi procedurali che
violino il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Tale
previsione, ad avviso della Corte (sentenza n. 379), è chiaro indice dell’inserimento,
anche al livello statutario, di istituti già sperimentati e funzionanti anche
in alcune delle maggiori democrazie contemporanee. Questi, lungo dall’essere
finalizzati ad ostacolare i poteri degli organi legislativi ed amministrativi,
mirano a migliorare ed a rendere più trasparenti le procedure di raccordo degli
organi rappresentativi con i soggetti (maggiormente) interessati dalle diverse
politiche pubbliche.
Quanto al fatto che «il provvedimento finale è motivato con
riferimento alle risultanze istruttorie», basta considerare che la legge sul
procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) non impone, ma certo
non vieta, la motivazione degli atti normativi; ed in ogni caso – come noto –
la motivazione degli atti amministrativi generali, nonché di quelli
legislativi, è la regola nell’ordinamento comunitario: alla luce di tali
rilievi, la fonte statutaria di una Regione può ben operare proprie scelte in
questa direzione.
Neppure la normativa statutaria che prevede un «diritto di
partecipazione» al procedimento legislativo in capo a «tutte le associazioni»
che ne facciano richiesta viola alcuna disposizione costituzionale: inserendo
siffatte previsioni,
La disposizione statutaria dell’Emilia-Romagna che prevede
che
Resta, peraltro, nell’area delle possibili determinazioni
delle Regioni la scelta di coinvolgere in altre forme di consultazione o di
partecipazione soggetti che comunque prendano parte consapevolmente e con
stabilità – almeno relativa – alla vita associata, anche a prescindere dalla
titolarità del diritto di voto e dalla cittadinanza italiana.
3.2.7. I testi unici regionali
La disposizione statutaria della Regione Umbria, che prevede
che
3.2.8. La titolarità e la tipologia del potere regolamentare
a) Sulla scorta del precedente costituito dalla sentenza n. 313 del
2003,
b) La disposizione statutaria della Regione Umbria, che
prevede che
3.2.9. Le Regioni ed il diritto comunitario
a) La norma dello statuto della Toscana che prevede che
gli organi di governo ed il Consiglio regionale partecipano, nei modi previsti
dalla legge, alla formazione ed all’attuazione degli atti comunitari nelle
materie di competenza regionale, non viola le competenze assegnate dalla
Costituzione allo Stato (sentenza n. 372). In effetti, nel quadro delle
norme di procedura che la legge statale di cui all’art. 117, quinto comma,
della Costituzione determina in via generale ai fini della partecipazione delle
Regioni alla formazione ed attuazione degli atti comunitari, la disposizione
statutaria impugnata prevede unicamente la possibilità che la legge regionale
stabilisca, a sua volta, uno specifico procedimento interno diretto a fissare
le modalità attraverso le quali si forma la relativa decisione regionale, nell’ambito
dei criteri organizzativi stabiliti, in sede attuativa, dall’art. 5 della legge
5 giugno 2003, n. 131.
b) La delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna,
secondo cui
Nella sentenza n. 379, tale prospettazione è stata
disattesa, in considerazione del fatto che la disposizione statutaria
disciplina, in generale, i rapporti tra le leggi ed i regolamenti regionali,
dando per presupposta la titolarità da parte della Regione dei poteri normativi
nelle varie materie; essa non pone, pertanto, il problema dei limiti
sostanziali e procedimentali che si impongono a tali poteri. D’altra parte,
nulla di difforme rispetto a quanto disposto è stato previsto dalla
legislazione statale di attuazione del nuovo Titolo V.
3.2.10. Le Regioni ed il diritto internazionale
La disposizione statutaria dell’Emilia-Romagna che prevede
che
3.2.11.
La previsione dello statuto umbro che attribuisce alla
Commissione di garanzia statutaria la funzione di esprimere pareri sulla conformità
allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali non può essere intesa nel
senso del conferimento ad un organo amministrativo del potere di sindacare gli
atti adottati dai competenti organi regionali. In proposito, nella sentenza n. 378 si evidenzia che le condizioni,
le forme ed i termini per lo svolgimento delle funzioni della Commissione sono
demandate ad una apposita legge regionale che dovrà disciplinare analiticamente
i poteri di questo organo nelle diverse fasi nelle quali potrà essere chiamato
ad esprimere pareri giuridici. In ogni caso,
3.2.12. Il conferimento di funzioni amministrative ed il principio di sussidiarietà
a) Nel ricorso statale si censura la disposizione della
delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna che prevede che «
Nella sentenza n. 379,
Di contro, il conferimento agli enti locali di funzioni
amministrative nelle materie di competenza legislativa delle Regioni tramite
apposite leggi regionali presuppone, non solo una previa valutazione da parte
del legislatore regionale delle concrete situazioni relative ai diversi settori
(alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) in riferimento
alle caratteristiche proprie del sistema di amministrazione locale esistente
sul territorio regionale, ma anche la perdurante ricerca del migliore modello
possibile di organizzazione del settore.
Con ciò, ad essere presupposta è anche la possibilità di
modificare la legislazione sulla base dei risultati conseguiti ed al fine di
una eventuale sperimentazione di diversi modelli possibili.
Altra disposizione della delibera statutaria della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi della quale l’assemblea legislativa individua, «in conformità
con la disciplina stabilita dalla legge dello Stato», le funzioni della Città
metropolitana dell’area di Bologna, è ritenuta dalla Corte non in contrasto con
l’art. 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione, nella misura in cui subordina espressamente l’esercizio dei
poteri regionali al rispetto della «disciplina stabilita dalla legge dello
Stato». D’altra parte, il secondo comma dell’articolo 118 della Costituzione,
nell’affidare il potere di «conferimento» delle funzioni amministrative anche
alla legge regionale, fa esplicito riferimento alle Città metropolitane.
b) La previsione statutaria della Toscana in cui si
stabilisce che l’organizzazione delle funzioni amministrative conferite agli
enti locali, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, possa
essere disciplinata con legge regionale per assicurare requisiti essenziali di
uniformità non lede la riserva di potestà regolamentare attribuita dall’art.
117, sesto comma, della Costituzione agli enti locali in ordine all’organizzazione
ed allo svolgimento delle funzioni loro conferite (sentenza n. 372). La disposizione, in effetti,
fa evidente riferimento alle diverse ipotesi di applicazione del principio di
sussidiarietà previste dalla Costituzione, operando una deroga rispetto al criterio
generale accolto da altra disposizione statutaria, che riserva alla potestà
regolamentare degli enti locali la disciplina dell’organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni conferite.
In particolare, una deroga siffatta si inserisce nell’ambito
della previsione del sesto comma dell’art. 117, come attuato dall’art. 4, comma
4, della legge n. 131 del 2003, secondo cui la potestà regolamentare dell’ente
locale in materia di organizzazione e svolgimento delle funzioni si esplica
nell’ambito delle leggi statali e regionali, che ne assicurano i requisiti minimi
di uniformità: la previsione statutaria di un regime di riserva assoluta
(anziché relativa) di legge regionale è dunque ammissibile purché sia limitata,
per non comprimere eccessivamente l’autonomia degli enti locali, ai soli casi
di sussistenza di «specifiche esigenze unitarie».
Del resto, negando tale facoltà, si perverrebbe all’assurda
conclusione che, al fine di evitare la compromissione di precisi interessi
unitari che postulano il compimento di determinate attività in modo
sostanzialmente uniforme, il legislatore regionale non avrebbe altra scelta che
allocare – in violazione del principio di sussidiarietà – le funzioni in
questione ad un livello di governo più comprensivo, assicurandone così l’esercizio
unitario.
3.2.13. I dipendenti della Regione
a) Con riguardo alla disciplina dello Statuto della Calabria
relativa al «regime contrattuale dei dirigenti»,
b) La delibera statutaria della Regione
Emilia-Romagna, nella parte in cui prevede che la disciplina del rapporto di
lavoro del personale regionale venga regolata in conformità ai principi
costituzionali e secondo quanto stabilito dalla «legge» e dalla contrattazione
collettiva, non lede la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento
civile». Ritiene
In buona sostanza, la disposizione in esame assume un
significato meramente ricognitivo del rapporto tra legislazione e
contrattazione, alla luce dei principi costituzionali, nella disciplina del
rapporto di lavoro del personale regionale.
3.2.14. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi regionali
Nella sentenza n. 372 si rileva che la disposizione
statutaria della Regione Toscana la quale stabilisce il diritto di accesso,
senza obbligo di motivazione, ai documenti amministrativi si conforma al
principio costituzionale di imparzialità e di trasparenza dell’azione
amministrativa ed è altresì del tutto coerente con l’evoluzione del diritto
comunitario (previsioni siffatte sono peraltro presenti anche nella
legislazione statale, ad esempio in materia di tutela ambientale).
Essa, inoltre, in quanto attinente ai principi fondamentali
di organizzazione e di funzionamento della Regione, rientra strettamente tra
gli oggetti di disciplina statutaria.
In ogni caso, la prevista legge di attuazione dovrà prevedere
criteri e modi in base ai quali l’interesse personale e concreto del
richiedente si contemperi adeguatamente con l’interesse pubblico al buon
andamento dell’amministrazione, nonché con l’esigenza di non vanificare in
concreto la tutela giurisdizionale delle posizioni di eventuali soggetti terzi
interessati.
a)
Di tali contenuti ulteriori non può farsi dunque questioni in
termini di legittimità, ma, al più in relazione alla loro opinabile efficacia
giuridica. Nel caso di specie, peraltro, i riferimenti alla potestà tributaria
non vanno oltre una parafrasi di quanto contenuto nei commi secondo, terzo e
quinto dell’art. 119, nonché nel comma primo dell’art. 120 della Costituzione.
b) Nell’impugnare la disposizione dello statuto della
Toscana secondo cui «la legge disciplina, limitatamente ai profili coperti da
riserva di legge, i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli
enti di istituirli», lo Stato ha dedotto che con essa si prevederebbe un
rapporto tra fonti normative «che è invece solo uno di quelli possibili,
costituzionalmente rimessi alle valutazioni ed alle scelte del legislatore
nazionale nel momento in cui darà attuazione all’art. 119 della Costituzione».
Disattendendo tali censure,
In ogni caso, la norma censurata deve essere interpretata nel
senso che, in base all’art. 119, secondo comma, della Costituzione, la legge regionale
deve attenersi ai principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario
appositamente dettati dalla legislazione statale «quadro» o, in caso di inerzia
del legislatore statale, a quelli comunque desumibili dall’ordinamento.
4. La ripartizione delle competenze
Nel corso del 2004, sono quanto mai numerose le statuizioni
che hanno riguardo il riparto di competenze tra gli enti territoriali. Senza
poter dare conto in modo completo di tutte le questioni, nei paragrafi che
seguono si è cercato di indicare le decisioni più significative (rectius, i passi più significativi delle
decisioni) in tema di individuazione degli ambiti competenziali. L’attenzione
si è concentrata essenzialmente sulle attribuzioni legislative; gli altri tipi
di attribuzioni (segnatamente, regolamentari ed amministrative) non sono comunque
state neglette, nella misura in cui di esse si è dato conto nel contesto dell’analisi
delle singole decisioni, ovviamente quando ciò risultasse opportuno e non si
traducesse in un eccessivo appesantimento della trattazione.
4.1. Le materie attinenti alla
competenza esclusiva dello Stato
4.1.1. «Difesa e Forze armate»
Nella sentenza n. 228,
La riserva di competenza allo Stato non comporta, tuttavia,
che ogni aspetto dell’attività dei cittadini che svolgono detto servizio sia
disciplinato da fonte statale. È dunque compito dello Stato quello di
disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio.
D’altra parte, nel servizio civile investono i più diversi
ambiti materiali, dall’assistenza sociale alla tutela dell’ambiente alla
protezione civile: le relative attività restano soggette – scil., per gli aspetti di rilevanza pubblicistica – alla disciplina
dettata dall’ente rispettivamente competente, e dunque, non necessariamente a
quella statale, ma anche a quella regionale e, se del caso, anche a quella
degli enti locali.
Come è chiaro, nelle ipotesi in cui lo svolgimento delle
attività di servizio civile ricada entro ambiti di competenza delle Regioni o
delle Province autonome di Trento e Bolzano, l’esercizio delle funzioni
spettanti, rispettivamente, allo Stato ed ai suddetti enti, dovrà improntarsi
al rispetto del principio della leale collaborazione tra gli enti costitutivi
della Repubblica.
L’inquadramento competenziale del «servizio civile nazionale»
non esclude, peraltro, che le singole Regioni o Province autonome istituiscano,
nell’autonomo esercizio delle proprie competenze legislative, un proprio servizio
civile regionale o provinciale, distinto da quello nazionale, il quale avrebbe
natura «sostanzialmente diversa» dal servizio civile nazionale, non essendo
riconducibile al dovere di difesa.
Questa affermazione, contenuta nella sentenza n. 228, avrebbe potuto avere diretta
applicazione nella sentenza n. 229, che definisce un giudizio
promosso dallo Stato avverso una legge regionale istitutiva, appunto, del
«servizio civile regionale». In concreto, peraltro, l’oggetto dell’impugnativa
era circoscritto alla disposizione che reca la previsione di una comunicazione
agli Uffici di leva dei nominativi di coloro che, svolgendo il servizio civile
regionale, abbiano comunque voluto dichiarare la loro obiezione di coscienza al
servizio militare, nella prospettiva e nell’eventualità che esso possa rivivere
come servizio obbligatorio. La disposizione è stata ritenuta dalla Corte come
mera estrinsecazione di uno spirito di collaborazione tra uffici regionali ed
uffici statali: da ciò la dichiarazione di infondatezza del ricorso,
argomentato su una pretesa invasione di competenze statali.
4.1.2. «Tutela della concorrenza»
Con la sentenza n. 14,
All’uopo,
Nel diritto interno, la nozione di concorrenza riflette
quella operante in ambito comunitario e l’aver accorpato, nel medesimo titolo
di competenza [art. 117, secondo comma, lettera e)], la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari,
il sistema valutario, i sistemi tributario e contabile dello Stato, la
perequazione delle risorse finanziarie e, appunto, la tutela della concorrenza,
rende palese che quest’ultima costituisce una delle leve della politica
economica statale, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a
favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare
assetti concorrenziali.
Ciò detto sul piano generale, nella sentenza n. 14 si sottolinea che una dilatazione
massima del titolo competenziale in parola, di tipo intrinsecamente
trasversale, rischierebbe di vanificare lo schema di riparto disegnato dall’art.
117 della Costituzione, il quale pure attribuisce alla potestà legislativa
delle Regioni materie incidenti innegabilmente sulle attività e sullo sviluppo
economici. Si tratta, dunque, di stabilire fino a che punto la riserva allo
Stato della predetta competenza trasversale sia in sintonia con l’ampliamento
delle attribuzioni regionali disposto dalla revisione del Titolo V, posto che
anche le Regioni possono predisporre interventi sulla realtà produttiva regionale
(purché, ovviamente, non creino ostacolo alla libera circolazione delle persone
e delle cose e non limitino l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte
del territorio nazionale).
Alla luce di tale obiettivo, pur non rientrando nei poteri
della Corte quello di operare una valutazione della correttezza «economica»
delle scelte del legislatore, devesi comunque ammettere la configurabilità di
un controllo di costituzionalità diretto a verificare, da un lato, che i
presupposti di tali scelte non siano manifestamente irrazionali e, dall’altro,
che gli strumenti di intervento siano disposti in una relazione ragionevole e
proporzionata rispetto agli obiettivi attesi.
In definitiva, ove sia dimostrabile la congruità dello
strumento utilizzato rispetto al fine di rendere attivi i fattori determinanti
dell’equilibrio economico generale, il titolo di questa competenza legislativa
funzionale dello Stato non potrà essere negata. Sulla base della ratio decidendi così ricostruita, la sentenza n. 14 ha dichiarato che non risultano
invasive delle competenze regionali le disposizioni statali che prevedono:
a) il concorso dello Stato nella costituzione e nella
dotazione annuale del fondo di mutualità e solidarietà per i rischi in
agricoltura;
b) un aumento dello stanziamento per la concessione di
contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis per il settore produttivo tessile, dell’abbigliamento e
calzaturiero;
c) la individuazione delle tipologie degli investimenti
per le imprese agricole, nonché per quelle di prima trasformazione e
commercializzazione ammesse agli aiuti;
d) il finanziamento di nuovi patti territoriali e
contratti di programma nel settore agroalimentare e della pesca.
In linea di stretta continuità con la sentenza n. 14 si pone la sentenza n. 272, concernente la nuova disciplina
della gestione dei servizi pubblici locali.
Tale disciplina era stata impugnata essenzialmente in quanto
il regime previsto – ad avviso della Regione ricorrente – avrebbe riguardato
interventi, non già di «tutela della concorrenza», ma, più propriamente, di
«promozione», quest’ultima essendo da intendersi come materia diversa dalla «tutela»
e, per ciò stesso, da ricomprendersi tra le competenze regionali ai sensi del
quarto comma dell’art. 117 della Costituzione.
In buona sostanza, non sono censurabili tutte quelle norme
statali che garantiscono, in forme adeguate e proporzionate, la più ampia
libertà di concorrenza nell’ambito di rapporti – come quelli relativi al regime
delle gare o delle modalità di gestione e conferimento dei servizi – i quali
per la loro diretta incidenza sul mercato appaiono più meritevoli di essere
preservati da pratiche anticoncorrenziali.
Peraltro, proprio in applicazione del criterio della
proporzionalità ed adeguatezza, che consente di delimitare l’ambito di
applicazione di una «materia-funzione» qual è la tutela della concorrenza,
viene dichiarata la incostituzionalità delle previsioni statali che introducono
prescrizioni dettagliate ed auto applicative che vanno al di là della doverosa
tutela degli aspetti concorrenziali inerenti alla gara per l’aggiudicazione dei
servizi.
Ad analogo esito di illegittimità costituzionale
Nella sentenza n. 345 è stato evidenziato che anche
la disciplina – contenuta nella legge finanziaria per il 2003 – dell’acquisto
di beni e servizi secondo procedure di evidenza pubblica, là dove impone la
gara, fissa l’ambito soggettivo ed oggettivo di tale obbligo, limita il ricorso
alla trattativa privata e collega alla violazione dell’obbligo sanzioni civili
(nullità dei contratti) e forme di responsabilità, trova fondamento nella
potestà dello Stato di regolare il mercato e di favorire rapporti concorrenziali
nell’ambito dello stesso. Le procedure di evidenza pubblica, anche alla luce
delle direttive della Comunità europea, hanno, infatti, assunto un rilievo fondamentale
per la tutela della concorrenza tra i vari operatori economici interessati alle
commesse pubbliche.
Nel caso della normativa specificamente sottoposta all’esame
della Corte, l’estensione agli acquisti sotto soglia di beni e servizi non
implica (rectius, non può implicare)
per gli enti autonomi una indebita applicazione di puntuali modalità, ma solo l’osservanza
dei principi desumibili dalla normativa in questione: a suffragio di questa
interpretazione si pone, del resto, lo stesso tenore testuale delle
disposizioni oggetto di scrutinio, e segnatamente di quella secondo cui le
disposizioni de quo «costituiscono norme di principio e di coordinamento»
(espressione, questa che, sia detto per
incidens, conferma ulteriormente la natura peculiare della materia «tutela
della concorrenza», la cui estensione è commisurata al rispetto dei principi di
proporzionalità ed adeguatezza dei mezzi usati rispetto al fine che si vuol
raggiungere).
4.1.3. «Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»
Con riguardo alla materia in oggetto, è da segnalare, in
primo luogo, la sentenza
n. 3, con cui
Secondo la regione ricorrente, la norma non sarebbe stata integralmente
riconducibile alla materia dell’organizzazione delle amministrazioni statali o
di enti nazionali, con ciò esorbitando dalla competenza legislativa statale.
Disattendendo siffatta prospettazione,
Sulla scorta di questo parametro costituzionale, la sentenza n. 134 ha dichiarato l’illegittimità
della legge della Regione Marche che prevedeva, tra i componenti del Comitato
di indirizzo dell’istituendo Osservatorio regionale per le politiche integrate
di sicurezza, i Prefetti della Regione, il Procuratore generale della
Repubblica presso
In effetti, la legge, nell’attribuire nuovi compiti ai
titolari di uffici giudiziari in quanto tali, configurandoli ex lege come componenti necessari di un
organo regionale, ha invaso la potestà legislativa esclusiva dello Stato in
tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato, violando altresì
la riserva di legge statale prevista dall’art. 108, primo comma, della Costituzione
in tema di ordinamento giudiziario.
4.1.4. «Ordine pubblico e sicurezza»
In ordine alla materia in oggetto, può segnalarsi la sentenza n. 428, con la quale
In tal senso, si rileva che considerazioni di
carattere sistematico inducono a ritenere che la disciplina della circolazione
stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive,
ai sensi dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione. In primo luogo, l’esigenza di assicurare
l’incolumità personale dei soggetti coinvolti nella circolazione (conducenti,
trasportati, pedoni) pone problemi di sicurezza, ricadendo, così, nella materia
«ordine pubblico e sicurezza», di cui alla lettera h)
del secondo comma dell’art. 117.
Inoltre, la disciplina della circolazione
stradale, in quanto funzionale alla tutela dell’incolumità personale, mira senza dubbio a prevenire una
serie di reati ad essa collegati, come l’omicidio colposo e le lesioni colpose,
e, pertanto, essa trova, anche sotto questo diverso profilo, la sua collocazione
nella materia «ordine e sicurezza pubblica».
Peraltro, nell’esaminare una determinata normativa, non si
rivela sempre agevole individuare un preciso titolo competenziale: proprio la sentenza n. 428 è, a tal proposito, un buon
esempio.
Infatti, la normativa inerente alla circolazione stradale non
può essere ricondotta unicamente alla materia sopra menzionata. In tal senso,
giova sottolineare come la disciplina dell’assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione
dei veicoli a motore si inquadra certamente nella lettera l) del secondo comma dell’art. 117, nella parte in cui attribuisce
alla competenza statale esclusiva la materia dell’«ordinamento civile».
Minori problemi sono
posti con riferimento al settore delle sanzioni amministrative per le
infrazioni al codice della strada, in quanto per esso vale il principio
generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria
rientra in quella a porre i precetti della cui violazione si tratta. Per le
successive fasi contenziose (amministrativa e giurisdizionale), poi, opera
chiaramente la lettera l), del
secondo comma dell’art. 117, nella parte in cui attribuisce alla competenza
statale esclusiva le materie della «giurisdizione» e della «giustizia amministrativa».
4.1.5. «Giurisdizione e norme processuali»
La sentenza n. 18 ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la previsione di
legge statale che esenta dalla soggezione ad esecuzione forzata le somme di
competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all’Irpef disponibili sulle contabilità
speciali esistenti presso le tesorerie provinciali dello Stato ed intestate al
Ministero dell’interno.
Il limite, individuato dalla costante giurisprudenza della
Corte – ed oggi espresso nella riserva alla potestà esclusiva dello Stato della
materia «ordinamento civile», ai sensi del nuovo art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione –,
consistente nel divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i
rapporti privati è stato ritenuto, con la sentenza n. 282, violato dalla disposizione
della legge regionale dell’Emilia-Romagna secondo la quale erano «soppressi i
consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione nonché ogni altra
forma di gestione non consortile di opere o sistemi di scolo ed irrigui, che ricad[eva]no
nei comprensori di bonifica». Con il provvedimento di soppressione, il Consiglio
definiva «la successione nei rapporti giuridici ed amministrativi fra gli
organismi soppressi e i consorzi di bonifica che subentra[va]no nell’esercizio
dei compiti e delle funzioni»: la norma censurata, dunque, non si limitava a
riordinare l’esercizio delle attività di bonifica e la gestione delle relative
opere, ma disponeva senz’altro la soppressione ex lege di organismi e di gestioni, anche di carattere privato,
stabilendo che i consorzi di bonifica – enti pubblici economici a base
associativa – non solo subentravano nell’esercizio dei compiti e delle funzioni
dei predetti organismi, ma succedevano ad essi nei rapporti giuridici e
amministrativi (e quindi anche nella titolarità dei beni eventualmente
posseduti), al di fuori di ogni procedura di eventuale ablazione per ragioni di
interesse pubblico, con conseguente corresponsione di indennizzi.
In tal modo, la normativa, oltre a travalicare il limite del
diritto privato, andava a violare i principi costituzionali di autonomia e di
salvaguardia della proprietà privata e della libertà di associazione,
pretendendo di incidere sulla stessa esistenza degli organismi privati di cui
disponeva la soppressione (e, in ultima analisi, sul nucleo irriducibile della
loro autonoma sfera giuridica).
In continuità con la propria precedente giurisprudenza,
Nel censurare la legge regionale, si è sottolineato, da un
lato, che la norma penale che punisce il gioco d’azzardo in una casa da gioco è
espressione non irragionevole della discrezionalità del legislatore e, dall’altro,
che essa risponde all’interesse della collettività a vedere tutelati la sicurezza
e l’ordine pubblico in presenza di un «fenomeno che si presta a fornire l’habitat ad attività criminali».
Certo, non mancano nella legislazione statale deroghe più o
meno ampie alla previsione in parola; ciò nondimeno,
La materia previdenziale è venuta in considerazione nella sentenza n. 287. In essa,
Ciò in quanto le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi vigenti che disciplinano le funzioni ed i compiti relativi alla
materia dei servizi sociali evidenziano – quali che siano i settori di
intervento (ad esempio, la famiglia, i minori, gli anziani, i disabili) – la
sussistenza di un indefettibile nesso funzionale tra i servizi sociali e la
rimozione od il superamento di situazioni di svantaggio o di bisogno, per la
promozione del benessere fisico e psichico della persona. La provvidenza che è
stata oggetto della sentenza n. 287, di contro, è disposta a favore
delle donne, cittadine italiane o comunitarie, residenti in Italia (in relazione
alla nascita del secondo od ulteriore figlio, o all’adozione di un figlio),
senza che assumano alcun rilievo la condizione soggettiva e la sussistenza di
situazioni di bisogno, di disagio o di semplice difficoltà. Trattasi,
conseguentemente, di una provvidenza temporanea, di carattere indennitario, che
costituisce espressione di quella tutela previdenziale della maternità riconosciuta
alla donna in quanto tale, in ragione degli articoli 31, secondo comma, e 37
della Costituzione, riconducibile, in definitiva, alla competenza statale in
materia di «previdenza sociale», in base a quanto stabilito dall’art. 117,
secondo comma, lettera o), della
Costituzione.
4.1.9. «Tutela dell’ambiente [e] dell’ecosistema»
Nella sentenza n. 259, in particolare, si è
evidenziato che tale competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con
interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie
competenze. Sulla scorta di questa affermazione, è stata dichiarata non fondata
la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale che attribuiva
alle province la competenza al rilascio di autorizzazioni relative ad attività
di immersione di strutture in mare, di ripascimento della fascia costiera e di
movimentazione di fondali marini, dal momento che la competenza a rilasciare le
autorizzazioni per lo svolgimento delle attività ivi previste spetta alla
Regione, la quale può quindi delegarla – in coerenza con il principio di
sussidiarietà – alle Province.
Ad esito analogo
Una siffatta disposizione, ad avviso della Corte, non incide
sulle attribuzioni dell’Ente parco previste dalla normativa statale, e non
interferisce, dunque, sulla competenza esclusiva dello Stato, con la
precisazione che l’accordo interistituzionale o la convenzione suddetti in
nessun caso possono avere ad oggetto i contenuti e la portata del nulla osta
sopra citato.
4.1.10. «Tutela […] dei beni culturali»
Un altro aspetto sul quale
Con la sentenza n. 9,
Dal diritto positivo emerge comunque che «la valorizzazione è
diretta soprattutto alla fruizione del bene culturale, sicché anche il
miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in
cui avviene la fruizione ed ai modi di questa». Per altro verso, la riserva di
competenza statale sulla tutela dei beni culturali è legata alla «peculiarità
del patrimonio storico-artistico italiano, formato in grandissima parte da
opere nate nel corso di oltre venticinque secoli nel territorio italiano e che
delle vicende storiche del nostro Paese sono espressione e testimonianza»: i
beni culturali vanno dunque «considerati nel loro complesso come un tutt’uno,
anche a prescindere dal valore del singolo bene isolatamente considerato».
Per statuire in ordine alla legittimità della disciplina
regolamentare, indefettibile è il porre attenzione al suo contenuto specifico,
concernente il restauro.
Ora, il restauro non trova, nel diritto positivo, una
definizione specifica, ad esso facendosi riferimento soprattutto in relazione
alle sue finalità. Sul punto, peraltro, le varie definizioni rintracciabili
«nella loro sostanza coincidono e pongono l’accento non solo sulla inscindibilità
tra la struttura materiale ed il valore ideale che essa esprime, bensì anche
sulla necessità di incidere sulla stessa struttura materiale del bene, allo
scopo di conservarlo o di recuperarlo».
Alla luce di ciò, il restauro è da annoverare nell’ambito
della «tutela dei beni culturali», e ciò anche se attraverso le operazioni di
restauro può giungersi anche alla valorizzazione dei caratteri
storico-artistici del bene («che è cosa diversa, però, dalla valorizzazione del
bene al fine della fruizione»: «quest’ultima, infatti, non incidendo sul bene
nella sua struttura, può concernere la diffusione della conoscenza dell’opera e
il miglioramento delle condizioni di conservazione negli spazi espositivi»).
Sulla base di questa ricostruzione,
È da segnalare anche la sentenza n. 26, che ha deciso la questione di legittimità
costituzionale originata dalla pretesa lesione delle attribuzioni legislative
regionali derivante dalla norma che prevede, in capo al Ministero per i beni e
le attività culturali, la facoltà di dare in concessione a «soggetti diversi da
quelli statali» la gestione di servizi finalizzati «al miglioramento della
fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico» (c.d. «esternalizzazione»
della gestione dei servizi culturali di competenza statale).
Conseguentemente, la convenzione concessoria dei servizi
disciplinata dalla disposizione impugnata (e dal regolamento ministeriale ivi
previsto) non può che concernere servizi finalizzati a beni culturali, di cui
allo Stato sono riservate la titolarità e la gestione oltre che la tutela.
Sulla base di tale interpretazione,
In una prospettiva più generale, la sentenza n. 307 ha avuto modo di chiarire che
la previsione di contributi finanziari, da parte dello Stato, erogati con
carattere di automaticità in favore di soggetti individuati in base all’età o
al reddito e finalizzati all’acquisto di personal
computers abilitati alla connessione ad Internet,
non risulta invasivo di competenze legislative regionali, nella misura in cui
tale previsione corrisponde a finalità di interesse generale, e segnatamente
allo sviluppo della cultura, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in
tutte le sue articolazioni (art. 9 della Costituzione), anche al di là del
riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni di cui all’art. 117 della
Costituzione.
4.2. Le materie attinenti alla
legislazione concorrente
Uno degli ambiti materiali in cui più arduo è il riparto di
competenze è quello inerente all’istruzione.
In questo «intreccio»,
Alla luce di tale considerazione, la distribuzione, nell’ambito
della Regione, del personale docente tra le istituzioni scolastiche, che la
disposizione impugnata affida ad un organo statale, non può rientrare nella
materia delle «norme generali sull’istruzione», riservate alla competenza
esclusiva dello Stato, in quanto strettamente connessa alla programmazione
della rete scolastica di competenza regionale e non può quindi essere
scorporata da questa e innaturalmente riservata per intero allo Stato, il cui
compito è solo quello di fissare i principi fondamentali.
Ciò stabilito sul piano astratto,
Con riferimento alla materia di legislazione concorrente
della «ricerca scientifica», la sentenza n.
Nella fattispecie, la declaratoria di incostituzionalità è
derivata, in particolare, dalla circostanza che
Con precipuo riguardo alla materia inerente alla «tutela della
salute», nella sentenza
n. 162 sono state dichiarate non
fondate le questioni di legittimità costituzionale avverso alcune leggi
regionali che aboliscono il libretto di idoneità sanitaria, di cui deve essere
munito, ai sensi della legislazione statale (art. 14 della legge 30 aprile
1962, n. 283), chiunque lavori nei settori della preparazione, produzione,
manipolazione e vendita di sostanze alimentari.
Ad avviso della Corte, le disposizioni censurate non potevano
ritenersi in contrasto con la competenza esclusiva statale in tema di «ordine
pubblico e sicurezza» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal momento che
tale materia, sulla base di una giurisprudenza ormai consolidata, attiene al
solo settore relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al
mantenimento dell’ordine pubblico. Né può ritenersi che la disposizione statale
che prevede l’obbligo del libretto di idoneità sanitaria costituisca un
principio fondamentale della materia sanitaria (in quanto tale immodificabile
dal legislatore regionale): in effetti, a seguito di una profonda
trasformazione della legislazione – nazionale e comunitaria – a tutela della
disciplina igienica degli alimenti, prodottasi anche sulla spinta in tal senso
degli organismi scientifici e medici, al preesistente sistema è stato
affiancato un diverso sistema di garanzia sostanziale (e di controllo) sulle
modalità di tutela dell’igiene dei prodotti alimentari; non è pertanto
possibile considerare alla stregua di principi fondamentali della materia tutte
le prescrizioni sostanziali contenute nella legislazione statale del 1962.
L’evoluzione normativa constatata ha offerto alla Corte lo
spunto per confermare che «qualora nelle materie di legislazione concorrente i
principi fondamentali debbano essere ricavati dalle disposizioni legislative
statali esistenti, tali principi non devono corrispondere senz’altro alla
lettera di queste ultime, dovendo viceversa esserne dedotta la loro sostanziale
consistenza»; e ciò, ovviamente, «tanto più in presenza di una legislazione in
accentuata evoluzione».
Alla luce di ciò, tra l’altro, si è negata la desumibilità
dalla legislazione vigente del principio secondo cui spetta solo alle Ausl il rilascio di certificazioni
sanitarie ed i relativi accertamenti attribuiti al servizio sanitario nazionale,
dal momento che non poche leggi statali hanno attribuito funzioni
certificatorie a soggetti diversi ed hanno riconosciuto ai legislatori regionali
poteri di riorganizzazione delle strutture sanitarie locali.
Giudicando della legittimità costituzionale di una normativa
statale in tema di utilizzazione di impianti sportivi, la sentenza n. 424 ha evidenziato come non sia
«dubitabile» che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive
rientri nella materia dell’«ordinamento sportivo» e che in merito alla stessa
operi il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni sancito dall’art.
117, terzo comma, della Costituzione.
Alla luce di ciò, le disposizioni statali che erano state
impugnate da parte di alcune Regioni sono state ritenute non invasive delle
competenze regionali, in quanto recanti principi fondamentali. Tale, in
particolare, è stata configurata una disposizione con cui si stabilisce che l’uso
degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali
deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di
criteri oggettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
Del pari, espressione di un principio fondamentale è stata
considerata la disposizione in cui sono stabilite regole generali dirette a
garantire che la gestione degli impianti sportivi comunali, quando i Comuni non
vi provvedano direttamente, avvenga di preferenza mediante l’attribuzione a
determinati organismi sportivi, in via surrogatoria rispetto ai possibili atti
di autonomia degli enti locali, e quindi nel rispetto delle scelte appunto
autonomistiche degli enti stessi, ai quali è assicurata, in via principale, la
possibilità di gestire direttamente gli impianti in questione.
Ad esiti analoghi ha condotto lo scrutinio di una
disposizione che, relativamente agli impianti sportivi di pertinenza di
istituti scolastici (quali palestre, aree di gioco ed altre analoghe
attrezzature genericamente individuate come «impianti sportivi»), fissa regole
secondo le quali, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle
attività sportive della scuola, anche extracurriculari, i suddetti impianti debbono
essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche
aventi sede nello stesso Comune in cui si trova l’istituto scolastico, o in
Comuni confinanti.
È stata, invece, dichiarata costituzionalmente illegittima la
previsione di un finanziamento diretto al potenziamento dei programmi relativi
allo sport sociale ed a favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali degli
enti di promozione sportiva, in quanto in essa non si prevedeva alcun – pur
necessario – coinvolgimento diretto delle Regioni, anch’esse titolari di
potestà legislativa nella specifica materia.
4.2.5. «Governo del territorio»
Materia di competenza concorrente tra le più significative è
il «governo del territorio».
Con la sentenza n. 176 è stato affermato che la
previsione, contenuta in legge regionale, di subordinare il rilascio dell’autorizzazione
per l’apertura di una grande struttura di vendita alla previa programmazione
urbanistica (sospendendo cioè il rilascio di nuove autorizzazioni per l’apertura
di grandi strutture di vendita fino all’approvazione dei piani territoriali di
coordinamento provinciale che dovranno stabilire, d’intesa con i Comuni, la programmazione
riguardante la grande distribuzione con relativa individuazione di zone
idonee), introduce un limite non irragionevole all’iniziativa economica privata
per la salvaguardia di un bene di rilievo costituzionale, qual è, appunto, il
«governo del territorio». La ragionevolezza è peraltro veicolata da (e
vincolata a) l’adeguata protezione della libertà di iniziativa economica, nella
specie riscontrabile in ragione della presenza di termini finali certi del
periodo di sospensione e dell’esistenza di strumenti di tutela azionabili in
caso di inosservanza di tali termini da parte della pubblica amministrazione.
La materia del «governo del territorio» ha assunto un ruolo
centrale anche nello scrutinio relativo alla legittimità costituzionale delle
disposizioni legislative statali recanti il nuovo condono edilizio. Nella sentenza n. 196,
Al riguardo, pur non essendovi dubbio che solo il legislatore
statale dispone di assoluta discrezionalità in materia «di estinzione del reato
o della pena, o di non procedibilità», si rende nondimeno necessaria su tutto
il territorio nazionale la piena collaborazione dei comuni, titolari di poteri
di gestione e di controllo del territorio, con gli organi giurisdizionali, i
quali sono privi di una competenza «istituzionale» volta a compiere l’accertamento
di conformità delle opere agli strumenti urbanistici.
In particolare, non possono essere disattesi gli ampi poteri
legislativi (di tipo concorrente) spettanti alle Regioni, proprio in virtù
della competenza in materia di «governo del territorio» (nella quale debbono
ricomprendersi i settori dell’edilizia e dell’urbanistica), nella specie da
collegare, in primo luogo, con l’altra materia di competenza concorrente della
«valorizzazione dei beni culturali ed ambientali». Spazi ancor maggiori
spettano alle Regioni ad autonomia particolare, in virtù di competenze
legislative primarie in materia di «governo del territorio».
Per altro verso, la disciplina legislativa deve armonizzarsi
con la titolarità in capo ai comuni della gestione in proprio (ai sensi del
nuovo art. 118 della Costituzione) delle funzioni amministrative, nonché con le
previsioni del nuovo art. 119 della Costituzione, là dove esso afferma che le
normali entrate dei Comuni devono consentire «di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite» (quarto comma). I Comuni, pertanto, debbono avere la
facoltà di provvedere a sanare sul piano amministrativo gli illeciti edilizi e
debbono poter determinare, sulla base delle indicazioni provenienti da
disposizioni legislative regionali di dettaglio, anche la misura dell’anticipazione
degli oneri concessori e le relative modalità di versamento.
Dalla combinazione di queste previsioni,
Conseguentemente, pur facendo salvo l’impianto complessivo
della normativa sottoposta al giudizio della Corte, è stata dichiarata la
illegittimità costituzionale di diverse disposizioni che violavano le
competenze regionali, e segnatamente ad essere caducate sono state le
disposizioni legislative che non prevedevano che la legge regionale potesse
determinare:
a) le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a
sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio;
b) i limiti volumetrici inferiori a quelli indicati
come massimi;
c) l’applicabilità della legge regionale pure alle
opere – quand’anche si trattasse di beni insistenti su aree di proprietà dello
Stato o facenti parte del demanio statale – situate nel territorio regionale.
È stata, inoltre, dichiarata l’illegittimità costituzionale
de:
d) la mancata previsione di un rinvio esplicito alla
legge regionale, in tema di sanatoria di opere abusive, per la determinazione
di un termine perentorio, fissato invece dallo Stato, entro il quale le Regioni
avrebbero dovuto esercitare il loro potere normativo;
e) la mancata previsione in base alla quale si
attribuiva alla legge regionale il potere di disciplinare gli effetti del
silenzio, protratto oltre il termine previsto, del comune cui gli interessati
avessero presentato la documentazione richiesta;
f) la mancata attribuzione alla legge regionale del
potere di determinare la misura dell’anticipazione degli oneri concessori e le
relative modalità di versamento.
Finalmente, è stata dichiarata la incostituzionalità della
normativa nella parte in cui non prevedeva che la legge regionale, recante i
contenuti indicati nei precitati dispositivi di illegittimità costituzionale,
dovesse essere emanata entro un congruo termine, da stabilirsi ad opera del
legislatore statale: ciò in quanto l’attuazione della legislazione sul condono
esige, ai fini dell’operatività della normativa in esame, che il legislatore
nazionale provveda alla rapida fissazione di un termine che consenta alle
Regioni e alle Province autonome di determinare tutte le specificazioni cui
sono chiamate, con la riserva che, nell’ipotesi in cui una Regione o una
Provincia autonoma non eserciti il proprio potere legislativo entro il termine
prescritto, non potrà non trovare applicazione la disciplina statale.
Anche a seguito degli interventi caducatori della Corte,
hanno perso rilievo le doglianze regionali tese a contestare l’intera
disciplina del condono edilizio, sul presupposto che esso avrebbe operato un
illegittimo bilanciamento tra valori costituzionali primari (in particolare, la
tutela dei beni ambientali e paesaggistici) ed altri interessi pubblici.
4.2.6. «Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»
Ciò è avvenuto soprattutto con la sentenza n.
Tale disposizione deve dunque essere letta alla luce di quanto
disposto dalla legislazione statale (decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79),
con il che la disciplina contenuta, relativa alla progettazione tecnica degli
impianti di produzione, alla distribuzione ed all’utilizzo dell’energia
elettrica, oltre che alla costruzione dei relativi edifici, deve
necessariamente uniformarsi alle regole tecniche predisposte – ai termini della
disciplina statale – dal gestore nazionale, «al fine di garantire la più idonea
connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la
connessione operativa tra le reti».
Così ricostruita nella sua portata, la norma impugnata si
limita a prevedere la emanazione, da parte dei competenti organi regionali, di
linee guida che dettino criteri per le attività ivi indicate, criteri puramente
aggiuntivi rispetto a quelli individuati dalle «regole tecniche» adottate dal
gestore nazionale. Viene con ciò stesso garantito il rispetto delle regole
tecniche predisposte dal gestore nazionale e, in ultima analisi, il rispetto
delle esigenze di unitarietà della rete tutelate dalla disciplina statale.
La censura inerente alla violazione da parte della Regione
della competenza statale a porre principi fondamentali in materia concorrente è
stata, conseguentemente, ritenuta priva di fondamento.
Con riguardo alla giurisprudenza su questa materia, si rinvia
a quanto verrà detto infra, par. 6.1.
La sentenza n. 255, resa in sede di scrutinio
della disciplina statale che detta i criteri e le modalità di erogazione dei
contributi alle attività dello spettacolo e le aliquote di ripartizione annuale
del Fondo unico per lo spettacolo previsto dalla legge 30 aprile 1985, n.
In base ad un siffatto inquadramento,
Dato atto del (nuovo) ruolo delle Regioni, si è peraltro
precisato che, per quanto il sostegno finanziario degli spettacoli sia ormai
riconducibile ad una materia di cui al terzo comma dell’art. 117 della
Costituzione, ciò non può significare l’automatica sopravvenuta incostituzionalità
della legislazione statale vigente in materia, anzitutto in conseguenza del
principio della continuità dell’ordinamento.
In buona sostanza, «ci si trova con tutta evidenza dinanzi
alla necessità ineludibile che in questo ambito, come in tutti quelli analoghi
divenuti ormai di competenza regionale ai sensi del terzo comma dell’art. 117
Cost., ma caratterizzati da una procedura accentrata, il legislatore statale
riformi profondamente le leggi vigenti (in casi come questi, non direttamente modificabili
dai legislatori regionali) per adeguarle alla mutata disciplina costituzionale».
D’altra parte, le impellenti necessità finanziarie dei soggetti e delle
istituzioni operanti nei diversi settori degli spettacoli hanno indotto il
legislatore ad adottare la disposizione impugnata, che non a caso appare esplicitamente
temporanea, essendo stata approvata «in attesa che la legge di definizione dei
principî fondamentali di cui all’art. 117 della Costituzione fissi i criteri e
gli ambiti di competenza dello Stato». In considerazione di questa eccezionale
situazione di integrazione della legge n. 163 del 1985, la norma può trovare
giustificazione la sua temporanea applicazione, mentre appare evidente che
questo sistema normativo non potrà essere ulteriormente giustificabile in
futuro.
4.3. Le materie attinenti alla
competenza residuale delle Regioni
Nel corso del 2004,
Nella prima (sentenza n. 1), è stata dichiarata
costituzionalmente illegittima la disposizione legislativa statale che
disponeva la inapplicabilità delle disposizioni di cui alla legge 11 giugno
1971, n. 426, recante la disciplina del commercio, e delle sagre, fiere e manifestazioni
di carattere religioso, benefico o politico.
Se la finalità religiosa, benefica o politica da cui sia
connotata una fiera o una sagra non può valere, di per sé, a modificarne la
natura e dunque a mutare l’ambito materiale cui la disciplina di tali
manifestazioni inerisce – e che non può che essere individuato nella disciplina
del «commercio» –,
Con una successiva decisione (sentenza n. 12),
Quanto al miglioramento genetico, esso è stato invece
ascritto alla materia «agricoltura», di competenza residuale; peraltro, non
vertendosi in ogni caso in una materia riconducibile ad alcuna potestà
esclusiva dello Stato, la relativa disciplina è stata dichiarata incostituzionale,
unitamente alla previsione del potere conferito al Ministro dell’economia e
delle finanze di darvi attuazione, previsione che violava l’art. 117, sesto
comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato potestà regolamentare
nelle sole materie di competenza legislativa esclusiva.
Parimenti, la disciplina relativa all’impianto abusivo di
vigneti è stata ricondotta al «nocciolo duro della materia agricoltura»,
affidata in via residuale alla competenza legislativa delle Regioni: in
contrario, non avrebbe potuto rilevare che la disposizione era direttamente
attuativa del regolamento comunitario relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, poiché ai sensi dell’art. 117, quinto comma, della
Costituzione l’attuazione ed esecuzione della normativa comunitaria spettano,
nelle materie di loro competenza, alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
Infine, con la sentenza n. 380, la disposizione legislativa statale
secondo cui «ai medici che conseguono il titolo di specializzazione [era]
riconosciuto, ai fini dei concorsi, l’identico punteggio attribuito per il
lavoro dipendente» è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui si
applicava ai concorsi banditi dalle Regioni o dagli enti regionali. La norma,
infatti, contrariamente alla tesi «espansiva» sostenuta dalla difesa erariale,
atteneva specificamente alla disciplina dei concorsi per l’accesso al pubblico
impiego, e dunque la relativa regolamentazione era riferibile all’ambito della
competenza esclusiva statale, sancita dall’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, limitatamente ai
concorsi indetti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali.
Relativamente ai concorsi banditi dalle Regioni o dagli enti regionali, invece,
essendo di immediata percezione l’impossibilità di collocare la disciplina all’interno
del catalogo delle competenze legislative statali esclusive o in quello delle
competenze concorrenti, non poteva che concludersi nel senso che la
regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale era riconducibile
alla materia «innominata» dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e
degli enti pubblici regionali, di spettanza delle Regioni ai termini del quarto
comma dell’art. 117 della Costituzione.
4.4. Le competenze delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome
Nella giurisprudenza costituzionale del 2004, sono numerose
le decisioni che hanno riguardato le Regioni speciali e/o le Province autonome.
La gran parte, tuttavia, non ha interessato esclusivamente le autonomie
speciali, con il che la relativa trattazione trova la propria sedes materiae nei paragrafi che
precedono.
Con precipuo (ed esclusivo) riferimento alle Regioni speciali
e/o alle Province autonome si segnalano, comunque, quattro decisioni.
Innanzi tutto, con riferimento all’ambito competenziale
concorrente relativo a «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»,
merita un cenno la sentenza n. 8, che ha ad oggetto una
disposizione legislativa del Friuli-Venezia Giulia.
In ordine al contenuto della disposizione regionale
impugnata, essa, nel prevedere la possibilità che
Con la sentenza n. 412,
Fondandosi sul principio secondo cui «le disposizioni
legislative statali devono essere interpretate in modo da assicurarne la conformità con la posizione
costituzionalmente garantita alle Province autonome del Trentino-Alto Adige»,
nella decisione si è sottolineato come (in assenza di un espresso riferimento
nella norma censurata alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome,
ma anche in presenza – all’interno della legge – di una clausola generale di
salvaguardia per le attribuzioni delle autonomie speciali) la disposizione
impugnata non possa intendersi nel senso di trasferire alla competenza statale
autorizzazioni in materia ambientale che già appartengano alla competenza provinciale
o di ridurre il ruolo delle determinazioni provinciali nell’ambito delle
procedure di competenza statale.
Per quanto non direttamente concernente una questione di
legittimità costituzionale, è da segnalare anche la sentenza n. 177. Nel corso di un giudizio sulla
spettanza del potere ispettivo nei confronti degli istituti scolastici paritari
presenti nella Regione Siciliana,
Ora, dopo aver constatato che tale assetto delle competenze
dello Stato e della regione in materia di istruzione, deve ritenersi confermato
anche dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, stante il disposto dell’art. 10
della stessa legge,
Un’ultima decisione da menzionare è la sentenza n. 220, resa a proposito di una legge
della Regione Sardegna in materia di caccia, impugnata nella parte in cui esclude
i cacciatori non residenti nella regione dalla possibilità di rinnovare l’autorizzazione
venatoria. Disattendendo le censure prospettate dal giudice a quo,
4.5. L’attrazione di materie da parte
dello Stato sulla base del principio di sussidiarietà
La sentenza n. 6
costituisce il seguito ideale della sentenza n. 303 del 2003, con la quale
Nel caso di specie, era stato impugnato da parte di alcune
Regioni il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante «Misure urgenti per
garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» (oggetto di
impugnazione era poi stata anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, di conversione
del decreto legge).
Ciò premesso, è stato sottolineato come il problema della
competenza legislativa dello Stato non possa essere risolto esclusivamente alla
luce dell’art. 117 Cost., essendo indispensabile una ricostruzione che tenga conto
dell’esercizio del potere legislativo di allocazione delle funzioni amministrative
secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al
primo comma dell’art. 118 Cost.
Sulla scorta di queste considerazioni, è stata dedotta l’infondatezza
delle censure prospettate nei ricorsi regionali, atteso che la normativa ha
«ridefinito in modo unitario ed a livello nazionale i procedimenti di modifica
o ripotenziamento dei maggiori impianti di produzione dell’energia elettrica,
in base all’evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale
agli organi statali nell’esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative».
Ovviamente, la valutazione della necessità del conferimento
di una funzione amministrativa ad un livello territoriale superiore rispetto a
quello comunale deve essere necessariamente effettuata dall’organo legislativo
corrispondente almeno al livello territoriale interessato e non certo da un
organo legislativo operante ad un livello territoriale inferiore («come sarebbe
un Consiglio regionale in relazione ad una funzione da affidare – per l’esercizio
unitario – al livello nazionale»).
Ora, alla luce di quanto stabilito nella sentenza n. 303 del
2003, affinché un siffatto intervento da parte del legislatore statale sia
legittimo, è peraltro necessario (a)
che esso rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di
esercizio unitario di tali funzioni, (b)
che esso detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla
regolazione delle suddette funzioni, (c)
che esso risulti limitato a quanto strettamente indispensabile a tale fine, (d) che esso risulti adottato a seguito
di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti
attraverso strumenti di leale collaborazione (o, comunque, che preveda adeguati
meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative
allocate in capo agli organi centrali).
Applicando i criteri indicati alla normativa oggetto del
giudizio di legittimità costituzionale,
In secondo luogo, si è sottolineato come non potesse non
riconoscersi, da un lato, la «specifica pertinenza» della normativa in
relazione alla regolazione delle funzioni amministrative in questione, e, dall’altro,
che tale normativa si è limitata ad una regolamentazione «in funzione del solo
fine di sveltire le procedure autorizzatorie necessarie alla costruzione o al
ripotenziamento di impianti di energia elettrica di particolare rilievo».
Finalmente, in merito alla necessaria previsione di idonee
forme di intesa e collaborazione tra il livello statale e i livelli regionali,
sono stati considerati adeguati i due distinti livelli di partecipazione delle
Regioni disciplinati nel decreto legge n. 7 del 2002, quale convertito dalla
legge n. 55 del 2002: per il primo comma dell’art. 1, quale opportunamente
modificato in sede di conversione, la determinazione dell’elenco degli impianti
di energia elettrica che sono oggetto di questi speciali procedimenti viene
effettuata «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»; per il
secondo comma dell’art. 1, l’autorizzazione ministeriale per il singolo
impianto «è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, d’intesa con
Il riferimento all’intesa è stato poi ulteriormente
specificato nel senso che essa «va considerata come un’intesa “forte”», tale
per cui «il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla
conclusione del procedimento», a causa del «particolarissimo impatto» che un
impianto di energia elettrica ha «su tutta una serie di funzioni regionali, relative
al governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei
beni culturali ed ambientali, al turismo, etc.».
La medesima ratio
decidendi è stata alla base della sentenza n. 233, con la quale
Dato conto della riconducibilità dell’atto a materia di
competenza concorrente,
Nella vicenda concernente l’approvazione del progetto della
metropolitana di Bologna,
A conclusione della trattazione relativa al riparto di
competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, giova soffermarsi, sia pur
brevemente, su un tema di particolare importanza, quello cioè del modo di esercizio delle competenze,
segnatamente nel caso in cui si producano contrasti tra legislazioni.
Le disposizioni costituzionali in tema di rapporti tra gli
enti territoriali «presuppongono che l’esercizio delle competenze legislative
da parte dello Stato e delle Regioni, secondo le regole costituzionali di
riparto delle competenze, contribuisca a produrre un unitario ordinamento
giuridico, nel quale certo non si esclude l’esistenza di una possibile
dialettica fra i diversi livelli legislativi, anche con la eventualità di
parziali sovrapposizioni fra le leggi statali e regionali, che possono trovare
soluzione mediante il promuovimento della questione di legittimità
costituzionale dinanzi a questa Corte, secondo le scelte affidate alla discrezionalità
degli organi politici statali e regionali». È, però, «implicitamente escluso
dal sistema costituzionale […] che il legislatore regionale (così come il
legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potestà
legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una
legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non
addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio» dinanzi alla
Corte costituzionale, attraverso il giudizio di legittimità costituzionale in
via principale.
Tali considerazioni hanno guidato
La medesima ratio
decidendi è stata impiegata, nella sentenza n. 199, al fine di dichiarare che non
spettava ad una Regione, e per essa alla Giunta regionale, adottare un atto con
il quale si negava efficacia, all’interno del proprio territorio, all’art. 32
del decreto legge n. 269 del 2003, dovendosi all’uopo constatare che ciò che è
precluso ad una legge regionale (o statale) è precluso, a fortiori, ad un atto amministrativo di indirizzo che dichiari o
presupponga l’inapplicabilità di un atto legislativo (rispettivamente dello
Stato o delle Regioni).
5. I poteri sostitutivi
Un numero considerevole di decisioni, nel corso del
Il tema, come è chiaro, assume una particolare delicatezza,
se è vero che siffatti poteri concorrono a configurare ed a limitare l’autonomia
dell’ente nei cui confronti opera la sostituzione, con il che essi debbono
trovare fondamento esplicito o implicito nelle norme o nei principi
costituzionali che tale autonomia prevedono e disciplinano.
Rigettando le prospettazioni erariali,
Non è allora preclusa, «in via di principio», la possibilità
che la legge regionale, «intervenendo in materie di propria competenza, e nel
disciplinare, ai sensi dell’art. 117, terzo e quarto comma, e dell’art. 118, primo
e secondo comma, della Costituzione, l’esercizio di funzioni amministrative di
competenza dei Comuni, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi
regionali, per il compimento di atti o di attività obbligatorie, nel caso di inerzia
o di inadempimento da parte dell’ente competente, al fine di salvaguardare
interessi unitari che sarebbero compromessi dall’inerzia o dall’inadempimento
medesimi».
Un siffatto riconoscimento non può, tuttavia, non essere
contornato da condizioni e limiti; condizioni e limiti ricavabili,
essenzialmente, da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale
anteriormente alla riforma costituzionale del
L’insieme di queste considerazioni, formulate nella sentenza n. 43 (dalla quale sono tratti i brani
citati), sono state poi ribadite nelle successive decisioni che hanno avuto ad
oggetto il medesimo tema.
Nella sentenza n. 43 si è ritenuto che la
disposizione regionale impugnata fosse rispettosa di tutti i limiti e di tutte
le condizioni sopra enucleati. Del pari, immuni da censure sono risultate le
disposizioni regionali, oggetto dei giudizi conclusi con le sentenze numeri 70, 71, 72, 73, 140 e 172, che
attribuivano ad organi regionali poteri sostitutivi. Infondate sono state
dichiarate anche le questioni sollevate in merito a disposizioni legislative
regionali che attribuivano poteri sostitutivi, per un verso, alla Regione nei
confronti delle Province, e, per l’altro, alle Province nei confronti dei
Comuni e di altri enti minori (sentenza n. 227).
La declaratoria di illegittimità costituzionale ha invece
colpito una disposizione di legge regionale che, nel prevedere un potere
sostitutivo della Regione nei confronti dei Comuni, non determinava «in alcun
modo» la tipologia delle sostituzioni affidate alla Regione, non individuava l’organo
regionale competente, non disciplinava la procedura di esercizio del potere, né
prevedeva «alcun meccanismo di collaborazione con l’ente inadempiente» (sentenza n. 69). Analoga sorte hanno avuto le
disposizioni legislative regionali che affidavano poteri sostitutivi al
difensore civico, in quanto quest’ultimo, per la sua natura e per le funzioni
esercitate, non può essere configurato alla stregua di un organo di governo
regionale, configurazione che, «sola», consente di esercitare nei confronti
degli enti locali interventi di tipo sostitutivo (sentenze numeri 112 e 173).
Alla luce dei medesimi principi, è stata dichiarata infondata
la questione di legittimità costituzionale sollevata da una Regione nei
confronti della previsione, con atto legislativo statale, di un potere
sostitutivo statale da esercitarsi da parte di un commissario straordinario di
nomina governativa, secondo modalità che sono state ritenuti tali da offrire
idonee garanzie circa il rispetto del principio di leale cooperazione (sentenza n. 240).
Infine, il tema del potere sostitutivo, ed in particolare il
potere sostitutivo «straordinario» di cui al secondo comma dell’art. 120 della
Costituzione, è stato oggetto anche della sentenza n. 236, che ha definito i ricorsi
presentati dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna in
ordine all’art. 8 della legge n. 131 del 2003, attuativo del disposto
costituzionale.
Al quadro di riferimento così tratteggiato non è comunque
seguito un esame nel merito delle questioni prospettate, essendosi constatato
che «il concreto trasferimento alle Regioni ad autonomia speciale delle
funzioni ulteriori attratte dal nuovo Titolo V deve essere effettuato con le
procedure previste dall’art. 11 della legge n. 131 del 2003, ossia con norme di
attuazione degli statuti adottate su proposta delle commissioni paritetiche»,
con la conseguenza che, «fino a quando tali norme di attuazione non saranno
state approvate, la disciplina del potere sostitutivo di cui si [è]
contesta[ta] la legittimità resta nei loro confronti priva di efficacia e non è
idonea a produrre alcuna violazione delle loro attribuzioni costituzionali».
6. Il regime finanziario dello Stato,
delle Regioni e degli enti locali
Nel corso del 2004,
6.1. Legislazione statale ed
autonomie finanziarie
a) Le disposizioni della legge finanziaria 2002, che
pongono limiti e divieti nei confronti del personale alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni non sono lesive delle competenze regionali, in quanto
sono riconducibili a ben individuate competenze statali: ciò vale, secondo
quanto stabilito nella sentenza n. 4, per la norma secondo cui «gli
oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 sono a carico
delle amministrazioni di competenza nell’ambito delle disponibilità dei rispettivi
bilanci», e per quella in base alla quale, con riguardo alla contrattazione
integrativa, i comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di
indirizzo, si attengono ai «criteri indicati per il personale» dipendente dello
Stato. Tali previsioni, infatti, rientrano nella materia, di competenza
concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione), della «armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» e fissano – in
linea con gli impegni assunti dall’Italia «in sede comunitaria» – principi
fondamentali volti al contenimento della spesa corrente.
Anche le previste verifiche congiunte tra comitati di settore
e Governo in merito alle implicazioni finanziarie della contrattazione
integrativa di comparto impongono regole strumentali rispetto al fine –
legittimamente perseguito dalla legislazione statale in sede di coordinamento
della finanza pubblica – di valutazione della compatibilità con i vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.
Per quanto riguarda il divieto agli enti locali di assumere
personale a tempo indeterminato e di ricorrere, per la copertura dei posti
disponibili, alle procedure di mobilità, le disposizioni statali perseguono il
fine di dare effettività al patto di stabilità interno incidendo su una delle
più frequenti e rilevanti cause del disavanzo; sicché – attesa la stretta
attinenza di tali precetti con il fine del coordinamento della finanza
pubblica, sub specie del contenimento
della spesa corrente – non sussiste alcuna compressione delle competenze
regionali.
È, infine, chiaramente strumentale rispetto al fine di
coordinamento della finanza pubblica, e costituisce norma di principio, anche
la disposizione secondo cui gli organi di revisione contabile accertano che i
documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto
del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a
tale principio siano analiticamente motivate.
b) Sulla base delle medesime considerazioni, con la sentenza n. 260, viene respinta l’impugnazione
dell’Emilia-Romagna nei confronti delle disposizioni che, nelle leggi finanziarie
del 2003 e del 2004, pongono vincoli ai comitati di settore in sede di
deliberazione degli atti di indirizzo riguardanti i dipendenti del comparto
Regioni-autonomie locali.
c) La sentenza n. 17 ha ad oggetto alcune
disposizioni della legge finanziaria 2002 che prevedono che le pubbliche
amministrazioni, da un lato, sono autorizzate ad acquistare sul mercato i
servizi originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere
conseguenti economie di gestione, e, dall’altro, possono costituire soggetti di
diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, nel rispetto del
principio di economicità, si limitano ad indicare, con carattere non vincolante
per l’autonomia delle regioni, talune possibili modalità procedimentali per l’acquisizione
e l’affidamento dei servizi (c.d. esternalizzazione dei servizi) con finalità esclusivamente
economico-finanziarie.
Correttamente interpretata, la normativa in esame
costituisce, in realtà, una indicazione di principio di possibili misure
adottabili, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, in ordine al
reperimento di forme aggiuntive di copertura delle spese e di finanziamento,
nonché di riduzione dei fabbisogni finanziari per la gestione dei «servizi».
Del pari, la disposizione che prevede che le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere a forme di autofinanziamento, grazie alle entrate
proprie derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione
alle spese da parte degli utenti del servizio (al fine di ridurre gli
stanziamenti a carico del bilancio dello Stato), non costituisce lesione della
competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione e
funzionamento della Regione: essa si giustifica, infatti, non solo sulla base
dei poteri dello Stato diretti all’armonizzazione ed al coordinamento dei
bilanci, delle spese e delle entrate dell’intera finanza pubblica, compreso il
sistema tributario, ma anche in ragione del fatto che l’autofinanziamento delle
funzioni attribuite alle Regioni (ed agli enti locali) costituisce – nel nuovo
assetto delle competenze costituzionali – null’altro che un corollario della
potestà legislativa regionale esclusiva in materia.
Inoltre, la disposizione non pone limiti al legislatore
regionale sul presupposto, addotto dalle regioni ricorrenti, del
disconoscimento del carattere autonomo e non più derivato della finanza regionale:
essendo stato dato avvio – con il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 –
al passaggio dal sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario per
trasferimenti a quello che prevede l’accesso diretto (mediante la c.d. compartecipazione
ad alcuni tributi statali), l’applicabilità della norma de qua non può ledere l’autonomia finanziaria regionale, dovendo
questa conformarsi ai principi fondamentali fissati dalla legge statale; né è
sufficiente ad integrare detta violazione la semplice circostanza della
riduzione dei trasferimenti e stanziamenti statali a seguito di entrate
proprie. D’altra parte, la norma denunciata – per la sua natura di principio e
per l’interpretazione che deve essere data al necessario presupposto compensativo
di corrispondenti entrate proprie regionali – non è tale da poter comportare
uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale.
Non costituisce, infine, un indebito potere di indirizzo e
coordinamento l’attribuzione, in capo al Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, del potere di definire, per il miglioramento della qualità dei
servizi e la razionalizzazione della spesa per informatica, gli indirizzi per l’impiego
ottimale dell’informatizzazione delle pubbliche amministrazioni: ciò in quanto
trattasi di un potere limitato, per quanto riguarda le Regioni, ad un coordinamento
meramente tecnico, rientrante nell’ambito della previsione costituzionale di
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle pubbliche
amministrazioni, secondo la previsione dell’art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
d) Secondo quanto affermato nella sentenza n. 36, i limiti posti dalle disposizioni
della legge finanziaria 2002 alla crescita della spesa corrente degli enti
locali, in termini di impegni e pagamenti, sono introdotti in osservanza del
cosiddetto patto di stabilità interno, concernente il concorso delle Regioni e
degli enti locali «alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che
il paese ha adottato con l’adesione al patto di stabilità e crescita» definito
in sede di Unione europea. Non è contestabile, al riguardo, il potere del
legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento
finanziario connesse ad obiettivi nazionali (condizionati anche da obblighi
comunitari), vincoli alle politiche di bilancio, anche qualora questi si
traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa
degli enti. La natura e la finalità di tali vincoli escludono pertanto che tali
disposizioni possano considerarsi come esorbitanti dall’ambito di una
disciplina di principio spettante alla competenza dello Stato.
Non può, inoltre, negarsi che, in via transitoria ed in vista
degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti, il
legislatore statale possa, nell’esercizio non irragionevole della sua
discrezionalità, introdurre per un anno un limite alla crescita della spesa corrente
degli enti autonomi, tenendo conto che, comunque, si tratta di un limite complessivo,
che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i
diversi ambiti ed obiettivi di spesa.
e) Strettamente correlata alla sentenza n. 36 è la sentenza n. 353, resa a proposito di questioni
sollevate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione
Trentino-Alto Adige. I ricorrenti denunciano la disposizione della legge
finanziaria 2003 ai termini della quale «le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell’economia
e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese
correnti e dei relativi pagamenti»: la disposizione è censurata nella parte in
cui consente che sia il Ministro a determinare unilateralmente, in mancanza
dell’accordo, i flussi di cassa verso gli enti.
f) La sentenza n. 390 riconduce alla competenza
statale consistente nel dettare i principi fondamentali in materia di
«coordinamento della finanza pubblica» anche la disposizione della legge
finanziaria 2004 secondo cui le amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello
Stato «adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio
di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti
di finanza pubblica».
Ben può, inoltre, prevedere, la legge statale, un accordo tra
Governo, Regioni ed autonomie locali volto a far sì che vi sia il «concorso
delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica»,
e che l’accordo sia trasfuso in un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri che fissi «per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del
patto di stabilità interno per l’anno 2002, per gli altri enti locali e per gli
enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a
tempo indeterminato per l’anno 2003». Anche tale previsione costituisce un
principio di «coordinamento della finanza pubblica», legittimamente apposto
coinvolgendo nell’individuazione dei «criteri e limiti per le assunzioni a
tempo indeterminato» le Regioni e le autonomie locali.
Non altrettanto può dirsi, invece, per la disposizione
secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato devono, comunque, essere
contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal
servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002: in questo caso, infatti, la
disposizione non si limita a fissare un principio di coordinamento della
finanza pubblica, ma pone un precetto specifico e puntuale che si risolve in
una indebita invasione dell’area (individuabile nell’organizzazione della
propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli
enti locali, alle quali la legge statale può solo prescrivere criteri ed
obiettivi, ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare
per raggiungere quegli obiettivi.
g) La disposizione della legge finanziaria 2003 ai
termini della quale «le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato
aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e
agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di
previsione della spesa» (con la connessa disposizione che prevede che tali
contributi «sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro
dell’economia e delle finanze») intende fissare un limite al costo degli interventi,
anche regionali, di contribuzione alla produzione e agli investimenti: pur trattandosi
di disposizione con finalità di contenimento della spesa pubblica regionale ed
essendo, dunque, atta ad incidere sulla finanza regionale,
6.2. Il sistema finanziario e
tributario degli enti locali
Nelle pronunce che seguono,
a) Con la sentenza n. 37, in occasione della impugnativa
nei confronti di diverse disposizioni della legge finanziaria 2002 relative all’imposta
sulla pubblicità, a diversi tributi locali, all’addizionale comunale e
provinciale all’Irpef ed alla compartecipazione dei Comuni al gettito dell’Irpef,
L’attuazione di questo disegno costituzionale richiede,
peraltro, l’intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare
l’insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i
legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee
dell’intero sistema tributario, e definire gli spazi ed i limiti entro i quali
potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed
enti locali.
Un siffatto intervento richiede altresì la definizione di una
disciplina transitoria che consenta l’ordinato passaggio dall’attuale sistema –
caratterizzato dalla permanenza di una finanza regionale e locale ancora in non
piccola parte «derivata» e da una disciplina statale unitaria di tutti i
tributi, con limitate possibilità di autonome scelte riconosciute a Regioni ed
enti locali – ad uno affatto nuovo.
Ad oggi non si danno ancora, se non in limiti ristrettissimi,
tributi che possano definirsi a pieno titolo «propri» delle Regioni o degli
enti locali, nel senso che essi siano frutto di una loro autonoma potestà
impositiva, e quindi possano essere disciplinati dalle leggi regionali o dai
regolamenti locali, nel rispetto dei soli principi di coordinamento
(attualmente assenti in quanto «incorporati» in un sistema di tributi
sostanzialmente governati dallo Stato). In tal senso, non è eccezione probante
quella dei tributi di cui oggi la legislazione dello Stato destina il gettito,
in tutto o in parte, agli enti autonomi, e per i quali la stessa legislazione
riconosce spazi limitati di autonomia agli enti quanto alla loro disciplina,
trattandosi comunque di tributi che sono quasi integralmente riconducibili a
determinazioni provenienti dal centro.
Per quanto poi riguarda i tributi locali, stante la riserva
di legge che copre tutto l’ambito delle prestazioni patrimoniali imposte (art.
23 della Costituzione), e che comporta la necessità di disciplinare a livello
legislativo quanto meno gli aspetti fondamentali dell’imposizione, e data l’assenza
di poteri legislativi in capo agli enti sub-regionali, dovrà anche essere definito,
da un lato, l’ambito in cui potrà esplicarsi la potestà regolamentare degli
enti medesimi, e, dall’altro lato, il rapporto tra legislazione statale e
legislazione regionale per quanto attiene alla disciplina di grado primario dei
tributi locali (potendosi in astratto concepire situazioni di disciplina normativa
a tre livelli – legislativa statale, legislativa regionale, e regolamentare
locale – oppure a due soli livelli – statale e locale, ovvero regionale e
locale –).
Dalle premesse enunciate discende l’impossibilità di accedere
alla tesi secondo cui la materia del «sistema tributario degli enti locali»
spetterebbe fin da oggi alla potestà legislativa residuale delle Regioni.
Correlativamente, non possono essere accolte le censure basate sul carattere
dettagliato e non di principio delle disposizioni impugnate in materia di
tributi locali o devoluti agli enti locali: le norme impugnate, infatti, recano
modifiche particolari ad aspetti di tributi che già erano oggetto di specifica
disciplina in preesistenti leggi statali, e sui quali quindi il legislatore
statale conserva un potere di intervento sino alla definizione delle premesse
del nuovo sistema impositivo delle Regioni e degli enti locali.
b) Sulla base delle considerazioni contenute nella
sentenza n. 37,
Aggiunge
c) Sempre in linea di continuità,
d) Considerazioni analoghe consentono, nella sentenza n. 431, di respingere il ricorso
avverso la disposizione contenuta nella legge finanziaria 2003 che prevede talune
proroghe di agevolazioni fiscali relative all’Irap
inerenti all’agricoltura. Non condivisibile, in particolare, è ritenuta la tesi
secondo cui ogni intervento sul tributo che comporti un minor gettito per le
Regioni dovrebbe essere accompagnato da misure compensative per la finanza regionale.
Non può, infatti, essere effettuata una atomistica considerazione di isolate
disposizioni modificative del tributo, senza considerare nel suo complesso la
manovra fiscale entro la quale esse trovano collocazione, ben potendosi
verificare che, per effetto di plurime disposizioni di leggi, il gettito
complessivo destinato alla finanza regionale non subisca riduzioni.
e) Anche il ricorso avverso la disposizione, contenuta
nella legge finanziaria 2003, che dispone la fissazione delle basi di calcolo
dei sovracanoni per la produzione di energia idroelettrica è stato respinto (sentenza n. 261). Tale disciplina, ribadisce
6.3. I fondi speciali istituiti dallo
Stato
In un’altra (nutrita) serie di pronunce,
a) Viene innanzi tutto in rilievo la disposizione della
legge finanziaria 2002 che istituisce presso il Ministero dell’interno il Fondo
per la riqualificazione urbana dei comuni e che demanda ad un regolamento
ministeriale il compito di dettare le disposizioni per la ripartizione del Fondo
tra gli enti interessati.
Sulla scorta di tali affermazioni di principio, la
disposizione impugnata viene dichiarata costituzionalmente illegittima. Ora,
poiché la caducazione di tale norma non comportava diretto e immediato
pregiudizio per diritti delle persone,
b) Le considerazioni svolte nella sentenza n. 16 sono riproposte nella sentenza n. 49, che dichiarata la illegittimità
costituzionale delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2002 che
istituiscono ex novo il Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e il
fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.
c) Altresì illegittima risulta la
disposizione della legge finanziaria 2004 che affida la gestione del Fondo
istituito al fine di garantire il rimborso dei c.d. prestiti fiduciari in
favore degli studenti capaci e meritevoli a Sviluppo Italia S.p.a., società
interamente partecipata dallo Stato. In questo caso, le modalità di utilizzo
del fondo di garanzia, attinente alla materia dell’istruzione, comportano
scelte discrezionali relativamente ai criteri di individuazione degli studenti
capaci e meritevoli che esigono un diretto coinvolgimento delle Regioni, in
quanto titolari di potestà legislativa concorrente nella specifica materia. Di
ciò – conclude
d) Costituzionalmente illegittima si rivela anche la
disposizione della legge finanziaria 2003 nella è previsto l’intervento
legislativo dello Stato in tema di asili nido, nonché la creazione di un Fondo
statale di finanziamento dei datori di lavoro che realizzino asili nido o
micro-nidi nei luoghi di lavoro.
A tale declaratoria, contenuta nella sentenza n. 320, si giunge rilevando che la
disciplina degli asili nido ricade nell’ambito della materia dell’istruzione
(sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino), nonché, per altri
versi, nella materia della tutela del lavoro, che l’art. 117, terzo comma,
della Costituzione affida parimenti alla potestà legislativa concorrente, con
la conseguenza che in questi ambiti il legislatore statale può determinare
soltanto i principi fondamentali della materia e non può dettare, quindi, una
disciplina dettagliata ed esaustiva. In sostanza, si sottolinea ulteriormente
che l’art. 117 della Costituzione vieta che in una materia di competenza
legislativa regionale si prevedano interventi finanziari statali, seppur
destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato
potestà legislative e amministrative non derivanti dal sistema costituzionale
di riparto delle rispettive competenze.
e) Sempre in linea di continuità con le
pronunce che precedono (ed in particolare la sentenza n. 16),
Dalla lettura delle caratteristiche che connotano la
struttura e la funzione del Fondo,
Alla luce di tali considerazioni e delle disposizioni
costituzionali riguardanti l’autonomia finanziaria regionale,
Viene, invece, respinta la doglianza volta a contestare che
la quantità di risorse da destinare alla spesa sociale non sia stata concordata
tra Stato e Regioni. Ciò in quanto spetta in via esclusiva allo Stato, nell’esercizio
dei suoi poteri di regolazione finanziaria, stabilire quanta parte delle
risorse debba essere destinata alla copertura della spesa sociale; il coinvolgimento
delle Regioni – in ossequio al principio di leale cooperazione – deve essere assicurato
solo nella fase di concreta ripartizione delle risorse finanziarie.
L’autonomia finanziaria regionale non è neppure violata dalla
fissazione di un termine (ritenuto eccessivamente gravoso) per l’utilizzo delle
risorse da parte degli enti destinatari: la disposizione che prevede tale
fissazione risponde, infatti, all’esigenza di assicurare che le risorse non
tempestivamente utilizzate siano rese nuovamente disponibili per gli scopi che
la normativa si propone di raggiungere.
La declaratoria di illegittimità costituzionale, invece,
colpisce la disposizione che assegna alla Federazione dei maestri del lavoro d’Italia
un contributo annuo per far fronte a spese per diverse attività assistenziali.
Al riguardo,
Costituzionalmente illegittime sono anche le disposizioni che
prevedono, l’una, l’erogazione alle persone fisiche di un contributo,
finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l’attività
educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole
paritarie, e, l’altra, un intervento finanziario a favore delle Regioni che si
determinino ad istituire il reddito di ultima istanza (quale strumento di accompagnamento
economico ai programmi di reinserimento sociale destinato ai nuclei familiari a
rischio di esclusione sociale): siffatte previsioni incidono illegittimamente
sulla sfera di competenza regionale, con finanziamenti caratterizzati da
vincoli di destinazione in ambiti di materia spettanti alla competenza
legislativa regionale (rispettivamente, «istruzione» e «servizi sociali»).
Per quanto riguarda, infine, la disposizione che prevede
finanziamenti da destinare al potenziamento dell’attività di ricerca
scientifica e tecnologica,
6.4. Il ricorso all’indebitamento da
parte delle Regioni
La sentenza n. 425 ha deciso in merito alle
impugnative proposte avverso le disposizioni della legge finanziaria 2004 le
quali prevedono che, «ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della
Costituzione, le Regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli
organismi di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ricorrere
all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento», e che «le Regioni
a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l’indebitamento
delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi in
qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, solo per finanziare spese
di investimento».
Al riguardo, le Regioni a statuto speciale e
Altre censure, sollevate anche da Regioni a statuto
ordinario, concernono, da un lato, l’estensione dell’applicazione delle norme
ad enti diversi da quelli espressamente indicati nell’art. 119, sesto comma, e,
dall’altro, le restrizioni che si apportano alle nozioni di indebitamento e di
investimento. Viene contestato inoltre il potere ministeriale di modificare con
proprio decreto le tipologie di operazioni costituenti indebitamento ed
investimento.
Le censure sono dichiarate in parte fondate ed in parte non
fondate.
Sono invece fondate le censure che investono le disposizioni
che attribuiscono al Ministro dell’economia e delle finanze il potere di
disporre con proprio decreto modifiche alle tipologie di «indebitamento» e di
«investimento» stabilite ai fini di cui all’art. 119, sesto comma, della
Costituzione. Tali disposizioni conferiscono al Ministro una potestà il cui esercizio
può comportare una ulteriore restrizione della facoltà per gli enti autonomi di
ricorrere all’indebitamento per finanziare le proprie spese senza che sia osservato
il rispetto del principio di legalità sostanziale, in forza del quale l’esercizio
di un potere politico-amministrativo incidente sull’autonomia regionale (nonché
sull’autonomia locale) può essere ammesso solo sulla base di previsioni
legislative che predeterminino in via generale il contenuto delle statuizioni
dell’esecutivo, delimitandone la discrezionalità.
6.5. Il patrimonio degli enti
autonomi
Con la sentenza n. 427,
La disposizione costituisce, in definitiva, una
manifestazione del potere dominicale dello Stato di disporre dei propri beni e,
come tale, non incontra i limiti della ripartizione delle competenze secondo le
materie.
6.6. Il regime tributario della
Regione Siciliana
Nel 2004,
a) La sentenza n. 29 ha ad oggetto, in primo luogo,
la disposizione statale che riserva allo Stato il gettito di imposte
sostitutive correlate all’emersione di basi imponibili, destinandolo ad
apposito fondo. Tale disposizione è stata impugnata in quanto asseritamente
lesiva delle prerogative della Regione in materia finanziaria. Disattendendo la
censura,
Ne consegue che, trattandosi di un imposta sostitutiva di
tributi di pacifica spettanza della Regione Siciliana, il gettito derivante
dalle stesse non possa confluire nel fondo statale, perché ciò sarebbe in
contrasto con la normativa di attuazione dello Statuto speciale, secondo la
quale spettano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel
suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia
destinato alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità
dello Stato.
Per le ragioni sopra riportate,
Sempre nella stessa pronuncia,
b) Nella sentenza n. 103,
c) In sede di conflitto di attribuzione sollevato dalla
Regione siciliana,
Del pari infondata è stata ritenuta la tesi secondo cui il
gettito dell’imposta sia ormai attribuito alle province, in quanto la normativa
statale limita il trasferimento con riferimento alle Regioni a statuto
ordinario, mentre demanda alle Regioni a statuto speciale l’attuazione sul
proprio territorio delle disposizioni sulla devoluzione del tributo alle
province.
7. I referendum consultivi delle popolazioni locali
7.1. Il distacco di un Comune da una
Regione e la sua aggregazione ad un’altra
La sentenza n. 334 ha deciso la questione di
legittimità costituzionale sollevata dall’Ufficio centrale per il referendum presso
Il procedimento disegnato dalla disposizione legislativa, nel
richiedere le deliberazioni di una quota consistente di consigli non
direttamente interessati dalla variazione territoriale, appariva eccessivamente
onerosa per i richiedenti, risolvendosi nella frustrazione del diritto di
autodeterminazione dell’autonomia locale, la cui affermazione e garanzia è
risultata invece tendenzialmente accentuata (attraverso l’introduzione dell’esplicito
riferimento alla approvazione da parte della «maggioranza delle popolazioni
della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati»)
a seguito della riforma dell’art. 132 della Costituzione avvenuta del 2001.
7.2. Il mutamento di denominazione di
un Comune
Conformandosi ad un indirizzo ampiamente consolidato,
A proposito dei rapporti tra diritto interno e diritto
comunitario, di rilievo appare la sentenza n. 129, che ha risolto un conflitto di
attribuzione tra
L’iter logico
seguito dal giudice si basava essenzialmente sulla constatazione che, «dopo la
riforma del Titolo V della Costituzione, quel nucleo minimo di salvaguardia
della fauna selvatica che [avrebbe giustificato] una disciplina di livello
nazionale sarebbe [stato] ascrivibile […] all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva alla
legislazione esclusiva statale la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema». Anziché
concludere nel senso della illegittimità costituzionale della legge regionale,
e rinviare conseguentemente alla Corte la questione inerente all’incompetenza
della fonte, il giudice aveva tuttavia provveduto direttamente alla disapplicazione.
Ora, l’unica condizione che avrebbe reso legittima la disapplicazione
era l’efficacia diretta dell’atto comunitario. Le incertezze riscontrabili nell’ordinanza
in ordine al profilo della efficacia diretta, che il giudice non dimostrava e
nemmeno affermava, e la denuncia di una incompatibilità che non si risolveva
unicamente nel rapporto tra la direttiva e la legge regionale, ma richiedeva la
necessaria intermediazione legislativa statale, confermavano, ad avviso della
Corte, che tale sviluppo argomentativo aveva carattere meramente servente rispetto
alla effettiva ratio decidendi, che
consisteva nel denunciato vizio di incompetenza della legge regionale. La disapplicazione
operata su tale premessa era pertanto dichiarata illegittima in quanto lesiva
delle attribuzioni costituzionali della Regione ricorrente.
2. Il diritto comunitario nelle rationes decidendi della Corte
Tralasciando, in questa sede, l’esame puntuale dei casi che
si sono posti in relazione a norme attuative di obblighi comunitari, possono
segnalarsi alcuni esempi di decisioni nelle quali il riferimento al diritto
comunitario si è integrato nella ratio
decidendi al fine di rafforzare l’argomentazione esposta.
Così, onde dichiarare infondato un ricorso avverso una legge
regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia,
Del pari, nel respingere i ricorsi regionali diretti contro
una disposizione della legge finanziaria per il 2002, la sentenza n.
Le modifiche intervenute a livello di direttive comunitarie
hanno fornito un elemento da cui trarre la deduzione secondo cui, anche se non
si è prodotta una modifica del diritto statale, si è «sostanzialmente
affiancato al preesistente sistema sulla disciplina igienica relativa alle
sostanze alimentari un diverso sistema, di matrice europea, di garanzia
sostanziale (e di controllo) sulle modalità di tutela dell’igiene dei prodotti
alimentari», nel quale l’eliminazione dell’obbligo del «libretto di idoneità
sanitaria» da parte di alcune Regioni trova una propria legittimità (sentenza n. 162).
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge
regionale che dettava norme restrittive in tema di sperimentazione scientifica
sugli animali si è fondata sul rilievo in base al quale, sebbene la normativa
comunitaria autorizzasse gli Stati membri ad adottare o ad applicare anche
«misure più rigide per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali
o per il controllo e la limitazione dell’uso degli animali in esperimenti», il
legislatore statale, nell’esercizio del proprio potere di determinare i
principi fondamentali della materia, non si era limitato a recepire il livello
di tutela previsto dalla normativa comunitaria, ma aveva già direttamente
dettato una disciplina in parte più rigida delle prescrizioni della direttiva
europea, peraltro attraverso una regolamentazione uniforme per tutto il
territorio nazionale (sentenza n. 166).
Anche l’illegittimità di una legge regionale in tema di
istituzione di case da gioco è stata argomentata, tra l’altro, attraverso un
richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che «ha affermato che
spetta agli Stati membri determinare l’ampiezza della tutela dell’impresa con
riferimento al gioco d’azzardo ed ha fondato la discrezionalità di cui devono
godere le autorità nazionali, oltre che sulle sue dannose conseguenze
individuali e sociali, proprio sugli elevati rischi di criminalità e di frode
che ad esso si accompagnano» (sentenza n. 185).
Onde dichiarare l’inammissibilità di una questione con la
quale si chiedeva alla Corte un intervento che, per il suo carattere
apertamente «creativo», le era precluso, si è rilevato come «la disciplina
oggetto dello scrutinio di costituzionalità appa[risse] destinata ad essere
rivista nell’immediato dal legislatore […] nel quadro dell’attuazione di due
direttive comunitarie: la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate
e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), che sostituisce ed abroga
la direttiva 89/592/CEE, in
attuazione della quale la disciplina dell’insider
trading era stata originariamente introdotta nel nostro ordinamento; nonché
la direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalità
di esecuzione di essa» (sentenza n. 382).
A tali decisioni, debbono poi aggiungersi quelle (in
particolare, sentenze numeri 14 e 272) che,
nel tratteggiare i limiti entro i quali lo Stato può esercitare la funzione di
«tutela della concorrenza», hanno operato riferimenti – più o meno espliciti e
diretti – alla definizione della nozione che è riscontrabile in ambito
comunitario (sulla «tutela della concorrenza», v., amplius, supra, cap. III,
par. 4.1.2).
Parimenti, con la sentenza n. 6 si è negato, attraverso
riferimenti al diritto comunitario, che il concetto di «sicurezza», utilizzato
nella legislazione sull’energia come «sicurezza dell’approvvigionamento di
energia elettrica» e «sicurezza tecnica», potesse essere ricondotto alla
materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale», di cui alla lettera h)
del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione.
Infine, una evidente centralità nella ratio decidendi è stata assunta dal diritto comunitario in merito
ad una questione sollevata dal Consiglio di Stato, chiamato a fare applicazione,
onde pronunciarsi sul rilascio di una concessione all’esercizio di impianti di
radiodiffusione sonora, della disposizione che stabilisce che la maggioranza
delle azioni o quote delle società concessionarie private di radiodiffusione
sonora e televisiva, nonché delle società che direttamente o indirettamente le
controllino, o comunque un numero di azioni o quote che consenta il controllo
delle società o il loro collegamento, non può appartenere a persone fisiche, giuridiche,
società con o senza personalità giuridica, di cittadinanza o nazionalità
straniera, fatto salvo – tra l’altro – il caso di società costituite in Stati
appartenenti alla Comunità economica europea.
Il rimettente interpretava la disposizione impugnata nel
senso che essa, mentre escludeva che i soci delle società italiane
concessionarie o controllanti delle medesime potessero essere in maggioranza di
cittadinanza o nazionalità estera, non prevedeva lo stesso limite nei confronti
delle società concessionarie o controllanti costituite in un altro Stato
appartenente alla Comunità economica europea, realizzandosi, in tal modo, una
«discriminazione a rovescio» a danno delle società italiane nei confronti di
quelle di altri Stati comunitari.
Con la sentenza n. 86, rilevata la necessità di
leggere il diritto positivo in conformità ai principi costituzionali e
comunitari, è stata offerta una diversa interpretazione, in base alla quale debbono
essere integralmente parificati i requisiti che debbono essere posseduti dalle
società di altri Stati comunitari a quelli prescritti per le società di
nazionalità italiana.
3. (Segue:) il rilievo del diritto
internazionale
Sebbene meno frequentemente rispetto al diritto comunitario,
anche il diritto internazionale è stato invocato in alcune occasioni, nell’ambito
dell’iter logico che ha condotto ad
una determinata soluzione giurisprudenziale.
Si segnalano, a tal proposito, le sentenze numeri 231 e 413.
La prima, che ha dichiarato infondata la questione di
legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 314 del codice di procedura
penale, «nella parte in cui, in tema di estradizione passiva, non prevede la
riparazione per ingiusta detenzione nel caso di arresto provvisorio e di
applicazione provvisoria di misura custodiale su domanda dello Stato estero che
si accerti carente di giurisdizione», ha sottolineato come, «con specifico riferimento
alla detenzione a fini estradizionali,
Nella seconda, è stato rilevato che la proposta
interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 314, comma 3, del codice di
procedura penale (impugnato «nella parte in cui non prevede, in caso di
archiviazione del procedimento per morte del reo, la spettanza della riparazione
per ingiusta detenzione qualora nello stesso procedimento o comunque sulla base
dello stesso materiale probatorio si accerti nei confronti del coimputati che
il fatto non sussiste») era avvalorata da significative indicazioni normative,
anche di natura sovranazionale: «l’art. 2, n. 100, della legge 16 febbraio
1987, n. 81, contenente la delega legislativa per l’emanazione del nuovo codice
di procedura penale, enuncia la direttiva della riparazione dell’ingiusta
detenzione, senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa
o le ‘ragioni’ dell’ingiustizia; tra le convenzioni internazionali ratificate
dall’Italia relative ai diritti della persona e al processo penale,
4. I rapporti tra
Con precipuo riguardo ai rapporti tra la giurisdizione
costituzionale e la giurisdizione comunitaria, si segnalano le ordinanze numeri
125 e 165, già
menzionate nell’analisi dei profili processuali del giudizio di legittimità costituzionale
in via incidentale (cfr. supra parte
I, cap. I, par. 11.1). La prima ha ordinato la restituzione degli atti al
giudice rimettente tra l’altro in conseguenza del fatto che, dopo che la
questione era stata sollevata, «
5. Le Regioni ed il diritto
comunitario
Notevole rilievo, relativamente alla disciplina della
partecipazione delle Regioni al processo decisionale comunitario, ha avuto la sentenza n. 239, resa con riguardo all’art. 5
della legge n. 131 del 2003.
In tale decisione,
La prima riguardava la presunta violazione dell’art. 117,
terzo comma, della Costituzione, derivante dal carattere di dettaglio delle
norme dettate dallo Stato in una materia (quella dei «rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle Regioni») affidata alla competenza concorrente dello
Stato e delle Regioni.
Disattendendo la seconda censura,
Ad esiti analoghi ha condotto la censura incentrata sulla
previsione concernente la possibilità per il Governo di designare come capo
delegazione – in relazione a materie afferenti alla competenza residuale delle
Regioni – un Presidente di Giunta di una Regione o di una Provincia autonoma,
asseritamente illegittima in quanto non riferita anche alle materie di competenza
primaria delle Regioni speciali o delle Province autonome in base agli statuti
speciali. A tal riguardo, la previsione non può ritenersi irragionevole, alla
luce della considerazione secondo la quale la rappresentanza italiana nei
confronti dell’Unione europea deve necessariamente essere caratterizzata da una
posizione unitaria; al contempo, la titolarità di particolari materie (non
riconducibili all’art. 117, quarto comma, della Costituzione) da parte di una
Regione ad autonomia speciale o di una Provincia autonoma non può legittimare
una pretesa ad assumere la presidenza della delegazione italiana, dal momento
che in questi casi nelle altre aree territoriali le funzioni corrispondenti
spettano agli organi dello Stato.
Infine, immune dai vizi dedotti dalle ricorrenti è stata
ritenuta anche la previsione in base alla quale si consente alle Regioni di far
valere eventuali illegittimità degli atti normativi comunitari «davanti agli
organi competenti», qualora
Altra decisione da segnalare è la sentenza n. 283, resa in sede di conflitto intersoggettivo
tra
La disciplina normativa in questione concerneva ambiti che,
alla luce dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sono sicuramente
riconducibili ad una delle competenze esclusive delle Province autonome, ed in
cui pertanto, l’attuazione delle direttive comunitarie non può non spettare
alle Province autonome.
Il regolamento oggetto del conflitto, non proclamandosi
cedevole di fronte alla futura legislazione provinciale, né intendendo supplire
ad una mancanza di normazione di fonte primaria, e, inoltre, non essendo esecutivo
di una legge statale attuativa di direttive comunitarie, ma ponendosi esso
medesimo come immediatamente attuativo di una direttiva comunitaria, arrecava quindi
una lesione della competenza legislativa provinciale, pretendendo di
condizionare l’esercizio di una potestà provinciale: da ciò l’annullamento dell’atto,
previa declaratoria di spettanza alla Provincia dell’attribuzione in
contestazione.
6. Il potere estero delle Regioni
Con la sentenza n. 238
Alla luce di tali previsioni,
Inoltre, le medesime disposizioni, ad avviso della Corte, non
introducono regole ed istituti suscettibili di dar luogo ad indebite ingerenze
di merito dello Stato nelle decisioni delle Regioni in questa materia, così
ledendone l’autonomia.
In quest’ottica, attraverso una lettura costituzionalmente
conforme delle disposizioni censurate,
Analogamente, la possibilità per il Ministero degli affari
esteri di «indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei
negoziati» non possono essere intesi come direttive vincolanti in positivo
quanto al contenuto degli accordi, bensì solo come espressione delle esigenze
di salvaguardia degli indirizzi della politica estera, e dunque come
specificazione del vincolo generale nascente a carico della Regione dalla
riserva allo Stato della competenza a formulare e sviluppare tali indirizzi, e
dal conseguente divieto di pregiudicarli con attività e atti di essi lesivi.
Quanto alla prevista collaborazione degli uffici diplomatici
e consolari,
In ordine alla necessità di un accertamento preventivo da
parte del Ministero degli affari esteri della «opportunità politica» e della
«legittimità» dell’accordo, tale previsione deve intendersi nel senso che esso
non legittima alcuna ingerenza nelle scelte di opportunità e di merito
attinenti all’esplicazione dell’autonomia della Regione: il Governo può
legittimamente opporsi alla conclusione di un accordo da parte di una Regione
solo quando ritenga che esso pregiudichi gli indirizzi e gli interessi attinenti
alla politica estera dello Stato.
Una lettura costituzionalmente conforme si è imposta anche
con riferimento alla previsione secondo cui la stipulazione degli accordi deve
essere preceduta, a pena di nullità degli accordi medesimi, dal conferimento da
parte del Ministero degli affari esteri dei «pieni poteri di firma»: quest’ultimo
istituto ha il fine di dare certezza riguardo al fatto che il consenso prestato
o la firma apposta al trattato siano realmente idonei a impegnare lo Stato nell’ordinamento
internazionale, provenendo da chi ha i poteri rappresentativi a ciò necessari;
poiché però, secondo il diritto interno,
Se la sentenza n. 238 fissa alcuni punti fermi, sul
piano generale, in tema di esercizio dal parte delle Regioni del c.d. «potere
estero», un’altra decisione merita di essere segnalata, non solo per l’interesse
del caso di specie, ma anche per la circostanza che in essa il potere estero si
interseca con quello della partecipazione delle autonomie territoriali alla
politica comunitaria. Il riferimento va alla sentenza n. 258, specificamente concernente la conclusione di un accordo di
cooperazione transfrontaliera, nell’ambito del programma comunitario denominato
«Interreg III A, Italia-Austria». Nella specie,