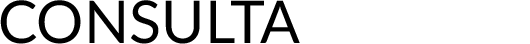SENTENZA N. 394
ANNO 2006
Commenti alla decisione di
I. Vittorio Manes, Illegittime le "norme penali di favore” in materia di falsità nelle competizioni elettorali, (per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)
II. Andrea Ridolfi, Intervento della Corte costituzionale in materia di reati elettorali, (per gentile concessione del sito dell’AIC – Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
III. Irene Pellizzone, Il fondamento costituzionale del principio di retroattività delle norme penali in bonam partem: due decisioni dall’impostazione divergente (sentt. n. 393 e n. 394 del 2006) (per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali), dell’art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), come modificato dall’art. 1, comma 2, della legge 2 marzo 2004, n. 61, e dell’art. 100, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 2 marzo 2004, n. 61, promossi con ordinanze del 10 maggio 2004 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, del 15 aprile 2004 dal Tribunale di Firenze, del 9 giugno 2004 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, del 27 maggio 2004 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pescara e del 18 novembre 2004 dal Tribunale di Roma, rispettivamente iscritte ai numeri 690, 769, 831, 996 del registro ordinanze 2004 e al n. 231 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai numeri 33, 41, 44 e 50, prima serie speciale, dell’anno 2004 e n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visti gli atti di intervento, di cui uno fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’8 novembre 2006 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto in fatto
1.1. – Con le due ordinanze indicate in epigrafe, di analogo tenore, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali), nella parte in cui, al comma 2, lettera a), numero 1), ha sostituito il terzo comma dell’art. 90 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), stabilendo che «chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l’autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell’ammenda da 500 euro a 2.000 euro».
Il giudice a quo premette di procedere nei confronti di persone imputate, nell’un caso (ordinanza r.o. n. 690 del 2004), del reato di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge n. 61 del 2004; e, nell’altro caso (ordinanza r.o. n. 831 del 2004), del reato di cui all’art. 479 del codice penale, per avere, in qualità di pubblici ufficiali legittimati all’autenticazione delle sottoscrizioni, attestato falsamente l’avvenuta apposizione in loro presenza delle firme di alcuni sottoscrittori di liste di candidati ad elezioni comunali e l’avvenuta identificazione degli stessi a mezzo di documenti di identità (fatti commessi nell’aprile 2003). In entrambi i casi il pubblico ministero aveva formulato richiesta di emissione di decreto penale di condanna, eccependo tuttavia contestualmente l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 61 del 2004, per contrasto con il principio di eguaglianza.
Il rimettente osserva come la norma impugnata determini, in effetti, una evidente disparità di trattamento fra le falsità in autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste di candidati, soggette alla sola pena dell’ammenda, e le falsità «in atti fidefacienti suscettivi della medesima efficacia», punite invece come delitto e con pena detentiva dagli artt. 476 e 479 cod. pen. Tale sperequazione si rivelerebbe del tutto irragionevole: giacché se, per un verso, l’autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati costituisce indubbiamente atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 del codice civile, in quanto destinata a far prova, fino a querela di falso, di quanto in essa attestato; per un altro verso, dovrebbe con tutta evidenza escludersi che l’attinenza alla materia elettorale possa attenuare il disvalore della falsità.
Il rimettente richiama, in proposito, la sentenza n. 84 del 1997. Con essa questa Corte – nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 93 del d.P.R. n. 570 del 1960 – ha rimarcato come il differente trattamento sanzionatorio della sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidatura, a seconda che essa abbia luogo nell’ambito di elezioni amministrative o politiche, sarebbe stato difficilmente giustificabile ove fosse dipeso da una diversa valutazione in astratto della gravità dei comportamenti, di per sé identici, piuttosto che dalla particolare tecnica utilizzata dal legislatore nella redazione della norma incriminatrice considerata. Il giudice a quo ricorda, ancora, come con la sentenza n. 403 del 1988 (recte: con l’ordinanza n. 433 del 1998) questa Corte abbia ritenuto ragionevole la diversa e più mite risposta sanzionatoria prefigurata dall’art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) per l’indebita percezione di fondi dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), rispetto a quella prevista dall’art. 640-bis cod. pen. per la truffa in erogazioni pubbliche: e ciò sul rilievo che le due norme incriminatrici si porrebbero in rapporto di sussidiarietà e non di specialità, essendo la prima di esse volta a sanzionare condotte (quale il mero mendacio documentale) non punibili in base alla seconda.
Considerazioni similari non sarebbero tuttavia riproponibili nel caso in esame: giacché con la norma censurata il legislatore avrebbe effettuato esclusivamente una diversa valutazione in astratto della gravità del falso avente ad oggetto l’autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali e di candidati, rispetto a quello sanzionato, in termini generali, dagli artt. 476 e 479 cod. pen.
La questione sarebbe infine rilevante nei giudizi a quibus, dato che gli imputati – soggetti esclusivamente alla pena dell’ammenda in base alla nuova norma – nel caso in cui la stessa fosse dichiarata incostituzionale dovrebbero invece rispondere di un delitto.
1.2. – In entrambi i giudizi di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
La difesa erariale rileva come – alla stregua della giurisprudenza di questa Corte – il sindacato di costituzionalità in materia di proporzione e adeguatezza delle sanzioni penali, pur ammissibile, debba essere tuttavia contenuto entro limiti rigorosi. Una violazione, sotto tale profilo, dell’art. 3 Cost. sarebbe infatti ravvisabile solo quando siano previsti trattamenti sanzionatori significativamente differenziati di fattispecie per ogni aspetto analoghe; rimane, per contro, escluso che possano assumere rilievo, in detta direzione, considerazioni soggettive inerenti all’opportunità o all’utilità della singola scelta legislativa, quali quelle svolte dal rimettente.
Né, d’altro canto, sarebbe condivisibile l’assunto del giudice a quo, stando al quale tra la norma incriminatrice di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960 e quelle degli artt. 476 e 479 cod. pen. non sarebbe configurabile un rapporto di specialità: giacché, al contrario, la previsione punitiva in materia elettorale colpisce condotte totalmente corrispondenti ai richiamati paradigmi sanzionatori del codice penale, con il solo elemento specializzante rappresentato dalla particolare categoria di atti incisa dalla falsità. Trattandosi, quindi, di «condotte ad offensività non identica in rapporto di specialità», si dovrebbe riconoscere al legislatore piena autonomia nella scelta del rispettivo trattamento sanzionatorio: e ciò a prescindere dai possibili margini di opinabilità delle soluzioni concretamente adottate, in rapporto alla natura degli interessi coinvolti ed all’armonia del sistema.
2.1. – Una questione di legittimità costituzionale analoga è stata sollevata, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pescara, il quale sottopone peraltro a scrutinio direttamente l’art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 61 del 2004.
Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a celebrare l’udienza preliminare nei confronti di persona imputata del reato di cui al citato art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, per avere – quale consigliere provinciale addetto all’autenticazione delle firme apposte sulle liste di candidati – attestato falsamente, in occasione di una competizione elettorale, l’autenticità di una sottoscrizione e l’avvenuta apposizione della stessa in sua presenza (fatto commesso il 14 marzo 2000). In sede di discussione, il pubblico ministero –intendendo chiedere il rinvio a giudizio dell’imputato – aveva eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 61 del 2004 per violazione dell’art. 3 Cost.
Dopo aver esposto le ragioni della non manifesta infondatezza della questione in termini pressoché identici a quelli delle precedenti ordinanze, il rimettente osserva come il quesito sia senz’altro rilevante nel giudizio a quo. Infatti, ove si dovesse fare applicazione della norma impugnata, il reato non soltanto verrebbe ad avere una fisionomia del tutto diversa, ma risulterebbe altresì prescritto: così da imporre la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per tale causa, ai sensi dell’art. 425 del codice di procedura penale, in luogo del rinvio a giudizio.
2.2. – Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, sulla base di considerazioni identiche a quelle svolte in rapporto alle precedenti ordinanze di rimessione.
3.1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze ha sollevato, su eccezione del pubblico ministero, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., dell’art. 100, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge n. 61 del 2004, nella parte in cui punisce con la pena dell’ammenda da 500 euro a 2.000 euro sia «chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l’autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati»; sia chi «forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati».
Il giudice a quo premette di essere investito del processo penale nei confronti di una pluralità di persone, alcune delle quali imputate del reato di cui all’art. 479 cod. pen., per aver falsamente attestato «l’avvenuta sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale […] di numerosi elenchi di elettori per la presentazione dei candidati di un partito alle elezioni della Camera dei deputati»; altre anche, o soltanto, del reato di cui all’art. 100, secondo comma, del d.P.R. n. 361 del 1957, per avere, «apponendo false firme di sottoscrittori, formato falsamente […] liste di elettori di candidati» nelle predette elezioni.
Il rimettente rileva come entrambe le fattispecie criminose siano state incise dall’art. 1 della legge n. 61 del 2004, che, introducendo la norma «speciale» di cui al terzo comma dell’art. 100 del d.P.R. n. 361 del 1957, ha previsto per le condotte contestate, in luogo dell’originaria pena della reclusione da uno a sei anni, quella dell’ammenda da 500 euro a 2.000 euro. Per effetto di tale modifica – sopravvenuta alla commissione dei fatti, ma applicabile nel giudizio a quo ai sensi dell’art. 2, terzo comma, cod. pen., in quanto più favorevole al reo – i reati per cui si procede dovrebbero essere dichiarati prescritti, risultando interamente decorso il termine biennale stabilito dall’art. 157, primo comma, numero 6), cod. pen., con il massimo prolungamento consentito dall’art. 160, ultimo comma, cod. pen.
Ciò premesso, il giudice a quo esclude che – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli imputati – la questione di costituzionalità debba ritenersi inammissibile, in quanto volta a provocare una pronuncia additiva in malam partem tramite il ripristino di una norma abrogata, o comunque a sollecitare un sindacato su scelte discrezionali del legislatore in tema di politica criminale. Con la legge n. 61 del 2004, infatti, il legislatore ha da un lato mantenuto, nel secondo comma dell’art. 100 del d.P.R. n. 361 del 1957, l’originaria previsione sanzionatoria delle falsità documentali commesse nel corso delle operazioni elettorali; dall’altro lato ha introdotto, al terzo comma, una disposizione speciale che prevede una sanzione diversa e più lieve per alcune delle falsità già rientranti nella «norma generale» del citato secondo comma: norma, quest’ultima, a propria volta speciale rispetto alle disposizioni del codice penale in materia di falso documentale e personale. Di conseguenza, l’eventuale pronuncia di incostituzionalità si limiterebbe a decretare l’illegittimità della norma speciale, senza aggiungere alcuna norma né ripristinare norme abrogate, dato che le particolari condotte di falso ora contemplate dal terzo comma dell’art. 100 rimarrebbero punite dalle norme «generali» contenute nel secondo comma dello stesso articolo e nel codice penale. Al tempo stesso, poi, l’ampia discrezionalità di cui il legislatore gode in materia di politica criminale troverebbe pur sempre un limite nella manifesta irragionevolezza delle scelte operate, risultando anche in tale materia ineludibile il rispetto dei principi costituzionali, tra cui, in primis, quello stabilito dall’art. 3 Cost.
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente evidenzia come la novella legislativa censurata abbia determinato una serie di incongruenze nel sistema sanzionatorio delle falsità in atti – sia all’interno della stessa categoria dei reati elettorali, sia nel confronto con la disciplina generale stabilita dal codice penale – facendo sì che condotte identiche o di pari gravità risultino irragionevolmente sottoposte a pene marcatamente sperequate.
Del tutto irragionevole sarebbe così, anzitutto, che la falsa formazione di liste di elettori o di candidati sia punita in modo assai più lieve rispetto alla falsa formazione o alterazione di qualunque altro atto concernente le operazioni elettorali, per la quale il secondo comma dell’art. 100 del d.P.R. n. 361 del 1957 continua a comminare la pena della reclusione da uno a sei anni. La formazione di false liste di elettori o di candidati risulterebbe, difatti, gravemente lesiva dei diritti elettorali di ogni cittadino, incidendo sulla regolarità delle operazioni di voto in modo persino maggiore rispetto alla falsificazione di altri atti (quale, ad esempio, una singola scheda o un singolo certificato elettorale), in quanto consente che partecipi alla competizione un partito o un candidato non presentato dal numero minimo di elettori prescritto dalla legge; col risultato di alterare l’esito dell’intera votazione.
Altrettanto irrazionale sarebbe, poi, che venga punito con una semplice ammenda chi forma falsamente le liste di candidati o di elettori, quando invece chi «sostituisce, sopprime o distrugge» qualunque atto relativo alle operazioni elettorali – ivi comprese le predette liste – resta tuttora soggetto alla severa pena detentiva comminata dal secondo comma dell’art. 100. Tanto la presentazione di false liste, quanto la soppressione o distruzione di quelle vere sarebbero infatti idonee a produrre il medesimo effetto, consistente nell’alterare le operazioni di voto, incidendo sulla partecipazione di partiti e candidati: o col permettere loro di concorrere illegittimamente (nel caso della falsificazione delle liste), ovvero con l’escluderli indebitamente (nel caso della distruzione di liste regolarmente formate).
Le medesime considerazioni varrebbero in rapporto alla disparità di trattamento riscontrabile tra chi forma falsamente le liste di elettori o di candidati e chi «fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti»: condotta, quest’ultima, compresa – anche in rapporto alle liste – nell’area applicativa della fattispecie delittuosa del secondo comma dell’art. 100. Risulterebbe evidente, anche in questo caso, l’identità del disvalore delle due condotte: dovendosi semmai ritenere più grave la condotta di chi pone in essere la falsificazione o partecipa ad essa, rispetto a quella di chi si limita a depositare la falsa lista da altri predisposta.
Un ulteriore profilo di irragionevolezza andrebbe rinvenuto nella previsione del terzo comma dell’art. 100, che assoggetta alla sola pena dell’ammenda chi commette «uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l’autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati». In relazione a condotte identiche del pubblico ufficiale, ma concernenti sottoscrizioni di altro tipo, la disciplina generale del codice penale (art. 479 cod. pen.) prevede, difatti, un trattamento sanzionatorio ben più grave; parimenti, la falsa attestazione della propria identità da parte dell’elettore – punita con la sola ammenda se effettuata in occasione della sottoscrizione di una lista – incorrerebbe nella pena detentiva prevista dagli artt. 494 o 495 cod. pen. ove abbia luogo in diverso contesto (ad esempio, ai fini della consegna di un certificato elettorale).
Considerato il rapporto di specialità che, per costante giurisprudenza, intercorre fra il reato di cui all’art. 100 del d.P.R. n. 361 del 1957 ed i delitti di falso documentale contemplati dal codice penale, il divario evidenziato nella risposta punitiva non sarebbe in alcun modo giustificabile. Risulterebbe, infatti, del tutto irrazionale punire più gravemente un comportamento che può avere scarsa «rilevanza pubblica» (quale, ad esempio, la falsa autenticazione della firma apposta su un contratto privato o sulla domanda di partecipazione ad un concorso), rispetto ad altro comportamento (quale la falsa autenticazione di sottoscrizioni di liste) che – consentendo l’irregolare partecipazione di un candidato o di un partito alla competizione elettorale – ha «una rilevanza pubblica enorme, in quanto incide sul godimento di uno dei diritti fondamentali del cittadino, quello elettorale attivo e passivo, essenza stessa della vita democratica».
La previsione normativa dianzi riprodotta si porrebbe in contrasto anche con il principio di «chiarezza e tassatività» della norma penale, desumibile dall’art. 25 Cost., posto che il generico riferimento alla commissione di «uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale» sarebbe tale da abbracciare un’ampia gamma di condotte diverse, «non sufficientemente individuabili» per il tramite di detto rinvio. Al tempo stesso, col prevedere che in ogni caso si applichi un’identica pena (l’ammenda), la disposizione censurata opererebbe un irrazionale livellamento sanzionatorio di fattispecie eterogenee – ad esempio, la condotta di chi attesti falsamente al pubblico ufficiale la propria identità per sottoscrivere una lista di elettori e quella del pubblico ufficiale che attesti il falso nell’autenticazione della sottoscrizione – le quali, «nella loro forma ordinaria», risultano punite in modo significativamente difforme dal codice penale (artt. 495 e 479 cod. pen.).
L’illegittimità della norma censurata emergerebbe, infine, anche dal raffronto con il trattamento sanzionatorio – in questo caso «irragionevolmente simile» – previsto per la condotta, assai meno grave, di chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura: violazione, quest’ultima, che l’art. 106 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall’art. 1 della stessa legge n. 61 del 2004, punisce con l’ammenda da 200 euro a 1.000 euro, e dunque con pena solo di poco più lieve di quella comminata dalla norma impugnata per un fatto di ben più accentuato disvalore.
3.2. – Nel giudizio di costituzionalità è tardivamente intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
4.1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera a), secondo capoverso, della legge n. 61 del 2004, nella parte in cui – sostituendo il terzo comma dell’art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960 – stabilisce che «chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l’autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell’ammenda da 500 euro a 2.000 euro».
Il giudice a quo riferisce di procedere nei confronti di due persone imputate dei reati di cui agli artt. 485 e 479 cod. pen. e all’art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, in relazione a falsità commesse nelle rispettive qualità di presentatore delle «liste elettorali» di un partito politico, e di pubblico ufficiale addetto all’autenticazione delle firme dei candidati alla carica di consigliere circoscrizionale del IV Municipio del Comune di Roma: falsità consistite, in specie, nell’apposizione di false firme di accettazione delle candidature; nella falsa attestazione dell’avvenuta identificazione dei candidati e dell’autenticità della firma da questi apposta; e, di conseguenza, nella falsa formazione della lista dei candidati del partito in questione (fatti tutti commessi in epoca antecedente e prossima al 14 aprile 2001). Il rimettente riferisce, altresì, che all’«udienza di costituzione delle parti», il difensore di uno degli imputati aveva chiesto che venisse dichiarata, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione per prescrizione dei reati contestati al proprio assistito, alla luce della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 61 del 2004.
Ciò premesso, il rimettente ritiene di dover fare applicazione della norma censurata in rapporto alle imputazioni relative ai reati di cui agli artt. 479 cod. pen. e 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, posto che i fatti contestati a tal titolo – concernenti la falsità ideologica nell’autenticazione di sottoscrizioni e la falsa formazione di una lista di candidati – rientrerebbero certamente nella previsione del terzo comma del citato art. 90, come novellato dall’art. 1, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 61 del 2004, sopravvenuta alla commissione dei fatti stessi ed implicante una risposta punitiva largamente più mite.
La rilevanza della questione resterebbe tuttavia limitata al solo reato di falsa autenticazione di sottoscrizioni delle liste di candidati, in quanto per il reato di falsa formazione delle medesime liste l’eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma modificatrice non inciderebbe sull’esito del giudizio, dovendosi comunque dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. La fattispecie della falsa formazione di liste di candidati era infatti già punita dal testo originario del secondo comma dell’art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960: con la conseguenza che la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunciata, facendo "rivivere” la vecchia norma, renderebbe applicabile al reato in questione il termine biennale di prescrizione stabilito dall’art. 100 del medesimo decreto in relazione a tutti i reati in esso contemplati. Al contrario, la falsa autenticazione delle sottoscrizioni delle liste di candidati, espressamente prevista nella nuova norma, non era menzionata nella vecchia, e doveva quindi ritenersi punibile in base alla norma generale sul falso ideologico del pubblico ufficiale in atto pubblico, di cui all’art. 479 cod. pen.: cosicché, rimossa la disposizione denunciata, la fattispecie in parola tornerebbe ad essere regolata dalla norma del codice; con conseguente inapplicabilità del termine prescrizionale più breve.
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente assume che la previsione della sola pena dell’ammenda, per la falsa autenticazione delle sottoscrizioni di liste di candidati, si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost.; si determinerebbe, infatti, un trattamento sanzionatorio nettamente differenziato di condotte pienamente «sovrapponibili tra loro», posto che la falsità in autenticazione di firme da parte del pubblico ufficiale integra, negli altri casi, il delitto di cui al citato art. 479 cod. pen., punito con la reclusione da uno a sei anni. Siffatto salto nella risposta punitiva risulterebbe ancor più irragionevole, ove si consideri che il falso incidente sul procedimento di formazione delle liste coinvolge un ambito direttamente presidiato da precetti costituzionali, quale quello relativo al diritto di voto (art. 48 Cost.). Il libero esercizio di tale diritto verrebbe infatti compromesso dalla indicazione di falsi candidati, a favore dei quali il cittadino potrebbe esprimere il proprio voto, che risulterebbe così inutilmente dato: circostanza, questa, che avrebbe dovuto suggerire, non già un affievolimento, ma semmai un inasprimento del trattamento sanzionatorio, proporzionale alla pregnanza costituzionale degli interessi lesi.
Sotto tale profilo, risulterebbe contraddetto anche il fine rieducativo assegnato alla pena dall’art. 27, terzo comma, Cost., giacché – prevedendo una reazione punitiva diversificata in rapporto alla condotta di falso che incida su competizioni elettorali e, al tempo stesso, assolutamente sproporzionata per difetto ai valori da essa pregiudicati – la norma impugnata farebbe sì che il condannato percepisca del trattamento sanzionatorio «solo la minima portata afflittiva, senza essere messo in grado di comprendere appieno il reale, rilevante disvalore della sua condotta».
4.2. – Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata sulla base di considerazioni identiche a quelle svolte in rapporto alle ordinanze di rimessione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara.
Considerato in diritto
1.1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ed il Giudice dell’udienza preliminare del medesimo Tribunale dubitano, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61, nella parte in cui, al comma 2, lettera a), numero 1), ha sostituito il terzo comma dell’art. 90 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).
I giudici rimettenti impugnano il primo la norma sostituente, e il secondo la norma sostituita. Essi assumono che – col sottoporre alla sola pena dell’ammenda le falsità in autenticazioni delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati – la disposizione censurata avrebbe generato una evidente disparità fra il trattamento sanzionatorio delle predette falsità e quello, ben più energico, stabilito dagli artt. 476 e 479 del codice penale, per il falso in atti fidefacenti della medesima efficacia: disparità da ritenere del tutto irragionevole, non potendo ipotizzarsi che l’incidenza sulla materia elettorale attenui il disvalore del falso.
1.2. – Analoghe censure muove all’art. 1, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 61 del 2004 il Tribunale di Roma. Esso rimarca come l’attitudine del falso in liste di candidati a compromettere in modo diretto valori costituzionalmente garantiti – quale, in primis, la libertà del diritto di voto (art. 48 Cost.) – avrebbe dovuto suggerire non già un’attenuazione, ma semmai un irrigidimento della risposta punitiva prefigurata in via generale dall’art. 479 cod. pen. per la falsità in autenticazione di firme.
Sotto tale profilo, il rimettente ritiene quindi leso anche il principio della finalità rieducativa della pena, sancito dall’art. 27, terzo comma, Cost., sul rilievo che la previsione di una sanzione affievolita e non proporzionata, per difetto, alle capacità di offesa del fatto incriminato, impedirebbe al condannato di percepirne in modo adeguato il disvalore.
1.3. – Il Tribunale di Firenze sottopone a sua volta a scrutinio di costituzionalità l’art. 100, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge n. 61 del 2004, sostenendone la contrarietà agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui punisce con la pena dell’ammenda da 500 euro a 2.000 euro sia «chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l’autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati»; sia chi «forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati».
Il rimettente rimarca preliminarmente − in punto di ammissibilità della questione – come il quesito non sia volto a provocare né una pronuncia additiva in malam partem, tramite il ripristino di una norma abrogata; né un sindacato su scelte discrezionali del legislatore, in tema di politica criminale. L’invocata declaratoria di illegittimità costituzionale si limiterebbe difatti a rimuovere la norma denunciata: con l’effetto di ricondurre le condotte, attualmente incriminate dal terzo comma del citato art. 100, nella sfera applicativa delle più ampie previsioni punitive racchiuse nel secondo comma dello stesso articolo e nelle norme del codice penale in tema di falso.
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo rileva come la norma censurata determini una serie di incongruenze nel sistema sanzionatorio delle falsità in atti − sia all’interno della categoria dei reati elettorali; sia in rapporto alla disciplina generale del codice penale – facendo sì che condotte identiche o di pari gravità vadano incontro a risposte punitive irragionevolmente diversificate.
Priva di razionale giustificazione sarebbe segnatamente, sul primo versante, l’assai più blanda reazione sanzionatoria alla falsa formazione di liste di elettori o di candidati, prevista dal terzo comma dell’art. 100, rispetto a quella (reclusione da uno a sei anni) stabilita dal secondo comma dello stesso articolo per la falsa formazione o alterazione di qualunque altro atto concernente le operazioni elettorali, nonché per la sostituzione, soppressione o distruzione degli atti in questione o l’uso di atti falsificati, alterati o sostituiti: fattispecie, queste ultime, che potrebbero peraltro avere ad oggetto le stesse liste di elettori o di candidati.
Altrettanto irragionevole, sul secondo versante, risulterebbe la sottoposizione alla sola pena dell’ammenda di un comportamento idoneo ad incidere sul fondamentale diritto elettorale dei cittadini – quale la falsità in autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati – quando invece la falsa autenticazione di tutte le altre sottoscrizioni, ancorché attinenti ad atti di «scarsa rilevanza pubblica», risulta soggetta all’assai più severo regime punitivo dell’art. 479 cod. pen.
Sempre in rapporto alle autenticazioni delle firme, d’altro canto, la tecnica utilizzata dal legislatore nella descrizione della fattispecie incriminata – consistente nel generico rinvio ai reati previsti da due interi capi del codice penale – sarebbe lesiva del principio di «chiarezza e tassatività» della norma penale, desumibile dall’art. 25 Cost., non consentendo di individuare con sufficiente certezza le condotte penalmente represse. Mentre, poi, il conseguente livellamento quoad poenam – con la previsione dell’identica pena dell’ammenda – di fattispecie, quali quelle comprese nelle predette partizioni del codice penale, ordinariamente punite con pene significativamente diversificate, si risolverebbe in un ulteriore vulnus del principio di ragionevolezza.
La compromissione di quest’ultimo emergerebbe, infine, anche dal raffronto con il trattamento sanzionatorio – questa volta irrazionalmente simile – stabilito dall’art. 106 del d.P.R. n. 361 del 1957, nel testo modificato dallo stesso art. 1 della legge n. 61 del 2004, per una condotta di disvalore assai più tenue, quale la sottoscrizione di più di una dichiarazione di presentazione di candidatura.
2. – Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.
3. – In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio relativo all’ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze r.o. n. 769 del 2004, in quanto effettuato oltre il prescritto termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’ordinanza di rimessione.
4. – La questione sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pescara è manifestamente inammissibile.
Il giudice a quo – in sede di udienza preliminare – non è chiamato a determinare la pena in concreto, potendo esclusivamente prosciogliere o rinviare a giudizio: con conseguente ininfluenza, ex se, del trattamento sanzionatorio previsto per il reato per cui si procede rispetto alla sua decisione (sentenza n. 295 del 2002 e ordinanza n. 156 del 2000). Egli motiva, infatti, la rilevanza della questione con la considerazione che la nuova qualificazione contravvenzionale impressa alla fattispecie criminosa dalla norma impugnata – applicabile ai sensi dell’art. 2, terzo comma, cod. pen., quale norma sopravvenuta più favorevole al reo – farebbe sì che il reato risulti prescritto: imponendo di conseguenza la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per tale causa, ex art. 425 cod. proc. pen., anziché il rinvio a giudizio.
Tuttavia, il rimettente omette di prendere in esame la disposizione dell’art. 100, secondo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, che prevedeva (e continua a prevedere, anche dopo la legge n. 61 del 2004) per tutti i reati contemplati dallo stesso testo unico – compreso quello di cui all’art. 90, contestato all’imputato nel giudizio a quo – un termine di prescrizione biennale, identico per durata a quello stabilito per le contravvenzioni punite con la sola ammenda dall’art. 157, primo comma, numero 6), cod. pen. (nel testo vigente alla data dell’ordinanza di rimessione, anteriore alla sostituzione operata dall’art. 6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251).
Tale profilo di omessa ponderazione del quadro normativo, incidendo sull’adeguatezza della motivazione sulla rilevanza, implica dunque la manifesta inammissibilità della questione.
5. – Del pari manifestamente inammissibile è la questione sollevata dal Tribunale di Roma.
Il giudice rimettente, che procede in sede dibattimentale per vari reati, ritiene rilevante la questione unicamente in rapporto alle falsità in autenticazione delle firme delle dichiarazioni di accettazione della candidatura, relativamente alle quali è stato contestato agli imputati il reato di falso ideologico in atto pubblico, di cui all’art. 479 cod. pen.: e ciò sull’assunto che l’eventuale accoglimento della questione consentirebbe di evitare la prescrizione del reato. Alla falsa autenticazione di sottoscrizioni non sarebbe infatti applicabile – secondo il giudice a quo – il termine prescrizionale breve di due anni stabilito dall’art. 100 del d.P.R. n. 570 del 1960, trattandosi di condotta non espressamente contemplata dal testo originario dell’art. 90, secondo comma, del citato decreto, né riconducibile all’ipotesi, già ivi prevista, della falsa formazione di liste di elettori o di candidati; quest’ultimo convincimento risulterebbe confortato anche dall’odierno testo del terzo comma dell’art. 90, il quale configura la falsa autenticazione delle firme e la falsa formazione delle liste come condotte fra loro alternative, secondo quanto emerge dall’impiego della disgiuntiva «ovvero». Di qui la conclusione che − una volta rimossa la norma impugnata – la falsa autenticazione delle firme ricadrebbe nel paradigma punitivo generale del falso ideologico in atto pubblico, ex art. 479 cod. pen., contestato nella specie: con conseguente applicabilità del ben più lungo termine di prescrizione ordinario.
Tuttavia, il giudice a quo omette di dar conto, anche solo al fine di contestare la validità degli argomenti addotti a suo supporto, del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità – ribadito anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 61 del 2004 – in forza del quale la fattispecie della falsa formazione di liste di candidati, già contemplata dal secondo comma dell’art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, abbracciava, a dispetto dell’assenza in essa di espliciti riferimenti al falso ideologico, anche l’ipotesi della falsa autenticazione delle sottoscrizioni per la presentazione di dette liste: con l’effetto di rendere inapplicabile a quest’ultima falsità, in base al principio di specialità (art. 15 cod. pen.), la norma incriminatrice del codice penale. Tale asserto risultava fondato, in specie, sulla considerazione che le autentiche delle firme non servono soltanto ad attribuire all’atto una maggiore efficacia probatoria, ma costituiscono l’elemento per attribuire giuridica esistenza alle dichiarazioni cui accedono: con la conseguenza che il falso – materiale o ideologico – su tale genere di autentiche incide sulla funzione dell’atto stesso; e viola lo speciale interesse al regolare svolgimento delle operazioni elettorali, sotteso alla previsione punitiva de qua.
Deve registrarsi pertanto, anche in questo caso, un difetto di adeguatezza della motivazione sulla rilevanza, tale da rendere il quesito manifestamente inammissibile.
6. – Comune alle residue ordinanze di rimessione è il distinto problema di ammissibilità – che solo il Tribunale di Firenze si pone e ritiene superabile – connesso al petitum, posto che i rimettenti invocano una modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio delle fattispecie criminose considerate.
6.1. – Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, all’adozione di pronunce in malam partem in materia penale osta non già una ragione meramente processuale – di irrilevanza, nel senso che l’eventuale decisione di accoglimento non potrebbe trovare comunque applicazione nel giudizio a quo – ma una ragione sostanziale, intimamente connessa al principio della riserva di legge sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso» (ex plurimis, tra le ultime, sentenze n. 161 del 2004 e n. 49 del 2002, n. 508 del 2000; ordinanze n. 187 del 2005, n. 580 del 2000 e n. 392 del 1998; con particolare riguardo alla materia elettorale, ordinanza n. 132 del 1995). Rimettendo al legislatore – e segnatamente al «soggetto-Parlamento», in quanto rappresentativo dell’intera collettività nazionale (sentenza n. 487 del 1989) – la riserva sulla scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, detto principio impedisce alla Corte sia di creare nuove fattispecie criminose o di estendere quelle esistenti a casi non previsti; sia di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità (e così, ad esempio, sulla disciplina della prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi: ex plurimis, ordinanze n. 317 del 2000 e n. 337 del 1999).
Questa Corte ha peraltro chiarito che il principio di legalità non preclude lo scrutinio di costituzionalità, anche in malam partem, delle c.d. norme penali di favore: ossia delle norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall’applicazione di norme generali o comuni. Di tale orientamento – che trova la sua prima compiuta enunciazione nella sentenza n. 148 del 1983 – questa Corte ha fatto ripetute applicazioni (sentenze n. 167 e n. 194 del 1993; n. 124 del 1990; n. 826 del 1988), anche in rapporto a questioni di costituzionalità omologhe a quelle oggi in esame, dirette a conseguire una modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio di determinate figure di reato (sentenza n. 25 del 1994; v., altresì, le ordinanze n. 95 del 2004 e n. 433 del 1998, con le quali la Corte ha scrutinato direttamente nel merito questioni di tal fatta). Esso si connette all’ineludibile esigenza di evitare la creazione di «zone franche» dell’ordinamento (così la sentenza n. 148 del 1983), sottratte al controllo di costituzionalità, entro le quali il legislatore potrebbe di fatto operare svincolato da ogni regola, stante l’assenza d’uno strumento che permetta alla Corte di riaffermare il primato della Costituzione sulla legislazione ordinaria. Qualora alla preclusione dello scrutinio di costituzionalità in malam partem fosse attribuito carattere assoluto, si determinerebbe, in effetti, una situazione palesemente incongrua: venendosi a riconoscere, in sostanza, che il legislatore è tenuto a rispettare i precetti costituzionali se effettua scelte di aggravamento del trattamento penale, mentre può violarli senza conseguenze, quando dalle sue opzioni derivi un trattamento più favorevole.
In accordo con l’esigenza ora evidenziata, va osservato che il principio di legalità impedisce certamente alla Corte di configurare nuove norme penali; ma non le preclude decisioni ablative di norme che sottraggano determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque più generale, accordando loro un trattamento più benevolo (sentenza n. 148 del 1983): e ciò a prescindere dall’istituto o dal mezzo tecnico tramite il quale tale trattamento si realizza (previsione di una scriminante, di una causa di non punibilità, di una causa di estinzione del reato o della pena, di una circostanza attenuante o di una figura autonoma di reato punita in modo più mite). In simili frangenti, difatti, la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione resta salva: l’effetto in malam partem non discende dall’introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza dell’automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria. Tale riespansione costituisce una reazione naturale dell’ordinamento – conseguente alla sua unitarietà – alla scomparsa della norma incostituzionale: reazione che si verificherebbe in ugual modo anche qualora la fattispecie derogatoria rimossa fosse più grave; nel qual caso a riespandersi sarebbe la norma penale generale meno grave, senza che in siffatto fenomeno possa ravvisarsi alcun intervento creativo o additivo della Corte in materia punitiva.
Con riguardo ai criteri di identificazione delle norme penali di favore, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare come occorra distinguere fra le previsioni normative che "delimitano” l’area di intervento di una norma incriminatrice, concorrendo alla definizione della fattispecie di reato; e quelle che invece "sottraggono” una certa classe di soggetti o di condotte all’ambito di applicazione di altra norma, maggiormente comprensiva. Solo a queste ultime si attaglia, in effetti – ove l’anzidetta sottrazione si risolva nella configurazione di un trattamento privilegiato – la qualificazione di norme penali di favore; non invece alle prime, le quali si traducono in dati normativi espressivi di «una valutazione legislativa in termini di "meritevolezza” ovvero di "bisogno” di pena, idonea a caratterizzare una precisa scelta politico-criminale»: scelta cui la Corte non potrebbe sovrapporre − «senza esorbitare dai propri compiti ed invadere il campo riservato dall’art. 25, secondo comma, Cost. al legislatore» – «una diversa strategia di criminalizzazione volta ad ampliare», tramite ablazione degli elementi stessi, «l’area di operatività della sanzione» (sentenza n. 161 del 2004).
Inoltre, la nozione di norma penale di favore è la risultante di un giudizio di relazione fra due o più norme compresenti nell’ordinamento in un dato momento: rimanendo escluso che detta qualificazione possa esser fatta discendere dal raffronto tra una norma vigente ed una norma anteriore, sostituita dalla prima con effetti di restringimento dell’area di rilevanza penale o di mitigazione della risposta punitiva. In tal caso, difatti, la richiesta di sindacato in malam partem mirerebbe non già a far riespandere la portata di una norma tuttora presente nell’ordinamento, quanto piuttosto a ripristinare la norma abrogata, espressiva di scelte di criminalizzazione non più attuali: operazione, questa, senz’altro preclusa alla Corte, in quanto chiaramente invasiva del monopolio del legislatore su dette scelte (sentenze n. 330 del 1996 e n. 108 del 1981; ordinanza n. 175 del 2001).
6.2. – Sulla base di tali premesse, la natura di norme penali di favore delle disposizioni oggi impugnate risulta palese.
Al riguardo, va rilevato come − con gli originari secondo e terzo comma degli artt. 100 del d.P.R. n. 361 del 1957 e 90 del d.P.R. n. 570 del 1960 − il legislatore avesse delineato, entro il corpus dei reati elettorali, due parallele figure delittuose di falso documentale, valevoli, rispettivamente, in rapporto alle elezioni politiche e alle elezioni amministrative. Le disposizioni del d.P.R. n. 361 del 1957 – relative alle elezioni della Camera dei deputati − risultano infatti estese alle elezioni del Senato e dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo dagli artt. 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18; mentre quelle del d.P.R. n. 570 del 1960 – concernenti le elezioni comunali − risultano applicabili anche alle elezioni regionali e provinciali, in forza degli artt. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e 8 della legge 8 marzo 1951, n. 122.
Si trattava di figure criminose dalla struttura alquanto eterogenea, le quali accorpavano, allineandole sul piano della risposta punitiva edittale – attestata su livelli di significativa severità (reclusione da uno a sei anni nell’art. 100 del d.P.R. n. 361 del 1957; reclusione da due a cinque anni, oltre la multa, nell’art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, cui si sostituiva, in entrambi i casi, la reclusione da due a otto anni, oltre la multa, nel caso di fatto commesso da appartenente all’ufficio elettorale) – plurime ipotesi di falso, che nell’ambito del codice penale formano invece oggetto di considerazione autonoma e diversificata. E ciò in rapporto tanto al soggetto attivo del reato (che poteva identificarsi in «chiunque», e dunque sia in un pubblico ufficiale che in un privato); quanto alla condotta (comprensiva, oltre che della falsificazione e dell’alterazione, anche del falso per soppressione e dell’uso di atto falso); quanto, infine, all’oggetto materiale (dato che il riferimento alle «liste di elettori o di candidati», alle «schede» – espressamente menzionate peraltro, in origine, nel solo art. 100 – e agli «altri atti […] destinati alle operazioni elettorali», era suscettibile di abbracciare tanto atti pubblici che scritture private).
La giurisprudenza di legittimità appariva costante nel ritenere che le norme incriminatrici in questione – stante la specificità del loro oggetto sia giuridico che materiale – si ponessero in rapporto di specialità rispetto alle corrispondenti previsioni punitive del codice penale: escludendo di conseguenza l’applicabilità di queste ultime, nel caso di convergenza su un medesimo episodio. La giurisprudenza di legittimità – secondo quanto già dianzi ricordato ad altro fine – era inoltre orientata a ritenere che l’ipotesi della falsa formazione di liste di elettori o di candidati, contemplata dalle norme stesse, valesse a qualificare penalmente anche la falsa autenticazione delle sottoscrizioni richieste dalla legge ai fini della presentazione delle candidature o delle liste di candidati; e ciò in accordo con la rimarcata ampia comprensività che, nel disegno legislativo, caratterizzava, all’interno del settore elettorale, le figure criminose in parola.
L’assetto ora descritto è stato modificato dalla legge 2 marzo 2004, n. 61, la quale – nel sostituire le previsioni punitive de quibus – ha provveduto anzitutto a renderle pienamente omogenee, tanto sul piano della descrizione delle condotte incriminate, che su quello della risposta sanzionatoria. Il fondamentale elemento di novità consiste, peraltro, nell’avvenuta estrapolazione dal corpo delle originarie figure delittuose – per il resto riproposte – dei falsi concernenti le liste di elettori e di candidati, al fine di riservare loro un distinto e assai più mite trattamento sanzionatorio, configurandoli come contravvenzioni punite con la sola ammenda. Al tempo stesso, nella cornice delle fattispecie contravvenzionali di nuovo conio, all’ipotesi della «falsa formazione» delle predette liste, già espressamente contemplata dalle norme novellate, viene affiancata – in termini alternativi («ovvero»); e con peculiare tecnica di descrizione della condotta incriminata (consistente nel rinvio in blocco ai capi del codice penale concernenti le falsità in atti e personali) – quella della falsità relativa all’autenticazione delle sottoscrizioni delle liste medesime, in precedenza non menzionata e che solo in via interpretativa era ritenuta ricompresa nella prima.
In conseguenza di tali operazioni, il secondo comma dei citati artt. 100 e 90 continua quindi a prevedere come delitto, punito con la pena della reclusione da uno a sei anni – con aumento della stessa da due ad otto anni e con l’aggiunta della multa da 1.000 a 2.000 euro, nel caso di fatto commesso da persona appartenente all’ufficio elettorale – sia la falsa formazione, in tutto o in parte, e l’alterazione di schede o altri atti destinati alle operazioni elettorali; sia la sostituzione, soppressione o distruzione, totale o parziale, dei medesimi atti; sia ancora l’uso, effettuato «scientemente», di atti falsificati, alterati o sostituiti, anche senza concorso nella commissione del fatto. Per contro, il terzo comma dei citati articoli punisce, con la sola pena dell’ammenda da 500 a 2.000 euro, sia «chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l’autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati»; sia chi «forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati».
Tanto premesso, la fattispecie della falsa formazione di liste di elettori o di candidati si pone all’evidenza in rapporto di specialità rispetto al falso elettorale delineato dall’attuale secondo comma degli artt. 100 e 90, dato che le predette liste rappresentano una species del genus degli «atti destinati alle operazioni elettorali», ivi menzionati: ciò emerge inequivocamente, del resto, dall’impiego, nella precedente formulazione dell’art. 90, dell’aggettivo «altri» immediatamente dopo il riferimento alle liste di elettori o di candidati («forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti destinati dal presente testo unico alle operazioni elettorali»). Analogamente, le falsità contravvenzionali relative all’autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati costituiscono ipotesi speciali o rispetto al falso elettorale previsto dal secondo comma degli artt. 100 e 90 citati (nei limiti in cui le si ritenga riconducibili al paradigma della falsa formazione di «atti destinati alle operazioni elettorali»); ovvero, e comunque, rispetto alle fattispecie del codice penale richiamate ai fini della descrizione della condotta, da cui le prime si distinguono unicamente per la specificità dell’oggetto materiale.
Ne deriva che le disposizioni di cui all’attuale terzo comma degli artt. 100 e 90 presentano senz’altro il connotato tipico delle norme penali di favore. Per il tramite dell’applicazione del principio di specialità, di cui all’art. 15 cod. pen., dette disposizioni sottraggono, infatti, dall’ambito applicativo di norme più ampie, compresenti nell’ordinamento, talune fattispecie, allo scopo e con l’effetto di riservare loro un trattamento sanzionatorio (sensibilmente) più mite di quello altrimenti stabilito da tali norme.
6.3. – Le pronunce di questa Corte che hanno riconosciuto l’ammissibilità del sindacato di costituzionalità sulle norme penali di favore si sono fatte carico – una volta superato il profilo di ordine sostanziale – anche del profilo di ordine processuale, connesso alla necessità di verificare l’incidenza della eventuale decisione di accoglimento nel giudizio a quo.
Il problema è stato affrontato avendo riguardo, in particolare, all’ipotesi in cui il fatto oggetto di giudizio fosse stato commesso sotto l’impero della norma penale di favore; evenienza, questa, che evoca uno dei fondamentali principi di garanzia in materia penale, direttamente sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost.: quello di irretroattività della norma penale sfavorevole.
Ferma restando l’assoluta intangibilità del principio in forza del quale nessun soggetto potrebbe essere condannato, o condannato a pena più severa, per un fatto che, nel momento in cui è stato commesso, non costituiva per legge reato, o costituiva un reato meno grave (sentenza n. 161 del 2004), la Corte ha osservato che anche le pronunce concernenti la legittimità delle norme penali di favore potrebbero comunque influire sull’esercizio della funzione giurisdizionale, sotto un triplice profilo. In primo luogo, incidendo sulle formule di proscioglimento o, quanto meno, sui dispositivi delle sentenze penali, i quali dovrebbero imperniarsi sul primo comma dell’art. 2 cod. pen., anziché sulla disposizione annullata. In secondo luogo, perché anche le norme penali di favore fanno parte del sistema, e lo stabilire in qual modo il sistema potrebbe reagire al loro annullamento è problema che i singoli giudici debbono affrontare caso per caso. In terzo luogo e da ultimo, perché non può escludersi che il giudizio della Corte sulla norma penale di favore si concluda con una sentenza interpretativa di rigetto (nei sensi di cui in motivazione) o con una pronuncia correttiva delle premesse esegetiche su cui si fonda l’ordinanza di rimessione: donde una serie di decisioni suscettibili di influire sugli esiti del giudizio penale pendente (sentenze n. 25 del 1994; n. 167 e n. 194 del 1993; n. 124 del 1990; 148 del 1983).
6.4. – Nei casi oggetto delle odierne ordinanze di rimessione si discute, tuttavia, esclusivamente di fatti commessi prima dell’entrata in vigore della norma penale di favore (ergo, quando il fatto era più severamente punito): onde il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole non viene affatto in rilievo. Viene in considerazione, piuttosto, il distinto principio di retroattività della norma penale più mite: principio che – riconosciuto in strumenti internazionali (art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; v. anche art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000, qui richiamata ancorché tuttora priva di efficacia giuridica, per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei: sentenza n. 135 del 2002) – trova espressione nell’ordinamento interno, a livello di legge ordinaria, nell’art. 2, secondo comma e seguenti, cod. pen.
In un simile frangente, peraltro, la conclusione dell’ammissibilità della questione si impone a fortiori, e per una ragione più radicale di quelle dianzi ricordate, riferentisi all’ipotesi di fatto commesso sotto la vigenza della legge più favorevole.
Infatti, il principio di retroattività della lex mitior ha una valenza ben diversa, rispetto al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole. Quest’ultimo si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell’esigenza della "calcolabilità” delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale. Avuto riguardo anche al fondamentale principio di colpevolezza ed alla funzione preventiva della pena, desumibili dall’art. 27 Cost., ognuno dei consociati deve essere posto in grado di adeguarsi liberamente o meno alla legge penale, conoscendo in anticipo – sulla base dell’affidamento nell’ordinamento legale in vigore al momento del fatto – quali conseguenze afflittive potranno scaturire dalla propria decisione (al riguardo, v. sentenza n. 364 del 1988): aspettativa che sarebbe, per contro, manifestamente frustrata qualora il legislatore potesse sottoporre a sanzione criminale un fatto che all’epoca della sua commissione non costituiva reato, o era punito meno severamente.
In questa prospettiva, è dunque incontroverso che il principio de quo trovi diretto riconoscimento nell’art. 25, secondo comma, Cost. in tutte le sue espressioni: e, cioè, non soltanto con riferimento all’ipotesi della nuova incriminazione, sulla quale pure la formula costituzionale risulta all’apparenza calibrata; ma anche con riferimento a quella della modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio di un fatto già in precedenza penalmente represso. In questi termini, il principio in parola si connota, altresì, come valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali. La circostanza che una determinata norma, di rilievo penalistico, sia contraria a Costituzione, non può comunque comportare – come conseguenza della sua rimozione da parte della Corte – l’assoggettamento a pena, o a pena più severa, di un fatto che all’epoca della sua commissione risultava, in base alla norma rimossa, penalmente lecito o soggetto a pena più mite: derivandone, per tale aspetto, un limite al principio della privazione di efficacia della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, enunciato dall’art. 136, primo comma, Cost. e dall’art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) (sentenza n. 148 del 1983).
Invece, il principio di retroattività della norma più favorevole non ha alcun collegamento con la libertà di autodeterminazione individuale, per l’ovvia ragione che, nel caso considerato, la lex mitior sopravviene alla commissione del fatto, al quale l’autore si era liberamente autodeterminato sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo. In quest’ottica, la Corte ha quindi costantemente escluso che il principio di retroattività in mitius trovi copertura nell’art. 25, secondo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 80 del 1995, n. 6 del 1978 e n. 164 del 1974; ordinanza n. 330 del 1995). Ciò non significa, tuttavia, che esso sia privo di un fondamento costituzionale: tale fondamento va individuato, invece, nel principio di eguaglianza, che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma che ha disposto l’abolitio criminis o la modifica mitigatrice.
Va, tuttavia, precisato che i fatti commessi prima e dopo l’entrata in vigore della norma penale favorevole sono identici nella loro materialità, ma non sul piano della "rimproverabilità”. Altro, infatti, è il porre in essere una condotta che in quel momento è penalmente lecita o punita in modo mite; altro è porre in essere la stessa condotta in contrasto con la norma che in quel momento la vieta o la punisce in modo più severo. Il principio della retroattività in mitius è legato, dunque, ad una concezione oggettivistica del diritto penale, che emerge dal complessivo tessuto dei precetti costituzionali: a fronte di essa, la sanzione criminale rappresenta non già la risposta alla mera disobbedienza o infedeltà alla legge, in quanto sintomatica di inclinazioni antisociali del soggetto; quanto piuttosto la reazione alla commissione di fatti offensivi di interessi che il legislatore, interprete della coscienza sociale, reputa oggettivamente meritevoli di essere salvaguardati da determinate forme di aggressione col presidio della pena. Se la valutazione del legislatore in ordine al disvalore del fatto muta – nel senso di ritenere che quel presidio non sia più necessario od opportuno; o che sia sufficiente un presidio meno energico – tale mutamento deve quindi riverberarsi a vantaggio anche di coloro che abbiano posto in essere il fatto in un momento anteriore.
Il collegamento del principio della retroattività in mitius al principio di eguaglianza ne segna, peraltro, anche il limite: nel senso che, a differenza del principio della irretroattività della norma penale sfavorevole − assolutamente inderogabile – detto principio deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli (sentenze n. 74 del 1980 e n. 6 del 1978; ordinanza n. 330 del 1995).
Ma soprattutto, per quanto interessa nella specie, è giocoforza ritenere che il principio di retroattività della norma penale più favorevole in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima. Il nuovo apprezzamento del disvalore del fatto, successivamente operato dal legislatore, può giustificare − in chiave di tutela del principio di eguaglianza – l’estensione a ritroso del trattamento più favorevole, a chi ha commesso il fatto violando scientemente la norma penale più severa, solo a condizione che quella nuova valutazione non contrasti essa stessa con i precetti della Costituzione. La lex mitior deve risultare, in altre parole, validamente emanata: non soltanto sul piano formale della regolarità del procedimento dell’atto legislativo che l’ha introdotta e, in generale, della disciplina delle fonti (v., con riferimento alla mancata conversione di un decreto-legge, sentenza n. 51 del 1985); ma anche sul piano sostanziale del rispetto dei valori espressi dalle norme costituzionali. Altrimenti, non v’è ragione per derogare alla regola sancita dai citati art. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, non potendosi ammettere che una norma costituzionalmente illegittima – rimasta in vigore, in ipotesi, anche per un solo giorno – determini, paradossalmente, l’impunità o l’abbattimento della risposta punitiva, non soltanto per i fatti commessi quel giorno, ma con riferimento a tutti i fatti pregressi, posti in essere nel vigore dell’incriminazione o dell’incriminazione più severa.
7. – Nel merito, con riferimento alla denuncia di violazione dell’art. 3 Cost., le questioni sono fondate.
7.1. – Per costante giurisprudenza di questa Corte, la configurazione delle ipotesi criminose e la determinazione delle sanzioni per ciascuna di esse rientrano nella discrezionalità del legislatore. Gli apprezzamenti in ordine alla "meritevolezza” ed al "bisogno di pena” – dunque sull’opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa – sono infatti, per loro natura, tipicamente politici: con la conseguenza che un sindacato sul merito delle scelte legislative è possibile solo ove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio (ex plurimis, tra le ultime, sentenze n. 144 del 2005 e n. 364 del 2004; ordinanze n. 109, n. 139, n. 212 del 2004; n. 177, n. 206 e n. 234 del 2003), come avviene allorquando la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione (con riguardo alla materia elettorale, sentenza n. 287 del 2001).
Tale ipotesi ricorre nel caso in esame.
Con riferimento alla prima delle due fattispecie in cui si articolano le disposizioni censurate – quella concernente le falsità relative all’«autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati» – si coglie una palese dissimmetria fra il trattamento sanzionatorio riservato a dette falsità e quello previsto, in termini generali, dalle norme del codice penale in tema di falso, richiamate a fini di descrizione delle condotte incriminate. Così, con riguardo alla falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale chiamato ad autenticare le firme in questione – ma il rilievo vale, mutatis mutandis, in rapporto ad ognuna delle altre ipotesi di falso riferibili a tale autentica (quale, ad esempio, la falsità materiale commessa dal privato, di cui all’art. 482 cod. pen.) – le disposizioni impugnate vengono a sottoporre alla pena della sola ammenda da 500 a 2.000 euro – comminatoria che rende il reato suscettibile di oblazione c.d. obbligatoria, mediante pagamento della somma di 666 euro (art. 162 cod. pen.) – un fatto riconducibile, nella generalità dei casi, al paradigma punitivo del delitto di falsità ideologica di pubblico ufficiale in atto pubblico, represso dall’art. 479 cod. pen. con la reclusione da uno a sei anni (salvo il possibile aumento previsto dall’art. 476, secondo comma, cod. pen., in rapporto al falso in atti c.d. fidefacienti).
L’opzione per il modulo della contravvenzione oblabile – di per sé eccentrica, sul piano sistematico, in rapporto a reati di falso, tanto più ove aventi come oggetto materiale un atto pubblico e come soggetto attivo un pubblico ufficiale – risulta motivata, nei lavori parlamentari relativi alla legge n. 61 del 2004, con la ritenuta «minore offensività» delle condotte punite a tal titolo (in questi termini, la relazione della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati al testo unificato delle proposte di legge n. 1619, n. 2451 e n. 2676, da cui ha tratto origine la riforma).
Occorre, tuttavia, osservare che i reati di falso – e di falso documentale in particolare – hanno natura tipicamente strumentale. Comune ad essi è difatti la protezione di un bene giuridico "strumentale-intermedio”, tradizionalmente compendiato nella formula della «fede pubblica», intesa quale affidamento dei consociati nella genuinità e veridicità – ovvero, da altro angolo visuale, nell’efficacia probatoria – di determinate fonti documentali. Questo valore – ed in ciò risiede appunto la sua "strumentalità” – non è fine a sé stesso, ma rappresenta un mezzo di protezione di beni "finali” ulteriori, atti ad essere compromessi dalla manipolazione delle predette fonti: beni "finali” che, in rapporto alla loro variegata caratura (patrimoniale, personale, pubblica, collettiva, ecc.), ben possono contribuire a qualificare, sul piano del disvalore, le differenti ipotesi di falso.
Nella specie, la condotta costitutiva dei due illeciti posti a raffronto – reato generale del codice penale e reato elettorale specifico di cui al terzo comma degli artt. 100 e 90 – è, per definizione, identica. Nel caso della falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, si tratta, in particolare, della falsa attestazione, resa da soggetto abilitato all’autenticazione delle firme, circa l’avvenuta identificazione del sottoscrittore e circa il fatto che l’apposizione della firma è avvenuta in sua presenza. Correlativamente, nessuna diversità tra le due fattispecie è ravvisabile sotto il profilo della lesività del bene "strumentale-intermedio” della fede pubblica: la valenza probatoria – o, per guardare il fenomeno da altra angolazione, il livello di affidamento – che l’ordinamento ripone nell’autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati, non differisce, sotto alcun profilo, da quello proprio di qualsiasi altra autenticazione di firme.
A fronte di ciò, il salto sanzionatorio tra le figure criminose in esame – per non essere qualificato come manifestamente irragionevole – dovrebbe poter trovare giustificazione in considerazioni legate alla diversa pregnanza del bene "finale”. Cioè, lo specifico oggetto materiale del reato elettorale in questione – nel quale risiede l’elemento specializzante rispetto al reato comune – dovrebbe risultare indicativo del fatto che l’attitudine offensiva del falso si proietta verso un valore di rango decisamente più basso, rispetto alla media dei beni aggredibili dalla falsa autenticazione di firme.
Senonché, il bene finale tutelato dal reato de quo è di rango particolarmente elevato, anche sul piano della rilevanza costituzionale, in quanto intimamente connesso al principio democratico della rappresentatività popolare: trattandosi di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali ed il libero ed efficace esercizio del diritto di voto. In effetti, proprio la considerazione della particolare pregnanza di tale bene giustifica l’emersione dei reati elettorali come segmento autonomo dell’ordinamento penale; e spiega – sia pur nella cornice di un sistema tutt’altro che privo di contraddizioni e disarmonie, in rapporto alle quali questa Corte ha da tempo segnalato l’esigenza di una compiuta razionalizzazione (sentenze n. 455 del 1998, n. 84 del 1997, n. 121 del 1980 e n. 45 del 1967) – le previsioni extra ordinem che ne caratterizzano la disciplina (quale, ad esempio, quella dell’art. 100, primo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, secondo cui «qualunque elettore può promuovere l’azione penale, costituendosi parte civile»; ovvero quella degli artt. 96 del d.P.R. n. 361 del 1957 e 86 del d.P.R. n. 570 del 1960, che puniscono con pene di significativa severità la corruzione, attiva e passiva, finalizzata ad ottenere la firma per la presentazione di una candidatura, il voto elettorale o l’astensione, in deroga alla normale non punibilità della corruzione tra privati).
A tale prospettiva si ispira puntualmente, del resto, anche il falso elettorale di cui al secondo comma degli artt. 100 e 90, quale risulta dalla stessa riforma del 2004. Esso non attua affatto, nel complesso, un abbattimento dei livelli sanzionatori rispetto alle ordinarie previsioni codicistiche; ma allinea anzi tendenzialmente verso l’alto, rispetto agli atti elettorali, la risposta punitiva a condotte di falso normalmente diversificate: prevedendo, in specie – anche quando si tratti di falsità commessa da privato o incidente su documento qualificabile come scrittura privata – una pena edittale uguale a quella stabilita dagli artt. 476 e 479 cod. pen. per il falso, materiale e ideologico, del pubblico ufficiale in atti pubblici. Tale pena, d’altra parte, in assenza delle disposizioni censurate, si applicherebbe anche al falso in autenticazione di sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati, ove lo si ritenesse sussumibile – in accordo con la prospettiva ermeneutica dianzi accennata – nel paradigma della falsa formazione di «atti destinati alle operazioni elettorali».
7.2. – Per giustificare una così macroscopica differenza di trattamento sanzionatorio, non si potrebbe neppure ritenere che il falso contravvenzionale contemplato dalle norme impugnate presenti − con riguardo al bene "finale” – un minor disvalore di condotta: nel senso che, a differenza del falso in altri atti elettorali, esso sarebbe in grado di attentare al predetto bene solo in modo estremamente tenue.
A tal fine, non varrebbe in particolare sostenere che l’abbattimento della risposta punitiva riflette il ridotto rilievo assunto, nell’apprezzamento discrezionale del legislatore, dalla formalità della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste dei candidati. Apprezzamento del quale sarebbe testimonianza il fatto che la legge n. 61 del 2004 deriva dallo stralcio di un più ampio testo normativo (il ricordato testo unificato delle proposte di legge n. 1619, n. 2451 e n. 2676, predisposto dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati), il quale prevedeva originariamente, nella sua prima parte (art. 1), l’esenzione dal predetto onere per i partiti, movimenti o gruppi politici rappresentati in Parlamento (esenzione peraltro già contemplata, relativamente all’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, dall’art. 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18).
Il nostro sistema elettorale è caratterizzato dalla regola in forza della quale le candidature e le liste di candidati debbono essere presentate da un numero prefissato di elettori, compreso tra un minimo e un massimo. Tale regola risponde ad una esigenza di tutela dell’ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, evitando un’abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l’elettorato (in proposito, v. sentenza n. 83 del 1992). Ciò premesso, sarebbe sufficiente osservare che, fin tanto che l’onere di raccolta delle firme è concretamente contemplato − con la conseguente previsione, altresì, della garanzia della necessaria autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori, da parte di soggetti a ciò abilitati (v., al riguardo, art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dall’art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120) – non è comunque possibile attribuire al falso in tali autenticazioni una rilevanza comparativamente minimale. E ciò per l’evidente ragione che detto falso – consentendo la partecipazione alla competizione di candidati o di liste che per legge non avrebbero potuto prendervi parte – si traduce in un artificio idoneo ad inficiare nel suo complesso la regolarità delle operazioni di voto; e che esso può portare, in concreto, all’annullamento dell’intera consultazione elettorale. Un simile esito non potrebbe certamente qualificarsi "bagatellare”, nel raffronto con la generalità degli eventi lesivi "finali”, suscettibili di venir prodotti dagli altri falsi in autenticazione.
Al di là di ciò, l’intento perseguito dalla parte stralciata del testo normativo – intento realizzato, successivamente alle ordinanze di rimessione, con riguardo alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato, dagli artt. 1, comma 6, e 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), sostitutivi, rispettivamente, dell’art. 18-bis del d.P.R. n. 361 del 1957 e dell’art. 9 del d.lgs. n. 533 del 1993 – non era comunque quello di sopprimere tout court l’onere delle raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati e delle liste. L’obiettivo, poi attuato dalla citata novella del 2005, era, invece, quello di esentare dall’onere in parola determinati soggetti politici, i quali potessero fornire per altra via – segnatamente sulla base dell’esito di precedenti competizioni elettorali a livello nazionale – garanzie di sufficiente rappresentatività dei candidati da essi presentati. In tal caso, tuttavia – al lume sia dell’art. 12, quinto comma, della legge n. 18 del 1979 (già vigente alla data delle ordinanze di rimessione), sia delle disposizioni successivamente introdotte dalla novella del 2005 – la sottoscrizione degli elettori viene ad essere surrogata da quella del presidente o segretario del partito o gruppo politico, o di suoi delegati: sottoscrizione che deve essere parimenti autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Con il risultato che anche le falsità concernenti l’autentica della firma dell’esponente di vertice del partito o del gruppo politico potrebbero beneficiare di fatto, contro ogni logica, del trattamento largamente preferenziale stabilito dalle disposizioni censurate.
Va aggiunto, ancora, che a fronte del tenore di siffatte disposizioni, il denunciato regime di favore investe non soltanto le autenticazioni delle firme dei presentatori delle liste, ma anche i falsi inerenti all’autenticazione – essa pure prescritta dalla legge elettorale (v., attualmente, artt. 18-bis del d.P.R. n. 361 del 1957 e 28 del d.P.R. n. 570 del 1960) – delle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati. L’attitudine lesiva di tali falsi risulta ancor più evidente ed immediata, trattandosi di manovra che può indurre gli elettori a votare per persone che non hanno mai inteso candidarsi per quella lista, disperdendo e rendendo così inutile il loro voto (oltre, naturalmente, a vulnerare il libero esercizio del diritto di elettorato passivo da parte dei candidati falsamente indicati).
7.3. – Va sottolineata, infine, l’ulteriore, profonda sperequazione di trattamento sanzionatorio venutasi a creare, per effetto delle norme in parola, fra le condotte di falso inerenti alle firme delle dichiarazioni di presentazione di candidati, da un lato; e le condotte di corruzione, attiva e passiva, violenza o minaccia e abuso di attribuzioni da parte di soggetti pubblici o ministri di culto, finalizzate all’ottenimento delle medesime firme, dall’altro, posto che queste ultime integrano tuttora delitti puniti con pene detentive di apprezzabile severità (artt. 96, 97 e 98 del d.P.R. n. 361 del 1957; artt. 86, 87 e 88 del d.P.R. n. 570 del 1960).
Anche tale sperequazione si rivela, in effetti, manifestamente priva di razionale giustificazione, in una cornice di sistema. Chi dà o promette ad un elettore una qualsiasi utilità affinché firmi una presentazione di candidatura ad elezioni politiche – fatto che in base alle norme comuni sarebbe privo di rilievo penale, non essendo la corruzione di privato ordinariamente sanzionata – risponde di un delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni, oltre la multa (art. 96 del d.P.R. n. 361 del 1957); il pubblico ufficiale che autentichi falsamente la firma del medesimo elettore, facendolo figurare come sottoscrittore della lista senza o contro la sua volontà – fatto che normalmente integrerebbe il delitto di cui all’art. 479 cod. pen. – risponde di una mera contravvenzione oblabile.
7.4. – Considerazioni similari possono svolgersi anche in rapporto alla seconda fattispecie contemplata dalle norme sottoposte a scrutinio – quella della falsa formazione di liste di elettori o di candidati (intesa come residuale rispetto alle falsità inerenti all’autentica delle sottoscrizioni) – nel confronto con il regime previsto, per la generalità dei falsi in materia elettorale, dal secondo comma degli artt. 100 del d.P.R. n. 361 del 1957 e 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, il quale, come già rimarcato, irrigidisce nel complesso – e non già attenua – il trattamento sanzionatorio prefigurato dalle corrispondenti norme del codice penale.
Lo scarto nella risposta punitiva è, anche per questo verso, di dimensioni tali da apparire manifestamente irragionevole: non essendo sostenibile che la falsità in questione abbia potenzialità lesive del bene giuridico protetto – di rilievo costituzionale − nettamente inferiori alla media di quelle inerenti agli altri atti destinati alle operazioni elettorali. Infatti, riguardo alla predisposizione di false liste di candidati, valgono rilievi analoghi a quelli dianzi svolti per le falsità in autenticazione, circa l’idoneità della manipolazione ad inficiare nel suo complesso la regolarità della competizione e a creare le premesse per la vanificazione dei voti espressi dagli elettori a favore di quelle liste; a sua volta, la falsificazione delle liste elettorali – atti che hanno natura pubblica – può essere strumento di perpetrazione di brogli elettorali.
7.5. – Non si potrebbe neppure fondare la macroscopica differenza di sanzioni, dianzi evidenziata, su una pretesa distinzione tra falsità rispettivamente inerenti alla fase «preparatoria» del procedimento elettorale, ed alle fasi «costitutiva» e di verifica dei risultati di esso: e ciò in base alla considerazione che nel primo caso la regolarità delle operazioni elettorali verrebbe lesa solo in termini collettivi e potenziali (facendo sì che alla competizione concorrano liste o candidati che avrebbero dovuto esserne esclusi, ma senza l’attribuzione ad essi di voti non espressi dagli elettori); mentre nel secondo caso la condotta incide direttamente sulla manifestazione individuale ed effettiva del diritto di voto.
Al riguardo, basta osservare che le falsità nella formazione delle liste non esauriscono il novero dei possibili falsi incidenti sulla fase preparatoria; che tale considerazione non varrebbe comunque a giustificare lo scarto sanzionatorio rispetto alle figure di falso del codice penale; che, ancora, in relazione alle altre forme di interferenza illecita (corruzione, violenza, minaccia, abuso di poteri), i citati artt. 96, 97 e 98 del d.P.R. n. 361 del 1957 e 86, 87 e 88 del d.P.R. n. 570 del 1960 equiparano pienamente – nell’ambito di unitarie fattispecie delittuose – le dichiarazioni di presentazione delle candidature all’espressione del voto e all’astensione da esso, senza operare, dunque, alcuna cesura fra fase preparatoria e fasi successive.
7.6 – Infine, le disposizioni censurate determinano un’ulteriore manifesta incongruenza, denunciata dal Tribunale di Firenze. La falsa formazione delle liste – a differenza delle falsità in autenticazione (in rapporto alle quali sono richiamate dalle norme in esame anche le disposizioni degli artt. 489 e 490 cod. pen.) – viene ad essere assoggettata ad una pena incomparabilmente più mite rispetto all’uso delle liste falsificate e alla sostituzione, soppressione o distruzione di liste vere: condotte, queste ultime, che – proprio perché le liste rappresentano una species del genus degli atti «destinati alle operazioni elettorali» – continuano ad integrare il delitto di cui al secondo comma degli artt. 100 e 90. E ciò quantunque si tratti, con ogni evidenza, di fattispecie equiparabili, o comunque non significativamente dissimili, sul piano del disvalore, come attestano le citate corrispondenti previsioni del codice penale, le quali, anzi, reprimono l’uso di atto falso in modo attenuato rispetto alla falsificazione.
8. – Gli ulteriori profili di asserita compromissione degli artt. 3 e 25 Cost. dedotti dal Tribunale di Firenze restano assorbiti.
Conclusivamente, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 100, terzo comma, del d.P.R. n. 361 del 1957 e dell’art. 90, terzo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, come sostituiti dall’art. 1 della legge n. 61 del 2004.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 100, terzo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati), come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali);
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 90, terzo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), come sostituito dall’art. 1, comma 2, lettera a), numero 1), della citata legge n. 61 del 2004;
3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 90 del citato d.P.R. n. 570 del 1960 e dell’art. 1, comma 2, lettera a), numero 1), secondo capoverso, della medesima legge n. 61 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pescara e dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2006.