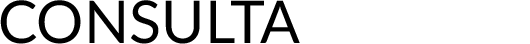SENTENZA
N. 164
ANNO
2017
Commenti
alla decisione di
I.
Stefano Catalano, L’irrilevanza
delle questioni sulla responsabilità civile dei magistrati: un cambio di rotta
‘mascherato’ da conferma del precedente?, per g.c.
del Forum di Quaderni
Costituzionali
II.
Raffaele Guido Rodio, La
Corte ridisegna (in parte) i confini costituzionali della (ir)responsabilità
dei magistrati, per g.c. della Rivista AIC
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo
GROSSI Presidente
- Alessandro
CRISCUOLO Giudice
- Giorgio
LATTANZI ”
- Aldo
CAROSI ”
- Marta
CARTABIA ”
- Mario Rosario
MORELLI ”
- Giancarlo
CORAGGIO ”
- Giuliano
AMATO ”
- Silvana
SCIARRA ”
- Daria
de PRETIS ”
- Nicolò
ZANON ”
- Franco
MODUGNO ”
- Augusto Antonio
BARBERA
”
- Giulio
PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt.
2, comma 1, lettere a), b) e c), 3, comma 2, e 4 della legge
27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati),
e degli artt. 2, commi 2 e 3, 4, 7, 8, comma 3, e 9, comma 1, della legge
13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), come modificati
dalla legge n. 18 del 2015, promossi dal Tribunale ordinario di Verona con
ordinanza del 12 maggio 2015, dal Tribunale ordinario di Treviso con ordinanza
dell’8 maggio 2015, dal Tribunale ordinario di Catania con ordinanza del 6
febbraio 2016, dal Tribunale ordinario di Enna con ordinanza del 25 febbraio
2016 e dal Tribunale ordinario di Genova con ordinanza del 10 maggio 2016,
rispettivamente iscritte ai nn. 198
e 218
del registro ordinanze 2015, e ai nn. 113,
126
e 130
del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 40 e 43, prima serie speciale, dell’anno 2015 e nn. 23 e 27, prima
serie speciale, dell’anno 2016.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2016 il Giudice
relatore Franco Modugno.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 12 maggio 2015 (r.o. n. 198 del 2015), il Tribunale ordinario di Verona ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 2, comma 1, lettera c), e 4, comma 1,
della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei
magistrati), nella parte in cui – sostituendo, rispettivamente, l’art. 2, comma
3, e l’art. 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni
cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei
magistrati) – includono il «travisamento del fatto o delle prove» tra le
ipotesi di colpa grave che possono dar luogo a responsabilità civile dello
Stato e del magistrato, per contrasto con gli artt. 101, secondo comma,
e 111, secondo comma,
della Costituzione;
b) dell’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n.
18 del 2015, per contrasto con l’art. 3 Cost.;
c) dell’art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015,
per contrasto con gli artt.
3, 25, primo
comma, 101,
secondo comma, e 111,
secondo comma, Cost.;
d) dell’art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988,
come modificato dall’art. 6 della legge n. 18 del 2015, per contrasto con gli artt. 25, primo comma,
101, secondo comma,
e 111, secondo comma,
Cost.;
e) dell’art. 4 della legge n. 18 del 2015, nella
parte in cui, sostituendo l’art. 7, comma 1, della legge n. 117 del 1998,
prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha l’obbligo di esercitare
l’azione di rivalsa verso il magistrato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.;
f) dell’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), e
dell’art. 4 della legge n. 18 del 2015, quest’ultimo nella parte in cui prevede
che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha l’obbligo di esercitare
l’azione di rivalsa verso il magistrato, per contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost.
1.1.– Il giudice a quo premette di essere investito
dell’opposizione proposta da una società cooperativa avverso il decreto con il
quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 142.292,53, oltre
interessi, in favore di una impresa agricola, quale corrispettivo di forniture
di prodotti documentate da fatture. A sostegno dell’opposizione, la cooperativa
ingiunta aveva dedotto una serie di motivi, tutti contestati dall’impresa
ingiungente, la quale – rilevato che l’opposizione non era fondata su prova
scritta, né di pronta soluzione – aveva chiesto, ai sensi dell’art. 648, primo
comma, del codice di procedura civile, che il decreto ingiuntivo opposto fosse
dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Secondo il rimettente, ai fini della decisione su
tale istanza assumerebbero rilievo alcune delle disposizioni in materia di
responsabilità civile dei magistrati introdotte dalla legge n. 18 del 2015, in
quanto «concretamente e immediatamente produttiv[e]
di una responsabilità potenziale» di esso giudice a quo.
Al riguardo, il rimettente ricorda come la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 18 del 1989, decidendo su una serie di
questioni relative alla pregressa disciplina della responsabilità civile dei
magistrati di cui alla legge n. 117 del 1988, abbia rilevato che l’art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale) esige, ai fini della proposizione dell’incidente di
costituzionalità, che il giudizio principale non possa essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità
costituzionale: sicché, di regola, la rilevanza della questione resta
strettamente correlata all’applicabilità della norma impugnata nel giudizio a
quo. Tuttavia – come già ritenuto implicitamente dalla stessa Corte
costituzionale in precedenti occasioni (sentenze n. 196 del
1982, n. 125
del 1977 e n.
128 del 1974) e, secondo il rimettente, anche nella più recente sentenza n. 237 del
2013 – «debbono ritenersi influenti sul giudizio anche le norme che, pur
non essendo direttamente applicabili nel giudizio a quo, attengono allo status
del giudice, alla sua composizione nonché, in generale, alle garanzie e ai
doveri che riguardano il suo operare. L’eventuale incostituzionalità di tali
norme è destinata ad influire su ciascun processo pendente davanti al giudice
del quale regolano lo status, la composizione, le garanzie e i doveri: in
sintesi, la "protezione” dell’esercizio della funzione, nella quale i doveri si
accompagnano ai diritti».
Occorrerebbe inoltre considerare – secondo il giudice
a quo – che la nuova legge ha ampliato le ipotesi che possono dar luogo a
responsabilità civile dello Stato e del magistrato, includendovi, in
particolare, le fattispecie del travisamento del fatto o delle prove (artt. 2,
comma 3, e 7 della legge n. 117 del 1988, come novellati dagli artt. 2, comma
1, lettera c, e 4, comma 1, della legge n. 18 del 2015). Almeno le citate
disposizioni troverebbero immediata applicazione in tutti i giudizi in corso
potenzialmente causativi di danno, giacché i giudici che li trattano, per non
incorrere in responsabilità (anche disciplinare), dovrebbero attenersi ai
criteri di valutazione da esse stabiliti.
1.2.– Ciò premesso, il giudice a quo dubita della
legittimità costituzionale dei citati artt. 2, comma 1, lettera c), e 4, comma
1, della legge n. 18 del 2015, osservando come, nell’originario assetto della
legge n. 117 del 1988, la valutazione dei fatti e delle prove – costituente,
assieme all’interpretazione delle norme di diritto, l’essenza stessa della
funzione giurisdizionale – non potesse mai dar luogo a responsabilità, in virtù
della cosiddetta clausola di salvaguardia enunciata dall’art. 2, comma 2, della
stessa legge. Come rilevato tanto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 18 del
1989, quanto dalla giurisprudenza di legittimità, detta clausola era
funzionale alla tutela dell’indipendenza del giudice, che, a propria volta,
costituisce garanzia di apprezzamento imparziale delle risultanze istruttorie.
La legge n. 18 del 2015 – pur riproponendo, nel suo
art. 2, comma 1, lettera b), la clausola di salvaguardia – ne avrebbe, di fatto,
sensibilmente ridotto l’àmbito di operatività. La lettera c) del medesimo art.
2, comma 1, ha infatti ampliato i casi di colpa grave generativi di
responsabilità risarcitoria tanto sul piano numerico, con l’aggiunta
dell’ipotesi del travisamento del fatto o delle prove, quanto sotto il profilo
soggettivo, con l’eliminazione del riferimento alla negligenza inescusabile (la
quale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come
sostituito dall’art. 4 della legge n. 18 del 2015, costituisce ora condizione
solo per l’esercizio dell’azione di rivalsa nei confronti del magistrato).
Ad avviso del giudice a quo, il nuovo regime si
porrebbe in contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 111, secondo comma,
Cost., apparendo le nozioni di travisamento del fatto o delle prove equivoche
ed indefinibili. Esse non coinciderebbero con le ipotesi – già contemplate
dall’art. 2, comma 3, della legge n. 117 del 1988 – dell’affermazione di un
fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del
procedimento, o della negazione di un fatto la cui esistenza risulti
incontrastabilmente dagli atti del procedimento, per la semplice ragione che
sono state aggiunte, e non già sostituite, a queste ultime. Nessuna indicazione
utile fornirebbero, peraltro, i lavori parlamentari, dai quali emergerebbe,
anzi, l’estrema difficoltà di definire gli esatti confini della nuova
fattispecie di illecito.
La formula in esame si rivelerebbe, quindi, del tutto
inidonea a delimitare l’àmbito della responsabilità del magistrato, come invece
esigerebbero i parametri costituzionali evocati. In effetti, erano state
proprio la limitatezza e la tassatività delle ipotesi di colpa grave,
originariamente prefigurate dalla legge n. 117 del 1988, ad indurre la Corte
costituzionale ad escludere, con la sentenza n. 18 del
1989, che la loro previsione potesse compromettere la serenità e
l’imparzialità di giudizio del giudice.
In difetto di una sufficiente tipizzazione, la nuova
fattispecie offrirebbe, di contro, ampie possibilità di condizionare
l’esercizio della funzione giurisdizionale: qualsiasi valutazione dei fatti o
del materiale probatorio potrebbe essere, infatti, censurata semplicemente
qualificandola come travisamento, con ulteriori ricadute negative in termini di
ampliamento indefinito della possibilità di sindacato disciplinare sui
provvedimenti giudiziari e di estrema incertezza sull’àmbito applicativo
dell’azione obbligatoria di rivalsa.
Peraltro, nemmeno la sfera applicativa della clausola
di salvaguardia –formalmente ribadita dall’art. 2, comma 1, lettera b), della
legge n. 18 del 2015 – risulterebbe individuabile con esattezza relativamente
all’attività di valutazione del fatto o delle prove, tanto da potersi dubitare
che la clausola stessa conservi un reale spazio operativo. Sotto tale profilo,
la norma da ultimo citata risulterebbe irragionevole e, quindi, in contrasto
con l’art. 3 Cost.
1.3.– Il rimettente censura, altresì, l’art. 3, comma
2, della legge n. 18 del 2015, che, abrogando l’art. 5 della legge n. 117 del
1988, ha soppresso la fase preliminare del giudizio risarcitorio comunemente
definita «filtro di ammissibilità».
In forza del citato art. 5, il tribunale investito di
una domanda risarcitoria nei confronti dello Stato per fatto illecito del
magistrato doveva deliberare, preventivamente e in tempi ristretti, sulla sua
ammissibilità. A tal fine, il giudice istruttore doveva, alla prima udienza,
rimettere le parti dinanzi al collegio, che era tenuto a decidere entro
quaranta giorni dalla rimessione. La domanda era dichiarata inammissibile con
decreto motivato quando non fossero stati rispettati i termini previsti a pena
di decadenza per l’esercizio dell’azione o non sussistessero i presupposti
stabiliti dagli artt. 2, 3 e 4 della stessa legge n. 117 del 1988, ovvero
quando la domanda risultasse manifestamente infondata. Ove, invece, il
tribunale avesse ritenuto la domanda ammissibile, doveva disporre la
prosecuzione del giudizio e la trasmissione di copia degli atti al titolare
dell’azione disciplinare.
Tale meccanismo – rileva il giudice a quo –
perseguiva il duplice obiettivo di impedire la proliferazione di inutili
giudizi di merito e, soprattutto, di tutelare «la serenità del singolo
magistrato, che, al riparo da azioni pretestuose e temerarie, poteva veder
limitato il peso dell’esposizione processuale a casi e tempi razionalmente
circoscritti». In questa prospettiva, la Corte costituzionale aveva
riconosciuto il «rilievo costituzionale» del filtro di ammissibilità, quale
strumento di salvaguardia dei valori di autonomia e indipendenza della funzione
giurisdizionale (sentenza
n. 468 del 1990), rilevando anche come esso impedisse che si creassero con
malizia i presupposti per l’astensione e la ricusazione (sentenza n. 18 del
1989).
Nell’abolire l’istituto, la disposizione censurata si
porrebbe, quindi, in contrasto non solo con gli artt. 101, secondo comma, e
111, secondo comma, Cost., ma anche con l’art. 25, primo comma, Cost.
Proponendo una domanda risarcitoria palesemente infondata o inammissibile, la
parte potrebbe, infatti, sottrarre il processo dal quale si assume danneggiata
al giudice naturale che ne è investito, il quale – nel caso di instaurazione di
un giudizio di responsabilità per provvedimenti a lui attribuiti – non potrebbe
non ravvisare le gravi ragioni di convenienza per astenersi ai sensi dell’art.
51, secondo comma, cod. proc. civ., o dell’art. 36, comma 1, lettera h), del
codice di procedura penale.
L’esposizione del giudice alle conseguenze ora
indicate risulterebbe, altresì, protratta nel tempo, diversamente da quanto
accadeva nel regime anteriore. Ogni giudizio di responsabilità, per quanto
inammissibile, deve ora svolgersi nelle forme del giudizio ordinario di
cognizione ed essere deciso con sentenza, soggetta ad impugnazione nei termini
ordinari, molto più ampi di quelli previsti in precedenza per l’impugnazione
del decreto di inammissibilità emesso ai sensi dell’art. 5 della legge n. 117
del 1988 (dieci giorni dalla comunicazione per l’appello, quaranta giorni per
il ricorso per cassazione).
Non rappresenterebbero, d’altronde, una sufficiente
remora alla proposizione di giudizi risarcitori temerari né la possibile
applicazione – futura e remota – dell’istituto della responsabilità aggravata,
previsto dall’art. 96 cod. proc. civ., né gli oneri relativi all’iscrizione a
ruolo della causa, posto che, per effetto della modifica dell’art. 15 della
legge n. 117 del 1988 disposta dall’art. 300, comma 6, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», i giudizi promossi
ai sensi di detta legge sono esenti dal pagamento del contributo unificato.
L’eliminazione del filtro di ammissibilità si
porrebbe in contrasto anche con l’art. 3 Cost., risultando contraddittoria
rispetto alle scelte che lo stesso legislatore ha operato con riguardo al
giudizio di appello e al giudizio di cassazione, in relazione ai quali sono
stati viceversa recentemente introdotti meccanismi di filtro (artt. 342, primo
comma, numero 2, 348-ter e 360-bis cod. proc. civ.).
1.4.– Il rimettente osserva, altresì, che, in
correlazione all’abolizione del filtro di ammissibilità, l’art. 6 della legge
n. 18 del 2015 ha soppresso l’inciso dell’art. 9, comma 1, della legge n. 117
del 1988 che ricollegava l’inizio del procedimento disciplinare, per i fatti
che avessero «dato causa all’azione di risarcimento», alla comunicazione, da
parte del tribunale, del provvedimento che aveva dichiarato ammissibile la
domanda. È rimasta, invece, invariata la parte della disposizione che obbliga il
titolare dell’azione disciplinare a procedere per i predetti fatti.
In base alla nuova disciplina, pertanto, l’attore
potrebbe rendere note al titolare dell’azione disciplinare le doglianze esposte
nel giudizio risarcitorio, per quanto manifestamente infondate, costringendolo,
per ciò solo, a promuovere l’azione disciplinare. Anche l’art. 9, comma 1,
della legge n. 117 del 1988, come novellato, si porrebbe, quindi, in contrasto
con gli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.,
consentendo ad una parte processuale di influire indebitamente sul corso del
giudizio e sulla serenità del giudice, senza una preventiva verifica dei suoi
assunti.
1.5.– Il Tribunale veronese sottopone, ancora, a
scrutinio di legittimità costituzionale l’art. 4 della legge n. 15 del 2018,
nella parte in cui, sostituendo l’art. 7, comma 1, della legge n. 117 del 1988,
prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri ha l’obbligo di esercitare
l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato.
La disposizione sottrarrebbe, infatti, al Presidente
del Consiglio dei ministri il diritto di valutare la convenienza di detta
azione, sulla base di un raffronto tra i costi del giudizio risarcitorio nei
confronti dello Stato e quelli del giudizio nei confronti del magistrato,
nonché delle probabilità di successo di quest’ultimo. In questo modo, essa
violerebbe tanto l’art. 24, primo comma, Cost. – che, nel garantire il diritto
di difesa, riconoscerebbe implicitamente anche il diritto di non agire in
giudizio – quanto il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Al riguardo,
si dovrebbe considerare che – diversamente da quanto accadeva nel sistema
originario della legge n. 117 del 1988 – i presupposti per l’esercizio
dell’azione nei confronti dello Stato non sono i medesimi dell’azione di
rivalsa, occorrendo, per questa, che i comportamenti individuati dalla norma
siano connotati da negligenza inescusabile. Il Presidente del Consiglio dei
ministri si troverebbe, di conseguenza, a dover esercitare l’azione di rivalsa
"al buio”, ossia senza che si sia avuta una positiva verifica dell’esistenza di
quel presupposto.
Irragionevole apparirebbe anche l’assimilazione,
operata dalla norma censurata, delle ipotesi del risarcimento sulla base di
transazione e sulla base di sentenza di condanna, quali presupposti
dell’esercizio dell’azione obbligatoria di rivalsa. Diversamente dalla
condanna, la transazione sarebbe, infatti, frutto di una scelta discrezionale
del Presidente del Consiglio dei ministri, basata su ragioni di convenienza:
scelta che potrebbe risultare viziata da un errore di valutazione riguardo
all’ammissibilità o alla fondatezza della domanda risarcitoria. Anche in tale
evenienza, tuttavia, il magistrato subirebbe l’azione di rivalsa, destinata ad
un insuccesso per lo Stato.
L’art. 3 Cost. risulterebbe violato anche sotto il
profilo della ingiustificata disparità di trattamento dell’azione in discorso
rispetto all’azione di regresso nei confronti degli altri dipendenti pubblici.
Tale ultima azione – in base ai principi generali in tema di azione di garanzia
personale (art. 1950 del codice civile), non derogati dall’art. 22, primo
comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) – non è, infatti,
obbligatoria, pur presupponendo che nel giudizio nei confronti dello Stato sia
stato accertato il dolo o la colpa grave del funzionario danneggiante: e ciò
anche nel caso di transazione della lite, come si evincerebbe dal disposto
dell’art. 30 del d.P.R. n. 3 del 1957.
La denunciata disparità di trattamento non potrebbe
essere spiegata facendo leva sulla differente entità economica della rivalsa
(limitata, per i magistrati, ad una somma pari alla metà dello stipendio
annuale al momento in cui l’azione di risarcimento è proposta, ai sensi
dell’art. 5 della legge n. 18 del 2015). Tale limitazione dovrebbe costituire,
al contrario, un ulteriore motivo per rendere discrezionale l’azione di rivalsa
contro il magistrato, posto che la ridotta entità della somma recuperabile
potrebbe sconsigliare l’iniziativa.
1.6.– Da ultimo, il rimettente denuncia il contrasto
con l’art. 81, terzo comma, Cost. dell’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), e
dell’art. 4 della legge n. 18 del 2015, quest’ultimo nella parte in cui prevede
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha l’obbligo di esercitare
l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato.
La novella non indicherebbe, infatti, i mezzi per far
fronte ai maggiori oneri derivanti, a carico dello Stato, dall’applicazione
delle norme che ampliano le ipotesi di responsabilità (art. 2, comma 1, lettere
b e c), di quella che riconosce la risarcibilità anche del danno non
patrimoniale conseguente ad un atto o provvedimento del magistrato (art. 2,
comma 1, lettera a) e di quella che prevede l’obbligatorietà dell’azione di
rivalsa (art. 4, comma 2). Ciò, sebbene la stima di tali oneri fosse ben
possibile sulla base dell’esperienza applicativa della legge n. 117 del 1988,
come emerge dalla relazione al disegno di legge n. 1626, di iniziativa
governativa, che conteneva, in effetti, una norma sulla copertura finanziaria
(art. 4).
1.7.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.
1.7.1.– La difesa dell’interveniente eccepisce, in
via preliminare, l’inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza.
Le norme censurate verrebbero, infatti, in rilievo
solo nell’ipotesi, teorica ed eventuale, in cui il giudice a quo adottasse un
provvedimento errato con dolo o con colpa grave, costituenti il presupposto
della responsabilità civile dei magistrati (o, meglio, della responsabilità
dello Stato per l’attività dei magistrati). Si dovrebbe, inoltre, trattare di
errore non emendabile tramite i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri
rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, al cui preventivo
esaurimento è subordinata l’azione risarcitoria (art. 4, comma 2, della legge
n. 117 del 1988). Le disposizioni in esame non avrebbero, pertanto, alcuna
incidenza sulla decisione che il rimettente è chiamato ad assumere nel caso di
specie, attinente alla concessione della provvisoria esecuzione di un decreto
ingiuntivo: decisione che implica semplicemente la verifica del fumus della fondatezza dell’opposizione e dell’esistenza di
eventuali vizi procedurali, e che è destinata, comunque sia, a rimanere
assorbita dalla sentenza di merito.
Le questioni risulterebbero, dunque, formulate in
termini astratti, facendo leva su ipotetici condizionamenti psicologici da
ritenere inidonei, in relazione all’alta professionalità che caratterizza la
funzione giurisdizionale del magistrato, ad influire sulla sua serenità di
giudizio.
Del tutto privo di consistenza risulterebbe, altresì,
l’argomento del rimettente basato sull’avvenuta introduzione, tra le ipotesi
che possono dar luogo a responsabilità dello Stato e del magistrato, della
fattispecie del «travisamento del fatto o delle prove». Sarebbe, infatti,
evidente che, a prescindere dalla censurata innovazione, il giudice non debba,
comunque sia, travisare i fatti di causa e le prove offerte dalle parti: senza
considerare, poi, che, data la natura eclatante dell’ipotetico errore, esso
sarebbe rimediabile dallo stesso giudice (in sede di revoca del provvedimento o
di pronuncia della sentenza), ovvero dal giudice di appello, cui la questione
andrebbe devoluta come motivo di impugnazione.
Il giudice a quo non avrebbe neppure prospettato
l’esistenza di elementi di particolare complessità della materia del contendere
sottoposta al suo esame, sicché, anche sotto tale profilo, l’ipotizzata
"pericolosità” della nuova disciplina sulla responsabilità civile risulterebbe
meramente astratta.
Ove si seguisse il ragionamento del rimettente,
d’altro canto, ogni modifica della legge n. 117 del 1988 diverrebbe rilevante
in tutti i giudizi – civili, penali e amministrativi – «con effetti distorsivi
sul funzionamento dell’intero sistema giudiziario».
1.7.2.– Nel merito, le questioni sarebbero, in ogni
caso, infondate.
Quanto all’inserimento dell’ipotesi del «travisamento
del fatto o delle prove» tra i casi di colpa di grave, detta fattispecie
presenterebbe – contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente – i caratteri
della «limitatezza» e della «tassatività», atti ad escludere la ventilata
compromissione della serenità e imparzialità di giudizio del magistrato.
L’ipotesi in discorso si porrebbe, infatti, al di fuori dell’attività
valutativa cui fa riferimento la clausola di salvaguardia tuttora presente
nell’art. 2, comma 2, della legge n. 117 del 1988 (in base alla quale «non può
dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né
quella di valutazione del fatto e delle prove»), rappresentandone un grave ed
ingiustificato sviamento determinato da un errore di tale gravità da escluderne
la scusabilità.
Pur in presenza di possibili «spazi di
sovrapposizione» con il cosiddetto errore revocatorio – ossia con le ipotesi
dell’affermazione di un fatto escluso e della negazione di un fatto risultante
incontestabilmente dagli atti – il concetto di travisamento conserverebbe un
proprio autonomo e definito àmbito di operatività. Il travisamento potrebbe,
infatti, consistere non solo nella «"svista” rappresentativa» che integra
l’errore revocatorio, ma anche nello stravolgimento del dato fattuale, dovuto
ad una macroscopica omissione nella percezione di fatti secondari decisivi,
ovvero della regola di inferenza logica applicata.
Nell’ottica di una interpretazione costituzionalmente
orientata, il travisamento dovrebbe risultare, altresì, di assoluta evidenza:
prospettiva nella quale la soluzione adottata dal legislatore si sottrarrebbe a
censure anche sul piano della ragionevolezza.
1.7.3.– Quanto, poi, all’abrogazione del filtro di
ammissibilità previsto dall’art. 5 della legge n. 117 del 1988, la ratio
dell’intervento andrebbe rinvenuta nella volontà del legislatore – esplicitata
nell’art. 1 della legge n. 18 del 2015 – di rendere effettiva la disciplina
della responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce
dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Con l’eliminazione della fase
del filtro, si è inteso consentire, in specie, l’accesso diretto del danneggiato
all’azione risarcitoria, tenuto conto di quanto emerso nei ventisette anni di
esperienza applicativa della legge n. 117 del 1988, durante i quali solo un
esiguo numero di domande risarcitorie era approdato ad un esame nel merito a
cognizione piena.
Non decisivi risulterebbero i richiami del rimettente
alle affermazioni delle sentenze n. 468 del
1990 e n. 18
del 1989, circa il «rilievo» costituzionale del filtro, le quali non
equivarrebbero al riconoscimento della sua indispensabilità. Al riguardo, si
dovrebbe sempre tenere conto del fatto che l’azione del danneggiato è diretta
contro lo Stato (unico legittimato passivo), essendo rimasta ferma, anche dopo
la novella legislativa, l’impossibilità di agire direttamente contro il
magistrato. Rientrerebbe, quindi, nella discrezionalità del legislatore
regolare le modalità procedurali dell’azione di responsabilità, senza che le relative
scelte incidano sul principio di autonomia e indipendenza della funzione
giurisdizionale, adeguatamente salvaguardato dalla posizione differenziata del
magistrato rispetto alla responsabilità dei pubblici dipendenti prevista
dall’art. 28 Cost.
Le citate sentenze della Corte costituzionale sono
state, d’altro canto, emesse all’indomani dell’entrata in vigore della legge n.
117 del 1988 e non potevano tener conto, quindi, né della concreta applicazione
della legge da parte della giurisprudenza interna, né degli approdi della
giurisprudenza comunitaria in punto di responsabilità dello Stato per
l’esercizio delle funzioni giudiziarie (Corte
di giustizia, 30 settembre 2003, causa C-224/01, Gerhard Köbler;
Corte
di giustizia, Grande Sezione, 12 giugno 2006, causa C-173/03, Traghetti del
Mediterraneo; Corte
di giustizia, 24 novembre 2011, causa C-379/10, Commissione contro Italia).
Privo di fondamento risulterebbe, inoltre, il timore
che, in mancanza del filtro, possano trovare ingresso azioni palesemente
inammissibili o infondate, idonee a provocare l’astensione del giudice o a
minarne la serenità. L’azione risarcitoria si propone, infatti, contro lo Stato
ed è prevista soltanto una facoltà di intervento volontario del magistrato del
giudizio, con la conseguenza che non sussisterebbe un obbligo di astensione di
quest’ultimo ai sensi dell’art. 51, primo comma, cod. proc. civ. (l’astensione
per gravi ragioni di convenienza, prevista dal secondo comma dello stesso
articolo, è meramente facoltativa ed è subordinata ad autorizzazione del capo
dell’ufficio). Il magistrato non potrebbe, quindi, neppure essere ricusato
dalla parte che si assume danneggiata, dato che la ricusazione può essere
proposta solo nei casi in cui l’astensione è obbligatoria. La proposizione di
cause pretestuose risulterebbe, per altro verso, scoraggiata dal meccanismo
della «condanna aggravata» del litigante temerario, previsto dall’art. 96 cod.
proc. civ.
Il paventato rischio della sovrapposizione temporale
dei due giudizi – quello da cui deriva il presunto danno e quello di
responsabilità – sussisteva, d’altronde, anche in presenza del filtro, posto
che i termini di definizione di tale fase non erano perentori e che i decreti
di inammissibilità erano soggetti a reclamo davanti alla corte d’appello e indi
a ricorso per cassazione.
Quanto, infine, all’asserita contraddittorietà
dell’eliminazione del filtro rispetto all’avvenuta introduzione di meccanismi
processuali di valutazione semplificata dell’ammissibilità o della fondatezza
in rapporto al giudizio di appello e al giudizio di cassazione, sarebbe
sufficiente osservare che tali meccanismi attengono ai giudizi di impugnazione,
mentre il filtro previsto dall’art. 5 della legge n. 117 del 1988 ineriva al
giudizio di primo grado. La comparazione andrebbe semmai operata con le altre
controversie disciplinate dal rito ordinario di cognizione davanti al tribunale
in composizione collegiale, rispetto alle quali nessuna previa delibazione di
ammissibilità è prevista.
1.7.4.– Riguardo alle censure inerenti alle ricadute
dell’abolizione del filtro sull’azione disciplinare, risulterebbe assorbente il
rilievo che, in precedenza, l’azione disciplinare non era affatto subordinata
all’esito positivo della fase di filtro. L’art. 9 della legge n. 117 del 1988
prevedeva, infatti, che l’azione disciplinare fosse obbligatoriamente
esercitata entro due mesi dalla comunicazione dell’ammissibilità della domanda,
«salvo che non sia stata già proposta». Il superamento della fase di filtro
rappresentava, dunque, un impulso obbligatorio all’azione disciplinare, ma non
una condizione di ammissibilità della stessa.
L’art. 6 della legge n. 18 del 2015 si sarebbe
limitato a modificare il citato art. 9 della legge n. 117 del 1988 per renderlo
coerente con l’abolizione del filtro, non avendo più senso, dopo di questa, la
ricordata previsione relativa al termine di attivazione del procedimento
disciplinare.
Il timore di procedimenti disciplinari di fronte a
domande manifestamente infondate non avrebbe, quindi, ragion d’essere, posto
che simili procedimenti si concluderebbero con un’archiviazione.
1.7.5.– Per quel che attiene all’obbligatorietà
dell’azione di rivalsa nei confronti del magistrato, la difesa
dell’interveniente osserva come già nella previgente disciplina la doverosità
dell’azione di rivalsa apparisse indubbia, alla luce delle previsioni degli
artt. 7, comma 1, e 8, commi 1 e 2, della legge n. 117 del 1988. Non avrebbe
avuto senso, infatti, far carico allo Stato di valutare se agire o meno in
ripetizione di quanto corrisposto a causa dell’errore del magistrato (peraltro
entro i limiti di responsabilità previsti dall’art. 8 di detta legge).
Sarebbe, d’altra parte, arduo ipotizzare casi di
manifesti errori di diritto, gravi violazioni di legge o travisamenti dei fatti
o delle prove idonei a determinare una condanna dello Stato, ma non ad
integrare la negligenza inescusabile del magistrato.
Nessun pregio avrebbe, altresì, l’assunto del
rimettente, secondo il quale l’obbligo di rivalsa sarebbe ingiustificato nel
caso di transazione tra lo Stato e il danneggiato, essendo evidente che il
Presidente del Consiglio dei ministri non concluderebbe mai delle transazioni
su cause manifestamente infondate, con sicuro insuccesso, poi, dell’azione di
rivalsa.
Nessuna irragionevole disparità di trattamento
sarebbe poi ravvisabile rispetto agli altri dipendenti pubblici, la cui
posizione è palesemente diversa da quella dei magistrati, potendo i primi
essere convenuti direttamente in giudizio dai danneggiati senza alcuna
limitazione della responsabilità dal punto di vista economico.
1.7.6.– Quanto, infine, alla censura relativa alla
mancata previsione dei mezzi di copertura finanziaria dei maggiori oneri
derivanti dall’ampliamento delle ipotesi di responsabilità, essa risulterebbe
generica e assiomatica, basandosi su una stima del tutto ipotetica dell’impatto
delle nuove disposizioni in termini di aumento delle cause contro lo Stato.
2. – Con ordinanza dell’8 maggio 2015 (r.o. n. 218 del 2015), il Tribunale ordinario di Treviso ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale:
a) dell’art. 7 della legge n. 117 del 1988, nella
parte in cui non prevede che «non può dar luogo a responsabilità personale del
singolo magistrato l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella
di valutazione del fatto e delle prove in tutti i casi di azione di rivalsa
dello Stato nei confronti del magistrato stesso», per contrasto con gli artt.
101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.;
b) dell’art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015,
nonché degli artt. «4 e/o 7» della legge n. 117 del 1988, come modificati dalla
legge n. 18 del 2015, nella parte in cui «non prevedono che il Tribunale
competente a decidere sull’azione di risarcimento proposta contro lo Stato e/o
il Tribunale competente a decidere sull’azione di rivalsa dello Stato nei
confronti del magistrato verifichi con rito camerale la non manifesta
infondatezza della domanda ai fini della sua ammissibilità», per contrasto con
gli artt. 25, 101, 104 e 113 Cost.;
c) dell’art. 8, comma 3, della legge n. 117 del 1988,
come sostituito dall’art. 5 della legge n. 18 del 2015, «nella parte in cui
prevede che l’esecuzione della rivalsa nei confronti del magistrato, quando
viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, può comportare il
pagamento per rate mensili fino ad un importo corrispondente ad un terzo,
anziché ad un quinto, dello stipendio netto», per contrasto con gli artt. 3 e
«101 e seguenti» Cost.
2.1.– Il giudice a quo premette di essere investito
del processo penale nei confronti di una persona imputata del reato di illegale
detenzione, nel territorio dello Stato, di un rilevante quantitativo di tabacco
lavorato estero.
Riferisce, altresì, che, alla luce delle risultanze
dell’istruzione dibattimentale, l’esito del giudizio dipenderebbe da un’unica
questione: se si possa, cioè, ritenere provato che l’imputato sapesse che
all’interno di un capannone da lui locato era custodito il tabacco di cui al
capo di imputazione. Sul punto non sarebbero state acquisite prove dirette, ma
solo semplici elementi indiziari. La valutazione di elementi di tal fatta
risulterebbe, tuttavia, sempre particolarmente difficile e "rischiosa”, tanto
che lo stesso legislatore ha subordinato la possibilità di desumere un fatto da
indizi ai requisiti della gravità, precisione e concordanza di questi ultimi
(art. 192 cod. proc. pen.).
Proprio nei procedimenti nei quali i risultati
probatori sono meramente indiziari – e, dunque, di più problematico
apprezzamento – si manifesterebbero i riflessi negativi della nuova disciplina
della responsabilità civile dei magistrati introdotta con la legge n. 18 del
2015. Alcune previsioni della novella inciderebbero, infatti, sul principio del
libero convincimento del giudice, il quale, per essere indipendente, deve poter
valutare le prove senza temere conseguenze negative secondo l’esito del suo
giudizio. La nuova disciplina, di contro, esporrebbe il giudice alle pressioni
delle parti e, prevedendo come possibile fonte di responsabilità civile anche
la valutazione dei fatti e delle prove, minerebbe «il cuore dell’attività
giurisdizionale». Di fronte alla prospettiva di una responsabilità per danni,
il giudice sarebbe portato, «per forza di cose», soprattutto nei casi più
difficili, ad assumere la decisione per lui meno "rischiosa”: decisione che,
nel processo penale, si identifica quasi sempre nell’assoluzione dell’imputato.
Le questioni sarebbero, dunque, rilevanti, in quanto
le norme censurate inciderebbero, nei sensi indicati, anche sulla valutazione
che il rimettente è chiamato ad operare nel giudizio a quo: conclusione che
troverebbe, d’altra parte, puntuale conforto nelle indicazioni della sentenza della
Corte costituzionale n. 18 del 1989 in precedenza ricordate.
2.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il
giudice a quo dubita, in primo luogo, della legittimità costituzionale
dell’art. 7 della legge n. 117 del 1988, come sostituito dall’art. 4 della
legge n. 18 del 2015, nella parte in cui non prevede che «non può dar luogo a
responsabilità personale del singolo magistrato l’attività di interpretazione
di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove in tutti i
casi di azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato stesso».
Il rimettente rileva come la novella del 2015, nel
sostituire il comma 2 dell’art. 2 della legge n. 117 del 1988, abbia mantenuto
fermo solo formalmente il principio per cui «nell’esercizio delle funzioni
giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di
norme di diritto né quelle di valutazione del fatto e delle prove». La nuova
disposizione si apre, infatti, con una «eccezione totalizzante» («fatti salvi i
commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo»), per effetto della quale la clausola di
salvaguardia non opera in tutti i casi di colpa grave in cui scatta la
responsabilità dello Stato e, in sede di rivalsa, del magistrato: sicché, nella
sostanza – secondo il giudice a quo – «è come se la clausola non ci fosse».
Rendere civilmente responsabile il giudice pure per
la sua attività di interpretazione di norme giuridiche e di valutazione del
fatto e delle prove comporterebbe, peraltro, una evidente lesione dei principi di
soggezione del giudice solo alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.) e di
indipendenza della magistratura (art. 104, primo comma, Cost.). Un simile
regime genererebbe, infatti, il concreto pericolo che il giudice sia portato a
preferire, tra due opzioni ermeneutiche o tra due ricostruzioni probatorie dei
fatti, quella che appare meno rischiosa sul piano di una eventuale
responsabilità risarcitoria, tenuto conto anche del "peso” delle parti in
causa. Sul piano interpretativo, inoltre, il giudice sarebbe indotto – sempre
per limitare i rischi – ad uniformarsi agli indirizzi della Corte di cassazione
e della giurisprudenza europea, con una surrettizia elusione della regola,
desumibile dal citato art. 101, secondo comma, Cost., che esclude l’efficacia
vincolante dei precedenti giurisprudenziali.
Al fine di rendere conforme a Costituzione la nuova
disciplina, sarebbe necessario – secondo il rimettente – reintrodurre la
clausola di salvaguardia in rapporto all’azione di rivalsa dello Stato nei
confronti del magistrato: operazione che risulterebbe pienamente rispettosa
delle indicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, che hanno
costituito il principale stimolo alla riforma. È ben vero, infatti, che la
Corte di Lussemburgo ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario
l’esclusione della responsabilità civile nei casi in cui il danno connesso
all’esercizio di funzioni giudiziarie sia dovuto ad una errata interpretazione
di norme di diritto o ad una errata valutazione del fatto o delle prove (sentenza
13 giugno 2006, causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo), ma tale
affermazione – come precisato espressamente dalla sentenza
30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler – si
riferisce solo alla responsabilità dello Stato, e non anche alla responsabilità
personale del magistrato. Alcuni passaggi delle pronunce della Corte di
giustizia parrebbero, anzi, evocare necessari limiti alla responsabilità
personale del giudice.
2.3.– Il Tribunale trevigiano dubita, in secondo
luogo, della legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge n. 18
del 2015, che, abrogando l’art. 5 della legge n. 117 del 1988, ha eliminato
qualunque filtro sulla domanda risarcitoria, nonché degli artt. «4 e/o 7» della
legge n. 117 del 1988, come riformulati, «nella parte in cui non prevedono, per
l’appunto, alcun meccanismo di filtro volto a delibare la manifesta
infondatezza della domanda di risarcimento».
Il rimettente denuncia innanzitutto il contrasto
delle norme censurate con gli artt. 101, 104 e 113 Cost., ricordando come il
«rilievo costituzionale» del meccanismo di filtro – quale strumento di
salvaguardia dei valori dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura –
fosse stato specificamente affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 468 del
1990 e n. 18
del 1989. Il filtro apparirebbe, peraltro, ancora più necessario nel nuovo
regime, essendo tutt’altro che remota la possibilità che l’azione di
responsabilità venga esercitata quando il giudizio in cui si sarebbe verificato
il danno pende ancora dinanzi al giudice "accusato” dell’illecito civile. È
vero, infatti, che l’art. 4, comma 2, della legge n. 117 del 1988, come
novellato, subordina l’esercizio dell’azione risarcitoria contro lo Stato
all’esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione o dei rimedi previsti
avverso i provvedimenti cautelari e sommari, ovvero – se tali rimedi non sono
previsti – all’esaurimento del grado di giudizio nell’àmbito del quale si è
verificato il fatto che ha cagionato il danno. Il successivo comma 3 aggiunge,
tuttavia, che «l’azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del
fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si è concluso il grado
del procedimento nell’ambito del quale il fatto stesso si è verificato».
La possibile sovrapposizione dei due giudizi – quello
che si assume produttivo di danno e quello risarcitorio – provocherebbe,
peraltro, un «grave "cortocircuito giudiziario”», che aprirebbe la strada a
ricusazioni e astensioni, con conseguente lesione anche del principio del
giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.).
Il rimettente lascia alla Corte costituzionale il
compito di stabilire se, ai fini della tutela dei valori costituzionali
evocati, il filtro debba riguardare, ab origine, la domanda di risarcimento
proposta dal danneggiato contro lo Stato oppure la successiva domanda di
rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato.
2.4.– Il giudice a quo censura, infine, l’art. 8,
comma 3, della legge n. 117 del 1988, come sostituito dall’art. 5 della legge
n. 18 del 2015, «nella parte in cui prevede che l’esecuzione della rivalsa da
parte dello Stato nei confronti del magistrato, quando viene effettuata
mediante trattenuta sullo stipendio, può comportare il pagamento per rate
mensili fino ad un importo corrispondente ad un terzo dello stipendio».
Il rimettente rileva come la norma tratti i
magistrati in modo deteriore rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici, i
cui emolumenti – in forza dell’art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180
(Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti
dalle Pubbliche Amministrazioni) e dell’art. 33, ottavo comma, del d.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato) – possono formare oggetto di sequestro e di
pignoramento solo nei limiti del quinto del rateo mensile.
Tale disparità di trattamento, oltre a violare
anch’essa gli artt. «101 e seguenti» Cost., togliendo serenità al magistrato,
si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., risultando priva di ogni
ragionevole giustificazione. Quest’ultima non potrebbe essere rinvenuta, in
specie, nell’ammontare dello stipendio, essendovi notoriamente dipendenti
pubblici che percepiscono stipendi più elevati di quello dei magistrati.
2.5.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dell’Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha eccepito l’inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza sulla
base di considerazioni analoghe a quelle svolte in rapporto all’ordinanza r.o. n. 198 del 2015, contestandone, in ogni caso, la
fondatezza nel merito.
Quanto alle questioni aventi ad oggetto l’art. 7
della legge n. 117 del 1988, la difesa dell’interveniente rileva che la
cosiddetta clausola di salvaguardia non è stata eliminata dal legislatore, ma
solo ridisegnata anche al fine di renderla conforme alle pronunce della Corte
di giustizia dell’Unione europea. L’«erosione» della clausola sarebbe stata,
d’altra parte, ragionevolmente circoscritta ai casi di «manifesto e
ingiustificato esercizio non corretto dell’attività di interpretazione delle
norme e di valutazione dei fatti e delle prove».
Infondate sarebbero anche le questioni inerenti
all’abolizione del filtro di ammissibilità, previsto dall’art. 5 della legge n.
117 del 1988, per le stesse ragioni indicate in rapporto all’ordinanza r.o. n. 198 del 2015. Con particolare riguardo all’assunto
del rimettente, secondo il quale la Corte costituzionale dovrebbe valutare se
il filtro sia indispensabile in relazione alla causa contro lo Stato ovvero
solo per l’azione di rivalsa, l’Avvocatura generale dello Stato aggiunge che la
presenza del filtro nell’azione di rivalsa non avrebbe, in realtà, alcun senso,
tanto da non essere prevista neppure nella previgente disciplina.
Quanto, infine, alle questioni inerenti alla misura
della rivalsa, nel caso di esecuzione mediante trattenuta sullo stipendio, le
posizioni poste a confronto dal rimettente – quella del magistrato e quella
degli altri dipendenti pubblici – sarebbero palesemente diverse e non
comparabili.
3.– Con ordinanza del 6 febbraio 2016 (r.o. n. 113 del 2016), il Tribunale ordinario di Catania ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale:
a) dell’art. 7 della legge n. 117 del 1988, come
sostituito dall’art. 4, comma 1, della legge n. 18 del 2015, nella parte in cui
prevede che l’azione di rivalsa sia esperibile anche nelle ipotesi di ritenuto
«travisamento del fatto o delle prove di cui all’art. 2, commi 2, 3», per
contrasto con gli artt. 3, 24, 28 e «101-113» Cost.;
b) dell’art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015,
che ha abrogato l’art. 5 della legge n. 117 del 1988, per contrasto con gli
artt. 3 e «101-113» Cost.;
c) dell’art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988,
come modificato dall’art. 6, comma 1, della legge n. 18 del 2015, nella parte
in cui prevede l’obbligo del titolare dell’azione disciplinare di procedere nei
confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all’azione di
risarcimento, a seguito della proposizione dell’azione risarcitoria,
indipendentemente dall’esito della domanda, per contrasto con gli artt. 3, e
«101-113» Cost.;
d) dell’art. 4, comma 3, della legge n. 117 del 1988,
per contrasto con gli artt. 3 e «101-113» Cost.;
e) dell’art. 8, comma 3, della legge n. 117 del 1988,
come sostituito dall’art. 5, comma 1, della legge n. 18 del 2015, nella parte
in cui prevede che la rivalsa, ove effettuata mediante trattenuta sullo
stipendio, possa comportare il pagamento per rate mensili fino ad importo
corrispondente ad un terzo dello stipendio netto, anziché ad un quinto, per
contrasto con gli artt. 3, 101 e 111 Cost.
3.1.– Il giudice a quo riferisce di essere investito
dell’opposizione proposta da un datore di lavoro avverso l’ordinanza – emessa
dallo stesso Tribunale, nella medesima composizione monocratica – con la quale,
in parziale accoglimento del ricorso proposto da una lavoratrice contro il
licenziamento per giusta causa, era stata disposta la reintegrazione della
medesima nel posto di lavoro a norma dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).
L’ordinanza opposta, pur dando atto dell’esistenza di
elementi indiziari a carico della lavoratrice, li aveva ritenuti non
sufficienti per considerare provati gli addebiti a questa mossi
(impossessamento illecito di beni commercializzati dal datore di lavoro), per
difetto dei caratteri dell’univocità e della concordanza (art. 2729 cod. civ.).
L’opponente aveva censurato aspramente l’ordinanza,
sostenendo che essa avesse disatteso risultanze decisive dell’istruttoria con
affermazioni contrarie «alla logica e al buon senso, prima ancora che ai
principi di diritto», dovendo l’ordinanza stessa, «all’evidenza», «smontare
tutte le prove raccolte per dar credito alla tesi dell’opposta».
Alla prima udienza di discussione, lo stesso
opponente, rilevata l’identità fisica tra il giudice della fase sommaria e il
giudice dell’opposizione, aveva proposto istanza di ricusazione ai sensi
dell’art. 51, numero 4), cod. proc. civ.: istanza rigettata, tuttavia, dal
collegio, sul rilievo che la fase di opposizione, prevista dall’art. 1, comma
51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), non costituisce un giudizio
di impugnazione, ma un giudizio ordinario di cognizione in materia di lavoro.
Riassunta la causa, le parti avevano chiesto un
rinvio per la discussione, ritenendo esaustiva l’istruttoria già espletata
nella fase sommaria. Nelle more, era entrata, peraltro, in vigore la legge n.
18 del 2015.
Tanto premesso, il rimettente rileva come l’oggetto
del giudizio di cui è investito sia costituito dalla conferma, o meno, della
decisione assunta nella fase preliminare, sulla base di una nuova valutazione
dello stesso materiale probatorio. Rileva, altresì, come i vizi che l’opponente
addebita all’ordinanza opposta possano essere ricondotti alla nozione,
particolarmente generica, di «travisamento del fatto o delle prove». Sarebbe,
quindi, del tutto verosimile che il medesimo addebito verrebbe mosso dalla
parte opponente alla decisione di conferma del provvedimento. La stessa
lavoratrice, peraltro, in caso di accoglimento delle tesi avversarie, potrebbe
a sua volta ravvisare un omologo vizio. Sussisterebbe, dunque, la «reale e
tangibile probabilità» che qualsiasi decisione possa essere contestata «per
ritenuto "travisamento del fatto o delle prove”»: ipotesi, questa, oggi
rientrante nei casi di «colpa grave», costituenti presupposto tanto dell’azione
risarcitoria nei confronti dello Stato per i danni cagionati nell’esercizio
delle funzioni giudiziarie, quanto della successiva azione di rivalsa nei
confronti del magistrato.
La novella legislativa del 2015 ha anche stabilito
che l’azione risarcitoria dia subito luogo ad un giudizio a cognizione piena,
essendo stato abolito il filtro di ammissibilità già previsto dall’art. 5 della
legge n. 117 del 1988; che il titolare dell’azione disciplinare debba attivarsi
indipendentemente da un esito della domanda risarcitoria; che la misura delle
somme ripetibili dallo Stato attraverso la trattenuta sullo stipendio del
magistrato sia elevata ad un terzo (art. 8 della legge n. 117 del 1988, come
novellato); che l’azione risarcitoria, decorsi tre anni, sia esperibile ove il
grado di giudizio nel quale il fatto si è verificato non risulti esaurito (art.
4, comma 3, della legge n. 117 del 1988, come novellato).
Tale complesso di disposizioni sarebbe direttamente
rilevante nel giudizio a quo – considerati i termini della controversia – in
quanto idoneo a pregiudicare la serenità del giudizio, l’imparzialità ed il
libero convincimento di esso rimettente: il timore di poter subire svantaggi –
anche solo sul piano dell’esigenza di svolgere «una considerevole attività
difensiva» – potrebbe indurre, infatti, il giudice, «anche inconsapevolmente o
in maniera del tutto istintiva, ad adottare una decisione, anziché un’altra,
non perché ritenuta più corretta […], ma solo perché, per lui, meno rischiosa».
Né varrebbe obiettare che la decisione emananda è suscettibile di impugnazione, posto che, nel
caso di conferma della sentenza nei successivi gradi di giudizio, l’eventuale
domanda risarcitoria riguarderebbe, comunque sia, anche e innanzitutto,
l’operato del giudice di primo grado.
Le conclusioni ora esposte sarebbero, d’altronde,
conformi – anche secondo il Tribunale di ordinario di Catania – alle affermazioni
contenute nella sentenza
n. 18 del 1989 della Corte costituzionale.
3.2.– Ciò posto, il giudice a quo dubita, anzitutto,
della legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge n. 117 del 1988, come
sostituito dall’art. 4, comma 1, della legge n. 18 del 2015, nella parte in cui
prevede che l’azione di rivalsa sia esperibile anche nelle ipotesi di ritenuto
«travisamento del fatto o delle prove di cui all’art. 2, commi 2, 3».
Ad avviso del rimettente, la disposizione violerebbe
l’art. 3 Cost., riducendo irragionevolmente, se non addirittura eliminando, «il
carattere tassativo delle ipotesi per le quali il magistrato, nell’attività di
valutazione del fatto o delle prove, può essere convenuto civilmente in sede di
rivalsa»: carattere di fronte al quale la giurisprudenza costituzionale (e, in
particolare, la sentenza
n. 18 del 1989) aveva escluso che l’originario impianto della legge n. 117
del 1988 si esponesse a rilievi sul piano della legittimità costituzionale.
La formula «travisamento del fatto o delle prove» –
evidentemente non riferibile alle ipotesi dell’affermazione o della negazione
di un fatto incontrastabilmente escluso o emergente dagli atti del
procedimento, già originariamente contemplate dalla legge n. 117 del 1988 e da
essa tuttora menzionate – risulterebbe, infatti, generica ed ambigua, apparendo
idonea a ricomprendere un numero indefinito di casi e prestandosi, perciò, a
letture soggettive e opinabili.
L’ipotesi di responsabilità in questione
rischierebbe, quindi, di instaurare «una sorta di "contro-processo”»,
sovrapponendo al giudizio del giudice naturale precostituito per la definizione
della controversia quello di altro giudice, con sostanziale soppressione della
clausola di salvaguardia pure formalmente ribadita dall’art. 2, comma 2, della
legge n. 117 del 1988, volta a tutelare «l’indipendenza del giudice nel cuore
della propria attività» (quella di valutazione del fatto e delle prove).
La norma censurata violerebbe anche il «principio di
legalità» desumibile dalle previsioni degli artt. 28 e 101 Cost., in forza del
quale dovrebbe essere il legislatore a stabilire in quali casi il giudice è
civilmente responsabile. Con l’adozione di formule così generiche quale quella
censurata, il predetto compito verrebbe, di fatto, delegato al giudice
dell’azione risarcitoria, con conseguente rischio di affermazioni di
responsabilità basate semplicemente sulla mancata condivisione dei criteri
valutativi e interpretativi applicati nel giudizio che si assume produttivo di
danno.
Sarebbero violati, ancora, i principi di indipendenza
ed autonomia del giudice «di cui agli artt. 101-113 Cost.». La mera possibilità
che il giudice sia sottoposto ad azione di rivalsa per aver "travisato” il
materiale probatorio o il fatto genera il pericolo che egli sia indotto a
scegliere, tra più opzioni disponibili, non quella ritenuta più giusta, ma
quella che appare «meno rischiosa», favorendo così – in contrasto con il
principio del libero convincimento – «atteggiamenti remissivi o conformisti».
In questo modo, il giudice verrebbe anche privato –
in contrasto con l’art. 111 Cost. – della sua terzietà, perdendo la propria
necessaria "indifferenza” rispetto alle parti e alla causa. Il timore di
pregiudizi personali lo porterebbe, infatti, «istintivamente» ad adottare
soluzioni "accomodanti”, tanto più quando taluna delle parti vanti particolari
risorse economiche od ostenti «atteggiamenti audaci ovvero velatamente
minacciosi».
Il pericolo di condizionamenti non è escluso dal
fatto che, in base alla norma denunciata, l’azione di rivalsa deve essere
esercitata solo se il travisamento del fatto o delle prove siano stati
determinati da dolo o da «negligenza inescusabile». Tale condizione non è,
infatti, prevista dall’art. 2, comma 3, della legge n. 117 del 1988, nel testo
vigente, ai fini della proponibilità dell’azione risarcitoria nei confronti
dello Stato. Di conseguenza, il mero risarcimento del danno per ritenuto
travisamento assoggetterebbe il giudice alla decisione del Presidente del
Consiglio dei ministri di attivare l’azione di rivalsa, potendo ogni ulteriore
valutazione dell’elemento soggettivo rilevare in tale sede. In ogni caso, il
presunto travisamento potrebbe attenere ad una attività di valutazione che il
giudice ha svolto con perfetta consapevolezza, nell’adempimento del suo dovere
di decidere secondo il proprio convincimento: sicché egli potrebbe essere
chiamato a rispondere addirittura per aver travisato il fatto con dolo.
Per superare gli esposti rilievi non si potrebbe far
leva sugli indirizzi della giurisprudenza comunitaria, secondo i quali
l’esclusione della responsabilità civile, nei casi di danno determinato da
un’errata interpretazione di norme di diritto o di valutazione del fatto o
delle prove, non è compatibile con il diritto dell’Unione europea.
L’affermazione riguarda, infatti, la sola responsabilità dello Stato e non
investe la responsabilità del singolo giudice, rispetto alla quale, anzi, lo
stesso Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa – con la raccomandazione
CM/Rec(2010) 12 del 17 novembre 2010 – ha sollecitato
gli Stati aderenti ad evitare aggravamenti suscettibili di minacciare un
esercizio della funzione giurisdizionale conforme ai principi dello Stato di
diritto. Le limitazioni apposte dalla legge n. 18 del 2015 alla clausola di
salvaguardia («Fatti salvi i commi 3 e 3-bis») sarebbero quindi giustificabili
in rapporto alla responsabilità dello Stato, ma non in relazione alla
responsabilità del giudice.
3.3.– Il Tribunale etneo dubita, altresì, della
legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015,
che abroga l’art. 5 della legge n. 117 del 1988.
L’eliminazione, «senza […] appositi bilanciamenti»,
del filtro di ammissibilità sulla domanda risarcitoria previsto dalla norma
abrogata violerebbe i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di
indipendenza e autonomia della magistratura (artt. «101-113» Cost.). In occasione
dello scrutinio dell’impianto originario della legge n. 117 del 1988, la Corte
costituzionale aveva, infatti, posto in rilievo come il meccanismo fosse
indispensabile al fine di garantire i valori costituzionali evocati, ponendo al
riparo il magistrato da azioni temerarie e intimidatorie (sentenze n. 468 del
1990 e n. 18
del 1989).
La soppressione del filtro non potrebbe essere
logicamente giustificata con la supposizione che l’istituto abbia favorito, in
passato, atteggiamenti «di tipo corporativo», posto che analoghi atteggiamenti
potrebbero, comunque sia, manifestarsi, dopo la sua scomparsa, nelle sedi di
merito. L’intervento sarebbe contrario, per converso, alle esigenze di
deflazione e di efficienza del sistema, creando fenomeni di congestione degli
uffici giudiziari competenti sulle domande risarcitorie.
Nell’attuale sistema, d’altro canto, qualsiasi
domanda risarcitoria, indipendentemente dalla sua fondatezza, esporrebbe il
giudice a pregiudizi di carattere non patrimoniale, dovendo egli preoccuparsi
di predisporre un’adeguata difesa, eventualmente già come interveniente nel
giudizio risarcitorio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 117 del 1988. Di qui
un ulteriore possibile stimolo a scelte accomodanti e arrendevoli.
3.4.– Il rimettente censura ancora, per violazione
dei medesimi parametri costituzionali, l’art. 9, comma 1, della legge n. 117
del 1988, come sostituito dall’art. 6, comma 1, della legge n. 18 del 2015,
nella parte in cui prevede l’obbligo del titolare dell’azione disciplinare di
procedere nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa
all’azione di risarcimento, a seguito della mera proposizione di quest’ultima,
indipendentemente dall’esito della domanda.
Tale modifica – conseguente alla soppressione del
filtro di ammissibilità – violerebbe anch’essa i principi di indipendenza,
terzietà ed imparzialità del giudice, facendo sì che quest’ultimo possa
risultare esposto contemporaneamente, a seguito della mera proposizione della
domanda risarcitoria, «a più oneri difensivi, sia in sede risarcitoria che in
sede disciplinare, anche in chiave meramente preventiva», con conseguenti
rischi di condizionamento della sua serenità di giudizio.
La norma violerebbe, altresì, l’art. 3 Cost.,
apparendo irragionevole imporre l’avvio del procedimento disciplinare a
prescindere da ogni valutazione di fondatezza della domanda risarcitoria, con
il risultato di provocare intuibili disfunzioni sia presso l’ufficio del
giudice coinvolto (le cui energie verrebbero distolte dall’esigenza di curare
le proprie difese), sia presso l’ufficio titolare dell’azione disciplinare.
3.5.– Il rimettente ventila, poi, l’illegittimità
costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge n. 117 del 1988, ove si
stabilisce – in deroga alla regola generale enunciata dal comma 2 dello stesso
articolo – che l’azione risarcitoria può essere esercitata decorsi tre anni
dalla data del fatto che ha cagionato il danno, se in tale termine non si è
concluso il grado del procedimento nell’àmbito del quale il fatto stesso si è
verificato.
La norma denunciata violerebbe gli artt. 3 e
«101-113» Cost., in quanto idonea «a turbare la serenità, l’indipendenza e,
dunque, l’imparzialità del giudice». Questi, nell’ipotesi di prolungamento del
giudizio nel medesimo grado oltre i tre anni, potrebbe, infatti, veder promossa
un’azione risarcitoria riferita ad un proprio provvedimento interinale, pur essendo
ancora investito della causa. In questo modo, la serenità del giudicante –
chiamato a confermare le valutazioni interinali cui è riferita la domanda
risarcitoria – risulterebbe del tutto compromessa. Il condizionamento
dell’autonomia di giudizio – acuito dall’avvenuta abolizione del filtro di
ammissibilità su detta domanda – potrebbe, peraltro, estendersi anche al
giudice del grado successivo, chiamato a verificare la correttezza dell’operato
del primo giudice.
La soluzione costituzionalmente corretta – anche in
un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti – sarebbe, per
converso, quella di differire, in ogni caso, l’esperibilità dell’azione
risarcitoria al momento in cui il provvedimento che si assume dannoso non sia
più modificabile.
3.6.– Con i medesimi parametri costituzionali si
porrebbe in contrasto, da ultimo, anche l’art. 8, comma 3, della legge n. 117
del 1988, come sostituito dall’art. 5, comma 1, della legge n. 18 del 2015,
nella parte in cui prevede che la rivalsa, ove effettuata mediante trattenuta
sullo stipendio, possa comportare il pagamento per rate mensili fino ad un
importo corrispondente ad un terzo dello stipendio netto, anziché ad un quinto.
La norma censurata discriminerebbe, infatti,
irragionevolmente i magistrati rispetto agli altri dipendenti pubblici – le cui
retribuzioni, a mente degli artt. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950 e 3, ottavo
comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, sono sequestrabili e pignorabili solo fino a
concorrenza di un quinto – perturbando, una volta ancora, con il timore di una
così rilevante compressione dei propri emolumenti, il sereno svolgimento delle
loro funzioni.
3.7.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
eccependo l’inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, sulla
base di considerazioni analoghe a quelle già svolte in rapporto alle precedenti
ordinanze di rimessione.
Le questioni sarebbero, in ogni caso, infondate.
Con riguardo alle prime tre delle cinque norme
censurate, la difesa dell’interveniente ripropone argomenti similari a quelli
prospettati nei precedenti atti di intervento. In particolare, con riguardo
alle questioni concernenti l’art. 7 della legge n. 117 del 1988, ribadisce che
il concetto di «travisamento» non sarebbe affatto ambiguo e generico e,
soprattutto, esulerebbe dall’àmbito dell’attività valutativa, rappresentandone
un grave e ingiustificato sviamento. La circostanza, poi, che l’azione di
rivalsa presupponga, a mente della disposizione censurata, il dolo o la
negligenza inescusabile del magistrato escluderebbe senz’altro il rischio che
questi possa essere chiamato a rispondere civilmente per la mera «non
condivisione» dei criteri valutativi e interpretativi da lui applicati. Del
tutto infondato sarebbe, altresì, l’assunto del rimettente stando al quale la
consapevole scelta della decisione da parte del giudice potrebbe addirittura
integrare il «dolo». Quest’ultimo si configurerebbe, infatti, solo nei casi di
scelte contra legem perché frutto di interessi o di
accordi illeciti, e non perché si tratti di scelte «consapevoli».
Riguardo, poi, alle questioni che investono l’art. 4,
comma 3, della legge n. 117 del 1988, l’Avvocatura generale dello Stato rileva
come sia comprensibile e ragionevole che, a tutela del danneggiato, sia
prevista la possibilità di agire per il risarcimento quando il grado di
giudizio non si sia concluso nel termine di tre anni. Il riconoscimento di tale
facoltà – peraltro di rara esplicazione pratica – trova, infatti, giustificazione
nella irragionevole durata del grado del procedimento in cui si è verificato il
fatto dannoso. La circostanza che penda una causa risarcitoria contro lo Stato
non dovrebbe, d’altra parte, in alcun modo intaccare la serenità di giudizio
del magistrato che ha operato secondo diligenza.
Infondate, da ultimo, risulterebbero anche le
questioni relative all’esecuzione della rivalsa, per le stesse ragioni già
indicate in rapporto alle omologhe questioni sollevate dal Tribunale ordinario
di Treviso.
4.– Con ordinanza del 25 febbraio 2016 (r.o. n. 126 del 2016), il Tribunale ordinario di Enna ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale:
a) dell’art. 2, comma 3, della legge n. 117 del 1988,
come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 18 del 2015,
nella parte in cui, secondo il diritto vivente, configurerebbe come «colpa
grave» del magistrato, per «violazione manifesta del diritto», l’adozione di
un’interpretazione di norme di diritto contrastante con quella adottata dalla
Corte costituzionale in una pronuncia interpretativa di rigetto, resa in un
diverso processo, per violazione degli artt. 101, secondo comma, 104, primo
comma, 107, terzo comma, e 134 Cost.;
b) dell’art. 2, comma 2, della legge n. 117 del 1988,
come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 18 del 2015,
nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non estenderebbe la clausola di
esclusione della responsabilità per l’«interpretazione delle norme di diritto»
anche all’ipotesi in cui l’interpretazione accolta dal giudice sia in contrasto
con quella adottata dalla Corte costituzionale in una pronuncia interpretativa
di rigetto, resa in un diverso processo, per violazione degli artt. 101, secondo
comma, 104, primo comma, 107, terzo comma, e 134 Cost.
4.1.– Il giudice a quo premette di essere investito
del giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo, emesso per il pagamento
della somma di euro 13.679,92 a titolo di regresso nell’àmbito di un contratto
di fideiussione.
Il debitore ingiunto aveva dedotto, a fondamento
dell’opposizione, l’usurarietà degli interessi
applicati dalla banca garantita sulle rate di mutuo rimaste inadempiute, per il
cui pagamento era stato escusso il fideiussore ingiungente. Quest’ultimo, nel
costituirsi in giudizio, aveva contestato le avverse deduzioni, aveva chiesto
di chiamare in causa la banca e, infine, aveva fatto istanza per la concessione
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con riguardo a tale ultima istanza, il rimettente
rileva che l’opposizione – oltre a non apparire di pronta soluzione – non
risulta neppure fondata su prova scritta. Alla luce del tenore letterale
dell’art. 648, primo comma, cod. proc. civ., ciò dovrebbe portare
all’accoglimento della richiesta dell’ingiungente, impedendo una rivalutazione
in fase di opposizione della prova documentale da questi offerta in sede
monitoria: soluzione che risulterebbe conforme al principio di ragionevole
durata del processo, apparendo «superfluo» e illogico sottoporre a due diversi
giudici la valutazione delle stesse prove, in un ristretto arco temporale.
La Corte costituzionale, tuttavia, con una pronuncia
interpretativa di rigetto – l’ordinanza n. 295
del 1989 – ha offerto una diversa lettura della disposizione, affermando
che anche «nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non fondata su
prova scritta, la concessione della provvisoria esecuzione […] deve ovviamente
essere esercitata – come in ogni ipotesi di misura avente (anche) natura
cautelare – attraverso la congiunta valutazione del fumus
boni iuris e del periculum
in mora». La riconduzione del provvedimento previsto dall’art. 648 cod. proc.
civ. nell’alveo dei provvedimenti lato sensu
cautelari, quindi, legittimerebbe – secondo la Corte – una rivalutazione
dell’intero materiale offerto dalla parte creditrice anche di fronte a
un’opposizione non fondata su prova scritta.
In una simile situazione, verrebbero in rilievo, ai
fini della decisione che il giudice a quo è chiamato ad assumere, alcune delle
disposizioni della legge n. 117 del 1988 – e, in particolare, il suo art. 2,
commi 2 e 3 – «così come interpretate dal diritto vivente della Corte di cassazione».
Secondo il rimettente, le sezioni unite civili della
Corte di cassazione avrebbero infatti affermato, con la sentenza 16 dicembre
2013, n. 27986, che le pronunce interpretative di rigetto della Corte
costituzionale hanno effetto vincolante nei confronti di tutti i giudici
comuni, e non solo del giudice che ha sollevato l’incidente di
costituzionalità. Con altra pronuncia (sezione terza civile, 5 novembre 2013,
n. 24798), la Corte di cassazione avrebbe, altresì, ritenuto che l’adozione di
una soluzione interpretativa rifiutata dalla Corte costituzionale in una
pronuncia interpretativa di rigetto costituisca, per il giudice, una «grave
violazione di legge determinata da negligenza inescusabile», ai sensi
dell’originario testo dell’art. 2, comma 3, lettera a), della legge n. 117 del
1988: affermazione riferita proprio a fattispecie nella quale il giudice si era
discostato dall’interpretazione adottata dalla citata ordinanza della Corte
costituzionale n. 295 del 1989, in punto di presupposti per la concessione
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Sulla ricordata conclusione non inciderebbero le
modifiche normative operate dalla legge n. 18 del 2015: la nozione di «manifesta
violazione della legge», utilizzata dalla novella, sarebbe infatti
sovrapponibile a quella di «grave violazione di legge», da essa sostituita.
Di conseguenza, per non incorrere in responsabilità,
il giudice a quo dovrebbe – a suo avviso – scartare a priori una delle
possibili opzioni interpretative dell’art. 648 cod. proc. civ. (la prima dianzi
prospettata). Una motivazione che disattendesse expressis
verbis l’interpretazione accolta dall’ordinanza n. 295
del 1989 esporrebbe il rimettente – sempre secondo la sua ricostruzione –
addirittura ad una responsabilità diretta nei confronti delle parti, potendosi
configurare una ipotesi di dolo.
Di qui, dunque, la rilevanza delle questioni, anche
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 18 del
1989 e implicitamente ribaditi – a parere del rimettente – nella sentenza n. 237 del
2013.
4.2.– In punto di non manifesta infondatezza, il
Tribunale di Enna assume che le norme censurate – nella parte in cui, secondo
il «diritto vivente», configurano come ipotesi di «colpa grave» del giudice
l’adozione di una interpretazione contrastante con quella adottata dalla Corte
costituzionale in una pronuncia interpretativa di rigetto resa in un diverso
processo – violerebbero i principi di soggezione del giudice soltanto alla
legge e di indipendenza della magistratura, espressi dagli artt. 101, secondo
comma, 104, primo comma, e 107, terzo comma, Cost.
Detti principi, sottraendo il giudice ad ogni vincolo
gerarchico, escluderebbero che possa attribuirsi efficacia vincolante ad
interpretazioni di disposizioni di legge provenienti da giurisdizioni
superiori, compresa la Corte costituzionale. Diversamente opinando, si
attribuirebbe alla Corte – in violazione dell’art. 134 Cost. – una «funzione
nomofilattica», riconoscendo a tale organo, non solo il potere di dichiarare
erga omnes l’incompatibilità della legge con la
Costituzione, ma anche il «monopolio interpretativo della compatibilità tra
legge e Costituzione».
4.3.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, eccependo l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.
Le norme della cui compatibilità costituzionale si
dubita verrebbero, infatti, in rilievo solo in linea teorica ed eventuale, qualora
il giudice a quo decidesse di disattendere il richiamato orientamento della
Corte costituzionale. Peraltro, il Tribunale rimettente non avrebbe neppure
indicato le ragioni che dovrebbero indurlo ad una simile opzione.
Ove pure, poi, il giudice a quo si ritenesse
vincolato all’interpretazione della Corte costituzionale riguardo alla natura
del giudizio sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo, potrebbe pur sempre sollevare questione di legittimità
costituzionale dell’art. 648 cod. proc. civ. Questa soltanto sarebbe, in
effetti, la norma rilevante nel giudizio a quo, e non già le disposizioni sulla
responsabilità civile dei magistrati. Nella stessa sentenza delle sezioni unite
civili della Corte di cassazione citata dal rimettente si afferma
specificamente, del resto, che il vincolo che deriva, sia per il giudice a quo
che per tutti i giudici comuni, dalle pronunce interpretative di rigetto è solo
negativo, consistendo nell’imperativo di non applicare la "norma” ritenuta non
conforme al parametro scrutinato dalla Corte costituzionale. Non è preclusa,
invece, la possibilità di seguire "terze interpretazioni” ritenute compatibili
con la Costituzione, oppure di sollevare nuovamente, in diversi gradi dello
stesso processo a quo o in diversi processi, la questione di legittimità
costituzionale della medesima disposizione sulla base dell’interpretazione
rifiutata dalla Corte costituzionale.
Non pertinente risulterebbe, altresì, il richiamo del
giudice a quo alla sentenza della Corte di cassazione n. 24798 del 2013,
concernente una fattispecie nella quale il giudice aveva negato l’esistenza del
fumus boni iuris,
concedendo, ciò nondimeno, la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Nel merito, la questione sarebbe, ad ogni modo,
infondata. La clausola di salvaguardia, in base alla quale «non può dar luogo a
responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di
valutazione del fatto e delle prove», sarebbe rimasta inalterata nell’impianto
della legge n. 117 del 1988 anche dopo le modifiche di cui alla legge n. 18 del
2015, «salva la sua erosione derivante anche dagli interventi della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea». In ogni caso, tale clausola cesserebbe di
operare nei casi di «manifesto ed ingiustificato esercizio non corretto
dell’attività di interpretazione delle norme», quale quello del giudice che si
discostasse immotivatamente dal diritto vivente e dall’unica opzione
ermeneutica suggerita dalla Corte costituzionale come legittima, senza sollevare
un nuovo incidente di costituzionalità.
5.– Con ordinanza del 10 maggio 2016 (r.o. n. 130 del 2016), il Tribunale ordinario di Genova ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della
legge n. 18 del 2015, che ha abrogato l’art. 5 della legge n. 117 del 1988, per
contrasto con gli artt. 3, 25, 101, 104 e 111 Cost.
5.1.– Il Tribunale premette di essere investito della
causa civile per risarcimento del danno promossa nei confronti del Presidente
del Consiglio dei ministri, con ricorso depositato il 2 aprile 2015, da una
persona che si assume danneggiata dall’operato di alcuni giudici del Tribunale
di Firenze e della Corte d’appello di Firenze. Il ricorrente si era lamentato
del fatto che il Tribunale fiorentino, con sentenza poi confermata dalla Corte
d’appello, avesse dichiarato il fallimento di una società in accomandita
semplice e del ricorrente stesso, quale socio illimitatamente responsabile,
senza che gli fosse stato dato valido avviso dell’udienza a seguito della quale
il fallimento era stato pronunciato. Il ricorso per cassazione dell’interessato
era stato accolto con sentenza del maggio 2013, che aveva annullato la sentenza
di fallimento rimettendo gli atti al giudice di primo grado. Nel 2011, peraltro
– e, dunque, prima ancora della pronuncia della Corte di cassazione – il
fallimento era stato chiuso per mancanza di attivo.
L’Avvocatura dello Stato, nel giudizio a quo, aveva
contestato la pretesa del ricorrente, eccependo l’inammissibilità della domanda
sotto un duplice profilo: da un lato, per tardività, in quanto, trattandosi di
fallimento chiuso nel 2011, il ricorso sarebbe stato depositato oltre il
termine previsto a pena di decadenza dalla legge n. 117 del 1988; dall’altro,
per mancato esperimento di tutti i mezzi di impugnazione, non avendo il
ricorrente riassunto il giudizio dopo l’annullamento con rinvio della decisione
della Corte d’appello. Nel merito, la difesa dello Stato aveva negato la
sussistenza dei vizi procedurali denunciati dal ricorrente.
Il giudice istruttore – sul presupposto che
l’abolizione del filtro di ammissibilità, disposta dall’art. 3, comma 2, della
legge n. 18 del 2015, dovesse ritenersi inoperante in rapporto alle domande
risarcitorie proposte dopo l’entrata in vigore della novella, ma per illeciti
anteriori ad essa (quale quella in esame) – aveva rimesso le parti davanti al
collegio per la deliberazione preliminare di ammissibilità ai sensi del
previgente art. 5 della legge n. 117 del 1988.
Il collegio rimettente ritiene, tuttavia, di dover
aderire alle opposte indicazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo
le quali la soppressione del filtro opera anche rispetto alle domande relative
agli illeciti pregressi: circostanza che gli imporrebbe di restituire la causa
al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie.
Di qui, dunque, la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale
della citata norma abrogatrice.
5.2.– Ciò premesso, il rimettente denuncia, in primo
luogo, la violazione dell’art. 111 Cost., assumendo che il filtro di
ammissibilità costituisca strumento imprescindibile per l’attuazione del
«giusto processo» sia nell’àmbito del giudizio risarcitorio promosso dal
danneggiato contro lo Stato, sia nell’àmbito del giudizio in cui si è verificato
il fatto che si assume dannoso.
Sul primo versante, il filtro risulterebbe essenziale
al fine di assicurare la ragionevole durata del giudizio risarcitorio. In virtù
di esso, il collegio era chiamato a valutare in limine litis
l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza della domanda, nel comune
interesse del soggetto che si pretendeva danneggiato e dello Stato, dichiarando
immediatamente l’eventuale inammissibilità con decreto, la cui procedura di
impugnazione era «snella e compressa» e, soprattutto, «alleggerita della
valutazione del merito». A seguito dell’abolizione del filtro, i tempi per
pervenire ad una pronuncia sull’ammissibilità sono invece quelli del processo
ordinario, di «lunghezza eccessiva ed irragionevole», senza considerare, poi, i
maggiori tempi dell’impugnazione, «appesantita dalla commistione tra profili di
ammissibilità e profili di merito».
Tali effetti negativi della riforma sarebbero bene
apprezzabili nel caso sottoposto all’esame del rimettente, nel quale potrebbero
rivelarsi fondate alcune delle eccezioni di inammissibilità formulate dalla
difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, con la conseguenza che la
pronuncia immediata su di esse consentirebbe uno svolgimento della causa
«adeguato ai principi di effettività e celerità della tutela».
L’intervento considerato si porrebbe, d’altra parte,
in frizione con la recente introduzione, da parte del legislatore, di «pronunce
semplificate di inammissibilità» in rapporto alle impugnazioni ordinarie, quali
quelle previste dagli artt. 360-bis e 375, primo comma, numeri 1) e 5), cod.
proc. civ., riguardo al ricorso per cassazione, e dagli artt. 348-bis e 348-ter
cod. proc. civ., in relazione all’appello. Per questo verso, la soppressione
del filtro di ammissibilità disposta dalla legge n. 18 del 2015 si porrebbe in
contrasto anche con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza (art. 3
Cost.), posto che il giudizio sulla responsabilità civile del giudice
assumerebbe assai spesso il carattere di un "processo sul processo”, presentando,
perciò, evidenti «comunanze logiche» con le impugnazioni.
L’abolizione del filtro pregiudicherebbe, peraltro,
l’attuazione del giusto processo anche nel giudizio nel quale si assume essersi
verificato il fatto dannoso. Le peculiarità dell’attività giurisdizionale – in
particolare, la circostanza che ogni processo comporti un pregiudizio per
almeno una delle parti – e la difficoltà che la parte soccombente incontrerebbe
nel comprendere quando vi sia stato realmente un cattivo esercizio della giurisdizione
incentiverebbero, infatti, la proposizione di azioni di responsabilità anche
inammissibili o palesemente infondate. Un meccanismo di filtro che blocchi sul
nascere iniziative di tal fatta assumerebbe, quindi, una essenziale funzione di
tutela della serenità di giudizio del magistrato.
Per converso, l’assenza del filtro genererebbe il
rischio della cosiddetta «giurisprudenza "difensiva”», ossia che il giudice si
curi – già nel processo "a monte” – del proprio interesse e della propria difesa,
abdicando alla propria posizione di terzietà ed imparzialità. Tale
atteggiamento potrebbe manifestarsi in varie forme, dal semplice ricorso a
motivazioni ridondanti e poco aderenti al caso concreto, sino al vero e proprio
"snaturamento” del contenuto delle decisioni, secondo quale fra le parti possa
più facilmente proporre un’azione di responsabilità: e ciò specie in presenza
di parti «agguerrite o già larvatamente minacciose».
L’abolizione del meccanismo in questione – impedendo
l’immediata declaratoria di inammissibilità della domanda per mancato
esaurimento dei mezzi di impugnazione – favorirebbe, altresì, la contemporanea
pendenza del giudizio di responsabilità intentato nei confronti dello Stato e
di quello che vi ha dato origine, con conseguente lesione anche del principio
del contraddittorio. Sarebbe, infatti, ben difficile che la controparte di un
soggetto che ha proposto azione di responsabilità civile «possa essere certa di
non avere un trattamento diverso da parte di un giudice "coinvolto”».
Risulterebbero violati anche i principi di soggezione
del giudice solo alla legge (art. 101 Cost.) e di autonomia e indipendenza
della magistratura (art. 104 Cost.). La giurisprudenza costituzionale, infatti,
avrebbe posto in evidenza a più riprese come la presenza di un filtro, che
ponga il giudice al riparo da domande temerarie o intimidatorie, debba
ritenersi indispensabile per la salvaguardia di detti valori (sono citate le sentenze n. 468 del
1990, n. 18
del 2015 e n.
2 del 1968).
Da ultimo, il giudice a quo ravvisa la violazione del
principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.).
Secondo il rimettente, sarebbe condivisibile
l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale la
proposizione di un’azione di responsabilità, ai sensi della legge n. 117 del 1988,
quando è ancora pendente il primo giudizio non comporta automaticamente un
obbligo di astensione per il giudice di quest’ultimo, né consente alle parti di
ricusarlo. In mancanza del filtro, tuttavia, il magistrato sarebbe incentivato
ad esercitare la facoltà di intervento nel giudizio risarcitorio, non essendo
più nettamente distinto l’esame dei profili di ammissibilità della domanda da
quello del merito: opzione che, rendendolo parte di quel giudizio, farebbe
scattare l’obbligo di astensione nel processo originario ai sensi dell’art. 51,
primo comma, numero 3), cod. proc. civ. Anche laddove non sussista tale
obbligo, il giudice potrebbe ravvisare, comunque sia, gravi ragioni di
convenienza per un’astensione facoltativa, «che difficilmente gli verrebbe negata».
La proposizione dell’azione di responsabilità
potrebbe, pertanto, costituire uno strumento per distogliere la causa dal suo
giudice naturale, specie nei casi in cui il magistrato assegnatario della
stessa abbia assunto decisioni interinali che facciano presagire la soccombenza
di una delle parti.
5.3.– Intervenuto a ministero dell’Avvocatura
generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito
l’inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza.
Il collegio rimettente non avrebbe, infatti,
considerato che, essendo stato investito della decisione dal giudice istruttore
a norma dell’art. 189 cod. proc. civ., avrebbe potuto, comunque sia, definire
nel merito la controversia, a prescindere dal previo esame della domanda in
sede di filtro. Nella stessa ordinanza di rimessione si rileva, d’altro canto,
che alcune delle eccezioni di inammissibilità prospettate dalla parte convenuta
potrebbero rivelarsi fondate. Di conseguenza, il collegio avrebbe dovuto darsi
carico di verificare se la causa potesse essere decisa, esaminando le questioni
preliminari pur di fronte all’erronea rimessione della causa da parte del
giudice istruttore sulla base della disciplina previgente.
Nel merito, le questioni sarebbero, ad ogni modo,
infondate.
Quanto al dedotto contrasto con l’art. 111 Cost., la
difesa dell’interveniente rileva che, pur essendo ovvio che un rito accelerato
è più breve di un rito ordinario, nondimeno anche l’ordinario giudizio di
cognizione si presta ad essere definito in tempi brevi in base alle scansioni
processuali delineate dalla normativa vigente, sulle quali possono incidere
negativamente solo mere circostanze di fatto, irrilevanti ai fini del giudizio
di costituzionalità, quali l’organizzazione degli uffici giudiziari o la
limitatezza delle risorse disponibili.
Né l’eliminazione del filtro potrebbe ritenersi
contraddittoria rispetto all’avvenuta introduzione di meccanismi di valutazione
preliminare dell’ammissibilità e della non manifesta infondatezza con riguardo
al giudizio di appello e al giudizio di cassazione. Tali ultimi meccanismi
attengono, infatti, alle impugnazioni, mentre il filtro previsto dall’art. 5
della legge n. 117 del 1988 condizionava l’accesso al giudizio di primo grado.
Seguendo il ragionamento del rimettente, poi, si
dovrebbe ritenere che l’applicazione del rito ordinario a qualsiasi tipo di
controversia determini una violazione del principio di ragionevole durata del
processo.
Privo di pregio sarebbe, altresì, l’assunto del
giudice a quo, secondo il quale l’eliminazione del filtro di ammissibilità
creerebbe il pericolo di un atteggiamento "difensivo” del magistrato, il quale
sarebbe indotto ad adottare la soluzione per lui meno "rischiosa” a detrimento
della giustizia sostanziale. L’alta professionalità che caratterizza la
funzione giurisdizionale dovrebbe essere, infatti, idonea a scongiurare un
simile pericolo; d’altra parte, la decisione meno "rischiosa” per il giudice è
quella presa secondo legge e sulla base del prudente apprezzamento dei fatti e
delle prove, non quella che pregiudichi la parte più «agguerrita» o
«larvatamente minacciosa».
Il rimettente non valorizzerebbe, poi, adeguatamente
la duplice circostanza che l’azione risarcitoria ha come unico legittimato
passivo lo Stato e che la proposizione di cause pretestuose o preordinate ad
incidere sulla serenità del giudicante è già scoraggiata dalla responsabilità
aggravata del soccombente temerario prevista dall’art. 96 cod. proc. civ.
Quanto alla censura di violazione dei principi di
autonomia e indipendenza della magistratura, l’Avvocatura generale dello Stato,
dopo aver ribadito alcune delle considerazioni svolte su questioni consimili
nei precedenti atti di intervento, pone in risalto come il principio che si
ricava dalla giurisprudenza costituzionale evocata dal giudice a quo sia solo
quello della necessità di prevedere adeguate garanzie e limiti nella disciplina
della responsabilità civile dei magistrati, correlate alla peculiarità delle
funzioni giudiziarie e alla natura dei relativi provvedimenti, non anche quello
dell’imprescindibilità di una fase di valutazione preliminare
dell’ammissibilità della domanda risarcitoria indiretta (contro lo Stato).
Dette garanzie e limiti non mancherebbero
nell’attuale assetto normativo, caratterizzato dalla previsione della sola
legittimazione passiva dello Stato nell’azione risarcitoria, con esclusione
dell’azione diretta verso il magistrato; dalla previsione di un termine di
decadenza (ora triennale) per la proposizione dell’azione, inferiore a quello
quinquennale valevole per tutti gli altri dipendenti pubblici, e di uno ancora
più breve (biennale) per l’azione di rivalsa; dall’onere, per il danneggiato,
di esperire preventivamente tutti i rimedi impugnatori avverso il provvedimento
che si assume dannoso; dalla previsione di rigidi presupposti sostanziali che
delimitano l’àmbito della colpa grave e di un tetto massimo (pari alla metà
dello stipendio annuo) alla eventuale condanna del magistrato in sede di
rivalsa.
La questione riferita all’art. 25 Cost. sarebbe,
infine, inammissibile per difetto di rilevanza, essendo argomentata con il
riferimento all’astratta possibilità che il magistrato sia indotto a spiegare
intervento volontario nella causa risarcitoria con maggiore frequenza che non
in passato: evenienza che non risulta, tuttavia, essersi concretamente
verificata nel giudizio a quo. Lo stesso rimettente, d’altra parte, condivide
la tesi secondo cui la proposizione dell’azione di responsabilità non comporta
alcun obbligo di astensione del magistrato e, correlativamente, non ne consente
la ricusazione.
La questione risulterebbe, comunque sia, infondata
nel merito, posto che, in nessun caso, l’esercizio dell’azione risarcitoria
potrebbe costituire strumento per sottrarre la causa al giudice naturale.
Seguendo il ragionamento del rimettente, d’altronde, anche nella vigenza del
filtro una situazione come quella ipotizzata (intervento del magistrato e
richiesta di astensione) si sarebbe potuta parimente verificare.
Considerato in diritto
1.– Questa Corte è chiamata a pronunciarsi su un
articolato complesso di questioni di legittimità costituzionale, dianzi
analiticamente descritte, tutte attinenti alla disciplina della responsabilità
civile dei magistrati, quale risultante a seguito delle modifiche apportate
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei
magistrati) alle previgenti disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117
(Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e
responsabilità civile dei magistrati).
2.– In ragione della rilevata comunanza di oggetto e
dei profili problematici coinvolti, le questioni vanno riunite per essere
decise con unica sentenza.
3.– Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione
con cui l’Avvocatura generale dello Stato ha contestato l’ammissibilità, per
difetto di rilevanza, di tutte le questioni sollevate con le ordinanze dei
Tribunali ordinari di Verona (r.o. n. 198 del 2015),
di Treviso (r.o. n. 218 del 2015), di Catania (r.o. n. 113 del 2016) e di Enna (r.o.
n. 126 del 2016).
Nei vari atti di intervento, la difesa del Presidente
del Consiglio dei ministri, con argomentazioni similari, ove non anche
identiche, pone in evidenza che i giudici rimettenti non sono chiamati a fare
diretta applicazione delle disposizioni della cui costituzionalità dubitano,
sicché la rilevanza di esse, nei rispettivi giudizi a quibus,
è affermata «solo in linea teorica ed eventuale». Le disposizioni impugnate –
secondo l’Avvocatura − potrebbero venire in rilievo esclusivamente
nell’ipotesi «in cui il giudicante adottasse un provvedimento errato con dolo o
colpa grave» e, dunque, nel caso di una «patologia conclamata del futuro
provvedimento». Ma, in tale ipotesi, esso sarebbe rimediabile dallo stesso
giudice che lo ha emesso ovvero dal giudice cui sarebbe devoluta
l’impugnazione, considerata la natura dell’azione di responsabilità, la quale
presuppone che il rimedio previsto sia stato esperito. In conseguenza,
risulterebbe del tutto insussistente la dedotta incidenza sulla serenità del
giudicante, come invece ipotizzato dai giudici a quibus.
In ogni caso – risultando imprescindibile presupposto
dell’azione risarcitoria l’irrevocabilità del provvedimento, ai sensi dell’art.
4 della legge n. 117 del 1988 − i dedotti profili di disarmonia
costituzionale potrebbero venire in rilievo solo dopo l’eventuale esaurimento
dei gradi dei rispettivi giudizi incidentali, con la «definitività del
provvedimento giudiziario», che, invece, neppure risulta adottato nei giudizi
in questione. La rilevanza delle questioni affermata dai giudici rimettenti
risulterebbe, pertanto, pressoché virtuale, in quanto ancorata solo al mero
«pericolo di una valutazione errata delle risultanze di causa»: non
sussisterebbe, infatti, alcuna correlazione «tra la regola da applicare e la
soluzione della questione controversa», fino al punto che, in alcune delle
ordinanze di rimessione, la «pericolosità decisionale» sarebbe, addirittura,
semplicemente postulata, trattandosi piuttosto di semplici problemi decisori, risolvibili
in base ad elementari ed ordinarie regole di diritto e sulla base del prudente
apprezzamento del giudice.
L’Avvocatura dello Stato ha ulteriormente osservato
che, nelle questioni di costituzionalità prospettate, la sussistenza della
rilevanza sarebbe stata dedotta dall’asserito perturbamento del giudice
conseguente ad un’ipotetica azione di rivalsa intentabile, nei suoi confronti,
dallo Stato: azione a sua volta meramente eventuale ed effetto di altra azione
di risarcimento danni esperita nei confronti di quest’ultimo, per la
responsabilità derivante dal provvedimento giudiziario, frutto dell’«errore
commesso dal magistrato». Per effetto di tale catena ipotetica, la rilevanza
delle questioni di costituzionalità sollevate risulterebbe, tuttavia, giustificata
solo dalla stessa «pericolosità […] della funzione giurisdizionale», ritenuta,
sempre e comunque sia, incidente sulla serenità di giudizio e, quindi, sullo
status del magistrato.
Il presupposto della rilevanza, in conclusione,
riposerebbe solo su postulati ed «ipotetici condizionamenti psicologici»: con
la paradossale conseguenza che qualsivoglia modifica della legge n. 117 del
1988 risulterebbe rilevante in tutte le controversie di ogni tipo (civili,
penali e amministrative), «con effetti distorsivi sul funzionamento dell’intero
sistema giudiziario, in contrasto, peraltro, con i principi costituzionali e
del diritto dell’U.E. sull’effettività della tutela giurisdizionale».
3.1.– L’eccezione d’inammissibilità è fondata, per i motivi
che seguono.
3.2.– Nelle quattro ordinanze di rimessione, i
giudici a quibus – di là dalla complessità o
difficoltà decisoria specifica dei singoli giudizi in corso, di cui non è
necessario dar conto in questa sede − affermano che le sollevate questioni
di costituzionalità, pur concernenti alcune delle norme introdotte dalla legge
n. 18 del 2015, risultano direttamente rilevanti nei rispettivi giudizi
incidentali in quanto tale disciplina normativa sarebbe «concretamente ed
immediatamente produttiva di una responsabilità potenziale» di essi giudicanti,
«potendo dar luogo ad un giudizio di responsabilità» (così, testualmente,
l’ordinanza del Tribunale ordinario di Verona, iscritta al r.o.
n. 198 del 2015); ovvero in quanto essa va «ad incidere, in generale, sulla
libertà del giudice di valutare i fatti e le prove secondo la legge e, quindi,
anche sulla valutazione che il Giudice è chiamato ad operare nel presente
processo» (in tal senso si esprime l’ordinanza del Tribunale ordinario di
Treviso, iscritta al r.o. n. 218 del 2015); ovvero,
ancora, che non è da escludersi che ogni decisione adottabile «possa essere
contestata per ritenuto travisamento del fatto e delle prove», integrando
dunque un’ipotesi di colpa grave ai sensi della normativa, come oggi modificata,
sulla responsabilità civile dei magistrati (in tal senso opina, ad esempio,
l’ordinanza del Tribunale ordinario di Catania, iscritta al r.o.
n. 113 del 2016).
Tali affermazioni – che pure delineano la semplice e
sola "potenzialità” dell’evenienza di una responsabilità civile dello Stato (e
della successiva, eventuale, azione di rivalsa nei confronti del magistrato)
connessa ai provvedimenti adottati nel giudizio a quo – assurgono a discorso
giustificativo della rilevanza delle plurime questioni di legittimità
costituzionale a mezzo del richiamo, comune a tutte le predette ordinanze di
rimessione e su cui esse lungamente insistono, alle statuizioni della sentenza n. 18 del
1989.
Rammentano invero i rimettenti che, in tale
pronuncia, questa Corte – chiamata a scrutinare alcune questioni di legittimità
costituzionale sollevate in relazione alla disciplina della responsabilità
civile dei magistrati di cui alla legge n. 117 del 1988 ed a fronte della
eccezione di inammissibilità delle stesse per difetto di rilevanza, anche
allora avanzata dall’Avvocatura generale dello Stato − ebbe a statuire
l’infondatezza di detta eccezione.
Si osservò, in proposito, che, effettivamente, l’art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), stabilendo che la questione di
costituzionalità proposta debba essere tale che «il giudizio non possa essere
definito indipendentemente dalla risoluzione» di essa, «implica, di regola, che
la rilevanza sia strettamente correlata all’applicabilità della norma impugnata
nel giudizio a quo». Tuttavia, si affermò che «debbono ritenersi influenti sul
giudizio anche le norme che, pur non essendo direttamente applicabili al
giudizio a quo, attengono allo status del giudice, alla sua composizione
nonché, in generale, alle garanzie ed ai doveri che riguardano il suo operare»,
e che pertanto la «eventuale incostituzionalità di tali norme è destinata a
influire su ciascun processo pendente davanti al giudice del quale regolano lo
status, la composizione, le garanzie e i doveri: in sintesi, la "protezione”
dell’esercizio della funzione, nella quale i doveri si accompagnano ai
diritti».
Tali affermazioni, secondo i giudici a quibus, risulterebbero ulteriormente corroborate, ai fini
della rilevanza delle odierne questioni di legittimità costituzionale, dalla
circostanza che la nuova disciplina sulla responsabilità civile, risultante
dalle modifiche introdotte dalla legge n. 18 del 2015, ha ampliato le ipotesi
che possono dar luogo a responsabilità dello Stato e del magistrato,
introducendo, tra l’altro, quelle del «travisamento del fatto o delle prove».
Pertanto, quantomeno le relative disposizioni modificate in tal senso (vale a
dire gli artt. 2, comma 3, e 7, comma 1, della legge n. 117 del 1988)
inciderebbero immediatamente su tutti i giudizi in corso.
I soli Tribunali ordinari di Verona ed Enna, inoltre,
affermano che le statuizioni della sentenza n. 18 del 1989 sarebbero state
implicitamente richiamate, da questa Corte, nella sentenza n. 237 del
2013.
3.3.– Movendo dall’esame di tale ultimo argomento, si
deve rilevare che il convincimento dei due rimettenti è erroneo.
Nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 237 del
2013, infatti, questa Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità
costituzionale di norme che avevano disposto la soppressione di diversi uffici
giudiziari: oggetto del giudizio di costituzionalità era, dunque, la potestà di
ius dicere dei giudici
rimettenti, direttamente e immediatamente dipendente dalle norme censurate.
Nessun dubbio poteva sussistere, pertanto, sulla rilevanza – secondo
l’ordinaria regola posta dall’art. 23 della legge n. 87 del 1953 – delle
sollevate questioni di legittimità costituzionale, «ben potendo, in limine litis, ogni giudice investire questa Corte della verifica
di conformità a Costituzione delle disposizioni legislative che affermino,
ovvero escludano, la sua legittimazione a trattare un determinato procedimento»
(ordinanza n.
258 del 2016), rientrando detta facoltà nel suo «potere-dovere di
verificare la regolare costituzione dell’organo giudicante, anche in rapporto
alla legittimità costituzionale delle norme che la disciplinano» (sentenza n. 71 del
1975).
3.4.– Quanto, poi, al richiamo operato da tutti i
giudici rimettenti alla sentenza n. 18 del 1989, in funzione di giustificazione
della rilevanza delle odierne questioni di legittimità costituzionale, esso non
risulta pertinente.
È qui doveroso sottolineare il ben diverso àmbito
dell’incidente di costituzionalità nel quale vennero a collocarsi le richiamate
affermazioni di questa Corte. In quella circostanza, infatti, il nucleo
principale delle varie questioni sollevate dai diversi giudici (ordinari,
amministrativi e tributari), che dubitavano della legittimità costituzionale
della prima legge sulla responsabilità civile dei magistrati, fece leva – per
dedurre la rilevanza delle questioni stesse – sul fatto che nei diversi giudizi
veniva in discorso l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 16 della
legge n. 117 del 1988 (poi dichiarata parzialmente incostituzionale con la sentenza n. 18 del
1989), la quale introduceva – nel processo civile (art. 131 del codice di
procedura civile) ed in quello penale (art. 148 del codice di procedura penale)
– il verbale relativo alla opinione dissenziente per i provvedimenti
collegiali, per i conseguenti riverberi che la stessa disciplina presentava
proprio sul piano della responsabilità civile.
Veniva in rilievo inoltre – e in relazione a ciò
questa Corte affermò quanto oggi è richiamato − la stessa struttura e
composizione dell’organo giudicante, assumendosi, da una delle ordinanze di
rimessione, che il "concorso decisorio”, all’interno dell’organo collegiale
civile, non potesse essere egualmente distribuito tra il relatore e gli altri
componenti del collegio, poiché era da escludere che questi ultimi fossero
«tenuti ad esaminare gli atti di causa, a ciò ostando l’immensa mole di lavoro
gravante sui tribunali» e che, conseguentemente, a tale diversa collocazione
"funzionale” interna avrebbe dovuto corrispondere anche una diversa graduazione
di responsabilità. Prospettiva che indusse questa Corte a ribadire, al
contrario, e proprio in ordine alla struttura e funzione dell’organo, che «la
decisione emessa dall’organo giudiziario collegiale è un atto unitario, alla
formazione del quale concorrono i singoli membri del collegio in base allo
stesso titolo ed agli stessi doveri» (sentenza n. 18 del
1989).
Altra ordinanza di rimessione, poi, era stata
adottata dalla sezione specializzata per le tossicodipendenze, a componente
mista, in relazione alla quale si prospettava questione di legittimità
costituzionale in ordine alla responsabilità dei laici componenti il collegio.
Infine, per le questioni sollevate da una commissione
tributaria, si osservava, nella ordinanza di rimessione, che esse attenevano
«alla costituzione del giudice», con la conseguenza che la rilevanza sussisteva
in quanto, «ove le norme impugnate fossero illegittime, la decisione della
Commissione tributaria sarebbe nulla», anche in questo caso evocando (come pure
nella questione sollevata da un pretore onorario) il tema della partecipazione
dei laici alla giustizia.
Nello scrutinio allora operato da questa Corte in
punto di ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, pertanto,
ben si spiega la motivazione adottata (poi meramente richiamata soltanto
dall’immediatamente successiva sentenza n. 243 del
1989). Essa, appunto, si fondava – coerentemente con il rilievo delle norme
processuali allora coinvolte nei diversi giudizi a quibus
– sui profili che concernevano lo «status di giudice», la «sua composizione,
nonché, in generale, [le] garanzie e [i] doveri che riguardano il suo operare»:
aspetti, questi, ontologicamente rilevanti nell’àmbito dei relativi
procedimenti – ordinari, speciali, amministrativi o tributari – dai quali le
questioni provenivano. Come dire che le quaestiones
sulla responsabilità civile dei magistrati erano allora rilevanti in quanto
direttamente collegate con profili attinenti alla struttura dell’organo e ad
ipotizzate "distinzioni” funzionali interne ad esso: dunque, alla sua stessa
composizione.
3.5.– Si trattava di un quadro profondamente diverso
da quello che viene oggi in attenzione e che, in sé, vale a tracciare un netto
distinguo tra dette statuizioni – pertinenti a quello specifico quadro di
riferimento – e le altre che questa Corte è chiamata ad adottare circa la
rilevanza delle questioni ora in esame.
Nell’àmbito delle odierne questioni, infatti, ciò che
questa Corte è tenuta a verificare è la necessaria relazione di "dipendenza
funzionale” tra giudizio a quo e tema agitato attraverso la questione di
legittimità costituzionale: relazione che, secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte, deve assumere i connotati della pregiudizialità, la quale
comporta l’impossibilità di definire il procedimento pregiudicato in assenza
della delibazione della quaestio pregiudicante.
Ebbene, alla luce di tali preliminari rilievi e
tenuto conto di quanto gli stessi giudici rimettenti hanno posto in luce al
fine di asseverare la sussistenza della rilevanza, se ne deve desumere che le
questioni sono state dai rimettenti delibate a prescindere da qualsiasi
considerazione circa una loro diretta incidenza sullo statuto di autonomia e di
indipendenza dei magistrati, tale da condizionare strutturalmente e
funzionalmente lo ius dicere,
ma facendo esclusivo riferimento alle sue modalità di esercizio. Né rileva che
tali modalità possano costituire elementi variamente perturbatori della
condizione psicologica di questo o quel magistrato, secondo i principi, del
resto, costantemente ribaditi – sia prima sia dopo la sentenza n. 18 del
1989 – dalla giurisprudenza di questa Corte.
Si è escluso, infatti, che potesse strutturare il
nesso di pregiudizialità, richiesto ai fini di rendere rilevante la questione,
il mero richiamo del giudice a quo al turbamento psicologico e della propria
serenità di giudizio prodotto dall’applicazione dei «ferri di sicurezza» nelle
operazioni di traduzione degli imputati detenuti, «non potendosi ovviamente
qualificare per tale una soggettiva situazione psicologica come quella allegata
dal giudicante che, oltre tutto, deriva da norme assolutamente estranee
all’oggetto del processo principale» (sentenza n. 147 del
1974).
Allo stesso modo, si è pure escluso che potessero
considerarsi rilevanti, in un qualsiasi giudizio di competenza della Corte dei
conti, questioni volte a denunciare l’asserita menomazione della serenità e
autonomia di giudizio dei magistrati di detta Corte derivante dal carattere, in
assunto, «troppo latamente discrezionale» dei poteri riconosciuti al Presidente
della Corte stessa in materia di assegnazione di funzioni e promozioni: le
doglianze attenevano, infatti, a disposizioni che non dovevano essere applicate
dal giudice rimettente, riflettendo «violazioni solo potenziali ma non attuali
delle garanzie costituzionali» (sentenza n. 19 del
1978).
Nessun seguito hanno avuto, altresì, più di recente,
le questioni intese a censurare, nell’àmbito di ordinari giudizi, la previsione
di compensi dei giudici di pace e dei componenti delle commissioni tributarie
collegati ad ogni singolo processo definito: sistema che si asseriva idoneo a
condizionare psicologicamente l’operato di detti giudici, e dunque a
comprometterne la terzietà ed imparzialità, inducendoli ad optare non per le
soluzioni ritenute più corrette, ma per quelle che permettevano di decidere un
maggior numero di cause in minor tempo, e consentendo, inoltre, alla parte
attrice o ricorrente di avvantaggiarli economicamente con la proposizione di
domande o ricorsi separati, anziché di domande o ricorsi cumulativi. Anche
simili questioni sono state ritenute, infatti, prive di rilevanza, in quanto
attinenti a norme che non venivano affatto in rilievo ai fini della decisione
delle controversie di cui i giudici rimettenti erano investiti (ex plurimis, ordinanze n. 421
del 2008, n.
180 del 2006 e n. 326 del 1987).
3.6.– Più in generale, va riconosciuto, tuttavia, che
un sistema che non garantisse un adeguato presidio istituzionale in capo alla
posizione del giudice si presenterebbe, a sua volta, fortemente asintonico rispetto a quel rigoroso presupposto di legalità
a cui il giudice è costituzionalmente tenuto.
Il ruolo del giudice, nell’architettura
costituzionale della giurisdizione, appare infatti peculiare, non potendosi
escludere a priori che norme, pur non immediatamente applicabili nel processo,
vadano ad incidere in maniera evidente ed attuale sulle garanzie costituzionali
della funzione giurisdizionale, così condizionando l’esercizio della relativa
attività. Ciò tuttavia presuppone che tale incidenza – per qualità, intensità,
univocità ed evidenza della sua direzione, immediatezza ed estensione dei suoi
effetti – sia tale da determinare una effettiva interferenza sulle condizioni di
indipendenza e terzietà nel decidere, a prescindere da qualsiasi profilo che
possa riguardare un eventuale "perturbamento psicologico” del singolo giudice.
Di là da questa prospettiva, ai fini della rilevanza
occorrerà ulteriormente verificare se la norma asseritamente interferente sullo
status di magistrato ne comprometta o possa comprometterne l’indipendenza e la
terzietà in relazione alla concreta regiudicanda
posta al suo esame ed alla specifica e conseguente decisione che è chiamato ad
adottare nel giudizio a quo. Presupposti − questi – che non è dato
rinvenire nelle odierne questioni, alla luce della stessa motivazione sulla
rilevanza fornita dai giudici a quibus in relazione
all’attuale sistema normativo sulla responsabilità civile del giudice.
3.7.– In conclusione sul punto, devono pertanto
essere dichiarate inammissibili, perché irrilevanti, tutte le questioni
sollevate con le ordinanze dei Tribunali ordinari di Verona (r.o. n. 198 del 2015), di Treviso (r.o.
n. 218 del 2015), di Catania (r.o. n. 113 del 2016) e
di Enna (r.o. n. 126 del 2016).
4.– I profili di inammissibilità dianzi evidenziati
non coinvolgono, invece, l’ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di
Genova (r.o. n. 130 del 2016), unica, fra quelle in
esame, emessa nell’àmbito di un giudizio risarcitorio promosso nei confronti
dello Stato ai sensi della legge n. 117 del 1988.
4.1.– Con riguardo alle questioni sollevate da detta
ordinanza, l’Avvocatura generale dello Stato ha formulato una diversa eccezione
di inammissibilità.
In base al previgente art. 5 della legge n. 117 del
1988 – abrogato dall’impugnato art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015 – il
giudice istruttore della causa volta ad ottenere il ristoro dei danni
conseguenti all’esercizio delle funzioni giudiziarie doveva rimettere le parti
davanti al collegio alla prima udienza, ai fini della preliminare verifica
della sussistenza dei presupposti dell’azione, della sua tempestività in
rapporto al previsto termine biennale di proposizione e della sua non manifesta
infondatezza (cosiddetto "filtro di ammissibilità”).
Nel caso di specie, il giudice istruttore ha
provveduto nel modo ora indicato, sul presupposto che, in assenza di una
disciplina transitoria, il meccanismo di "filtro” dovesse ritenersi ancora applicabile
in rapporto alle domande risarcitorie proposte dopo l’entrata in vigore della
legge di riforma, ma per illeciti anteriori ad essa, quale quella di cui si
discute nel giudizio principale.
Il collegio rimettente reputa, tuttavia, di dover
aderire alle opposte indicazioni della giurisprudenza di legittimità (e, in
particolare, della sentenza della Corte di cassazione, sezione terza civile, 15
dicembre 2015, n. 25216), secondo le quali l’abolizione del "filtro” – in
ragione della sua valenza processuale e non sostanziale – opera per tutti i
giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore della legge n. 18 del 2015
(ancorché relativi ad illeciti pregressi): circostanza che imporrebbe al
collegio stesso di restituire gli atti al giudice istruttore per la prosecuzione
del giudizio nelle forme ordinarie. Di qui la ritenuta rilevanza delle
questioni sollevate, intese a censurare proprio e soltanto l’avvenuta
soppressione del "filtro”.
Obietta il Presidente del Consiglio dei ministri che
il collegio rimettente, essendo stato investito della decisione dal giudice
istruttore ai sensi dell’art. 189 cod. proc. civ., avrebbe potuto definire in
ogni caso la controversia, a prescindere dal previo esame della domanda in sede
di filtro. Nella stessa ordinanza di rimessione si dà atto, d’altro canto, di
come alcune fra le plurime eccezioni di inammissibilità della domanda
risarcitoria, formulate dalla parte convenuta nel giudizio a quo, potrebbero
rivelarsi fondate. A parere dell’Avvocatura generale dello Stato, pertanto, il
collegio avrebbe dovuto verificare preventivamente se la causa potesse essere
decisa, esaminando le questioni preliminari pur di fronte all’erronea
rimessione della causa da parte del giudice istruttore sulla base della
disciplina previgente.
4.2.– L’eccezione della difesa dell’interveniente non
è fondata.
Ove pure fosse immediatamente riscontrabile una
ragione di inammissibilità della domanda, le questioni inciderebbero, comunque
sia, sulle modalità procedurali della relativa verifica, che l’abrogato art. 5
regolava con disciplina ad hoc, allo stato non più applicabile e che il
rimettente mira per l’appunto a ripristinare, tramite la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma meramente abrogatrice.
In base alla disposizione abrogata, infatti, il
tribunale doveva deliberare entro 40 giorni in camera di consiglio, anziché
nelle forme ordinarie del giudizio di cognizione (che prevedono la possibile
discussione in udienza pubblica, ai sensi dell’art. 275 cod. proc. civ.),
dichiarando l’inammissibilità della domanda con decreto motivato (e non già con
sentenza), impugnabile non nei modi ordinari, ma in quelli previsti dall’art.
739 cod. proc. civ. per i provvedimenti in camera di consiglio.
Se la domanda era ritenuta ammissibile, d’altro canto,
il tribunale doveva disporre la prosecuzione del processo e la trasmissione
degli atti ai titolari dell’azione disciplinare (previsione anche questa venuta
meno).
La rilevanza delle questioni è, pertanto, indubbia.
5.– Ancorché ammissibili, le questioni prospettate
dall’ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Genova (r.o. n. 130 del 2016) sono tuttavia infondate.
5.1.– Il giudice a quo prospetta plurimi dubbi di
legittimità costituzionale del solo art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015,
il quale, come già detto, abrogando l’art. 5 della legge n. 117 del 1988, ha
eliminato il "filtro di ammissibilità” della domanda risarcitoria proposta nei
confronti dello Stato.
Il Tribunale ordinario di Genova reputa,
preliminarmente, che la soppressione del meccanismo dianzi descritto non possa
trovare «pertinente» giustificazione nel richiamo alle pronunce «della Corte di
Strasburgo» o di quelle della Corte di giustizia dell’Unione europea, il cui
fondamento non riposerebbe sulla «responsabilità del singolo magistrato, ma
(su) quella dello Stato», con la conseguenza che tali decisioni «non imponevano
alcuna modifica della legge n. 117/1988 dal punto di vista processuale».
Ciò premesso, il rimettente ritiene che la
disposizione denunciata violerebbe, anzitutto, l’art. 111 Cost., per contrasto
con il principio di ragionevole durata del processo. Il meccanismo di "filtro”
risponderebbe, infatti, al comune interesse tanto del cittadino, che si ritenga
leso, quanto dello Stato, potenziale responsabile, a che l’eventuale
inammissibilità della domanda risarcitoria sia dichiarata al più presto e con
procedura snella. In assenza di tale meccanismo, i tempi per la pronuncia sono
invece quelli del processo ordinario, di «lunghezza eccessiva ed
irragionevole».
La norma censurata violerebbe, inoltre, l’art. 3
Cost., sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della
irragionevolezza. L’abolizione del "filtro”, da essa disposta, contrasterebbe,
infatti, con il sempre più diffuso ricorso del legislatore a meccanismi di
questo tipo e, in particolare, con l’avvenuta introduzione di «pronunce
semplificate di inammissibilità» in rapporto alle impugnazioni ordinarie:
istituti, questi ultimi, comparabili all’azione prevista dalla legge n. 117 del
1988, atteggiandosi essa, spesso, come un «processo sul processo» (il
riferimento del rimettente è alle previsioni degli artt. 348-bis e 348-ter cod.
proc. civ., quanto all’appello, e degli artt. 360-bis e 375, primo comma,
numeri 1 e 5, cod. proc. civ., quanto al ricorso per cassazione).
L’intervento abrogativo censurato pregiudicherebbe,
inoltre, l’attuazione del giusto processo – così integrando un ulteriore vulnus
all’art. 111 Cost. − anche nel giudizio nel quale si assume essersi
verificato il fatto dannoso. Imbrigliando immediatamente le azioni di
responsabilità inammissibili o palesemente infondate, il meccanismo processuale
soppresso svolgerebbe, infatti, una essenziale funzione di tutela della
serenità di giudizio del giudice, scongiurando il pericolo della cosiddetta
«giurisprudenza "difensiva”», ossia che il giudice abdichi alla propria
posizione di terzietà e imparzialità in favore delle decisioni che appaiono per
lui meno "rischiose”.
Risulterebbero altresì violati i principi di
soggezione del giudice solo alla legge (art. 101 Cost.) e di autonomia e
indipendenza della magistratura (art. 104 Cost.), alla luce delle affermazioni
della giurisprudenza costituzionale secondo cui la presenza di un "filtro”, che
ponga il giudice al riparo da domande temerarie o intimidatorie, dovrebbe
ritenersi indispensabile per la salvaguardia dei corrispondenti valori (sono
citate le sentenze
n. 468 del 1990, n. 18 del 1989
e n. 2 del 1968).
La norma censurata si porrebbe, infine, in contrasto
con il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.).
In mancanza del meccanismo del "filtro”, infatti, il magistrato sarebbe
incentivato ad esercitare la facoltà di intervento nel giudizio risarcitorio
prevista dall’art. 6 della legge n. 117 del 1988, non essendo più nettamente
distinto l’esame dei profili di ammissibilità della domanda da quello del
merito: ciò che, rendendolo parte di quel giudizio, farebbe scattare l’obbligo
di astensione nel processo originario ai sensi dell’art. 51, primo comma,
numero 3), cod. proc. civ. In ogni caso, il giudice potrebbe ravvisare i
presupposti per un’astensione facoltativa. In conseguenza, la proposizione
dell’azione di responsabilità potrebbe costituire indiretto strumento per
distogliere la causa dal suo giudice naturale.
5.2.– Movendo dal preliminare riferimento del giudice
a quo alle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, va
rammentato come un forte stimolo alla riforma operata dalla legge n. 18 del
2015 sia venuto proprio dai principi affermati dalla Corte di Lussemburgo,
riguardo all’obbligo degli Stati membri di riparare i danni causati ai singoli
dalle violazioni del diritto comunitario (ora, dell’Unione europea) commesse da
organi giurisdizionali nazionali (anche di ultimo grado): principi con i quali
alcune delle limitazioni previste dalla legge n. 117 del 1988 sono state
ritenute incompatibili (Corte
di giustizia, grande sezione, sentenza 13 giugno 2006, in causa C-173/03,
Traghetti del Mediterraneo spa), tanto da dar luogo all’apertura di una
procedura di infrazione, decisa in senso sfavorevole per il nostro Paese (Corte
di giustizia, sentenza 24 novembre 2011, in causa C-379/10, Commissione europea
contro Repubblica italiana).
Nel contesto di tali principi, assumono qui rilievo,
in particolare, quelli relativi alla "giustiziabilità”
della pretesa risarcitoria del danneggiato.
La Corte di Giustizia, a partire dalla nota pronuncia
Köbler (sentenza
30 settembre 2003, in causa C-224/01, Gerhard Köbler),
ebbe infatti a statuire che «[…] è nell’ambito delle norme del diritto
nazionale relative alla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le
conseguenze del danno provocato, fermo restando che le condizioni stabilite
dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono
essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura
interna e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente
impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento».
In tale affermazione – ribadita dai costanti arresti
successivi (ex multis, Corte
di giustizia dell’Unione europea, grande sezione, sentenza 13 marzo 2007, in
causa C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation; Corte
di giustizia dell’Unione europea, sentenza 25 novembre 2010, in causa C-429/09,
Günter Fuß; Corte
di giustizia dell’Unione europea, sentenza 9 settembre 2015, in causa C-160/14,
João Filipe Ferreira da Silva e Brito
e altri) – risultano compendiati tanto il «principio di equivalenza» quanto
il «principio di effettività», i quali così assurgono a cardini necessari di
ogni diritto nazionale in tema di responsabilità dello Stato per le conseguenze
del danno provocato da provvedimenti giurisdizionali adottati in violazione del
diritto europeo.
Il «principio di equivalenza» − secondo
denominazione propria ed originale della Corte di giustizia – postula che le
condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento
dei danni nei confronti dello Stato, per la responsabilità civile in esito alla
violazione del diritto europeo per mezzo di provvedimento giurisdizionale, non
possono essere «meno favorevoli» di quelle riguardanti analoghi reclami di
natura interna, vale a dire delle altre "normali” azioni risarcitorie
esercitabili dai cittadini nei confronti dello Stato in altre e diverse
materie.
Il «principio di effettività» esige, poi, che i
meccanismi procedurali del diritto nazionale non siano congegnati in modo da
rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il
risarcimento.
5.3.– L’affermazione di tali principi − pur se
non immediatamente e specificamente pretensivi
dell’abolizione del cosiddetto "filtro di ammissibilità” contemplato dall’art.
5 della legge n. 117 del 1988 – ha rappresentato un considerevole mutamento del
quadro normativo di riferimento in tema di responsabilità civile dello Stato e
del giudice, finendo inevitabilmente per ispirare e permeare l’intervento
riformatore, sul punto, della legge n. 18 del 2015. Al riguardo, il legislatore
ha ritenuto che, per un verso, l’azione di responsabilità nei confronti dello
Stato per i danni conseguenti ad un provvedimento giudiziario non si collocasse
in una condizione di equivalenza rispetto alle azioni risarcitorie nei
confronti dello Stato in altre materie che non prevedono un simile "filtro” e,
per altro verso, che l’esperienza applicativa della legge n. 117 del 1988,
arrestando le azioni di danno contro lo Stato in larghissima misura nella fase
della delibazione preliminare, non avesse garantito l’effettività del risarcimento
per il cittadino danneggiato. È appena il caso di sottolineare, al proposito,
che l’intervento riformatore non era evidentemente limitabile alle sole
violazioni del diritto europeo, se non al prezzo di determinare una
irragionevole disparità di trattamento rispetto alle violazioni delle norme del
diritto nazionale che fossero all’origine, anch’esse, di danno per il
cittadino.
Come più volte affermato da questa Corte, nella
materia in esame occorre perseguire il delicato bilanciamento tra due interessi
contrapposti: da un lato, il diritto del soggetto ingiustamente danneggiato da
un provvedimento giudiziario ad ottenere il ristoro del pregiudizio patito,
posto che «una legge che negasse al cittadino danneggiato dal giudice qualunque
pretesa verso l’amministrazione statale sarebbe contraria a giustizia» (sentenza n. 2 del
1968); dall’altro, la salvaguardia delle funzioni giudiziarie da possibili
condizionamenti, a tutela dell’indipendenza e dell’imparzialità della
magistratura, «in quanto la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura
dei relativi provvedimenti suggeriscono condizioni e limiti alla responsabilità
dei magistrati, specie in considerazione dei disposti costituzionali
appositamente dettati per la Magistratura (artt. 101 e 113), a tutela della sua
indipendenza e dell’autonomia delle sue funzioni» (sentenza n. 26 del
1987).
Tale bilanciamento è stato operato anche dalla legge
di riforma n. 18 del 2015, fondamentalmente tramite una più netta divaricazione
tra la responsabilità civile dello Stato nei confronti del danneggiato −
che le istituzioni europee chiedevano con forza di espandere − e la
responsabilità civile del singolo magistrato. Il legislatore della riforma ha
cioè mirato a superare la piena coincidenza oggettiva e soggettiva degli àmbiti di responsabilità dello Stato e del magistrato e, in
tale prospettiva, ha ritenuto di ampliare il perimetro della prima a
prescindere dai confini, più ristretti, della seconda, così stemperando il
meccanico ed automatico effetto dell’accertamento della responsabilità dello
Stato sul magistrato nel giudizio di rivalsa.
In tale cornice di rinnovato bilanciamento normativo −
i cui termini sono rimessi alla discrezionalità del legislatore, nei limiti
della ragionevolezza − si colloca la scelta legislativa di abolizione del
cosiddetto "filtro di ammissibilità”, ritenuta funzionale al nuovo impianto
normativo, specie se riguardata alla luce dei già ricordati principi affermati
dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Non è costituzionalmente
necessario, infatti, che, per bilanciare i contrapposti interessi di cui si è
detto, sia prevista una delibazione preliminare dell’ammissibilità della
domanda contro lo Stato, quale strumento indefettibile di protezione
dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura. Tale esigenza può essere
infatti soddisfatta dal legislatore per altra via: ciò è quanto accaduto con la
legge n. 18 del 2015, per un verso mediante il mantenimento del divieto
dell’azione diretta contro il magistrato e con la netta separazione dei due àmbiti di responsabilità, dello Stato e del giudice; per un
altro, con la previsione di presupposti autonomi e più restrittivi per la
responsabilità del singolo magistrato, attivabile, in via di rivalsa, solo se e
dopo che lo Stato sia rimasto soccombente nel giudizio di danno; per un altro
ancora, tramite il mantenimento di un limite della misura della rivalsa. Tanto
vale a stornare il paventato pericolo che l’abolizione del meccanismo
processuale in esame determini un pregiudizio alla «serenità del giudice» come
pure la temuta deriva verso una «giurisprudenza difensiva», ipotesi, questa,
che evidentemente oblitera l’elevato magistero proprio di ogni funzione
giurisdizionale. Che tutto ciò valga ad escludere il rischio – secondo una
direttrice opposta a quanto riscontrato nel precedente assetto circa la
sostanziale "irresponsabilità” dei magistrati – di un eventuale abuso
dell’azione risarcitoria è questione, poi, che solo l’attuazione nel tempo
della nuova disciplina potrà chiarire.
5.4.– Né le conclusioni sopra assunte palesano
disarmonia o, tantomeno, contrasto con le pregresse affermazioni sul punto di
questa Corte, richiamate dal Tribunale rimettente.
Il giudice a quo evoca taluni contenuti argomentativi
delle sentenze
n. 2 del 1968 e, soprattutto, n. 18 del 1989
e n. 468 del
1990.
È agevole tuttavia rilevare che la più remota di tali
pronunce si è limitata ad affermare in termini generali, come già ricordato,
l’esigenza di prevedere «condizioni e limiti» alla responsabilità del
magistrato, avuto riguardo alla situazione normativa dell’epoca (che prevedeva
una responsabilità civile diretta del magistrato limitata ai casi di dolo,
frode, concussione e denegata giustizia, condizionando la domanda risarcitoria
all’autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia: originari artt. 55, 56 e
74 cod. proc. civ.). Affermazione, questa, di imprescindibile ed immutabile
valenza, ma che risulta, al più, neutra rispetto all’odierno thema decidendum.
Le affermazioni sul preteso «rilievo costituzionale»
del filtro sono piuttosto contenute nella già citata sentenza n. 18 del 1989 e,
soprattutto, nella n. 468 del 1990.
Nella prima di tali pronunce, questa Corte ebbe ad affermare che «la previsione
del giudizio di ammissibilità della domanda (art. 5, l. cit.) garantisce
adeguatamente il giudice dalla proposizione di azioni "manifestamente
infondate”, che possano turbarne la serenità, impedendo, al tempo stesso, di
creare con malizia i presupposti per l’astensione e la ricusazione». Nella
sentenza n. 468 del 1990, si enunciò poi l’assunto della «indispensabilità di
un "filtro” a garanzia della indipendenza ed autonomia della funzione
giurisdizionale».
Se doverosamente riguardate nella cornice storica e
normativa, oltre che nella specifica occasio che ebbe
a determinarle, queste affermazioni risultano tuttavia di valore assai meno
dirimente rispetto a quello loro attribuito dalle argomentazioni del tribunale
rimettente.
L’affermazione – contenuta nella sentenza n. 18 del
1989 − relativa alla "garanzia adeguata” derivante dal preventivo
giudizio di ammissibilità rispetto alla proposizione di azioni manifestamente
infondate o temerarie non individua di certo, in tale rimedio, la soluzione
unica e costituzionalmente obbligata affinché un sistema di responsabilità
civile non risulti strutturalmente lesivo dell’autonomia ed indipendenza della
magistratura, incidendo sul "perturbamento della serenità” del giudice. Già si
è osservato che, in un mutato quadro storico e normativo, il legislatore ha
praticato, in forme diverse e non censurabili per irragionevolezza, quel
bilanciamento di valori contrapposti che, vigente la legge n. 117 del 1988,
risultava svolto dal meccanismo procedurale in esame, oggi abrogato dalla norma
censurata. Ciò è tanto più vero considerando, inoltre, che, anche a mezzo della
citata argomentazione, questa Corte, con la sentenza n. 18 del 1989, ebbe a
ritenere non fondato il dubbio di costituzionalità inerente all’«intera l. 13
aprile 1988, n. 117»: dubbio allora prospettato per «la previsione, in sé, di
tale responsabilità», reputando, il giudice rimettente dell’epoca, che la
stessa introduzione di una disciplina della responsabilità civile dei giudici
per colpa grave compromettesse «l’imparzialità della magistratura, con
l’attribuire alle parti uno strumento di pressione idoneo ad influenzarne le
decisioni». Da qui la precisa valenza che il riferimento alla "garanzia
adeguata” del filtro assumeva in quella decisione.
Parimente, anche l’indicata affermazione della sentenza n. 468 del
1990 – circa la «indispensabilità di un "filtro” a garanzia della
indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale» − assume una
connotazione diversa rispetto a quella propugnata dal tribunale rimettente di
soluzione costituzionalmente imposta. Mette conto, infatti, di rammentare
l’assoluta peculiarità della prospettiva da cui tale affermazione trasse
origine: quella, cioè, dell’estensione del meccanismo del filtro alle azioni di
danno promosse per fatti anteriori alla sua entrata in vigore; azioni che – se
pure fortemente limitate nei presupposti, in base all’abrogato art. 55 cod.
proc. civ. – avevano, però, come destinatario diretto il magistrato. Come dire
che il riferimento all’«indispensabilità di un "filtro”» quale garanzia
dell’indipendenza ed autonomia del giudice risultava riferito ad un sistema
così congegnato, del tutto diverso da quello odierno che non prevede forme di
responsabilità diretta del magistrato.
Alla luce di quanto precede, le questioni sollevate
dal Tribunale ordinario di Genova in riferimento ai principi di indipendenza e
autonomia della magistratura e di terzietà e imparzialità del giudice, di cui
agli artt. 101, 104 e 111 Cost., debbono ritenersi quindi non fondate.
5.5.– Infondato è, altresì, il dubbio di
costituzionalità avanzato dal giudice a quo in relazione all’art. 3 Cost.,
sulla base della ritenuta irragionevolezza intrinseca della soppressione del
filtro di ammissibilità e della violazione del principio di eguaglianza
rispetto alle «pronunce semplificate di inammissibilità» introdotte dal
legislatore in rapporto alle impugnazioni ordinarie.
Invero, l’àmbito del tutto eterogeneo in cui si muove
il raffronto prospettato dal rimettente – e rappresentato dagli artt. 348-bis e
348-ter cod. proc. civ., in relazione all’appello, e dagli artt. 360-bis e 375,
primo comma, numeri 1) e 5), cod. proc. civ., riguardo al ricorso per
cassazione – rende la censura priva di fondamento. La mera «comunanza logica»
evocata dal giudice a quo non vale evidentemente ad accomunare normativamente –
e, dunque, a rendere comparabili − strumenti deflattivi e semplificativi
innestati dal legislatore nel regime delle impugnazioni civili con l’abrogato
meccanismo del "filtro di ammissibilità”, il quale riguardava il giudizio di
primo grado, la cui disciplina generale non contempla analoghi meccanismi. E
ciò anche a prescindere dalla diversità di scopi degli istituti nonché dalla
discrezionalità di cui gode il legislatore nelle scelte in materia processuale,
il cui limite della manifesta irragionevolezza, ad ogni modo, non risulta, nel
caso in esame, travalicato né in senso assoluto, né "per comparazione”.
5.6.– È altresì infondata la censura dell’art. 3, comma
2, della legge n. 18 del 2015 per violazione del principio del giudice naturale
precostituito per legge (art. 25 Cost.), che si verificherebbe, secondo il
giudice rimettente, perché la contemporanea pendenza del giudizio contro lo
Stato e di quello principale – agevolata dall’eliminazione del "filtro di
ammissibilità” – indurrebbe il giudice del secondo giudizio ad astenersi o
all’astensione addirittura lo obbligherebbe, nel caso in cui intervenisse nel
giudizio intentato nei confronti dello Stato.
A prescindere dalla considerazione che l’identica
situazione oggi paventata dal rimettente ben poteva verificarsi anche in
vigenza del meccanismo abrogato, è sufficiente osservare che, secondo la
giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite civili,
sentenza 22 luglio 2014, n. 16627), la pendenza della causa di danno contro lo
Stato non costituisce motivo di astensione o ricusazione del giudice autore del
provvedimento. E ciò – come recentemente affermato dalla Corte di cassazione,
sezioni unite civili, sentenza 23 giugno 2015, n. 13018 – neppure nel caso di
intervento del magistrato in detta causa: non vi è, infatti, un rapporto
diretto parte-magistrato, che valga a qualificare il secondo come debitore –
anche solo potenziale – della prima.
5.7.– È infine non fondata la questione in
riferimento all’art. 111 Cost., sotto il profilo del contrasto con il principio
della ragionevole durata del processo.
Il giudice a quo – motivando tale dubbio di
legittimità costituzionale sulla base dell’assunto che, abolito il filtro
preliminare, i tempi per pervenire ad una pronuncia sull’ammissibilità sono
invece quelli del processo ordinario, di «lunghezza eccessiva ed irragionevole»
− non considera che detto dubbio dovrebbe per ciò stesso inerire a tutti
i giudizi civili ordinari se non preceduti da meccanismi di preliminare
delibazione della domanda simili a quello contemplato dall’abrogato art. 5
della legge n. 117 del 1988. Ciò che rende di evidente precarietà logica la
premessa argomentativa del rimettente e, dunque, non fondata la questione che
da essa si sviluppa.
5.8.– In conclusione, tutte le questioni di
legittimità costituzionale, aventi per oggetto l’art. 3, comma 2, della legge
n. 18 del 2015, prospettate dal Tribunale ordinario di Genova, debbono essere
dichiarate non fondate.
per questi
motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma
1, lettere a), b) e c), 3, comma 2, e 4 della legge 27 febbraio 2015, n. 18
(Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), e dell’art. 9, comma
1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati
nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei
magistrati), come modificato dall’art. 6 della legge n. 18 del 2015, sollevate,
in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 81, terzo comma, 101, secondo
comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di
Verona, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibili
le questioni di legittimità costituzionale degli artt. «4 e/o 7», 7 e 8, comma
3, della legge n. 117 del 1988, come modificati o sostituiti dalla legge n. 18
del 2015, e dell’art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 25, 101, «101 e seguenti», 104 e 113 Cost., dal
Tribunale ordinario di Treviso, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma
3, 7, 8, comma 3, e 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificati o
sostituiti dalla legge n. 18 del 2015, e dell’art. 3, comma 2, della legge n.
18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 101, 111 e
«101-113» Cost., dal Tribunale ordinario di Catania, con l’ordinanza indicata
in epigrafe;
4) dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2 e
3, della legge n. 117 del 1988, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettere
b) e c), della legge n. 18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 101,
secondo comma, 104, primo comma, 107, terzo comma, e 134 Cost., dal Tribunale
ordinario di Enna, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
5) dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2,
della legge n. 18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 101,
104 e 111 Cost., dal Tribunale ordinario di Genova con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2017.