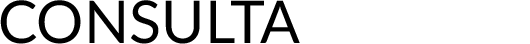SENTENZA N. 12
ANNO 2016
Commento alla decisione di
Lina Matarrese
per g.c. di Diritto Penale Contemporaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 538 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento penale a carico di C.E. con ordinanza del 15 gennaio 2015, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Visti l’atto di costituzione di B.P.I., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 12 gennaio 2016 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
uditi l’avvocato Michele Passione per B.P.I. e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 15 gennaio 2015, il Tribunale ordinario di Firenze, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti del medesimo codice, anche quando pronuncia sentenza di assoluzione dell’imputato in quanto non imputabile per essere, nel momento in cui ha commesso il fatto, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere.
Il giudice a quo riferisce che, all’esito dell’istruzione dibattimentale, tutte le parti del processo principale avevano concluso per l’assoluzione dell’imputato, in quanto incapace di intendere e di volere al momento del fatto per vizio totale di mente: circostanza che apparirebbe, in effetti, pacifica alla luce delle risultanze processuali. La parte civile aveva chiesto, peraltro, che l’imputato fosse condannato a corrisponderle un’equa indennità ai sensi dell’art. 2047 del codice civile.
Tale richiesta, ad avviso del rimettente, non potrebbe essere allo stato accolta. Vi osterebbe, infatti – secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione (sezione prima penale, sentenza 8 ottobre-8 novembre 2013, n. 45228) – il chiaro disposto dell’art. 538 cod. proc. pen., a mente del quale il giudice penale decide sulle questioni civili solo nel caso di condanna dell’imputato. Con la conseguenza che, quando quest’ultimo sia assolto per totale infermità di mente, il danneggiato, costituitosi parte civile, non avrebbe altra via, per far valere i suoi diritti, che quella di promuovere un autonomo giudizio davanti al giudice civile.
Il giudice a quo dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale di tale disciplina, escludendo che il dubbio possa essere superato con lo strumento dell’interpretazione costituzionalmente orientata, preclusa dall’univocità del dettato della norma censurata.
Osserva, in specie, il Tribunale fiorentino che – contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di cassazione – la disciplina in esame non potrebbe essere ritenuta un coerente corollario della «cessazione, con il vigente codice di procedura penale, del pregresso sistema di unitarietà della funzione giurisdizionale e di generale prevalenza dell’accertamento in sede penale». Nella dinamica dei rapporti tra azione civile e azione penale – ispirata, in base al vigente codice di rito, al principio di autonomia dei giudizi e al favor separationis – è lasciata alla persona danneggiata dal reato la scelta tra chiedere la tutela dei suoi interessi nella sede propria o nel processo penale. È ben vero che, in caso di opzione per la seconda via, l’azione civile deve necessariamente adattarsi alla struttura e alla funzione del processo penale in cui si innesta: ma tali adattamenti non potrebbero andare comunque al di là di quanto richiesto dalle esigenze di salvaguardia dei diritti dell’imputato e di osservanza delle regole sulla formazione della prova. Le legittime aspettative del danneggiato non potrebbero, in particolare, rimanere deluse per la semplice eventualità che, all’esito del giudizio penale, si accerti che l’imputato era affetto da vizio totale di mente al momento del fatto.
Impedendo al giudice penale di decidere sulla domanda civile in tale evenienza, l’art. 538 cod. proc. pen. violerebbe quindi il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), generando una ingiustificata disparità di trattamento tra il danneggiato costituitosi parte civile in un processo che si concluda con l’assoluzione dell’imputato per vizio totale di mente e il danneggiato che veda invece esaminata la sua domanda risarcitoria all’esito della condanna dell’imputato «sano di mente».
Risulterebbe compromesso, altresì, il pieno esercizio del diritto di difesa del danneggiato costituitosi parte civile (art. 24 Cost.). La lesione non sarebbe evitata dalla possibilità di riproporre la domanda risarcitoria in sede civile, giacché, in questo modo, il danneggiato si trova costretto ad agire nuovamente in giudizio, con totale vanificazione della precedente scelta di far valere le proprie ragioni in sede penale: e ciò anche quando – come nel caso di specie – l’infermità mentale dell’imputato non risultasse affatto comprovata al momento della costituzione di parte civile. La moltiplicazione dei giudizi per il conseguimento della tutela risarcitoria sarebbe, d’altronde, foriera di nocumento non solo patrimoniale, ma anche morale per la vittima del reato, costretta a rievocare, a distanza di tempo, davanti a giudici diversi i fatti posti a base della domanda.
Apparirebbe violato, infine, anche il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), in quanto l’esigenza di trasferire l’azione civile «da una giurisdizione ad un’altra» proietterebbe «in un tempo certamente lontano» la pronuncia definitiva sulla domanda risarcitoria.
Il vulnus al principio di ragionevole durata si apprezzerebbe, peraltro, non soltanto nella prospettiva dell’interesse del danneggiato ad ottenere giustizia in tempi brevi, ma anche – alla luce di una concezione che andrebbe acquisendo sempre maggiori consensi in ambito europeo – sulla base di criteri di proporzionalità che tengano conto della intrinseca limitatezza della «risorsa “giustizia”». Rendendo necessaria, nel caso in esame, l’instaurazione di un altro processo davanti a un’altra giurisdizione, la norma censurata mobiliterebbe, infatti, ulteriori risorse giudiziarie per un tempo non definito e imporrebbe la ripetizione dell’attività istruttoria, senza che tale duplicazione trovi giustificazione nell’eventuale specializzazione del nuovo giudice o nell’inidoneità del giudice penale a statuire sulle domande civili.
Non potrebbe trascurarsi, inoltre, la circostanza che il principio di ragionevole durata del processo risulta applicato in modo specifico a tutela delle vittime di reato dall’art. 16 della direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Ivi si stabilisce, infatti, che «Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell’ambito di un altro procedimento giudiziario».
La questione sarebbe, altresì, rilevante nel giudizio a quo, giacché, in caso di suo accoglimento, una volta accertata la riferibilità del fatto all’imputato, ancorché infermo di mente, egli potrebbe essere condannato al pagamento dell’equa indennità richiesta dalla parte civile in base al secondo comma dell’art. 2047 cod. civ. All’epoca, l’imputato non era sottoposto, infatti, alla sorveglianza di alcun soggetto, sicché la parte civile non avrebbe potuto chiedere la citazione a giudizio di un responsabile civile ai sensi del primo comma del medesimo articolo.
2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
A parere della difesa dello Stato, la denunciata violazione dell’art. 3 Cost. non sarebbe ravvisabile, stante l’assoluta eterogeneità delle due ipotesi poste a confronto dal giudice rimettente. L’accertamento dell’incapacità di intendere e di volere per infermità mentale, escludendo la punibilità dell’autore del fatto, giustifica la pronuncia di una sentenza di assoluzione: esito manifestamente non assimilabile alla sentenza di condanna, solo perché costituente l’epilogo di un processo in cui vi è stata costituzione di parte civile.
Parimenti insussistente risulterebbe la lamentata lesione del diritto di difesa del danneggiato costituitosi parte civile. L’impossibilità di ottenere la condanna al pagamento di un’equa indennità nei confronti dell’imputato assolto per totale infermità di mente costituirebbe, infatti, la logica conseguenza della scelta del danneggiato di chiedere la tutela dei propri diritti nel processo penale, anziché nella sede naturale: scelta che – secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale e come lo stesso rimettente ricorda – comporta l’impossibilità di sottrarsi agli effetti che ne conseguono, a causa della struttura e della funzione del giudizio penale, cui l’azione civile deve necessariamente adattarsi. Il danneggiato conserva, in ogni caso, la possibilità di rivolgersi al giudice civile.
Proprio perché coerente con la struttura del processo penale, nel cui ambito l’interessato ha scelto di far valere la sua pretesa, l’esigenza di adire il giudice civile non potrebbe essere ritenuta in contrasto neppure con il principio di ragionevole durata del processo.
3.– Si è costituita, altresì, B.P.I., parte civile nel giudizio a quo, la quale ha svolto deduzioni adesive alle tesi del giudice rimettente, chiedendo che la questione sia accolta e che la dichiarazione di illegittimità costituzionale sia «eventualmente» estesa, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), all’art. 185, primo e secondo comma, del codice penale: disposizioni, queste ultime, che – secondo la parte privata – concorrerebbero a determinare i vulnera costituzionali denunciati, unitamente alla norma processuale sottoposta a scrutinio.
Sulla base di una disamina della giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, la parte privata assume, in specie, che non vi sarebbe alcun ragionevole motivo per il quale – una volta accertato che il fatto illecito è stato commesso, che è previsto come reato e che ha prodotto un danno, ma non è penalmente perseguibile per difetto di imputabilità dell’autore – il giudice penale non possa decidere sulla domanda di ristoro del pregiudizio causato dall’incapace, sia pure sotto forma del pagamento di un’equa indennità, costringendo così il danneggiato costituitosi parte civile ad instaurare un nuovo giudizio davanti al giudice civile, con ulteriori attese e costi.
Considerato in diritto
1.– Il Tribunale ordinario di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell’art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti del medesimo codice, quando pronuncia sentenza di assoluzione dell’imputato in quanto non imputabile per vizio totale di mente.
Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe l’art. 3 della Costituzione, determinando una irragionevole disparità di trattamento fra il danneggiato costituitosi parte civile in un processo penale che si concluda con l’assoluzione dell’imputato per totale infermità di mente, e il danneggiato che veda invece esaminata la sua domanda risarcitoria all’esito della condanna dell’imputato «sano di mente». Se è vero infatti che, scegliendo di far valere le sue pretese nel processo penale, il danneggiato accetta i condizionamenti connessi al necessario adattamento dell’azione civile alla struttura e alla funzione del giudizio penale, i suoi diritti non potrebbero rimanere comunque pregiudicati dalla mera eventualità che – all’esito di quel giudizio – si accerti che l’imputato era totalmente infermo di mente al momento del fatto.
Risulterebbe compromesso, altresì, il pieno esercizio del diritto di difesa del danneggiato costituitosi parte civile (art. 24 Cost.), il quale si troverebbe costretto, per conseguire la tutela dei suoi diritti, ad instaurare un nuovo giudizio davanti al giudice civile, con totale vanificazione della scelta – che pure l’ordinamento gli consente – di far valere la sua pretesa in sede penale: e ciò anche quando – come nel caso di specie – l’infermità di mente dell’imputato non fosse affatto comprovata al momento della costituzione di parte civile.
Sarebbe violato, infine, il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), in quanto l’esigenza di trasferire la domanda risarcitoria in sede civile allontanerebbe sensibilmente nel tempo la pronuncia definitiva sulla stessa e impegnerebbe ulteriori risorse giudiziarie senza alcun apprezzabile motivo.
2.– Nell’approccio al thema decidendum, giova ricordare come la norma sottoposta a scrutinio trovi il suo immediato antecedente storico nell’art. 489, primo comma, del codice di procedura penale del 1930.
Nel confermare la scelta – già operata dai precedenti codici postunitari – di consentire l’esercizio dell’azione civile riparatoria nel processo penale, detto codice delineava, come è noto, un assetto dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile improntato ai principi di unitarietà della funzione giurisdizionale e di preminenza della giurisdizione penale.
Il danneggiato poteva esercitare l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato nel processo penale mediante la costituzione di parte civile, ovvero far valere le proprie pretese davanti al giudice civile. In quest’ultimo caso, tuttavia – salva la facoltà di trasferire, a determinate condizioni, l’azione civile nel processo penale – il giudizio civile rimaneva obbligatoriamente sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale irrevocabile, la quale assumeva efficacia vincolante nel giudizio di danno (artt. 23 e seguenti cod. proc. pen. del 1930).
In questo contesto, era espressamente previsto – sulla falsariga dell’art. 8 del codice di procedura penale del 1913 – che, nell’ipotesi in cui il danneggiato si fosse costituito parte civile, il giudice penale non poteva comunque decidere sull’azione civile ove il procedimento si fosse chiuso con sentenza di non doversi procedere o di assoluzione per qualsiasi causa (art. 23, primo comma, secondo periodo, cod. proc. pen. del 1930): dunque, neppure quando le ragioni del proscioglimento – non inerendo alla sussistenza del fatto o alla sua commissione da parte dell’imputato – non escludessero la configurabilità di una responsabilità civile. La regola era ribadita, in modo speculare, dal citato art. 489, primo comma, del codice abrogato, ove si stabiliva che l’imputato potesse essere condannato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile (solo) «Con la sentenza di condanna».
Si trattava – per corrente rilievo – di uno dei principali corollari del cosiddetto principio di accessorietà dell’azione civile innestata sul tronco dell’azione penale, rispetto alle finalità di quest’ultima: prospettiva nella quale la competenza del giudice penale a conoscere – eccezionalmente – del “torto civile” era destinata a cadere allorché detto giudice, prosciogliendo l’imputato, avesse con ciò esaurito il compito decisorio suo proprio, inscindibilmente connesso alla definizione della pretesa punitiva. Al riguardo, si rilevava nella relazione del Ministro guardasigilli al progetto preliminare del codice che «La competenza del giudice penale a statuire sopra la responsabilità civile può ammettersi esclusivamente quando egli riconosca e dichiari la responsabilità penale, perché soltanto in questo caso sussiste quella correlazione che giustifica tale competenza. Quando invece la responsabilità penale, cioè l’effetto della riconosciuta colpevolezza viene esclusa, il giudice penale non può esercitare soltanto la giurisdizione civile, che non gli è propria. Vi sono cause che escludono la condanna penale, nonostante la accertata colpevolezza dell’imputato […]. Ma il solo presupposto della colpevolezza non può bastare a mantenere nel giudice penale quella competenza civile, che non è più giustificata dalla connessione, una volta che egli deve assolvere. L’azione civile dovrà perciò proporsi dinanzi al giudice competente […]».
3.– Nonostante l’evidenziata possibilità di attivare la giurisdizione civile, l’assetto ora ricordato poteva risultare, in fatto, assai penalizzante per il danneggiato. Se si rivolgeva sin dall’inizio al giudice civile, egli vedeva, infatti, paralizzata la sua azione dal regime di sospensione obbligatoria; se optava per la costituzione di parte civile nel processo penale, rischiava di veder vanificata l’iniziativa – anche a distanza di numerosi anni – dall’esito assolutorio del giudizio, ancorché per ragioni che non escludevano affatto la fondatezza della sua pretesa.
Non stupisce, perciò, che nei dibattiti che hanno preceduto la nuova codificazione si fossero manifestate spinte per il superamento della regola che qui interessa: spinte che avevano trovato una parziale eco nel progetto preliminare del 1978, redatto sulla base della delega legislativa – rimasta poi inattuata – conferita dalla legge 3 aprile 1974, n. 108 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale).
L’art. 510 del progetto prevedeva, infatti, che il giudice penale decidesse sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno non soltanto nell’ipotesi di condanna, ma anche «in caso di estinzione del reato quando risulti già provata l’esistenza del fatto e la sua attribuzione all’imputato».
È interessante rilevare come, nella relazione al progetto, la commissione ministeriale incaricata della sua redazione riferisse di aver scartato – malgrado le perplessità espresse da alcuni suoi componenti – la più ampia soluzione di prevedere la pronuncia sulla domanda civile in tutti i casi di proscioglimento sulla base delle prove assunte in giudizio. Ciò, alla luce della considerazione che, in una simile prospettiva, la decisione sulla domanda civile si sarebbe ricollegata «non già alla fattispecie prevista dall’articolo 185 c.p., bensì a quella prevista dall’articolo 2043 c.c., in ordine alla quale manca la competenza del giudice penale». Si era fatta eccezione, tuttavia, per l’ipotesi di estinzione del reato, «giacché tale estinzione non esclude che sia integrata la fattispecie di cui all’art. 185 c.p.» e tenuto conto, altresì, del fatto che, «in tale ipotesi, sarebbe contrario alle regole di economia processuale, e sarebbe gravemente pregiudizievole per il danneggiato, impedire la pronuncia civile del giudice penale (particolarmente quando l’estinzione del reato si verifica in appello o in cassazione) e costringere il danneggiato a riproporre l’azione riparatoria in sede civile».
4.– La soluzione prefigurata dal progetto preliminare del 1978 non è stata, peraltro, recepita dal nuovo codice di procedura penale del 1988, il cui art. 538, comma 1, continua a collegare in via esclusiva la decisione sulla domanda della parte civile alla condanna dell’imputato («Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti»).
L’unica eccezione – fortemente circoscritta – è quella stabilita dall’art. 578 del medesimo codice e riguarda il giudizio di impugnazione. Riproponendo e ampliando la disposizione introdotta dall’art. 12, primo comma, della legge 3 agosto 1978, n. 405 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull’azione civile in seguito ad amnistia) e in puntuale attuazione del criterio direttivo di cui all’art. 2, numero 28), della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale), si prevede, infatti, che quando è stata pronunciata condanna, anche generica, dell’imputato alle restituzioni o al risarcimento dei danni a favore della parte civile, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione, decidono comunque sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
La cornice sistematica entro la quale si colloca la disciplina in esame è, tuttavia, marcatamente innovativa rispetto al passato. Se è stata disattesa, infatti, la proposta di “depurare” totalmente il processo penale dalla presenza della parte civile, in quanto istituto storicamente coeso ad impianti di tipo inquisitorio – essendosi, al contrario, rafforzati il ruolo e le garanzie di detto soggetto processuale – l’idea di fondo sottesa alla nuova codificazione, sul versante in esame, è che la costituzione di parte civile non dovesse essere comunque “incoraggiata”.
Anche in questa prospettiva, il sistema risulta quindi informato al principio della separazione e dell’autonomia dei giudizi. Il danneggiato può scegliere se esperire l’azione civile in sede penale o attivare la tutela giurisdizionale nella sede naturale. In questa seconda ipotesi, peraltro, egli non subisce alcuna limitazione di ordine temporale: diversamente che sotto l’impero del codice del 1930, l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto non comporta, di regola, la sospensione del processo civile, nell’ambito del quale l’eventuale giudicato penale di assoluzione non ha efficacia (art. 652 cod. proc. pen.). Il giudizio civile di danno prosegue, dunque, autonomamente malgrado la contemporanea pendenza del processo penale (art. 75, comma 2, cod. proc. pen.): la sospensione rappresenta l’eccezione, che opera nei limitati casi previsti dall’art. 75, comma 3.
5.– Con riferimento a tale mutato quadro ordinamentale, questa Corte ha affermato due principi di rilievo agli odierni fini.
Il primo è che «l’inserimento dell’azione civile nel processo penale pone in essere una situazione in linea di principio differente rispetto a quella determinata dall’esercizio dell’azione civile nel processo civile […], e ciò in quanto tale azione assume carattere accessorio e subordinato rispetto all’azione penale, sicché è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all’accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi» (sentenza n. 353 del 1994; in senso analogo, sentenze n. 217 del 2009 e n. 443 del 1990; ordinanze n. 424 del 1998 e n. 185 del 1994). Soluzione legislativa, questa, nella quale non può scorgersi alcun profilo di irrazionalità, stante la preminenza delle predette esigenze rispetto a quelle collegate alla risoluzione delle liti civili (ordinanza n. 115 del 1992) e considerato che si discute di «condizionamenti giustificati dal fatto che oggetto dell’azione penale è l’accertamento della responsabilità dell’imputato» (sentenza n. 532 del 1995).
Di conseguenza, una volta che il danneggiato, «previa valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi insiti nella opzione concessagli», scelga di esercitare l’azione civile nel processo penale, anziché nella sede propria, «non è dato sfuggire agli effetti che da tale inserimento conseguono», nei termini dianzi evidenziati (sentenza n. 94 del 1996, ordinanza n. 424 del 1998).
In secondo luogo, poi, è reiterato, nella giurisprudenza della Corte, il rilievo che «l’assetto generale del nuovo processo penale è ispirato all’idea della separazione dei giudizi, penale e civile», essendo «prevalente, nel disegno del codice, l’esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all’interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo» (sentenza n. 168 del 2006; in senso analogo, sentenza n. 23 del 2015).
In questa cornice, l’eventuale impossibilità, per il danneggiato, di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, prima ancora, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l’azione di risarcimento del danno nella sede civile: di modo che ogni separazione dell’azione civile dall’ambito del processo penale non può essere considerata una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale, giacché la configurazione di quest’ultima, in vista delle esigenze proprie del processo penale, è affidata al legislatore (sentenze n. 168 del 2006, n. 433 del 1997 e n. 192 del 1991; ordinanza n. 124 del 1999).
6.– Scendendo, sulla scorta di tali preliminari rilievi, all’esame dell’odierna questione, la premessa interpretativa da cui muove il giudice rimettente, e che fonda la questione stessa, appare senz’altro corretta.
L’accertamento che l’imputato è persona non imputabile, in quanto incapace di intendere o di volere al momento del fatto per vizio totale di mente, esclude la sua punibilità (artt. 85 e 88 del codice penale) e conseguentemente impone la pronuncia di una sentenza di assoluzione (art. 530, comma 1, cod. proc. pen.).
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 8 ottobre-8 novembre 2013, n. 45228), detta sentenza non si trasforma, eo ipso, in una pronuncia di condanna per il solo fatto che, con essa, sia eventualmente applicata all’imputato una misura di sicurezza personale. Nell’ambito dell’ordinamento penale, il concetto di «condanna» designa, infatti, unicamente il provvedimento che applica una pena, e non anche quello che dispone misure di sicurezza personali, le quali operano su un piano distinto, essendo finalizzate unicamente a contenere la pericolosità sociale dell’interessato.
Di conseguenza, resta inibito al giudice penale – in forza della norma censurata – adottare qualsiasi statuizione a carattere civile con la sentenza che qui interessa, compresa quella relativa alla liquidazione dell’equa indennità prevista dall’art. 2047, secondo comma, cod. civ.
7.– Nel merito, tuttavia, la questione non è fondata.
Il collegamento istituito dalla norma censurata, nel solco di una lunga tradizione storica, tra decisione sulle questioni civili e condanna dell’imputato riflette il carattere accessorio e subordinato dell’azione civile proposta nel processo penale rispetto agli obiettivi propri dell’azione penale: obiettivi che si focalizzano nell’accertamento della responsabilità penale dell’imputato. Di qui la ritenuta inopportunità di lasciar ferma la competenza del giudice penale a pronunciare sulle pretese civilistiche anche quando l’affermazione di detta responsabilità non abbia luogo.
Il fenomeno, d’altra parte, è ben noto al danneggiato nel momento in cui sceglie se esercitare l’azione di danno nella sede sua propria, o inserirla nel processo penale: scelta che il vigente sistema processuale gli consente senza limitazioni di sorta e, in particolare, senza la remora legata alla sospensione obbligatoria del processo civile in pendenza del processo penale sul medesimo fatto, già stabilita dal codice di procedura penale abrogato.
L’impossibilità di ottenere una decisione sulla domanda risarcitoria laddove il processo penale si concluda con una sentenza di proscioglimento per qualunque causa (salvo che nei limitati casi previsti dall’art. 578 cod. proc. pen.) costituisce, dunque, uno degli elementi dei quali il danneggiato deve tener conto nel quadro della valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle due alternative che gli sono offerte.
8.– Ciò puntualizzato in termini generali, con particolare riguardo alla denunciata violazione dell’art. 3 Cost. occorre rilevare come le due ipotesi poste a raffronto dal giudice a quo – sentenza di assoluzione dell’imputato per vizio totale di mente e sentenza di condanna – risultino palesemente eterogenee nella prospettiva considerata (quella del trattamento della domanda civile del danneggiato).
È ben vero che la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, lungi dall’assumere una valenza pienamente liberatoria, postula – allo stesso modo di quella di condanna – l’accertamento della sussistenza del fatto e della sua riferibilità all’imputato, in termini tanto materiali che psicologici: situazione che non rappresenta, peraltro, affatto un unicum, essendo riscontrabile in rapporto ad una serie di altre ipotesi di proscioglimento (al riguardo, sentenze n. 274 del 2009 e n. 85 del 2008).
Resta, tuttavia, il fondamentale tratto differenziale che, con la sentenza di condanna, la responsabilità penale dell’imputato viene affermata; con la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, viene invece esclusa. Anzi, viene esclusa – in virtù della regola generale dell’art. 2046 cod. civ. – persino la sua responsabilità civile. Il danneggiato potrà conseguire il ristoro del pregiudizio patito unicamente da terzi, ossia dai soggetti tenuti alla sorveglianza dell’incapace, qualora non provino di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047, primo comma, cod. civ.). Solo in via sussidiaria – allorché non risulti possibile ottenere il risarcimento in tal modo – il danneggiato sarà abilitato a pretendere dall’incapace, non già il risarcimento, ma la corresponsione di un’«equa indennità», rimessa, peraltro, sia nell’an che nel quantum, all’apprezzamento discrezionale del giudice, sulla base di una comparazione delle condizioni economiche delle parti (art. 2047, secondo comma, cod. civ.).
A fronte di ciò, la scelta legislativa di trattare diversamente le due ipotesi, escludendo che nella seconda il giudice penale debba pronunciarsi sulle tematiche civilistiche, non può, dunque, ritenersi manifestamente irragionevole e arbitraria: questo essendo il parametro di riferimento in materia, tenuto conto che si discute di istituti processuali, nella cui conformazione – per costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 64 del 2014 e n. 216 del 2013) – il legislatore fruisce di ampia discrezionalità (in senso analogo, con riguardo ai limiti di operatività della citata disposizione dell’art. 12, primo comma, della legge n. 405 del 1978, sentenza n. 68 del 1983).
L’opposta soluzione verrebbe, in effetti, a rompere il collegamento sistematico – reso esplicito dalla disposizione combinata degli artt. 74 e 538, comma 1, cod. proc. pen. – tra la competenza del giudice penale a conoscere delle questioni civili e la disposizione sostanziale dell’art. 185 cod. pen., che obbliga l’autore del reato e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere del fatto di lui a risarcire il danno, patrimoniale o non patrimoniale, cagionato dal reato stesso. Nella specie, infatti, la pretesa del danneggiato troverebbe fondamento non più nella predetta disposizione, ma nell’autonoma disciplina del citato art. 2047 cod. civ.: disciplina in base alla quale – per quanto detto – le istanze risarcitorie andrebbero rivolte primariamente nei confronti di chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, tramite la sua tempestiva citazione in giudizio quale responsabile civile. Con un risultato, peraltro, eccentrico rispetto alle attuali coordinate del sistema: quello, cioè, di un soggetto chiamato a rispondere civilmente del fatto dell’imputato in sede penale in assenza di un’omologa responsabilità di costui.
Come si è avuto modo di accennare, proprio sulla base di una considerazione similare – legata all’esigenza di non scardinare i presupposti sistematici della competenza del giudice penale a conoscere dell’illecito civile – i redattori del progetto preliminare del 1978 scartarono la proposta di consentire la decisione sulle questioni civili in tutti i casi di proscioglimento sulla base delle prove assunte in giudizio.
Alla luce di quanto precede, è dunque evidente come non possa essere invocata, in senso contrario, la sentenza n. 274 del 2009, con la quale questa Corte ha riconosciuto la sostanziale assimilabilità dell’assoluzione per vizio totale di mente ad una sentenza di condanna, ma in una prospettiva ben diversa da quella odierna: vale a dire, quella della limitazione dei poteri di impugnazione dell’imputato (nella specie, contro le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato); prospettiva nella quale veniva in precipuo rilievo il pregiudizio che la pronuncia in questione è suscettibile di recare al prosciolto.
9.– Quanto, poi, all’asserita lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), è sufficiente il richiamo alla ricordata, costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’impossibilità, per la persona danneggiata dal reato, di conseguire la riparazione del pregiudizio patito in sede penale non implica apprezzabile violazione di quel diritto (né, ancor prima, del diritto di agire in giudizio), restando sempre aperta la possibilità di far valere la pretesa in sede civile. E ciò – nella cornice di un sistema che, come il vigente, è ispirato al favor separationis – anche quando tale impossibilità dipenda da accadimenti successivi alla costituzione di parte civile, ai quali la legge processuale riconnette la necessaria divaricazione dei due percorsi.
10.– Con riguardo, infine, all’asserita violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, secondo periodo, Cost.), questa Corte ha ripetutamente affermato che – alla luce dello stesso richiamo al connotato di «ragionevolezza», che compare nella formula costituzionale – possono arrecare un vulnus a quel principio solamente le norme «che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza» (ex plurimis, sentenze n. 23 del 2015 n. 63 e n. 56 del 2009, n. 148 del 2005).
Tale ipotesi non è ravvisabile nel caso considerato. La preclusione della decisione sulle questioni civili, nel caso di proscioglimento dell’imputato per qualsiasi causa – compreso il vizio totale di mente – se pure procrastina la pronuncia definitiva sulla domanda risarcitoria del danneggiato, costringendolo ad instaurare un autonomo giudizio civile, trova però giustificazione, come già rimarcato, nel carattere accessorio e subordinato dell’azione civile proposta nell’ambito del processo penale rispetto alle finalità di quest’ultimo, e segnatamente nel preminente interesse pubblico (e dello stesso imputato) alla sollecita definizione del processo penale che non si concluda con un accertamento di responsabilità, riportando nella sede naturale le istanze di natura civile fatte valere nei suoi confronti.
Ciò, in linea, una volta ancora, con il favore per la separazione dei giudizi cui è ispirato il vigente sistema processuale.
11.– Non giova, altresì, alle tesi del giudice a quo il richiamo alla direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: richiamo destinato, peraltro, a fungere da mero argomento di supporto delle altre doglianze, non avendo il rimettente evocato i parametri costituzionali che imporrebbero – in ipotesi – l’adeguamento dell’ordinamento italiano alle istanze sovranazionali richiamate (ossia gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).
Al riguardo, è sufficiente osservare che l’obbligo degli Stati membri – sancito dall’art. 16, paragrafo 1, della citata direttiva – di garantire alla vittima «il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo», risulta espressamente subordinato alla condizione che «il diritto nazionale [non] preveda che tale decisione sia adottata nell’ambito di un altro procedimento giudiziario». Il che è proprio quanto si verifica, secondo l’ordinamento italiano, nell’ipotesi in esame.
12.– Parimenti non probanti appaiono, da ultimo, i riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo operati dalla parte privata: anche in questo caso, con semplice funzione rafforzativa delle denunciate violazioni degli artt. 24 e 111 Cost., non figurando tra i parametri dell’odierno scrutinio quello più direttamente conferente (l’art. 117, primo comma, Cost.).
La Corte di Strasburgo è, in effetti, costante nel riconoscere che, nella misura in cui la legislazione nazionale accordi alla vittima del reato la possibilità di intervenire nel processo penale per difendere i propri interessi tramite la costituzione di parte civile, tale diritto va considerato un «diritto civile» agli effetti dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, con conseguente spettanza, alla vittima stessa, delle garanzie in tema di equo processo ivi stabilite, compresa quella relativa alla ragionevole durata (Grande Camera, sentenza 12 febbraio 2004, Perez contro Francia; in senso conforme, tra le altre, sezione terza, sentenza 25 giugno 2013, Associazione delle persone vittime del sistema s.c. Rompetrol s.a. e s.c. Geomin s.a. e altri contro Romania; Grande Camera, sentenza 20 marzo 2009, Gorou contro Grecia).
In questa logica, la Corte europea si è, peraltro, specificamente occupata, in più occasioni, dell’ipotesi del mancato esame della domanda della parte civile per essersi il procedimento penale chiuso con provvedimento diverso dalla condanna dell’imputato, in applicazione di una regola condivisa – sia pure con diverse varianti e gradazioni – da plurimi ordinamenti nazionali. Tale regime non è stato affatto ritenuto, in sé e per sé, contrastante con le garanzie convenzionali. La violazione dell’art. 6 della CEDU, in particolare sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, è stata ravvisata dai giudici di Strasburgo solo in due ipotesi. In primo luogo, quando la vittima del reato non fruisca di altri rimedi accessibili ed efficaci per far valere le sue pretese (sezione terza, sentenza 25 giugno 2013, Associazione delle persone vittime del sistema s.c. Rompetrol s.a. e s.c. Geomin s.a. e altri contro Romania; sezione prima, sentenza 4 ottobre 2007, Forum Maritime s.a. contro Romania): rimedi che, nell’ordinamento italiano, sono invece offerti dalla possibilità di rivolgersi al giudice civile. In secondo luogo, la violazione è stata riscontrata allorché il concreto funzionamento del meccanismo frustri indebitamente le legittime aspettative del danneggiato, come nel caso in cui la prescrizione della responsabilità penale dell’autore del reato, impeditiva dell’esame della domanda civile, sia imputabile a ingiustificati ritardi delle autorità giudiziarie nella conduzione del procedimento penale (Grande Camera, sentenza 2 ottobre 2008, Atanasova contro Bulgaria; sezione prima, sentenza 3 aprile 2003, Anagnostopoulos contro Grecia): malfunzionamento che non dipende, peraltro, dalla norma e che comunque non viene in considerazione nell’ipotesi qui in esame.
13.– In conclusione – come questa Corte ebbe già a rilevare in passato (sentenza n. 68 del 1983) – il legislatore resta certamente libero, nella sua discrezionalità, di introdurre, in vista di una più efficace tutela della persona danneggiata dal reato e del conseguimento di maggiori risparmi complessivi di risorse giudiziarie, una disciplina ampliativa dei casi nei quali il giudice penale si pronuncia sulle questioni civili, pur in assenza di una condanna dell’imputato (casi oggi ristretti alle ipotesi dell’art. 578 cod. proc. pen.).
Ciò non esclude, tuttavia, che l’assetto espresso dalla norma censurata – in quanto munito di un suo fondamento logico-sistematico e tale da non impedire all’interessato di conseguire altrimenti il riconoscimento dei suoi diritti – si sottragga alle censure di illegittimità costituzionale che gli sono mosse.
La questione va dichiarata, pertanto, non fondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 538 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2016.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2016.