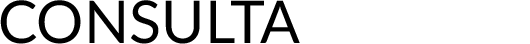SENTENZA N. 286
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29, primo comma, del codice penale, e 85, lettera b), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa l’8 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria sul ricorso proposto da Trapasso Gabriele contro l’ENPAS, iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 1998.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto in fatto
1. — Nel corso di un giudizio amministrativo per l’annullamento della delibera commissariale del 5 marzo 1992 con la quale un dipendente dell’ENPAS era stato destituito dall’impiego, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, primo comma, del codice penale; e, "per quanto occorra" (ove la norma si ritenga vigente), dell’art. 85, lettera b), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
Premette in fatto il giudice a quo che il ricorrente - operatore di esercizio in attività presso l’ufficio di Arezzo - veniva sospeso dal servizio, con decorrenza 4 ottobre 1986, a seguito dell’adozione nei suoi confronti di una misura restrittiva della libertà personale. Il processo, per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge n. 685 del 1975, si concludeva con la condanna dell’imputato a cinque anni e sei mesi di reclusione e di 11.000.000 di lire di multa, nonchè alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ridotta la pena detentiva, per successivi condoni e benefici, il 22 aprile 1992 il condannato veniva affidato al servizio sociale.
Il provvedimento dell’ENPAS, impugnato dal ricorrente, ha disposto la destituzione dall’impiego in applicazione dell’art. 108, lettera b), del regolamento organico del personale. Ma la norma regolamentare applicata dall’ente non sarebbe più in vigore, secondo il ricorrente, in quanto ricompresa nella previsione abrogativa dell’art. 9, comma 1, ultima parte, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti).
Il Collegio rimettente osserva che l’art. 108, lettera b), del regolamento organico dell’ENPAS statuisce la destituzione di diritto del dipendente a seguito di condanna, passata in giudicato, che importi l’interdizione perpetua dai pubblici uffici (ovvero l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata). La norma costituirebbe una integrale replica del testo dell’art. 85, lettera b), del d.P.R. n. 3 del 1957, attuando un vero e proprio rinvio materiale alla disposizione di legge, sì che la vigenza della previsione regolamentare dipenderebbe da quella della disposizione legislativa testè indicata.
Il giudice a quo ricorda che alla sentenza n. 971 del 1988 di questa Corte, dichiarativa dell’illegittimità della lettera a) del citato art. 85 del d.P.R. n. 3 del 1957, ha fatto seguito la menzionata legge n. 19 del 1990, che ha abrogato, all’art. 9, ogni disposizione attinente alla destituzione di diritto dei pubblici impiegati (comma 1), imponendo alle amministrazioni l’onere del preventivo procedimento disciplinare (comma 2). Tuttavia é dubbio, secondo il Collegio rimettente, se la destituzione di diritto sia stata abrogata nei contesti legislativi antecedenti, anche con riferimento alla commissione di delitti accertati nei confronti del dipendente con pronunce passate in giudicato; ovvero se essa é pienamente in vigore specie per le ipotesi normative, come quella dell’art. 85, lettera b), del d.P.R. n. 3 del 1957, non esaminata dalla giurisprudenza costituzionale.
La prima interpretazione troverebbe riscontro nell’intento del legislatore di recepire le considerazioni esposte nella pronuncia n. 971 del 1988, e nelle successive nn. 40 e 158 del 1990, 16 del 1991 e 197 del 1993. In esse la Corte avrebbe posto in evidenza sia la necessità di garantire la proporzionalità fra il fatto concreto e la sanzione da applicare, sia l’esigenza di ricondurre ogni valutazione nel merito alla sua sede naturale: il procedimento disciplinare. La diversa ipotesi della sanzione destitutoria correlata alla condanna penale esulerebbe peraltro, con riguardo alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, dall’assunto delle citate sentenze. In tal caso il rapporto di impiego cesserebbe per effetto di una decisione giudiziale che renderebbe superflua ogni valutazione in sede amministrativa; sotto questo profilo sarebbe esclusa la riconducibilità della lettera b), del citato art. 85 del d.P.R. n. 3 del 1957, dall’effetto abrogativo operato dall’art. 9, comma 1, della legge n. 19 del 1990. Sennonchè siffatta abrogazione - conclude su questo punto il giudice a quo - potrebbe riferirsi anche al caso della condanna alla interdizione dai pubblici uffici, in modo da stabilire un generale principio di obbligatorietà del procedimento disciplinare.
I dubbi di legittimità costituzionale della normativa concernente la risoluzione automatica del rapporto di impiego in conseguenza di fattispecie penalmente rilevanti non si supererebbero adottando tanto l’una quanto l’altra soluzione ermeneutica. Di qui, la lesione del principio di ragionevolezza, con riferimento ai casi di destituzione senza procedimento disciplinare, essendo impedito sia al giudice che all’amministrazione ogni giudizio di proporzionalità tra il fatto e la sanzione. Nè le perplessità si dissolverebbero riconoscendo - in base a una interpretazione letterale dell’art. 9 - l’obbligatorietà del procedimento disciplinare pure a seguito della condanna definitiva alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; e ciò perchè il procedimento in sede amministrativa non potrebbe avere conclusione diversa dalla destituzione. L’irrazionalità dell’effetto di automatica risoluzione dell’impiego, continua l’ordinanza, si verificherebbe altresì per i reati che, per l’oggetto e le circostanze dell’azione, hanno un rilievo marginale o nullo in relazione al rapporto di servizio con l’amministrazione.
La questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo, precisa infine il rimettente, poichè si riproporrebbe l’automatismo della sanzione, sia escludendo l’onere del procedimento disciplinare preventivo rispetto alla pronuncia di destituzione, sia ammettendolo: onde l’obbligo dell’amministrazione di tener conto della condanna alla interdizione inflitta dal giudice penale, e di comminare perciò la sanzione destitutoria.
2. — E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per l’infondatezza.
La giurisprudenza costituzionale richiamata nell’ordinanza di rimessione non riguarderebbe l’ipotesi della sanzione destitutoria correlata alla condanna, con sentenza del giudice penale, alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Perchè questa Corte si sarebbe chiaramente espressa per l’estraneità dell’art. 9 della legge n. 19 del 1990 all’applicazione delle pene accessorie, anche di carattere interdittivo (sentenza n. 363 del 1996), escludendo ch’esso abbia prodotto l’abrogazione dell’art. 85, lettera b), del testo unico degli impiegati civili dello Stato. Qualora vi sia condanna alla pena accessoria, l’amministrazione dovrebbe infatti disporre la destituzione del dipendente dal servizio. Si tratterebbe d’un provvedimento di natura dichiarativa di status conseguente al giudizio penale definitivo, peraltro emanato senza procedimentalizzazione e, quindi, senza compiere alcuna valutazione dell’impiegato.
Considerato in diritto
1. — Viene all’esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, primo comma, del codice penale, "nella parte in cui statuisce che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici"; e, "per quanto occorra (cioé se la norma deve ritenersi vigente)", dell’art. 85, lettera b), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, "nella parte in cui prescrive che l’impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato che importi l’interdizione dai pubblici uffici".
Stando alla prospettazione del rimettente, si tratta in realtà di due distinte questioni sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Le norme censurate sarebbero in contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità tra il fatto e la sanzione, perchè produttive dell’automatica risoluzione del rapporto di impiego nei confronti dei dipendenti pubblici condannati con sentenza passata in giudicato.
2. — Preliminarmente si deve dichiarare inammissibile la questione sollevata con riferimento all’art. 85, lettera b), del d.P.R. n. 3 del 1957, non solo perchè posta come meramente ipotetica, ma perchè é perplessa la motivazione, non risultando chiaro se, rispetto all’altra, essa si collochi in linea subordinata, o alternativa, o successiva.
3. — La questione sollevata con riferimento alla disposizione codicistica é, invece, non fondata.
L’art. 29, primo comma, del codice penale statuisce, come si é già anticipato, che "la condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici". Disposizione, questa, che il rimettente non censura nei suoi presupposti, ma nelle conseguenze giuridiche: non sotto il profilo generale, dunque, bensì con riguardo al rapporto di pubblico impiego, implicando l’automatica risoluzione di esso in ragione del carattere perpetuo della misura.
Il giudice a quo vorrebbe che dalla pena accessoria - applicabile secondo i principi generali solo in base a una condanna penale definitiva - non scaturisse l’automatismo della rimozione, ma si affermasse nella sua ineludibilità l’interposizione del giudizio disciplinare. A tal fine viene richiamata, nell’ordinanza di rimessione, la ratio decidendi su cui si fondano le sentenze nn. 363 e 239 del 1996 e 197 del 1993 e le ordinanze nn. 201 e 137 del 1994; ma l’affermazione del principio della necessità del procedimento disciplinare, in luogo della destituzione di diritto dei pubblici dipendenti, non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo, in genere, nè l’interdizione dai pubblici uffici, in particolare. La risoluzione del rapporto d’impiego costituisce, in questo caso, soltanto un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo.
Di là dai dubbi espressi dal Collegio, é appena il caso di soggiungere che, nella sua discrezionalità, il legislatore resta libero - sia pure con l’osservanza del principio di razionalità normativa - di determinare i presupposti, i contenuti e la durata della misura, assolvendo la pena accessoria finalità di difesa sociale e di prevenzione speciale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 85, lettera b) del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con l’ordinanza in epigrafe.
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1999.
Renato GRANATA, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1999.