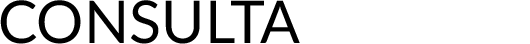SENTENZA N.18
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 13 aprile 1988, n. 117 (<Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati>), nella parte in cui disciplina la responsabilità civile dei magistrati, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 aprile 1988 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Mate Manlio e
2) ordinanza emessa il 4 maggio 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Marconi Francesco e l'I.A.C.P. della provincia di Roma, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30/1a s.s. dell'anno 1988;
3) ordinanza emessa il 10 maggio 1988 dal Tribunale di Biella nel procedimento civile vertente tra Machetti Mara e Cagnacci Massimo, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n 30/1a s.s. dell'anno 1988;
4) ordinanza emessa il 2 maggio 1988 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Rotundo Lorenzo e Senese Bentito, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31/1a s.s. dell'anno 1988;
5) ordinanza emessa il 2 maggio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Consorzio tenuta di Decima e Tordi Edmondo, iscritta al n. 358 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31/1a s.s. dell'anno 1988;
6) ordinanza emessa il 26 aprile 1988 dalla Corte d'Appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Polojaz Danilo, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/1a s.s. dell'anno 1988;
7) ordinanza emessa il 2 maggio 1988 dal Tribunale di Bari-Sezione specializzata Tossicodipendenze - nei confronti di Ambruoso Nazario, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/1a s.s. dell'anno 1988;
8) ordinanza emessa il 28 aprile 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ravenna sul ricorso proposto da Vincenzi Umberto contro l'Ufficio IVA di Ravenna, iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39/1a s.s. dell'anno 1988;
9) ordinanza emessa il 3 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto dall'Associazione della Stampa romana contro il Secondo Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40/1a S.S. dell'anno 1988;
10) ordinanza emessa il 12 maggio 1988 dal Tribunale amministrativo
regionale per
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato in diritto
1. -
2. - La questione più generale, sollevata dal Tribunale amministrativo
regionale per
Secondo il Tribunale amministrativo regionale remittente, la previsione, in sé, di tale responsabilità contrasterebbe, innanzitutto, con gli artt. 101, 104 e 108 della Costituzione, compromettendo l'imparzialità della magistratura, con l'attribuire alle parti uno strumento di pressione idoneo ad influenzarne le decisioni.
La possibilità di un <controprocesso, con finalità sanzionatorie a carico del magistrato, farebbe sorgere in lui, al momento della decisione di ogni controversia, un elemento d'interesse personale alla prudenza, al conformismo, alle scelte meno rischiose in relazione agli interessi economici coinvolti nella causa>, in contrasto con il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge. Ne deriverebbe la lesione della sua stessa sa in dipendenza, che ha per presupposto sto u no status di piena libertà da ogni influenza e intimidazione esterna.
Inoltre, la proposizione in concreto di azioni di danno verso lo Stato, esponendo il giudice all'eventuale rivalsa, inciderebbe sulla sua serenità-e quindi ancora sulla sua indipendenza-in relazione a giudizi analoghi a quelli che abbiano dato luogo a tali azioni, nonché ad altri proposti dinanzi a lui dalle stesse parti, esplicando una <forza psicologica di dissuasione dalla reiterazione di decisioni identiche o analoghe alla precedente>. I giudici infine, sarebbero spinti all'adesione forzata a principi giurisprudenziali consolidati, per porsi al riparo da responsabilità, con la conseguente compromissione dell'indipendenza della magistratura e di ogni evoluzione giurisprudenziale.
Nell'ordinanza di rimessione si rileva ancora che la possibilità di errore è connaturata al processo e l'esistenza, all'interno del processo, di appositi mezzi d'impugnazione finalizzati all'eliminazione dell'errore, costituiscono ragione d'incompatibilità fra processo e responsabilità del giudice a titolo di colpa.
Prospettando un secondo profilo d'incostituzionalità, il giudice a quo
deduce che l'Assemblea generale dell'O.N.U., tenendo conto della particolarità
della funzione giurisdizionale, con una risoluzione adottata il 29 novembre
3. -La questione è infondata sotto entrambi i profili.
Va premesso che la legge 13 aprile 1988, n. 117 rappresenta il punto di arrivo di una lunga evoluzione che, in materia di responsabilità civile del giudice, ha conosciuto in Italia significativi mutamenti.
Nei secoli dal XII al XV, prima del sorgere e dell'affermarsi dei tribunali supremi, l'interpretazione del diritto all'interno dei vari Stati italiani (spesso assai piccoli) era stata opera dei <dottori>, glossatori o commentatori-consulenti. Ciò essi avevano fatto specialmente con i loro Consilia, basati sulla communis opinio e dati ai giudici dell'epoca, spesso inesperti del giure e sottoposti al sindacato di responsabilità, senza distinzione tra dolo e colpa. Da questa indicazione muove il sentiero normativo non sempre lineare, svoltosi, in un lungo arco di tempo, in parallelo con il vario configurarsi della posizione del giudice.
L'affievolimento dell'idea dello Stato e della legge come volontà dello Stato, determinato dalle invasioni barbariche, si riflesse sull'idea della giurisdizione come funzione statale, funzione cioè di formulazione e di attuazione della volontà della legge.
E quanto più la giurisdizione, dapprima con lo stabilimento delle istituzioni feudali, poi con il frazionarsi sempre crescente della sovranità, si venne polverizzando fra i giudici più diversi (popolari, regi, imperiali, feudali, ecclesiastici, comunali) e venne assumendo l'aspetto di una prerogativa del giudice, avente carattere patrimoniale, trasmissibile ed alienabile, tanto più il processo cesso di essere considerato come istituto pubblico di attuazione della legge, e si profilo esclusivamente come una contesa fra litiganti: il giudice non fu più considerato come l'organo pubblico di una funzione statale, ma come l'arbitro incaricato di dirimere questa contesa in base ai risultati delle prove.
Poi, col sorgere e col consolidarsi della figura del giudice funzionario, al quale era delegata l'amministrazione della giustizia, si apri la via, da un lato, al delinearsi con maggiore precisione della responsabilità disciplinare, dall'altro, alla limitazione della sua responsabilità civile ai soli fatti dolosi.
Su tali basi erano impostati la disciplina dell'art. 783 del codice di procedura civile del 1865, il quale già limitava, sostanzialmente, la responsabilità civile del giudice alle ipotesi di <dolo, frode o concussione)> e <<denegata giustizia>, nonché gli artt. 55, 56 e 74 del codice di procedura civile del 1940.
Questo assetto normativo privilegiava la responsabilità interna - a carattere disciplinare- del giudice, rispetto alla responsabilità esterna, nel quadro di un ordinamento in cui non si erano ancora affermati i principi- frutto di lunga evoluzione e di progressivo ampliamento - relativi alla responsabilità in generale della Pubblica Amministrazione.
Già prima della Costituzione repubblicana, dottrina e giurisprudenza concordavano nell'affermazione (che trovò maggiore ostacolo nei confronti dell'amministrazione militare e di quella ferroviaria) del principio che la lesione del precetto del neminem ledere determinava la responsabilità dell'ente pubblico.
Svolgimento di tale principio, con connessa specificazione dei soggetti tenuti, e la regola enunciata nell'art. 28 della Costituzione, secondo la quale i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Questo precetto è stato interpretato nel senso che la responsabilità dello Stato può esser fatta valere anteriormente o contestualmente con quella dei funzionari e dei dipendenti, non avendo carattere sussidiario (Corte cost. 8 giugno 1963, n. 88).
Quanto al valore del riferimento alle <leggi penali, civili e amministrative>, destinate a regolare in concreto la responsabilità dei dipendenti pubblici, e da richiamare il t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3).
Secondo gli artt. 22 e 23 di tale normativa, l'impiegato statale che <nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla legge o dai regolamenti cagioni ad altri un danno ingiusto> e personalmente obbligato a risarcirlo (art. 22, primo comma). E danno ingiusto (inquadrabile nella sfera dell'art. 2043 c. civ.) quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave <salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti> (art. 23, primo comma). L'azione di risarcimento nei confronti dell'impiegato statale può <essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato> (art. 22, primo comma). Nel caso che, in seguito all'esperimento dell'azione diretta, l'Amministrazione abbia risarcito il danno, e prevista l'azione in rivalsa contro il dipendente (art. 22, secondo comma e 18, primo comma d.P.R. cit.).
5.-Mentre per gli impiegati civili dello Stato venne emanata tale normativa, che, in attuazione dell'art. 28 della Costituzione, li rendeva direttamente responsabili dei <danni ingiusti> cagionati nell'esercizio delle loro attribuzioni per colpa grave o dolo, per i magistrati resto ferma la previgente disciplina, nella sua consistenza di ius singulare, posta dagli artt. 55, 56 e 74 c.p.c..
In base a questa il giudice era civilmente responsabile soltanto quando nell'esercizio delle sue funzioni fosse <imputabile di dolo, frode o concussione> o quando senza giusto motivo rifiutasse, omettesse o ritardasse <di provvedere sulle domande o istanze della parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero>. Tali ipotesi si consideravano avverate solo ove la parte avesse depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l'atto e fossero decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito.
L'azione di responsabilità del giudice non poteva essere proposta senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.
Tale sistema determinava, in un certo senso, l'inversione della situazione normativa previgente all'entrata in vigore della Costituzione, poiché, mentre a quell'epoca soltanto per i magistrati era legislativamente sancita una responsabilità di retta-sia pure nelle limitate ipotesi anzi dette - con l'emanazione della Costituzione e poi del d.P.R. n. 3 del 1957, per gli impiegati civili dello Stato venne ad essere sancita una responsabilità più ampia, diretta verso i terzi; in rivalsa, verso lo Stato.
Tale normativa si caratterizza per un diverso ambito di operatività della responsabilità civile dello Stato verso i terzi: infatti, mentre si ritiene che l'art. 23 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, stabilendo che il dipendente risponde verso i terzi danneggiati solo se abbia agito con dolo o colpa grave, non escluda che, anche fuori da tali ipotesi, il danneggiato possa agire contro lo Stato; viceversa, in tema di danni derivanti dall'esercizio di attività giudiziaria, è principio consolidato in giurisprudenza che la responsabilità dello Stato sussiste solo nei limiti in cui si è in presenza di una responsabilità del giudice a norma dell'art. 55 c.p.c. e, cioè, solo qualora il fatto produttivo di danno sia ascrivibile a dolo, frode o concussione del giudice e nell'ipotesi di <denegata giustizia>.
6. - In tale contesto normativo e giurisprudenziale questa Corte, con la sentenza 14 marzo 1968, n. 2-pronunciata quando erano in vigore gli artt. 55, 56 e 74 c.p.c. - ha fissato alcuni principi, in materia di responsabilità civile dei pubblici impiegati in generale; tali principi e opportuno richiamare prima di passare all'esame dei profili d'incostituzionalità prospettati con l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale remittente.
Innanzitutto
In secondo luogo ha ritenuto che il principio generale, stabilito dall'art. 28, della responsabilità diretta dei pubblici dipendenti, compresi i magistrati, non esclude, stante il rinvio alle leggi ordinarie, che tale <responsabilità sia disciplinata variamente per categorie e per situazioni>.
Appunto la peculiarità della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziari, la stessa posizione super partes del magistrato, legittimano la previsione di <condizioni e limiti alla sua responsabilità>; senza, peraltro, giungere ad una negazione totale di essa, che si porrebbe in contrasto con l'art. 28 della Costituzione ed anche con l'art. 3, per l'irragionevole differenza di trattamento rispetto agli altri pubblici funzionari e dipendenti.
A proposito, infine, della responsabilità dello Stato,
In epoca più recente la giurisprudenza, in più stretto collegamento con il principio stabilito dall'art. 2043 cod.civ., ritenuto ormai generalmente applicabile alla P.A. sulla base del rapporto organico corrente tra l'ufficio del giudice e lo Stato, era giunta all'affermazione di una responsabilità diretta di quest'ultimo anche al di fuori delle ipotesi in cui il giudice poteva essere chiamato a rispondere direttamente del danno.
7. - In questo quadro si è inserito il referendum del 1987 sugli artt. 55, 56 e 74 c.p.c., risoltosi con la loro abrogazione. A questa ha fatto seguito l'emanazione della l. 13 aprile 1988, n. 117, con la quale il Parlamento ha posto una nuova disciplina della materia, sorretta dalla considerazione della peculiarità della funzione giudiziaria che - come questa Corte aveva enunciato nella sentenza 3 febbraio 1987, n. 26, ammissiva del referendum - rende necessaria la previsione di condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati, in considerazione <dei disposti costituzionali appositamente dettati per la magistratura (artt. 101-113) a tutela della sua indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni>.
La legge impugnata si applica (art. 1) a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali che esercitano attività giudiziaria, ivi compresi i magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali, nonché <agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria>>.
Il legislatore, restringendo l'ambito della responsabilità diretta dei magistrati nei limiti consentiti dalla disposizione dell'art. 28 della Costituzione, ha previsto che essi rispondano direttamente nella sola ipotesi di danni derivanti da fatti costituenti reato, commessi nell'esercizio delle loro funzioni (art. 13, primo comma). Nelle altre ipotesi in cui e prevista la risarcibilità dei danni (art. 2 e 3) derivanti dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, il danneggiato può agire solo verso lo Stato, al quale e poi attribuita una limitata azione di rivalsa (artt. 7 e 8).
8.-Le ipotesi in cui e ammessa l'azione contro lo Stato -e quindi la rivalsa contro il magistrato-sono tassativamente determinate dagli artt. 2 e 3 della legge. A norma dell'art. 2 <chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della liberta personale>>. Secondo l'espressa-e tassativa - statuizione dell'articolo: <costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione>.
L'articolo precisa che <non può dare luogo a responsabilità l'attività d'interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove>.
L'altra tassativa ipotesi in cui è ammessa l'azione di responsabilità e
costituita dal <diniego di giustizia>, regolato dall'art.
L'azione contro lo Stato, nei casi previsti dall'art. 2, può essere esercitata (art. 4) soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari d'impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, o quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. L'azione può comunque essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tale termine non si è concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto si è verificato.
In ogni caso l'azione va esercitata, a pena di decadenza, nel termine di due anni ed è previsto un giudizio preliminare di ammissibilità della stessa, inteso (art. 5) a verificare che siano rispettati <i termini o i presupposti di cui gli artt. 2, 3 e 4> e che non sussista la manifesta infondatezza della domanda.
L'art. 7 dispone che, entro un anno dall'avvenuto risarcimento, lo Stato esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.
La misura della rivalsa (art. 8), esclusi i casi di responsabilità del magistrato per dolo, non può superare una somma <pari al terzo di un'annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento e proposta, anche se dal fatto e derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità>. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio! non può comportare complessivamente il pagamento di rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.
9.-La disciplina posta dalla l. n. 117 del 1988 e caratterizzata dalla costante cura di predisporre misure e cautele idonee a salvaguardare l'indipendenza dei magistrati nonché l'autonomia e la pienezza dell'esercizio della funzione giudiziaria.
E muovendo da questa constatazione di carattere generale che occorre
procedere all'esame dei profili d'incostituzionalità della legge sollevati dal
Tribunale amministrativo regionale per
Come questa Corte ha affermato (sentenze 3 maggio 1974, n. 128; 27 marzo 1969, n. 60), il principio dell'indipendenza e volto a garantire l'imparzialità del giudice, assicurandogli una posizione super partes che escluda qualsiasi, anche indiretto, interesse alla causa da decidere. A tal fine la legge deve garantire l'assenza, in ugual modo, di aspettative di vantaggi e di situazioni di pregiudizio, preordinando gli strumenti atti a tutelare l'obiettività della decisione. La disciplina dell'attività del giudice deve perciò essere tale da rendere quest'ultima immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione, formale o sostanziale, ad altri organi, mirando altresì, per quanto possibile, a renderla <libera da prevenzioni, timori, influenze che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza>>.
Peraltro (sentenza 14 marzo 1968, n. 2), <l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e del giudice non pongono l'una al di là dello Stato, quasi legibus soluta, nè l'altro fuori dell'organizzazione statale>. Il magistrato deve essere indipendente da poteri e da interessi estranei alla giurisdizione, ma è <soggetto alla legge>: alla Costituzione innanzitutto, che sancisce, ad un tempo, il principio d'indipendenza (artt. 101, 104 e 108) e quello di responsabilità (art. 28), al fine di assicurare che la posizione super partes del magistrato non sia mai disgiunta dal corretto esercizio della sua alta funzione.
10. -
La limitatezza e tassatività delle fattispecie in cui e ipotizzabile una
colpa grave del giudice, rapportate a <negligenza inescusabile> in ordine
a violazioni di legge o accertamenti di fatto, ovvero all'emissione di
provvedimenti restrittivi della libertà fuori dei casi consentiti dalla legge o
senza motivazione; la specifica e circostanziata delimitazione della
responsabilità per <<diniego di giustizia>, non consentono di ritenere
che esse siano idonee a turbare la serenità e l'imparzialità del giudizio, come
afferma l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per
Il giudizio, per definizione e, infatti, diretto all'accertamento dei fatti ed all'applicazione delle norme, attraverso un'attività di valutazione ed interpretazione, nella quale al giudice sono riservati ampi spazi.
La garanzia costituzionale della sua indipendenza è diretta infatti a
tutelare, in primis, l'autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e
l'imparziale interpretazione delle norme di diritto. Tale attività non può dar
luogo a responsabilità del giudice (art. 2, n.
Nè può sostenersi - come fa il giudice a quo - che la legge impugnata spingerebbe il giudice a scelte interpretative accomodanti e a decisioni meno rischiose in relazione agli interessi in causa, cosi influendo negativamente sulla sua imparzialità. Come si è ora rilevato, l'art. 2, comma secondo, della l. n. 117 esclude espressamente che possa dar luogo a responsabilità <l'attività d'interpretazione di norme di diritto> e quella di valutazione del fatto e delle prove.
Tale statuizione rende parimenti priva di fondamento la censura, secondo
la quale la proposizione di un'azione di risarcimento di danni verso lo Stato,
riferita ad una determinata causa, potrebbe turbare l'imparzialità del giudice
riguardo a cause analoghe o nelle quali sia parte colui che abbia promosso il
giudizio di responsabilità. Ove ne ricorrano gli estremi, soccorre in tale caso
il rimedio dell'astensione. Comunque, va sottolineato che la previsione del
giudizio di ammissibilità della domanda (art.
11.-Per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 10 della Costituzione, sotto il profilo del contrasto con la risoluzione dell'O.N.U. adottata il 29 novembre 1985 -che ha affermato il principio secondo il quale i giudici debbono godere di un’immunità riguardo alle azioni civili per danni <derivanti da atti impropri od omissioni nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali>> - la questione va dichiarata non fondata. A norma dell'art. 10 della Costituzione <l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute> e tra queste non rientrano le statuizioni contenute nelle risoluzioni dell'O.N.U. in materia di dichiarazioni di principio alle quali, secondo la prassi internazionale, e negato carattere cogente.
Esse, infatti, non costituiscono fonti di diritto, pur potendo avere influenza nella formazione di consuetudini e di accordi conformi al loro contenuto.
Il principio anzi detto, comunque, si inserisce in un insieme di enunciazioni dirette a garantire l'indipendenza della magistratura e, in relazione a tale finalità, non sembra che esso implichi, necessariamente, il carattere totale dell'irresponsabilità, ben potendo l'indipendenza della magistratura essere garantita con apposite limitazioni e cautele, come ha ritenuto questa Corte, in riferimento all'art. 28 della Costituzione, e come ha, per quanto si è finora rilevato, rettamente disposto la l. n. 117.
12. - Passando gradatamente all'esame delle altre questioni, e da considerare quella, prospettata dal Tribunale di Biella con ordinanza 10 maggio 1988 (R.O. n. 327 del 1988), relativa agli artt. 1, comma secondo, 2 e 16 della l. n. 117 del 1988 cit., nonché all'art. 131 c.p.c., come modificato dall'art. 16 di questa legge.
Secondo l'ordinanza le norme impugnate, in quanto non stabiliscono <un diverso grado di responsabilità>, all'interno del collegio, tra il relatore e gli altri giudici, contrasterebbero con gli artt. 3 e 28 della Costituzione. Sarebbe irragionevole, infatti, che i membri del collegio diversi dal relatore rispondano nella stessa misura, in tal modo configurandosi, in alcuni casi, una responsabilità per fatto altrui.
In proposito il giudice a quo - il quale ha sollevato la questione con riferimento ad un processo civile-osserva che, secondo le norme del codice di procedura civile (artt. 275 e 738 c.p.c.), il giudice relatore <<fa la relazione della causa, esponendo i fatti e le questioni>. Sarebbe da escludere che anche gli altri componenti del collegio siano tenuti ad esaminare gli atti di causa, a ciò ostando l'immensa mole di lavoro gravante sui tribunali, che a fatica e con tempi già lenti può essere svolto solo limitando il contributo, da parte dei membri del collegio, alla decisione delle questioni cosi come prospettate dal relatore. Ne deriverebbe che, riguardo alle singole ipotesi previste dall'art. 2 della l. n. 117 del 1988, la responsabilità del relatore e degli altri membri del collegio dovrebbe essere differenziata.
In ordine alla rilevanza della questione, il Tribunale di Biella ha affermato che la decisione da assumere nel giudizio a quo <<e concretamente e immediatamente produttiva di una responsabilità potenziale, potendo dar luogo ad un giudizio di responsabilità>.
Le norme impugnate, pertanto, influirebbero sulla serenità e indipendenza di giudizio dei membri del collegio e, sotto tale profilo, inciderebbero sull'esito del giudizio a quo.
L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha contestato la rilevanza della questione, in quanto attinente a norme che non vengono in applicazione nel giudizio a quo.
Questione analoga e stata sollevata anche con la già citata ordinanza 12
maggio 1988 (R.O. n. 406 del 1988) del Tribuna le amministrativo regionale per
13. - L'eccezione d'irrilevanza è infondata.
L'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87, stabilendo che la questione di costituzionalità proposta debba esser tale che <il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione> di essa, implica, di regola, che la rilevanza sia strettamente correlata all'applicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo. Tuttavia, come questa Corte ha già implicitamente ritenuto in altre occasioni (cfr. Corte cost. 24 novembre 1982, n. 196; 4 luglio 1977, n. 125; 15 maggio 1974, n. 128), debbono ritenersi influenti sul giudizio anche le norme che, pur non essendo direttamente applicabili nel giudizio a quo, attengono allo status del giudice, alla sua composizione nonché, in generale, alle garanzie e ai doveri che riguardano il suo operare. L'eventuale incostituzionalità di tali norme e destinata ad influire su ciascun processo pendente davanti al giudice del quale regolano lo status, la composizione, le garanzie e i doveri: in sintesi, la <protezione> dell'esercizio della funzione, nella quale i doveri si accompagnano ai diritti.
14. - Nel merito la questione è infondata.
La decisione emessa dall'organo giudiziario collegiale, nel nostro ordinamento, tanto in materia civile che penale, e un atto unitario, alla formazione del quale concorrono i singoli membri del collegio, in base allo stesso titolo ed agli stessi doveri.
La disciplina del processo infatti, e caratterizzata da un complesso di regole, alla stregua delle quali la decisione, sia essa sentenza, ordinanza o decreto, non rappresenta la somma di distinte volontà e convincimenti dei membri del collegio, ma la loro sintesi-operata secondo la regola maggioritaria - la quale rende la decisione impersonale e imputabile al collegio nel suo insieme.
Per quanto concerne il processo civile, al quale specificamente si riferisce la questione sollevata del Tribunale di Biella, ciò emerge in maniera evidente dal disposto dell'art. 276 c.p.c., relativo al giudizio di primo grado-richiamato dagli artt. 359 per il giudizio di appello e 380 per quello di cassazione - secondo il quale <se intorno ad una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante e cosi successivamente finche le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva>. Tale meccanismo comporta che la decisione possa essere, per il formarsi di maggioranze diverse sulle varie questioni, diversa da quella che ciascuno dei membri del collegio avrebbe adottato se fosse s se stato giudice dice monocratico. Coerentemente, la motivazione della sentenza (art. 132 c.p.c.) (e non rileva in questa sede il riferimento al complesso dei valori sociali e istituzionali che ne sorreggono l'obbligo ex art. 111, primo comma, della Costituzione), consiste nella esposizione dei motivi di fatto e di diritto <<della decisione> e quindi nell'indicazione dell'iter logico che ha portato ad essa, senza che abbiano rilievo e necessita di menzione eventuali opinioni dissenzienti, tanto in relazione alle singole questioni che al decisum. Né la circostanza che essa sia estesa dal relatore o-in caso di suo dissenso - dal presidente o da altro giudice che abbia espresso voto conforme alla decisione (artt. 276 c.p.c.; 118 e 119 disp. att. c.p.c.), differenzia la posizione di questi da quella degli altri membri del collegio.
Tale struttura della decisione collegiale e diversa da quella prevista in
altri ordinamenti, nei quali e riconosciuta autonomia alla posizione assunta da
ciascun membro del collegio, attraverso la documentazione, nella sentenza,
delle motivazioni (eventualmente diverse) di ciascun giudice, o del suo
dissenso (con le relative ragioni) sullo stesso decisum. Né può ritenersi che
la struttura unitaria delle decisioni collegiali, nel nostro ordinamento, sia
stata alterata (a prescindere dal problema della sua legittimità
costituzionale, del quale ci si occuperà in seguito) dal disposto del comma
aggiunto all'art. 131 c.p.c. dall'art. 16 della l. n. 117 del
Quanto alla funzione del relatore, essa - secondo gli artt. 275 e 738 c.p.c. citati nell'ordinanza di rimessione -è caratterizzata da un'attività ulteriore rispetto a quella degli altri membri del collegio, costituita dal dovere di fare la relazione della causa, ma nessuna delle norme che regolano il giudizio collegiale, riserva a lui la disponibilità degli atti di causa e l'esame di essi ai fini del decidere.
In tale contesto normativo, l'avere attribuito, in linea di principio, come il legislatore ha fatto, pari responsabilità ai membri del collegio, per le decisioni prese erroneamente, nelle ipotesi qualificate dall'art. 2 come fattispecie di <colpa grave>, non appare affatto in contrasto né con l'art. 3, né con l'art. 28 della Costituzione. Infatti la pari responsabilità è correlata alla parità di doveri di ciascun membro del collegio - sulla quale non incide il compito specifico del relatore di fare la relazione al collegio - ed alla struttura unitaria della motivazione e del decisum degli organi giudiziari collegiali. E' ovvio che tale affermazione presuppone l'agevole possibilità di accesso all'informazione e alla documentazione da parte di tutti i membri del collegio.
15.-Altra questione, prospettata dalla sezione specializzata per le tossicodipendenze del Tribunale di Bari, con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 396 del 1988), riguarda la legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui limita la responsabilità dei cittadini <estranei alla magistratura> che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali, ai soli casi di dolo ed a quelli di colpa grave previsti dall'art. 2, comma terzo, lett. b) e c), cosi escludendo ogni loro responsabilità per l'ipotesi di grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, prevista dall'art. 2, lett. c).
Secondo il giudice a quo la norma impugnata violerebbe gli artt. 101, comma secondo, 104, comma primo e 108, comma secondo, della Costituzione in quanto, implicando che <i componenti C.D. Laici possano, a differenza degli altri, eventualmente violare la legge senza conseguenze personali, determina una inconcepibile alterazione dell'equilibrio interno del collegio giudicante, garantito dall'ordinamento con il sistema del voto di ciascun componente, espresso in piena e uguale libertà>. La norma impugnata violerebbe l'art. 107, comma terzo, della Costituzione, in quanto differenzierebbe i giudici non già soltanto in base alla diversità delle funzioni esercitate -come prescrive l'art. 107, comma terzo - ma anche in base alla diligenza alla quale i diversi componenti del collegio sono tenuti. Si porrebbe, infine, in espresso contrasto con l'art. 1O1, comma secondo, della Costituzione perché, assoggettando i giudici alla legge, vieterebbe che alcuni di essi possano essere esonerati dalla responsabilità prevista in via generale per <grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile> (art. 2, comma terzo, lett. a), l. n. 117 del 1988).
Questione analoga e stata sollevata anche dalla Commissione tributaria di primo grado di Ravenna, con ordinanza 28 aprile 1988 (R.O. n. 422 del 1988) con la quale è stata dedotta l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 7, terzo comma, e 8, quarto comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117, sotto il profilo che essi, limitando la responsabilità dei <membri laici> delle commissioni tributarie ai soli casi di dolo o colpa grave previsti dall'art. 2, comma terzo, lett. b) e c) della l. n. 117 del 1988, con esclusione della grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, contrasterebbero con gli artt. 3, 24, 25 e l'intero titolo quarto della Costituzione. Con l'art. 3 della Costituzione in quanto, all'interno del collegio, la disciplina differenziata in sede di rivalsa sarebbe incompatibile con l'esigenza della parità di trattamento fra quanti esercitano identici compiti ed identiche funzioni ed in quanto sussisterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento fra utenti della giustizia tributaria: non sarebbe possibile ammettere che controversie identiche vengano giudicate da giudici tenuti a maggiore o minor diligenza. Con gli artt. 24 e 25 e con l'intero titolo quarto della Costituzione, in quanto le norme impugnate violerebbero il diritto dei cittadini a che controversie identiche siano decise da giudici di pari capacita o comunque tenuti allo stesso grado di diligenza.
Altra questione, che investe pure l'art. 7, terzo comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117, è stata sollevata sotto altro aspetto dal Pretore onorario di Roma, con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 358 del 1988). In tale ordinanza il giudice a quo deduce il contrasto con l'art. 3 della Costituzione dell'art. 7, terzo comma, su detto <nella parte in cui prevede la responsabilità dei Pretori onorari, non solo per dolo ma anche per colpa grave, limitatamente ai casi di cui alle lett. b) e c), terzo comma, dell'art. 2 della stessa legge>, in quanto porrebbe in essere una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai giudici popolari ed ai giudici conciliatori, che rispondono solo per dolo.
16. - L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito l'irrilevanza delle questioni sollevate, investendo esse norme non applicabili nei giudizi a quibus. L'eccezione, peraltro, va disattesa per le stesse ragioni indicate, in relazione ad analoga eccezione, sub n. 12.
17. -Passando all'esame del merito, va preliminarmente dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8 della 1. n. 117 del 1988 sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Ravenna, in quanto erroneamente il giudice a quo ha ritenuto che essi escludano, per i <membri laici> delle Commissioni tributarie, la responsabilità per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile. Detta esclusione, infatti, e prevista unicamente ed espressamente nel terzo comma dell'art. 7 della l. n. 117 del 1988 (anch'esso impugnato), sul quale ci si soffermerà appresso, mentre nessun accenno ad esclusione, ne diretto ne indiretto, e contenuto negli artt. 1 e 8.
Va pure preliminarmente rilevato che l'ordinanza del Pretore onorario di Roma non e puntuale nell'impugnare l'art. 7, terzo comma, della 1. n. 117 del 1988 <nella parte in cui prevede la responsabilità dei pretori onorari, non solo per dolo ma anche per colpa grave, limitatamente ai casi di cui alle lett. b ) e c), terzo comma, dell'art. 2 della stessa legge>. Infatti l'art. 7, terzo comma, della 1. n. 117 del 1988 statuisce: <I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'art. 2, comma terzo, lett. b) e c)>.
Non essendo i vicepretori onorari - organi monocratici -<cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali>, e evidente che il giudice a quo erroneamente ha ritenuto applicabile la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 7, terzo comma, per i <cittadini estranei> anche ai vicepretori onorari. Questi rispondono, invece, ex art. 7, primo comma, in sede di rivalsa, come tutti gli altri giudici monocratici-escluso il giudice conciliatore - in tutte le ipotesi, dolose o colpose, previste dagli artt. 2 e 3 della l. n. 117 del 1988.
Poiché, tuttavia, dalla motivazione dell'ordinanza risulta chiaro che il giudice a quo ha inteso impugnare l'art. 7, terzo comma, in quanto non limita la responsabilità dei vicepretori onorari al solo caso di dolo, come e previsto invece per i giudici conciliatori e i giudici popolari, la questione - una volta precisata- può essere esaminata nel merito.
18.-Tutte le anzidette questioni, relative all'art. 7, terzo comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117, sono infondate.
La normativa dettata nel terzo comma dell'art. 7 rappresenta il punto di arrivo di una faticosa elaborazione legislativa. In proposito il disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia prevedeva che <d giudici conciliatori, i giudici popolari, nonché i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare organi giudiziari collegiali rispondono di colpa grave esclusivamente nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma terzo dell'art. 2>.
Tale disposizione fu modificata dalla Commissione giustizia della Camera
dei deputati, nel cui testo era previsto unicamente che <gli estranei che
partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali rispondono soltanto in
caso di dolo>: ciò - si legge nella relazione - <per evitare il rischio
di una fuga degli estranei dalla partecipazione a funzioni giudiziarie>. Sul
testo della Commissione, si accese un vivace dibattito e
Passato il disegno di legge al Senato, questo testo ottenne il parere
favorevole della Commissione affari costituzionali, considerato che i soggetti
anzi detti <<non svolgono professionalmente attività giurisdizionali ed è
quindi equo che si richieda ad essi un diverso grado di conoscenza della legge
e, di conseguenza, di diligenza>.
La rivalsa nei confronti dei giudici conciliatori e dei giudici popolari - come si legge nella relazione - fu limitata alla sola ipotesi di dolo, ritenendosi che essi non posseggano <<quelle cognizioni di diritto e quella specializzazione in materia di fatto che possano fondare la responsabilità per colpa grave>. Viceversa, per i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali, fu stabilita una responsabilità, in sede di rivalsa, anche nelle ipotesi indicate dalle lett. b) e c) dell'art. 2, riguardanti i più macroscopici errori di fatto, in quanto detti giudici <laici> sono da considerare esperti nelle materie in cui esercitano la funzione giurisdizionale, cosicché una loro totale irresponsabilità, in relazione agli errori di fatto, sarebbe apparsa ingiustificata. Giustificata fu ritenuta, invece, una loro completa irresponsabilità per gli errori, anche macroscopici, commessi nell'interpretazione della legge <non trattandosi di giuristi professionisti>.
Dall'assemblea fu approvato quest'ultimo testo, sia pur con discussioni.
Pertanto, tra la normativa proposta dal Ministro di grazia e giustizia (che prevedeva per i giudici conciliatori, i giudici popolari e gli <esperti>> chiamati a comporre gli organi collegiali una responsabilità solo per dolo e colpa grave per travisamento dei fatti) e quella adottata in un primo tempo, dalla Camera (che prevedeva per essi solo una responsabilità per dolo), è prevalsa una soluzione normativa intermedia, che ha previsto per i giudici conciliatori e i giudici popolari la sola responsabilità per dolo e per gli esperti chiamati a far parte degli organi collegiali, una responsabilità per dolo e travisamento dei fatti ai sensi dell'art. 2, comma terzo, lett. b) e c).
19. -Come emerge dall' esame degli atti parlamentari, sul tema in oggetto sono possibili scelte diverse da quelle adottate dal legislatore. Deve comunque riconoscersi la non irragionevolezza della previsione di una più circoscritta area di responsabilità per coloro che non hanno una specifica professionalità in relazione alle materie giuridiche. La legge n. 117 del 1988, limitando alle sole ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2, comma terzo, lett. b) e c), la responsabilità in sede di rivalsa dei <cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali>>, ha inteso riferirsi ad una vasta categoria di soggetti, chiamati a partecipare, occasionalmente o per periodi di tempo determinati, ad organi giudiziari collegiali, senza avere lo status di magistrato. Tali soggetti sono chiamati a comporre collegi che giudicano in materie, in relazione alle quali e necessaria una particolare preparazione tecnica: di regola non e richiesta, tra i requisiti in loro possesso, la laurea in giurisprudenza. Non e perciò irragionevole - come e stato osservato durante i lavori parlamentari-che essi siano responsabili dei più macroscopici errori di fatto, in quanto le loro particolari conoscenze tecniche sono richieste proprio in relazione agli accertamenti di fatto, e non e parimenti irrazionale che, non essendo provvisti di specifiche conoscenze di diritto, siano responsabili per le violazioni di legge solo in caso di dolo.
Esaminando specificamente la questione sollevata dal Tribunale di Bari, va rilevato che la sezione specializzata per le tossicodipendenze, competente a disporre gli interventi coattivi previsti dall'art. 100 della l. 22 dicembre 1975, n. 685, al fine della cura e del recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotropiche, è composta da un consigliere di corte d'appello che la presiede, da un giudice di tribunale e da due <esperti> designati dal Consiglio Superiore della Magistratura (art. 101, secondo comma, l. cit.).
Erroneamente il giudice a quo ritiene che la mancata previsione di una
pari responsabilità, in sede di rivalsa, per tutti i membri del collegio violi
gli artt. 101, comma secondo, 104, comma primo, 107, comma terzo e 108, comma secondo,
della Costituzione, alterando l'equilibrio del collegio, differenziando i
giudici in base ad un elemento diverso dalle funzioni e sottraendo alcuni di
essi allo specifico obbligo di osservanza della legge, al quale e correlata la
responsabilità ex art. 2, comma terzo, lett. c) della l. n. 117 del
La previsione costituzionale delle sezioni specializzate- come quella istituita dall'art. 101, secondo comma, della l. n. 685 del 1975 - delle quali fanno parte soggetti aventi una preparazione professionale ed uno status differenziati, implica che non può essere messa in dubbio di per sè la legittimità costituzionale di tali collegi. Parimenti, se del collegio possono legittimamente far parte soggetti con uno status ed una posizione professionale differenziata, debbono ritenersi legittime le norme che ne differenziano lo status in relazione alla diversa situazione professionale.
Unico limite al riguardo è dato dalla necessità che anche lo status degli <esperti> che fanno parte del collegio sia tale da garantirne l'indipendenza (art. 108, comma secondo, della Costituzione). Ma con questa esigenza non confligge la norma impugnata, la quale, regolando un aspetto dello status dei membri del collegio <estranei alla magistratura>, ne disciplina il regime di responsabilità in maniera diversa rispetto a quello previsto per i giudici <togati>, in coerenza con le rispettive attitudini tecniche, senza incidere minimamente sulla indipendenza di ciascun membro del collegio.
Neppure può ritenersi che la norma impugnata sostanzialmente sottragga gli <esperti> allo specifico dovere di osservare la legge, poiché essa introduce soltanto una diversa-e non irrazionale - diversificazione del regime di responsabilità, conseguente alla violazione di quell'obbligo. Neppure, infine, essa crea illegittime differenziazioni tra giudici, vietate dall'art. 107, terzo comma, della Costituzione, giacche il principio ivi stabilito, secondo il quale i giudici si distinguono solo <per diversità di funzioni>, implica che tra essi non si possono stabilire rapporti di gerarchia e non differenze, razionalmente non ingiustificate, nel regime di responsabilità.
20. - Parimenti non fondata è la questione sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Ravenna relativamente all'art. 7, terzo comma, della 1. n. 117 del 1988.
In proposito va precisato che - per attenersi ai limiti di rilevanza rispetto al giudizio a quo - la questione va esaminata con esclusivo riferimento ai componenti delle commissioni tributarie di primo grado.
Queste, a norma dell'art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, possono essere composte da uno o più sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati un presidente, un vicepresidente e quattro membri. Il presidente della commissione è scelto tra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio a riposo o fra gli intendenti e gli intendenti aggiunti di finanza a riposo. I presidenti delle sezioni e i vicepresidenti, oltre che fra tali categorie, possono essere scelti anche tra i laureati in giurisprudenza o in economia e commercio.
Gli altri membri della commissione sono scelti dal presidente del tribunale tra le persone designate dai consigli comunali dei comuni della circoscrizione, o inserite in elenchi formati dall'amministrazione finanziaria ed, eventualmente, in elenchi formati - a richiesta del presidente del tribunale -dalle camere di commercio e dai consigli degli ordini professionali degli avvocati, ingegneri, dottori commercialisti e ragionieri. Costoro debbono essere forniti (art. 4 d.P.R. n. 636 del 1972) di diploma d'istruzione secondaria di secondo grado di qualsiasi tipo. Il collegio giudicante decide con l'intervento del presidente o del vicepresidente e di due membri (art. 7, comma secondo, d.P.R. n. 636 cit.).
L'art. 10 del già richiamato d.P.R. n. 636 del 1972 statuisce che <i componenti delle commissioni tributarie hanno tutti identiche funzioni, indirizzate unicamente all'applicazione della legge in base all'obbiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione d'interessi territoriali, di categoria o di parte>.
La ratio di questa normativa va ricercata, oltre che nell’opportunità di integrare la composizione delle commissioni tributarie con <esperti> provenienti dall'amministrazione finanziaria, nella volontà del legislatore di realizzare, in materia di giustizia tributaria - attraverso la nomina di meta dei membri della commissione tra le persone inserite in elenchi formati dai consigli comunali - una varietà di provenienza dei membri, idonea a garantire l'adeguato esame delle questioni in una materia nella quale gli enti locali sono portatori di interessi particolarmente qualificati.
Questa Corte, investita in passato di questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina della composizione delle commissioni tributarie, in relazione agli artt. 102 e 108 della Costituzione, le ha ritenute non fondate (sentenze 7 giugno 1984, n. 154 e 24 novembre 1982, n. 196), affermando che le commissioni tributarie sono organi di giurisdizione speciale (sentenza 3 agosto 1976, n. 215), che la disciplina di esse, nel suo complesso, garantisce adeguatamente l'indipendenza dei componenti; che il meccanismo di nomina di questi ultimi - ancorché suscettibile di opportuni miglioramenti- e tale da fornire sufficienti garanzie della idoneità alle funzioni da svolgere.
Deve ritenersi - come già si è rilevato a proposito delle sezioni specializzate previste dall'art. 102, comma secondo, della Costituzione - che alla legittimità del carattere composito delle commissioni tributarie di primo grado consegue la non illegittimità di quelle differenze che, nella disciplina della responsabilità dei componenti del collegio, per gli errori compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, si connettano allo status di magistrati in servizio o di estranei all'amministrazione della giustizia. La differenza di status, alla quale si ricollega una specifica professionalità non soltanto in relazione agli accertamenti di fatto ma anche a quelli di diritto, giustifica infatti una differenziazione della responsabilità in relazione agli errori di fatto e all'applicazione della legge. Pertanto, l'art. 7, comma terzo, della l. n. 117 del 1988-applicabile ai membri delle commissioni tributarie di primo grado che, non essendo magistrati in servizio, rientrano nella categoria degli <estranei alla magistratura>-legittimamente differenzia il regime di responsabilità dei componenti delle commissioni tributarie di primo grado che non siano magistrati in servizio, da quello previsto in generale per questi ultimi.
Appare tutt'altro che irrazionale, infatti, che i membri delle commissioni tributarie, i quali non siano magistrati in servizio, rispondano in via di rivalsa solo nei casi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2, comma terzo, lett. b) e c), essendo tale normativa giustificata all'esigenza di trattare in maniera differenziata situazioni differenti. Né ciò dà luogo ad incongruenze e discriminazioni tra gli utenti della giustizia tributaria, rispondendo comunque, nei loro confronti, in via diretta lo Stato in tutte le ipotesi previste dall'art. 2 della l. n. 117 del 1988.
Vaga e imprecisata è la dedotta violazione del titolo quarto della Costituzione, mentre non pertinente è il profilo riguardante l'asserito contrasto della norma impugnata con gli artt. 24 e 25 della Costituzione, non limitando essa il diritto di agire e di difendersi in giudizio, né distogliendo alcuno dal giudice naturale precostituito per legge.
In conclusione, la censura promossa dalla Commissione tributaria di primo grado di Ravenna è infondata sotto ogni profilo.
21.-Infondata è anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma terzo, della l. n. 117 del 1988, sollevata dal Pretore onorario di Roma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto non limita la responsabilità dei vice pretori onorari ai soli casi di dolo, come prevede, invece, per i giudici conciliatori ed i giudici popolari.
Infatti, la differenza di trattamento appare giustificata dai diversi requisiti richiesti per la nomina a vice pretore onorario rispetto a quelli richiesti per la nomina a giudice conciliatore e giudice popolare.
A norma del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, possono essere nominati vice pretori onorari solo i laureati in giurisprudenza, i notai ed i procuratori legali. Viceversa, per la nomina dei giudici popolari delle Corti di assise (artt. 9 e 10 1. 10 aprile 1951, n. 287) non e necessario il possesso di specifiche cognizioni di diritto, essendo sufficiente l'aver conseguito un diploma di scuola media di primo grado o di secondo grado (a seconda che si tratti di Corte d'assise di primo grado o di appello). Lo stesso dicasi per la nomina dei giudici conciliatori, prescrivendo al riguardo l'art. 23 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 unicamente che la scelta debba cadere <su elementi capaci di assolvere adeguatamente, per requisiti d'indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario>.
Il possesso di specifiche conoscenze giuridiche da parte dei vice pretori onorari, che non sono richieste per la nomina a giudice popolare o a giudice conciliatore, costituisce un elemento di differenziazione rilevante rispetto al tema della responsabilità per gli errori compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni: esso, pertanto, e idoneo a giustificare la previsione, per i vice pretori onorari, di una più ampia responsabilità rispetto a quella stabilita per i giudici popolari ed i giudici conciliatori.
22.-Vanno esaminate da ultimo le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il primo e secondo comma dell'art. 16 della l. n. 117 del 1988 che hanno rispettivamente aggiunto all'art. 148 c.p.c. e all'art. 131 c.p.p. un comma contenente la seguente disposizione: <Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. II verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio>.
Tale disposizione (a norma dell'art. 16, comma terzo) si applica a tutti i provvedimenti dei giudici collegiali, aventi giurisdizione in materia penale e di prevenzione nonché ai provvedimenti dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia.
In caso di proposizione dell'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei componenti del collegio, a norma dell'art. 16, comma quinto, il tribunale dinanzi al quale l'azione è proposta chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale essa si riferisce e ne ordina l'acquisizione agli atti del giudizio.
23. - Il Tribunale di Roma, con ordinanze 29 aprile 1988 (R.O. n. 270 del 1988) e 4 maggio 1988 (R.O. n. 326 del 1988), e il Tribunale di Catanzaro con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 350 del 1988), hanno dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 anzi detto, nella parte in cui ha aggiunto all'art. 131 c.p.c. la disposizione relativa alla verbalizzazione dei provvedimenti collegiali.
Secondo i giudici a quibus l'art. 16, prevedendo tale verbalizzazione, contrasterebbe con gli artt. 101 e 104 della Costituzione. Infatti, essendo la verbalizzazione correlata alla divulgazione-in caso di giudizio di rivalsa dello Stato- delle posizioni assunte dai giudici al momento della deliberazione, la disposizione impugnata lederebbe il principio della segretezza della camera di consiglio (art. 276, comma primo, c.p.c.), il quale avrebbe rilievo costituzionale, perché diretto a garantire l'indipendenza del giudice, assicurando l'impersonalità della decisione, ritenuta una delle ragioni della collegialità.
Analoga questione e stata sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza 3 maggio 1988 (R.O. n. 448 del 1988) in riferimento al terzo comma dell'art. 16, che - come si è visto-estende la normativa sulla verbalizzazione dei provvedimenti a tutti gli organi giurisdizionali collegiali, ivi comprese le commissioni tributarie. Il giudice a quo, peraltro, mentre motiva la non manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 101 e 104 della Costituzione, menziona, nel dispositivo, quali parametri gli artt. 3, 97, 101 e 108 della Costituzione.
Il Tribunale di Catanzaro, con la citata ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 350 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della differenza di trattamento -ritenuta irrazionale - del segreto della camera di consiglio rispetto al segreto professionale (art. 351 c.p.p.).
La violazione dell'art. 3 della Costituzione e stata dedotta pure dalla Corte d'Appello di Trieste, che, con ordinanza 26 aprile 1988 (R.O. n. 382 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della l. n. 117 del 1988, nella parte in cui prevede la verbalizzazione delle decisioni relative ai provvedimenti giurisdizionali penali. Secondo il giudice a quo, la previsione della formalizzazione del dissenso deve intendersi correlata alle ipotesi di responsabilità per colpa grave previste dall'art. 2, comma terzo della legge, ma in relazione a queste essa sarebbe priva di razionalità. Infatti, <<qualora uno dei componenti abbia reso noto l'errore in cui il collegio stia per incorrere>, gli altri componenti non potrebbero ignorare il rilievo senza trasformare il proprio comportamento, precedentemente solo colposo, in doloso: peraltro, in tal caso <si sarebbe in presenza di comportamento integrante vera e propria ipotesi delittuosa, come tale ben diversamente riscontrabile e censurabile>.
Il Tribunale di Roma, con la citata ordinanza 29 aprile
Quest'ultimo rilievo è sviluppato dal Tribunale amministrativo regionale
per
Ciò sarebbe irrazionale, non essendovi motivo alcuno per verbalizzare la decisione ove sia stata presa all'unanimità ovvero col dissenso del relatore, risultando già tale dissenso dalla sentenza che, in casi del genere, (a norma dell'art. 118, ultimo comma, disp. att. c.p.c.) deve essere redatta da un altro componente del collegio, il quale la sottoscrive facendo espressa menzione di esserne l'estensore.
Per razionalizzare la normativa, anche secondo il Tribunale
amministrativo regionale per
L'art. 16 della l. n. 117 del 1988 è stato impugnato, infine, dal Tribunale di Roma, con la più volte citata ordinanza 29 aprile 1988 (R.O. n. 270 del 1988), dalla Corte d'Appello di Trieste con la già menzionata ordinanza 26 aprile 1988 (R.O. n. 382 del 1988) e (seppur immotivatamente sul punto) dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con la citata ordinanza 3 maggio 1988 (R.O. n. 448 del 1988), in riferimento all'art. 97 della Costituzione.
Il Tribunale di Roma e
24. -Il tema della responsabilità degli organi collegiali è uno dei più delicati dell'intera materia della responsabilità civile del giudice.
Riaffiorano in esso, con particolare intensità, i problemi della natura della deliberazione collegiale, del contributo del membro dissenziente, del meccanismo di riferimento al collegio della deliberazione non unanime. Tali temi concernenti la struttura dell'atto-caratterizzato dal particolare legame che la natura e l'esercizio della funzione determinano tra i membri del collegio-si riflettono, a loro volta, sulla disciplina della responsabilità civile del giudice. Le diverse vicende applicative, che hanno in ogni tempo caratterizzato questa materia e coinvolto la giustificazione, il contenuto, i limiti e le modalità del risarcimento per fatto illecito del giudice (cfr. spec. nn. 3, 4 e 5), sono emerse in tutta la loro pienezza nella elaborazione della normativa della l. n. 117 del 1988.
E' stato osservato che, al riguardo, affiora anzitutto l'esigenza di non sottrarre i componenti degli organi collegiali all'azione di rivalsa, <per non creare nell'ambito della magistratura un'area d'immunità politicamente inopportuna e non compatibile col principio di uguaglianza> (cfr. il parere del Consiglio Superiore della Magistratura sul disegno di legge governativo e la relazione a quest'ultimo). In secondo luogo, va anche soddisfatta l'esigenza di assicurare ai membri del collegio che, pur avendo partecipato alla decisione, non l'abbiano condivisa-essendo restati in minoranza-uno strumento che consenta di dimostrare il loro dissenso e non essere soggetti all'azione di rivalsa.
Il disegno di legge governativo si era fatto carico della prima esigenza, ma non della seconda, limitandosi a stabilire (art. 8) che le disposizioni sull'azione di rivalsa <si applicano anche ai magistrati che esercitano le loro funzioni in organi collegiali>.
Lo stesso aveva fatto
In assemblea sorsero vivaci contrasti, sottolineandosi il carattere personale che deve avere la responsabilità, disatteso da tale normativa. Ciò condusse, pero, solo alla soppressione del testo dell'art. 10 proposto dalla Commissione giustizia della Camera e all'inserimento nell'art. 1-che regola l'ambito di applicazione della legge - dell'attuale secondo comma, che rende applicabili le disposizioni della legge stessa <anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali>. Prevalse, cioè, l'opinione che dovesse essere affidata alla futura elaborazione giurisprudenziale l'identificazione in concreto <delle forme di responsabilità che possono configurarsi per gli organi collegiali> e la definizione dei meccanismi <che potranno presiedere all'individuazione delle posizioni eventualmente dissenzienti>.
I rilievi critici già emersi nella discussione alla Camera dei deputati-secondo i quali il Parlamento non poteva eludere, rimettendola alla magistratura, l'individuazione dei meccanismi di prova della responsabilità dei singoli membri del collegio, col rischio di una sostanziale esclusione della responsabilità per taluni componenti gli organi collegiali, ovvero della configurazione di una loro responsabilità oggettiva - indussero il Senato a prevedere e disciplinare la verbalizzazione del dissenso di taluno dei membri del collegio (art. 18 del testo del disegno di legge approvato dal Senato in prima lettura) con una norma analoga a quella ora impugnata.
Alla Camera - alla quale la legge era ritornata in seconda lettura-sorsero pero nuovi contrasti sul punto. Prevalse l'opinione che la possibilità di rendere pubblici le opinioni e i voti espressi in camera di consiglio, avrebbe potuto condizionare la <libertà di decisione> dei giudici, dando inoltre luogo ad un numero immenso di verbalizzazioni, che avrebbe gravemente appesantito l'attività giudiziaria. Pertanto la norma sulla verbalizzazione delle decisioni degli organi collegiali fu soppressa.
Reinserita dal Senato, nel testo ora vigente (art. 16), fu infine definitivamente approvata anche dalla Camera.
Come si vede, la norma impugnata (che e riprodotta nell'art. 125 del nuovo codice di procedura penale) e stata approvata tra incertezza, contrasti e ripensamenti, che dimostrano la difficoltà di contemperare collegialità e responsabilità del giudice, in un quadro rispettoso, ad un tempo, di divergenti esigenze, di non facile composizione.
L'ultimo comma dell'art. 16 prevede che <con decreto del Ministro di grazia e giustizia vengono definiti i modelli dei verbali di cui ai commi 1, 2 e 3 e determinate le modalità di conservazione dei plichi sigillati, nonché della loro distruzione quando sono decorsi i termini previsti dall'art. 4>.
Tale decreto è stato emanato in data 16 aprile 1988 e con esso sono state stabilite le modalità di attuazione dell'art. 16 della l. n. 117 del 1988, precisandosi i relativi adempimenti e predisponendosi nove tipi di modelli di processo verbale, in relazione ai vari tipi di giudizio.
25. - Tra le questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione all'art. 16 vanno innanzitutto dichiarate non fondate quelle sollevate dai Tribunali di Roma e di Catanzaro e dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma - in riferimento agli artt. 101 e 104 della Costituzione - sotto il profilo che l'art. 16, incidendo sulla segretezza della camera di consiglio, comprometterebbe l'indipendenza del giudice e l'imparzialità del giudizio.
Invero, nel nostro ordinamento costituzionale non esiste un nesso
imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza, nel senso indicato
nelle ordinanze di rimessione, cioè quale mezzo per assicurare l'indipendenza
attraverso l'impersonalità della decisione.
A quest'ultimo principio non contraddice la conoscibilità dell'operato anche di ciascun componente gli organi giudiziari collegiali e quindi la deroga, quanto meno nei limiti a ciò necessari, al segreto della camera di consiglio. Tale segreto -fuori di detti limiti-costituisce pertanto materia di scelta legislativa e nulla ha a che vedere con la garanzia dell'indipendenza dei giudici. E' da ribadire, al riguardo, che l'indipendenza è un valore morale, che si realizza in tutta la sua pienezza, proprio quando si esplica nella trasparenza del comportamento.
Parimenti - e per le stesse ragioni - va dichiarata non fondata la medesima questione proposta, senza ulteriori motivazioni, dalla commissione tributaria di primo grado di Roma anche con riferimento agli artt. 3 e 108 della Costituzione.
26.-Va pure dichiarata non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Catanzaro, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della diversa differenza di tratta mento, ritenuta irrazionale, del segreto della camera di consiglio rispetto al segreto professionale. Trattasi, infatti, di situazioni non omogenee e quindi non comparabili.
Non fondata è pure la questione sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della differenza di trattamento fra deliberazioni degli organi giudiziari collegiali e deliberazioni degli organi collegiali amministrativi o legislativi. Tali situazioni, infatti, non sono parimenti comparabili tenuto conto che le deliberazioni delle Camere, di regola, non sono segrete; che i membri di esse non sono perseguibili <per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni> (art. 68, comma primo, della Costituzione); che anche le deliberazioni degli organi collegiali amministrativi, di regola, non sono segrete (tranne che per le questioni concernenti le persone) e che, comunque, ogni membro può far constare nel verbale del suo voto e dei motivi che l'hanno determinato (cfr. art. 281, R D 3 marzo 1934, n. 383, t.u. legge comunale e provinciale).
Non fondata è, infine, anche la questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, sul presupposto che la norma impugnata prevederebbe la verbalizzazione del dissenso soltanto in relazione alle ipotesi stabilite dall'art. 2 della l. n. 117 del 1988.
L'ordinanza muove, infatti, da un'affermazione erronea, poiché l'art. 16 della l. n. 117 del 1988 prevede la verbalizzazione non soltanto in relazione a dette ipotesi. Comunque - come anche appresso si dirà-se ciò fosse, la norma non sarebbe irrazionale, essendo proprio e soltanto riguardo a dette ipotesi necessaria la documentazione dell'eventuale dissenso di uno o più membri del collegio, in relazione alla responsabilità che ne potrebbe derivare.
27.-Fondata è invece la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 sollevata dal Tribunale di Roma, dalla Corte d'Appello di Trieste e dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo che il sistema di verbalizzazione previsto dalla norma impugnata incide negativamente sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il che comporta l'assorbimento degli ulteriori profili d'illegittimità prospettati in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'art. 97 della Costituzione, nello stabilire che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento dell'amministrazione, non ha inteso riferirsi ai soli organi della pubblica amministrazione in senso stretto, ma anche agli organi dell'amministrazione della giustizia (Corte cost. 7 maggio 1982, n. 86).
L'art. 16 della l. n. 117 del 1988 prevede la compilazione di un sommario processo verbale, che deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, <su ciascuna delle questioni decise>, con l'indicazione nominativa di ogni componente del collegio che lo abbia espresso. Il che comporta una continua attività di verbalizzazione da parte dei collegi giudicanti, in relazione a qualsiasi questione decisa, sia essa pregiudiziale, preliminare, di diritto o di fatto, a prescindere dall'esistenza del dissenso di alcuno dei membri del collegio, della rilevanza del dissenso ai fini di eventuali azioni di responsabilità e dalla richiesta di verbalizzazione da parte dell'interessato. Ciò implica un intralcio costante all'attività giudiziaria, incompatibile col principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia e non giustificato dalle finalità che la norma intende realizzare.
Tale norma va dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede la compilazione obbligatoria del processo verbale in relazione ad ogni deliberazione del collegio, anziché la compilazione facoltativa di esso nelle sole ipotesi in cui la richiedano uno o più membri del collegio medesimo.
Il contenuto del primo comma dell'art. 16, che riguarda il processo penale, come si e già rilevato, e riprodotto nell'art. 125 del nuovo codice di procedura penale: alla necessaria modifica di quest'ultima norma, nei sensi di cui alla presente decisione, il Governo provvederà nell'esercizio della delega per l'adeguamento della nuova normativa ai sensi dell'art. 7 della l. 16 febbraio 1987, n. 81.
E' da rilevare infine che la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 16, operata dalla presente decisione, non comporta la stessa declaratoria per il terzo comma, il quale va ora letto secondo la modificazione dei predetti due commi ad opera di questa stessa decisione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, dell'art. 16 della l. 13 aprile 1988, n. 117 (<<Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati>) nella parte in cui dispongono che <<e compilato sommario processo verbale> anziché <può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale>;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale della legge 13 aprile 1988, n. 117-nella parte in cui disciplina
la responsabilità civile dei magistrati - sollevata dal Tribunale
Amministrativo Regionale per
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 della 1. 13 aprile 1988, n. 117, sollevate dal Tribunale di Catanzaro con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 350 del 1988), dal Tribunale di Roma con ordinanze 28 aprile 1988 (R.O. n. 270 del 1988) e 4 maggio 1988 (R.O. n. 326 del 1988), dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinanza 3 maggio 1988 (R.O. n. 448 del 1988) e della Corte d'Appello di Trieste con ordinanza 26 aprile 1988 (R.O. n. 382 del 1988) in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, 2 e 16 della l. 13 aprile 1988, n. 117, nonché dell'art. 131 c.p.c., come modificato dall'art. 16 della stessa legge, sollevata dal Tribunale di Biella, con ordinanza 10 maggio 1988 (R.O. n. 327 del 1988), in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione;
dichiara non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevata dal Pretore onorario di Roma con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 327 del 1988), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevata dal Tribunale di Bari con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 396 del 1988), in riferimento agli artt. 101, 104 e 108 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7, terzo comma e 8, quarto comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Ravenna con ordinanza 28 aprile 1988 (R.O. n. 422 del 1988), in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, e all'intero titolo quarto della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/01/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 18/01/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE