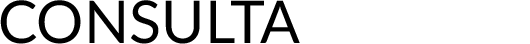ORDINANZA N. 196
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, come sostituiti dall’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promossi con ordinanze del 27 settembre 2005 dal Tribunale di Milano e del 1° giugno 2005 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Potenza, nei procedimenti penali a carico di D.U.M. ed altri e di S.F. ed altri, iscritte al n. 568 del registro ordinanze 2005 ed al n. 15 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2005 e n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con la prima delle ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 11 e 117 della Costituzione, nonché all’art. 6 della direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968 del Consiglio (intesa a coordinare, rendendole equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’art. 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi: cosiddetta prima direttiva in materia di società) e all’art. 5 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (ora art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità europea), questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, come sostituiti dall’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);
che il Tribunale rimettente premette di essere investito del processo penale nei confronti di tre persone imputate, tra l’altro, di reati di «falso in bilancio» commessi fino al 1993: fatti originariamente puniti dagli artt. 2621 e 2640 cod. civ. ed in relazione ai quali – dopo la riforma dei reati societari attuata dal d.lgs. n. 61 del 2002 – era stata contestata la violazione del nuovo art. 2622 cod. civ. («false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori»);
che il giudice a quo riferisce, altresì, di aver precedentemente sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, alcune questioni pregiudiziali attinenti all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva 68/151/CEE e dell’art. 5 del Trattato CEE, nonché alla compatibilità con tali disposizioni dei nuovi artt. 2621 e 2622 cod. civ.;
che alla Corte europea era stato chiesto, in particolare, di chiarire: a) se l’art. 6 della prima direttiva – nell’imporre agli Stati membri di prevedere «adeguate sanzioni» per i casi di «mancata pubblicità del bilancio e del conto dei profitti e perdite» – obbligasse gli Stati membri a sanzionare in modo adeguato anche la falsificazione degli anzidetti documenti contabili; b) se, a tali fini, il concetto di «sanzione adeguata» dovesse essere inteso – anche ai sensi dell’art. 5 del Trattato CEE (ora art. 10 del Trattato CE) – nel senso di sanzione «efficace, effettiva, realmente dissuasiva», avuto riguardo al concreto panorama normativo, sia sostanziale che processuale, del singolo Stato membro; c) se, infine, le caratteristiche di adeguatezza dianzi indicate fossero riscontrabili nelle sanzioni previste dai novellati artt. 2621 e 2622 cod. civ.;
che il dubbio circa la conformità delle disposizioni interne alle richiamate norme comunitarie, ove interpretate nel senso indicato nei primi due quesiti, discenderebbe – ad avviso del rimettente – da una duplice considerazione;
che, in primo luogo, i reati di falso in bilancio non produttivi di danno patrimoniale ai soci o ai creditori – ovvero produttivi di danno patrimoniale, ma non perseguibili ai sensi dell’art. 2622 cod. civ., per difetto della querela richiesta da tale norma, ove il fatto sia commesso nell’ambito di società non quotate in borsa (più precisamente: di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52») – risultano configurati dall’art. 2621 cod. civ. quale mero illecito contravvenzionale;
che tale configurazione implica non soltanto la comminatoria di pene – secondo il rimettente – «risibili», ma anche l’assoggettamento della fattispecie criminosa ad un termine di prescrizione comunque non superiore a quattro anni e sei mesi, tenuto conto del massimo prolungamento possibile in conseguenza di atti interruttivi;
che la brevità di tale termine impedirebbe, in concreto, di concludere il processo prima dell’estinzione del reato: e ciò in considerazione tanto delle garanzie offerte dal nostro sistema processuale, che contempla tre gradi di giudizio; quanto della particolare complessità dell’accertamento dell’illecito, il quale richiede indagini «di tipo contabile ed economico»: complessità peraltro accresciuta dal fatto che – in deroga all’art. 42, quarto comma, del codice penale – la contravvenzione di cui all’art. 2621 cod. civ. non soltanto non risulta punibile a titolo di mera colpa, ma richiede addirittura un dolo specifico, di non agevole dimostrazione;
che, in secondo luogo, per il falso in bilancio causativo di danno ai soci o ai creditori – punito dall’art. 2622 cod. civ. come delitto e con pena più energica – è prevista, nel caso di fatto commesso nell’ambito di società non quotate, la procedibilità a querela: con conseguente subordinazione dell’esercizio dell’azione penale alla volontà della persona offesa, pur in presenza di una lesione del bene – collettivo e tipicamente indisponibile – della «trasparenza» del «mercato societario»;
che la Corte di giustizia delle Comunità europee – prosegue il giudice rimettente – si è pronunciata sulla predetta richiesta di interpretazione in via pregiudiziale e su analoghe richieste formulate da altre autorità giudiziarie italiane con sentenza 3 maggio 2005, nei procedimenti riuniti C-387/02, C-391/02 e C-403/02, rispondendo in modo inequivocamente affermativo ai primi due quesiti dianzi ricordati;
che la Corte europea ha infatti riconosciuto, da un lato, che l’art. 6 della prima direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere adeguate sanzioni non soltanto per la mancata pubblicità, ma anche per la falsificazione dei bilanci; e, dall’altro lato, che il connotato dell’«adeguatezza» implica che, «pur conservando la scelta delle sanzioni», gli Stati membri debbono conferire alla sanzione prescelta «un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo»;
che la Corte di Lussemburgo – osserva il giudice a quo – non si è pronunciata, invece, sull’ultimo quesito ad essa sottoposto, inerente alla adeguatezza o meno delle sanzioni previste dagli artt. 2621 e 2622 cod. civ.: concludendo nel senso che, «in circostanze come quelle in questione nelle cause principali», la direttiva 68/151/CEE «non può essere invocata in quanto tale dalle autorità di uno Stato membro nei confronti degli imputati nell’ambito di procedimenti penali»;
che tale conclusione risulterebbe basata – apparentemente – su un duplice ordine di motivi: e, cioè, da un lato, sull’asserita esistenza di un principio generale di diritto comunitario – mutuato dalle «tradizionali costituzionali comuni agli Stati membri» – di «applicazione retroattiva della pena più mite» (discutendosi, nei giudizi principali, di fatti commessi sotto il vigore della più severa disciplina prevista dall’originario art. 2621 cod. civ., ma ai quali – in base all’art. 2 cod. pen. – dovrebbero comunque applicarsi le nuove e più favorevoli disposizioni degli artt. 2621 e 2622 cod. civ.); dall’altro lato, sulla impossibilità di invocare le direttive comunitarie, in difetto di una legge nazionale di attuazione, al fine di determinare o aggravare la responsabilità penale di singoli soggetti;
che in realtà – rileva ancora il rimettente – a prescindere dalle perplessità generate dalla prima delle due affermazioni ora ricordate, la stessa Corte di giustizia delle Comunità europee si è espressamente chiesta se il principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite sia destinato a valere anche quando quest’ultima risulti contraria ad altre norme di diritto comunitario: ma ha ritenuto non necessario risolvere tale questione «ai fini delle controversie principali», in quanto la norma comunitaria di cui si discute «è contenuta in una direttiva fatta valere nei confronti di un soggetto dall’autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali»;
che, per costante giurisprudenza della stessa Corte di giustizia, infatti, una direttiva comunitaria non può, in difetto di una legge nazionale di adeguamento, creare obblighi a carico di un soggetto e, in particolare, determinare nei suoi confronti effetti in malam partem di natura penale;
che dall’iter argomentativo ora esposto si desumerebbe, dunque, che l’effettiva ragione della dichiarata inapplicabilità della prima direttiva nel caso in questione non risiede nell’esigenza di evitare che si producano conseguenze contrastanti con il principio di retroattività della lex mitior; bensì soltanto nel fatto che la direttiva stessa – in quanto non «dettagliata» – è priva di efficacia diretta nell’ordinamento nazionale, richiedendo un intervento legislativo interno di attuazione;
che tale circostanza impedirebbe, altresì, al giudice nazionale di «disapplicare», di propria iniziativa, le norme interne incompatibili con le regole comunitarie, come sarebbe invece possibile e doveroso – in base alla giurisprudenza tanto della Corte di giustizia che della Corte costituzionale – qualora si fosse al cospetto di una direttiva cosiddetta «self executing»;
che, su tali premesse, il Tribunale rimettente ritiene, quindi, che la via onde rimuovere il denunciato contrasto con il diritto comunitario sia rappresentata dalla proposizione della questione incidentale di legittimità costituzionale dei nuovi artt. 2621 e 2622 cod. civ. per violazione degli artt. 10, 11 e 117 Cost., stante la «totale inadeguatezza» delle norme censurate «a sanzionare in modo efficace e dissuasivo le condotte colpevoli ivi previste», così come richiesto dall’art. 6 della prima direttiva e dall’art. 5 del Trattato CEE (ora art. 10 del Trattato CE);
che anche in presenza di una direttiva comunitaria non «dettagliata», ma comunque inequivoca nella sua interpretazione, il legislatore sarebbe infatti tenuto ad uniformare ad essa l’ordinamento interno; onde il mancato adeguamento si tradurrebbe in un atto suscettibile di censura, alla stregua degli evocati parametri costituzionali;
che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo ricorda come questa Corte, con la sentenza n. 148 del 1983, abbia ritenuto suscettibili di scrutinio di costituzionalità, anche in malam partem, le cosiddette «norme penali di favore»: tali dovendo qualificarsi, in assunto, le disposizioni censurate, le quali – ponendosi in linea di continuità normativa con il previgente art. 2621, numero 1), cod. civ. – hanno introdotto un trattamento sanzionatorio «più favorevole» per i fatti da esse contemplati;
che – alla stregua di quanto affermato nella citata sentenza n. 148 del 1983 – la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme penali di favore, pur non potendo produrre retroattivamente conseguenze negative per il reo, può sempre incidere «sul dispositivo e sulla “ratio decidendi”» della sentenza penale emessa nei suoi confronti, spettando al giudice a quo stabilire in qual modo il sistema giuridico debba reagire all’annullamento della norma di favore;
che nella specie, peraltro, trattandosi di fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore delle disposizioni impugnate, la dichiarazione di incostituzionalità di queste ultime consentirebbe, «con ogni probabilità» – secondo il giudice rimettente – di sottoporre a pena gli imputati sulla base del previgente art. 2621 cod. civ.;
che l’eventuale ablazione delle norme incriminatrici censurate, difatti, non comporterebbe necessariamente la totale perdita di rilevanza penale delle false comunicazioni sociali (abolitio criminis): potendosi ipotizzare, al contrario, che la rimozione della norma sopravvenuta più mite determini la «reviviscenza» di quella pregressa, in vigore al momento della commissione dei fatti oggetto di giudizio;
che tale soluzione si imporrebbe alla luce di una lettura «più attenta» dell’art. 2, terzo comma, cod. pen., a fronte della quale la norma posteriore più favorevole prevarrebbe su quella del tempo del commesso reato solo se «ancora vigente», e non, dunque, ove la stessa venga rimossa a seguito di accertata incostituzionalità: e ciò anche per una esigenza di rispetto del principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., onde evitare che si ricorra all’emanazione di una lex mitior a fini di riduzione dell’area di rilevanza penalistica, in luogo di percorrere altre strade «più aderenti allo spirito costituzionale» (quale, ad esempio, la concessione di un’amnistia);
che, in ogni caso – conclude il rimettente – quando pure l’ablazione delle norme censurate determinasse la “drastica” conseguenza di una totale abolitio della fattispecie criminosa considerata, tale circostanza «non rileverebbe nel procedimento a quo, se non nel determinare una diversa formula definitoria dei fatti contestati»;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;
che, con la seconda delle ordinanze indicate in epigrafe – pervenuta alla Corte il 16 gennaio 2006 – il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost. e all’art. 6 della direttiva 68/151/CEE, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.lgs. n. 61 del 2002, nella parte in cui, nel disciplinare la fattispecie criminosa delle «false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori», di cui al novellato art. 2622 cod. civ.:
a) esclude la punibilità dei fatti previsti dal primo e dal terzo comma se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, o comunque determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento (art. 2622, quinto comma, cod. civ.);
b) stabilisce che il fatto non è, in ogni caso, punibile «se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta» (art. 2622, sesto comma, cod. civ.);
c) prevede, per il reato di falso in bilancio commesso nell’ambito di società non quotate in borsa, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
che il giudice rimettente – chiamato a celebrare l’udienza preliminare nei confronti di persone imputate del reato di cui all’art. 2622 cod. civ. (donde la limitazione a tale norma delle censure di costituzionalità) – assume che il regime punitivo previsto dalla disposizione denunciata non presenti le caratteristiche di efficacia, proporzionalità e dissuasività che, in base all’art. 6 della prima direttiva, deve possedere la sanzione diretta a reprimere la pubblicazione di bilanci falsi, così come chiarito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza 3 maggio 2005, nei procedimenti riuniti C-387/02, C-391/02 e C-403/02;
che, difatti, una pena edittale non superiore nel massimo a tre anni di reclusione – pena che consente, dunque, il «patteggiamento» e che è suscettibile, di norma, di sospensione condizionale, in assenza di precedenti penali e con il riconoscimento delle attenuanti generiche – non potrebbe essere considerata proporzionata rispetto ad un reato plurioffensivo, quale quello in discorso, che lede non soltanto l’interesse patrimoniale dei soci e dei creditori sociali, ma anche l’affidamento dei terzi nella fedele rappresentazione delle condizioni economico-finanziarie della società;
che l’applicazione della predetta pena, d’altra parte, resta comunque esclusa qualora non si sia verificata, in conseguenza della condotta illecita, una sensibile alterazione della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, ovvero non venga accertato il superamento di «soglie di tolleranza» a carattere percentuale: e ciò sebbene la lesione del bene tutelato si connetta, in ogni caso, alla semplice intenzionale falsificazione dei dati contabili;
che la pena prevista dall’art. 2622 cod. civ. risulterebbe carente anche sul piano dell’efficacia dissuasiva: efficacia da valutare con riferimento non soltanto al tipo e alla misura della sanzione, ma anche alla probabilità che la stessa possa essere irrogata in concreto;
che, a fronte del limite edittale massimo di tre anni, il reato risulterebbe soggetto, infatti, ad un termine di prescrizione comunque non superiore – anche in presenza di atti interruttivi – a sette anni e mezzo: termine da reputare inidoneo ad assicurare la punizione dei colpevoli, per la sua eccessiva brevità;
che il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori si consuma, infatti, con il deposito del bilancio, dal quale inizia pertanto a decorrere il termine di prescrizione; la notitia criminis, tuttavia, viene di regola acquisita solo a distanza di tempo, a seguito di «verifiche ispettive»: d’altro canto, sia l’attività di indagine che quella di acquisizione della prova in dibattimento presuppongono l’esame di «copiosa documentazione» e l’espletamento di complesse consulenze contabili;
che ove si consideri, poi, che la definizione del procedimento passa, di norma, attraverso tre gradi di giudizio e che il reato rientra nella cognizione del giudice collegiale, con la conseguente necessità di celebrare l’udienza preliminare, apparirebbe estremamente improbabile che il reato in parola venga accertato con sentenza irrevocabile prima dello spirare del termine di prescrizione;
che sotto diverso profilo, poi, la circostanza che la Corte di giustizia, nella citata sentenza 3 maggio 2005, abbia escluso la diretta operatività della prima direttiva all’interno dell’ordinamento italiano, non implicherebbe l’irrilevanza del riscontrato contrasto con la norma comunitaria;
che l’impossibilità di applicare in modo immediato l’art. 6 della prima direttiva nell’ordinamento interno deriverebbe, in effetti, da una duplice ragione: e, cioè, sia dal fatto che una direttiva comunitaria non può mai determinare, di per sé – indipendentemente dall’adozione di una legge interna di attuazione – un aggravamento della responsabilità penale dell’imputato; sia dalla circostanza che il citato art. 6 non costituisce norma «autoapplicativa», in quanto – nell’imporre agli Stati membri di prevedere «adeguate sanzioni» per i casi di mancata pubblicità dei conti annuali – lascia ai singoli Stati un certo margine di discrezionalità nella scelta degli strumenti per la sua attuazione;
che, in simile situazione, non sarebbe dunque consentito al giudice italiano «disapplicare» sic et simpliciter le disposizioni della legge interna contrastanti con la norma comunitaria in parola, come viceversa è possibile – alla luce della giurisprudenza costituzionale – ove il contrasto si manifesti in rapporto ad una norma comunitaria immediatamente efficace nell’ordinamento nazionale (quali quelle contenute in regolamenti comunitari o anche in direttive, purché «self executing»);
che il vulnus del precetto comunitario andrebbe fatto valere, per contro, mediante proposizione di questione incidentale di legittimità costituzionale, sotto il profilo della violazione dei principi posti tanto dall’art. 11 Cost., il quale vincola lo Stato all’osservanza degli impegni assunti con l’adesione alla Comunità europea; quanto dall’art. 117 Cost. (come sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che impone espressamente allo Stato e alle Regioni di esercitare la potestà legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria;
che quanto, poi, alla rilevanza della questione, il rimettente osserva che, nella specie, gli imputati sono chiamati a rispondere del reato di cui all’art. 2622 cod. civ. per fatti commessi sotto il vigore dell’art. 2621 cod. civ. nella sua originaria formulazione;
che si tratta, in particolare, di falsi in bilancio commessi al termine degli esercizi 1996, 1997 e 1998, in relazione ad alcuni dei quali il termine di prescrizione potrebbe essere già maturato o prossimo a scadere; e per i quali, comunque, sarebbe necessaria la valutazione – non effettuata nel corso delle indagini preliminari, in quanto concluse prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina – del superamento delle «soglie di tolleranza» attualmente previste dall’art. 2622 cod. civ.: valutazione che allungherebbe notevolmente i tempi di definizione dell’udienza preliminare e condurrebbe verosimilmente ad una pronuncia di estinzione del reato per lo spirare, medio tempore, dei termini di prescrizione;
che l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata inciderebbe, dunque – secondo il rimettente – sull’esito del procedimento: giacché, provocando la cessazione ex tunc dell’efficacia di detta norma, essa determinerebbe la «riespansione» della norma incriminatrice del falso in bilancio nella sua originaria formulazione; con conseguente operatività del termine di prescrizione di dieci anni (prolungabili fino a quindici in presenza di atti interruttivi) e con il riconoscimento della completezza dell’attività di indagine espletata, ai fini della decisione;
che l’applicazione agli attuali imputati dell’art. 2621 cod. civ., nel testo originario, sarebbe d’altra parte possibile – pur trattandosi di norma meno favorevole di quella sottoposta a scrutinio di costituzionalità – proprio perché i fatti contestati risultano commessi nel vigore della disposizione più severa: onde l’operazione non comporterebbe alcuna lesione del principio «nullum crimen nulla poena sine lege», sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni in larga misura analoghe, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è intervenuta la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005, il cui art. 30 ha sostituito le norme impugnate, modificando l’assetto delle figure criminose in esame in rapporto a diversi profili investiti dalle censure di costituzionalità (risposta sanzionatoria, impunità dei fatti che restino al di sotto delle «soglie» di rilevanza penale e, indirettamente, prescrizione);
che il nuovo testo degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, quale risultante a seguito della citata legge – oltre ad includere fra i soggetti attivi dei reati anche i «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari» (nuova figura introdotta dall’art. 14, comma 1, lettera n, della stessa legge n. 262 del 2005); e ad inserire fra i soggetti passivi del danno penalmente rilevante, in rapporto al delitto di cui all’art. 2622 cod. civ. (e dunque titolari del diritto di querela), anche la società – prevede, infatti, rispetto al testo immediatamente precedente, oggetto dell’impugnativa, una pena più elevata nel massimo per la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 2621 cod. civ. (arresto fino a due anni, anziché fino ad un anno e sei mesi); e una pena specifica e più severa (reclusione da due a sei anni) per i fatti delittuosi commessi nell’ambito di società quotate che abbiano cagionato «un grave nocumento ai risparmiatori» (art. 2622, quarto e quinto comma, cod. civ.);
che le nuove norme prevedono, inoltre, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, unitamente a misure di tipo interdittivo, nei confronti degli amministratori e degli altri soggetti qualificati autori di falsità, quando queste ultime non siano punibili come reato: o perché non produttive di una alterazione «sensibile» della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale quest’ultima appartiene; ovvero perché rimaste comunque al di sotto delle «soglie», a carattere percentuale, di rilevanza penale del fatto (artt. 2621, ultimo comma, e 2622, ultimo comma, cod. civ.);
che tale ultima previsione si presta, d’altro canto, a rendere applicabile alle falsità ora indicate la disciplina generale della prescrizione stabilita in rapporto alle violazioni amministrative dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la quale, oltre a contemplare un termine quinquennale, rinvia alle norme del codice civile in tema di interruzione, in forza delle quali la prescrizione non corre nel corso del giudizio (art. 2945 cod. civ.);
che le neointrodotte sanzioni amministrative non sono poi, ovviamente, suscettibili di sospensione condizionale: istituto la cui applicabilità è addotta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Potenza tra gli argomenti a comprova del carattere non efficace e proporzionato della pena prevista dall’art. 2622 cod. civ.;
che, per altro verso, l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano non specifica se, nel caso concreto, le soglie di rilevanza penale del fatto risultino o meno superate; mentre quella del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Potenza riferisce che tale dato è ignoto e che occorrerebbe accertarlo;
che, avuto riguardo anche al particolare parametro evocato (l’asserita contrarietà al disposto dell’art. 6 della direttiva 68/151/CEE), il quale postula una valutazione di «adeguatezza» di risposte sanzionatorie non predefinite, compete quindi ai giudici rimettenti verificare se – anche alla luce dei principi in tema di successione delle leggi penali (concernendo i giudizi principali fatti commessi sotto il vigore dell’originaria disciplina di cui all’art. 2621, numero 1, cod. civ. e, dunque, in epoca anteriore ad entrambi gli interventi novativi succedutisi nel tempo) – le questioni sollevate restino o meno rilevanti alla luce dello ius superveniens;
che tale verifica appare tanto più necessaria a fronte del fatto che ambedue i rimettenti sollevano le questioni nella convinzione che l’eventuale rimozione delle norme denunciate – gli artt. 2621 e 2622 cod. civ., come sostituiti dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 – farebbe “rivivere” (o potrebbe far “rivivere”, secondo il Tribunale di Milano) l’art. 2621 cod. civ. nella previgente formulazione; con conseguente automatico “ripristino” di una situazione di rispetto del diritto comunitario (essendo, quella previgente, una norma in assunto “comunitariamente adeguata”);
che una simile convinzione si basa sull’implicito presupposto che l’invocata declaratoria di costituzionalità verrebbe a travolgere, oltre alle norme impugnate in quanto tali, anche l’effetto abrogativo da esse prodotto sulla norma anteriore: la quale ultima, d’altro canto, potrebbe essere applicata nei giudizi a quibus senza alcuna compromissione del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, di cui agli artt. 25, secondo comma, della Costituzione e 2, primo comma, del codice penale, in quanto i fatti sono stati commessi nel tempo della sua vigenza;
che, peraltro – a prescindere da ogni considerazione circa l’effettiva ammissibilità dell’intervento di reintroduzione di una fattispecie criminosa abrogata o modificata dal legislatore, che in tal modo viene sostanzialmente richiesto a questa Corte (e ciò anche alla luce di quanto precisato nella sentenza n. 394 del 2006, successiva alle ordinanze di rimessione) – appare evidente come la sequenza di effetti prospettata dai rimettenti non sia più ipotizzabile dopo la sopravvenienza della legge n. 262 del 2005;
che la ventilata “reviviscenza” dell’originario art. 2621 cod. civ. non potrebbe, infatti, comunque discendere dalla rimozione delle norme “intermedie” di cui agli artt. 2621 e 2622 cod. civ., come sostituiti dal d.lgs. n. 61 del 2002, proprio perché nel frattempo è intervenuta una successiva legge, che ha introdotto un ulteriore e diverso testo delle norme denunciate (artt. 2621 e 2622 cod. civ., come sostituiti dalla legge n. 262 del 2005): testo, peraltro, sempre più favorevole per il reo rispetto a quello dell’originario art. 2621 cod. civ., e dunque applicabile anche ai fatti pregressi, in luogo di quest’ultimo (una volta venute meno, in ipotesi, le norme “intermedie”), sulla base dell’attuale quarto comma dell’art. 2 cod. pen.;
che, alla luce di tali considerazioni – e a prescindere, altresì, da ogni rilievo circa le possibili manchevolezze delle ordinanze di rimessione in punto di motivazione sulla rilevanza (avuto riguardo segnatamente alla mancata espressa specificazione sia della natura, quotata o non, delle società nel cui ambito sono state commesse le falsità oggetto dei giudizi principali; sia dell’avvenuta presentazione o meno della querela richiesta dall’art. 2622 cod. civ. in rapporto alle società non quotate) – si impone dunque la restituzione degli atti ai giudici a quibus, in conformità a quanto già disposto da questa Corte in relazione ad analoghe ordinanze di rimessione (ordinanza n. 70 del 2006).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2007.