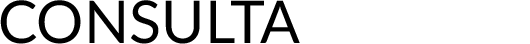SENTENZA N. 12
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 82 e 85 del T.U. 30 maggio 1955, n. 797, 16 del D.L. 9 novembre 1945, n. 788, e 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653, promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1964 dal Pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Actis Riccardo, iscritta al n. 189 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 del 13 febbraio 1965.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del Giudice Biagio Patrocelli;
udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Il 20 agosto 1964 l'Ispettorato del lavoro di Torino ha denunciato a quella Pretura Actis Riccardo per i reati previsti dagli artt. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 82 e 85 del T.U. 30 maggio 1955, n. 797, 16 del D.L. 9 novembre 1945, n. 788, 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653; reati tutti puniti con pena pecuniaria. Il Pretore di Torino, con ordinanza del 19 novembre 1964, ha sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale delle suddette norme in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione nella parte in cui stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale.
Nella ordinanza si osserva che la pena pecuniaria, per la sua stessa natura, risolvendosi cioè nel pagamento di una somma di denaro commisurata alla gravità del reato commesso, tenderebbe ad una finalità esclusivamente retributiva e non anche rieducativa, funzione quest'ultima che invece - ad avviso del Pretore - la suddetta norma costituzionale indicherebbe come essenziale della sanzione penale.
L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 del 13 febbraio 1965. Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, assistito dall'Avvocatura generale dello Stato, che il 5 marzo 1965 ha depositato atto di intervento e deduzioni.
In via preliminare l'Avvocatura dello Stato propone una eccezione di inammissibilità della questione. Il Pretore di Torino, secondo l'Avvocatura, avrebbe sollevata la questione nella veste di Pubblico Ministero e non in quella di giudice. Inoltre la questione sarebbe stata sollevata ancor prima di deliberare se procedere per decreto o altrimenti.
Nel merito l'Avvocatura osserva che quello del fine rieducativo della pena é un principio sancito dalla norma costituzionale in uno con il principio della umanità della pena stessa. Sarebbe pertanto arbitraria la scissione del contenuto del terzo comma dell'art. 27, che deve essere unitariamente considerato così come appare dalla sua formulazione: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".
L'Avvocatura richiama, quindi, la sentenza n. 29 del 1962, con la quale la Corte, nell'occuparsi della conversione della pena pecuniaria, avrebbe implicitamente già ammessa la legittimità costituzionale di un tal genere di sanzione.
Considerato in diritto
La Corte ritiene non fondata l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura dello Stato. Poiché la Pretura di Torino aveva già disposto il procedimento per decreto, si può ritenere che questo, sia pure in una fase preliminare, fosse già iniziato, con la conseguente potestà per il Pretore di proporre questioni di legittimità costituzionale: esigenza che deve potersi soddisfare anche in questa particolare forma di giudizio.
Nel merito l'ordinanza pone la questione se la pena pecuniaria, in quanto ritenuta, a differenza della pena detentiva, non idonea a svolgere funzione rieducativa, sia da considerarsi non conforme al principio costituzionale di cui al comma terzo, seconda parte, dell'art. 27 della Costituzione: "Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato".
La questione é priva di fondamento.
É arbitrario, innanzi tutto, il modo con cui viene presentato il comma terzo dell'art. 27, del quale l'ordinanza pone in esclusiva evidenza una parte tacendone del tutto l'altra. Invero la norma non si limita a dichiarare puramente e semplicemente che "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato", ma dispone invece che "le pene ‘non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità ' e devono tendere alla rieducazione del condannato": un contesto, dunque, chiaramente unitario, non dissociabile, come si vorrebbe, in una prima e in una seconda parte separate e distinte tra loro, né, tanto meno, riducibile a una di esse soltanto. Oltre tutto, le due proposizioni sono congiunte non soltanto per la loro formulazione letterale, ma anche perché logicamente in funzione l'una dell'altra. Da un lato infatti un trattamento penale ispirato a criteri di umanità é necessario presupposto per un'azione rieducativa del condannato; dall'altro é appunto in un'azione rieducativa che deve risolversi un trattamento umano e civile, se non si riduca a una inerte e passiva indulgenza.
Ricostituita la norma nella sua integrità, ne riemerge il suo vero significato. La rieducazione del condannato, pur nella importanza che assume in virtù del precetto costituzionale, rimane sempre inserita nel trattamento penale vero e proprio. É soltanto a questo, infatti, che il legislatore, con evidente implicito richiamo alle pene detentive, poteva logicamente riferirsi nel disporre che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità"; proposizione che altrimenti non avrebbe senso. Alla pena dunque, con tale proposizione, il legislatore ha inteso soltanto segnare dei limiti, mirando essenzialmente ad impedire che l'afflittività superi il punto oltre il quale si pone in contrasto col senso di umanità.
Rimane in tal modo stabilita anche la vera portata del principio rieducativo, il quale, dovendo agire in concorso delle altre funzioni della pena, non può essere inteso in senso esclusivo ed assoluto. Rieducazione del condannato, dunque, ma nell'ambito della pena, umanamente intesa ed applicata.
Del resto la portata e i limiti della funzione rieducativa voluta dalla Costituzione appaiono manifesti nei termini stessi del precetto. Il quale stabilisce che le pene "devono tendere" alla rieducazione del condannato: espressione che, nel suo significato letterale e logico, sta ad indicare unicamente l'obbligo per il legislatore di tenere costantemente di mira, nel sistema penale, la finalità rieducativa e di disporre tutti i mezzi idonei a realizzarla. Ciò, naturalmente, là dove la pena, per la sua natura ed entità, si presti a tal fine. D'altra parte non é nemmeno da escludere che la pena pecuniaria possa, di per sé, per altro verso, adempiere a una funzione rieducativa.
Di un diverso, e radicalmente diverso, indirizzo del legislatore costituente, tale cioè da dover alterare il sistema penale sino al punto da escluderne le pene pecuniarie, e con esse, in definitiva, quante altre fossero in analogo rapporto con la possibilità della funzione rieducativa, non v'é indizio alcuno nei lavori preparatori della Costituzione. Ché anzi da tali lavori, considerati nel loro insieme e nelle dichiarazioni - non contrastate - di singoli commissari, risulta chiaramente che il legislatore costituente, pur segnando i limiti e le finalità di cui all'art. 27, terzo comma, non intese prendere posizione sul problema generale della funzione della pena, né, tanto meno, pronunciarsi per l'uno o per l'altro dei vari orientamenti della dottrina; ma volle anzi proprio evitare che ciò avvenisse, sino al punto che ebbe perfino a manifestarsi la preoccupazione che formule imprecise potessero dare l'apparenza del contrario.
In conclusione, con la invocata norma della Costituzione si volle che il principio della rieducazione del condannato, per il suo alto significato sociale e morale, fosse elevato al rango di precetto costituzionale, ma senza con ciò negare la esistenza e la legittimità della pena là dove essa non contenga, o contenga minimamente, le condizioni idonee a realizzare tale finalità. E ciò, evidentemente, in considerazione delle altre funzioni della pena che, al di là della prospettiva del miglioramento del reo, sono essenziali alla tutela dei cittadini e dell'ordine giuridico contro la delinquenza, e da cui dipende la esistenza stessa della vita sociale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 82 e 85 del T.U. 30 maggio 1955, n. 797, 16 del D. L. 9 novembre 1945, n. 788, e 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653, sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza del 19 novembre 1964 in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1966.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1966.