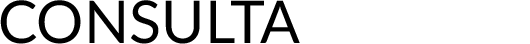Alessandro Pace
La Corte costituzionale nell’esperienza di un avvocato*
1. La trattazione della causa nelle pubbliche udienze.
A prima vista non vi sono, dal punto di vista dell’avvocato, rilevanti
differenze tra la Corte costituzionale e le altre magistrature superiori nella
trattazione orale della causa. Il giudizio viene infatti celebrato dinanzi ai
quindici giudici costituzionali (la stessa composizione numerica che
originariamente caratterizzava le Sezioni unite della Corte di cassazione) press’a poco con le stesse modalità seguite dinanzi a tutte
le supreme magistrature. La trattazione è preceduta dalla relazione del giudice
redattore designato, che in sostanza è costituita dalla lettura di quello che
sarà il «Ritenuto in fatto» delle decisioni della Corte.
Il giudice costituzionale prof. Cassese, di recente eletto, ha però
introdotto una nuova prassi: anziché leggere il «Ritenuto in fatto», come gli
altri giudici, egli da un lato si limita ad indicare i punti nodali della causa
(la questione di legittimità costituzionale [q.l.c.] e le eventuali sottoquestioni), dall’altro evidenzia i punti delle
rispettive difese che gli avvocati delle parti dovrebbero meglio chiarire. È
però ancora troppo presto per poter affermare che ciò preluda ad un mutamento
corale della prassi finora invalsa.
Dopo la relazione prendono per primi la parola i difensori (uno o più)
della parte che ha interesse all’accoglimento del ricorso o della q.l.c., poi i
difensori della parte convenuta o resistente, quindi i difensori degli
eventuali controinteressati nel giudizio a
quo e infine il rappresentante dell’Avvocatura generale dello Stato. In
passato si ammetteva la possibilità di repliche, ancorché brevi. Ora non più.
Il Presidente interviene solo per governare la discussione e quindi, di
massima, non si rivolge al difensore per chiedergli chiarimenti in punto di
fatto o di diritto. Nella mia esperienza ricordo che mi sono state rivolte
precise domande su aspetti fattuali della q.l.c. solo due volte, entrambe da
parte di due ottimi presidenti del collegio provenienti dalla magistratura: la
prima dal Presidente f.f. Gionfrida nel corso
dell’udienza che opponeva la Rai alla Rizzoli Editore s.p.a.
nel giudizio relativo alla legittimità costituzionale del monopolio
radiotelevisivo statale via etere terrestre su scala nazionale (causa che si
concluse con la sentenza
di rigetto n. 148 del 1981, rel. Maccarone);
la seconda dal Presidente Chieppa nel corso dell’udienza concernente la q.l.c.
di una norma che, ai fini dell’esonero dall’esame per l’iscrizione nel registro
dei revisori contabili, non prendeva in considerazione la posizione di coloro
che alla data di entrata in vigore della legge avessero ancora in corso la
sessione d’esame per l’iscrizione all’albo professionale di ragioniere e perito
commerciale (giudizio conclusosi con la sentenza
d’accoglimento n. 35 del 2004, red. Onida, che sostituì la rel.
Contri, evidentemente in disaccordo sul dispositivo della decisione).
In entrambi i casi la perfetta conoscenza dei fatti era della massima
importanza: nel primo caso perché si discuteva della capacità interferenziale
delle radiofrequenze utilizzate dalla rete PIN della Rizzoli a danno del
servizio pubblico; nel secondo perché soltanto nel distretto Milano-Lodi - con
riferimento al quale aveva preso le mosse il giudizio a quo - le prove orali degli esami professionali di ragioniere si
erano protratte oltre la data ritenuta rilevante dal legislatore ai fini
dell’esonero dall’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili (e
cioè la data di entrata in vigore della legge).
2. La «spirito» della Consulta.
Discutere una causa dinanzi alla Corte costituzionale rappresenta, per un
avvocato che sia anche studioso di diritto costituzionale, il top delle proprie aspirazioni professionali.
A parte il rilievo che per i giudici della Corte costituzionale la
conoscenza del diritto costituzionale non rappresenta un optional - e quindi il costituzionalista parla con la sicurezza di
essere compreso (come non sempre accade con altre supreme magistrature) -, è lo
stesso «ambiente» che è gratificante. La struttura dell’aula d’udienza - nella
quale i quindici giudici, pur sedendo su tre dei quattro lati della sala, non
sono così incommensurabilmente lontani dal banco dei difensori come nell’aula
delle Sezioni unite della Corte di cassazione - e la sobria eleganza di essa
danno una sensazione di vicinanza ideale e di comunanza di lavoro tra giudici e
avvocati.
Una comunanza di lavoro che i Presidenti della Corte hanno sempre inteso
sottolineare e ribadire nella cerimonia di commiato in onore dei giudici
costituzionali che partecipano per l’ultima volta ad una pubblica udienza, ai
quali viene rivolto il saluto di un avvocato del libero foro e di un
rappresentante dell’Avvocatura generale dello Stato.
Ma c’è di più. Per uno studioso di diritto costituzionale ciò che rende
particolarmente gratificante discutere una causa alla Consulta è che nel
collegio decidente siedono invariabilmente alcuni (talvolta svariati) colleghi
professori universitari dai quali non ci si aspetta certo un trattamento di
favore, ma la cui comune provenienza accademica fa almeno presumere che gli ex colleghi staranno a sentirlo, quanto
meno per curiosità.
E poiché non di rado anche i difensori della controparte sono colleghi universitari
oppure avvocati dello Stato di grande prestigio, la discussione ne trae
vantaggio e si svolge in modo intelligente e garbato, come pervaso da uno
spirito proprio di quel luogo.
3. La mia prima causa davanti alla Corte costituzionale.
La prima causa da me discussa davanti alla Corte costituzionale è stata
quella che portò alla famosa sentenza n. 202 del
1976 (rel. De Marco), con la quale la Corte
dichiarò l’incostituzionalità del monopolio statale delle trasmissioni
radiotelevisive via etere terrestre su scala locale.
Io difendevo la RAI insieme con due colleghi purtroppo scomparsi: il prof.
Paolo Barile (che allora era mio prestigioso collega nella Facoltà giuridica fiorentina)
e l’avv. Emanuele (Nello) Santoro, che dirigeva l’Ufficio studi della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e aveva fondato «Il
diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni», una pregevole rivista
da lui diretta che aveva conquistato una buona notorietà tra gli esperti del
settore.
La sconfitta fu bruciante perché la legge n. 103 del 1975, che venne con
tale decisione dichiarata incostituzionale in alcune sue disposizioni, era
stata approvata poco più di un anno prima, per giunta sulla base delle
indicazioni fornite dalla stessa Corte al legislatore nella sent. n. 225 del
1974. Bruciante ma non del tutto inaspettata. Nel periodo intercorrente tra
l’udienza di discussione (3 giugno) e la decisione della sentenza (15 luglio)
si era infatti verificato un evento di grande rilievo politico, di cui la Corte
probabilmente tenne conto: nelle elezioni politiche del 20 giugno il PCI, sotto
la guida di Enrico Berlinguer, aveva toccato il massimo storico dei suoi
consensi elettorali (il 34,47 per cento, pari a 227 seggi alla Camera)
avvicinandosi notevolmente alla DC (38,7 per cento, pari a 263 deputati). Si
disse allora, da più parti, che la Corte aveva così garantito all’Italia un
assetto radiotelevisivo pluralistico quand’anche il PCI avesse conquistato la
maggioranza parlamentare.
Vera che fosse tale interpretazione, essa comunque confermava quel che
Giuseppe Branca aveva, con la sua abituale schiettezza, dichiarato a più
riprese come ex Presidente della
Corte, e cioè che la Corte costituzionale, in conseguenza dei criteri previsti
per la sua composizione e dati gli effetti delle sue decisioni, è
sensibilissima alle conseguenze politiche delle proprie decisioni. Sul punto
avrò modo di tornare più volte.
Gli altri ricordi indissolubilmente collegati a quella mia prima esperienza
in Corte sono la brillantissima e incontenibile arringa del prof. Giuseppe
Guarino, che assisteva uno degli imputati nei giudizi penali nel corso dei
quali era stata sollevata la q.l.c. in discussione; il fatto che, per
l’emozione, ad un certo punto del mio intervento... persi il filo del discorso
(che però ritrovai, alla bell’e meglio, quasi subito); infine, l’inattesa
assenza, nel collegio giudicante, del prof. Leopoldo Elia, che sulla carta
avrebbe dovuto essere favorevole al rigetto della questione.
Quest’ultimo fatto merita una qualche considerazione perché solleva un
problema attinente al funzionamento della Corte e alla sua indipendenza, che è
un punto che sta molto a cuore agli avvocati. Sta di fatto che il prof. Elia si
astenne in tale occasione in quanto, nella sua notoria onestà ed indiscussa
sensibilità, ritenne - essendo stato in precedenza consigliere
d’amministrazione della RAI - di trovarsi in una situazione che non gli avrebbe
garantito un’assoluta terzietà nei confronti della regiudicanda.
Per quanto direttamente mi risulta, della stessa sensibilità dette prova
anche il giudice costituzionale Flick, che si astenne in un giudizio per
conflitto tra poteri promosso dalla Sezione disciplinare del CSM contro il
Senato della Repubblica (sent. n. 270 del
2002, red. Onida),
perché nella sua precedente veste di Ministro di grazia e giustizia aveva
promosso un giudizio disciplinare che costituiva appunto l’oggetto del
conflitto (con riferimento al quale il Senato si era espresso in favore
dell’insindacabilità delle opinioni del magistrato, successivamente eletto).
Della stessa sensibilità non hanno invece dato prova, in altre cause da me
discusse, quei giudici costituzionali che come liberi professionisti avevano
difeso - per giunta dinanzi alla stessa Corte e in cause consimili - una delle
parti della questione sulla quale si trovavano ora a dover giudicare.
A loro difesa deve però ricordarsi che l’art. 16 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dispone
espressamente l’inapplicabilità alla Corte delle norme relative all’astensione
e alla ricusazione dei giudici, fuori dei casi dei giudizi penali a carico del
Presidente della Repubblica.
É però obiettabile che, sebbene la Corte abbia più di una volta negato di
poter essere qualificata come organo della giurisdizione (con la conseguente
inapplicabilità degli obblighi di imparzialità e terzietà imposti ai giudici
dall’art. 111 Cost.), essa ha, ciò nonostante, ammesso di essere «disciplinata
in modo da rendere possibile il contraddittorio» (sent. n. 13 del
1960), il che dovrebbe essere motivo più che sufficiente per indurre la
Corte a fare doverosa applicazione della comune disciplina dell’astensione e
della ricusazione: comune disciplina che, allo stato, risulta esclusa non già
in conseguenza di una scelta costituzionale o legislativa, bensì, come già
detto, di una norma integrativa dettata dalla stessa Corte.
4. Varietà delle valutazioni «politiche» e delle conseguenti scelte che la
Corte talora effettua. La «scelta politica», puramente ipotetica e comunque
rientrante nei poteri della Corte, sottesa alla sent. n. 202 del
1976.
Ho ricordato le «voci» secondo le quali la Corte, nel pronunciare la decisione
d’accoglimento n. 202 del 1976, sarebbe stata condizionata da valutazioni lato sensu
politiche. Un fatto, questo, che in via di principio non trova mai favorevole
chi ragiona con l’habitus mentale
dell’avvocato laddove lo studioso è più duttile. Questi ne prende atto e, a
seconda del tipo di costituzionalismo che professa - «irenico» o «polemico»
(come direbbe Massimo Luciani) ([1])
-, lo giustifica e addirittura lo teorizza nel primo caso (in nome della
razionalità del reale!) oppure, nel secondo, ne lamenta la portata derogatoria
dei diritti di azione e di difesa e quindi cerca di limitarne concettualmente
le ipotesi.
A proposito della sent. n. 202
devo però aggiungere, onestamente e per completezza del discorso, che la c.d.
libertà d’antenna veniva già da anni sempre più sostenuta da vasti settori
della pubblica opinione e dello schieramento politico moderato (Tele Biella
risale al 1972!) e che la Corte, con tale sentenza, tutto sommato, ribadì, con
riferimento agli impianti via etere terrestre su scala locale, quanto da essa
già deciso con la sentenza
d’accoglimento n. 226 del 1974 relativamente al monopolio statale sulle
trasmissioni radiotelevisive via cavo su scala locale. Anzi, le indicazioni di
quest’ultima decisione erano state così restrittivamente seguite dalla legge n.
103 del 1975 (la quale si limitò a consentire ai privati il solo cavo
monocanale!), che da taluni giudici costituzionali si ritenne - almeno così
allora si vociferò - che vi fosse stata un’elusione del giudicato della sent. n. 226 del
1974 che «andava sanzionata», per l’appunto, con un’ulteriore pronuncia
d’incostituzionalità: la sent. n. 202 del
1976.
Se la Corte, con la sent. n. 202 del
1976, ebbe a compiere una «scelta politica», questa però avvenne senza
abusare delle proprie attribuzioni costituzionali: da un lato il dispositivo
d’annullamento riguardava solo il profilo penale dell’esercizio, senza
concessione, di impianti radiotelevisivi via etere terrestre su scala locale;
dall’altro la motivazione della sentenza non solo sottolineava esplicitamente
che il «riconoscimento del diritto di iniziativa privata» postulava «la
necessità dell’intervento del legislatore nazionale», ma indicava altresì i
limiti che, nell’interesse generale, il legislatore avrebbe dovuto porre a tale
diritto.
Ergo la Corte costituzionale,
in coerenza con la propria giurisprudenza sull’inesistenza di un diritto
costituzionale all’uso dei mezzi di diffusione, non riconobbe affatto, con tale
decisione, in capo ai privati, un immediato diritto a trasmettere - come invece
si disse da politici e da imprenditori interessati e come fu ripetuto dai loro
difensori nelle aule giudiziarie. E quando la Corte smentì questa tesi
(sentenze nn. 237 del 1984, 826 del 1988
ecc.), era ormai troppo tardi ([2]).
5. Le «notevoli» e «determinanti» scelte politiche della Corte sottese alle
sentenze nn. 420 del 1994 e 466 del 2002
ovvero «le dichiarazioni d’incostituzionalità praticamente inutili».
Mi sono soffermato sulla c.d. politicità della sent. n. 202 del
1976 perché ben diverse sono le decisioni rese dalla Corte nelle due cause
in cui presi parte come difensore di TVI (titolare di TMC, poi La7) contro RTI
(Fininvest prima e Mediaset poi): cause che concernevano entrambe
l’illegittimità costituzionale di norme che consentivano al maggior gruppo
televisivo privato italiano (e che praticamente gli consentono tuttora) di
possedere ben tre reti nazionali con impianti via etere terrestre in tecnica
analogica.
Pur dichiarando l’incostituzionalità delle norme sottoposte al suo giudizio
la Corte evitò, nel primo caso, di dichiarare l’incostituzionalità di altre
norme (aventi la stessa ratio e
quindi parimenti incostituzionali: il d.l. n. 323 del
1993) che consentivano ad altro titolo, per quasi due anni e mezzo, il
funzionamento degli impianti in questione (così la sent. n. 420 del
1994, red. Granata) dichiarativa dell’incostituzionalità
dell’art. 15, comma 4, della legge n. 223 del 1990).
Nel secondo caso (e questa volta la TVI era difesa dal carissimo avv.
Ottavio Grandinetti oltre che da me) la Corte
utilizzò invece, nel dispositivo, una formula che impediva l’immediata
caducazione della norma dichiarata incostituzionale, che anzi veniva spostata
al 31 dicembre 2003 «per determinare le modalità della definitiva cessazione
del regime transitorio di cui al comma 7 dell’art. 3, comma 7, della legge n.
249 del 1997» (così la sent. n. 466 del
2002, red. Chieppa).
E’ evidente che, in entrambi i casi, la q.l.c. - come argutamente
sottolineato in dottrina con specifico riferimento alla sent. n. 466 ([3])
- mentre era stata rilevante «in entrata», non lo era più «in uscita», nel
senso cioè che, dato il tenore del dispositivo, alla parte vittoriosa dinanzi
alla Corte costituzionale veniva sottratta la benché minima possibilità di
utilizzare in suo favore, nel giudizio a
quo, la sentenza che aveva accolto la q.l.c. da essa prospettata.
Contrariamente all’ipotesi della sent. n. 202 del
1976 (nella quale il contesto politico ha soltanto «agevolato» una certa
decisione d’accoglimento), nei casi delle sentenze nn.
420 del 1994 e 466 del 2002
l’attenzione della Corte per le conseguenze politiche connesse alla propria
pronuncia (cessazione dell’operatività in tecnica analogica della terza rete
RTI) è stata «determinante». Anzi, è stata così esclusiva da farle dimenticare
ciò che essa stessa aveva in precedenza rilevato in una famosa decisione - la sent. n. 232 del
1989 (red. Ferri) -, e cioè che «il diritto di
ognuno ad avere per qualsiasi controversia un giudice e un giudizio verrebbe a
svuotarsi dei suoi contenuti sostanziali se il giudice, il quale dubiti della
legittimità di una norma che dovrebbe applicare, si veda rispondere dalla
autorità giurisdizionale cui è tenuto a rivolgersi, che effettivamente la norma
non è valida, ma che tale invalidità non ha effetto nella controversia oggetto
del giudizio principale, che dovrebbe quindi essere deciso con l’applicazione
di una norma riconosciuta illegittima».
Il che significa che, in un sistema di sindacato incidentale di
costituzionalità, la decisione d’accoglimento dovrebbe spiegare sempre effetti
(retroattivi) quanto meno nel giudizio principale, a meno di voler considerare
una lustra i diritti di azione e di difesa costituzionalmente proclamati come
inviolabile ([4]).
Rilievi, quest’ultimi, che come di recente ricordato ([5]),
avevano già indotto la Corte a superare la sua precedente giurisprudenza intesa
a limitare pro futuro gli effetti delle proprie decisioni d’accoglimento (sentenze nn. 266 e 501 del 1988, n. 50 del 1989)
([6]).
Quanto alla natura delle valutazioni politiche connesse alle sentenze nn.
420 del 1994 e 466 del 2002, è
comunque opportuno ricordare che entrambe furono decise quando il maggior
beneficiario della permanenza in vigore delle norme dichiarate incostituzionali
era anche Presidente del Consiglio dei ministri. Ne consegue che delegare al
Parlamento il potere di «determinare le modalità della definitiva cessazione
del regime transitorio» equivaleva, in effetti - soprattutto nel secondo caso,
data la maggioranza di centro-destra della XIV legislatura -, a rinviare sine die la perdita di efficacia delle
norme dichiarate incostituzionali.
In entrambi i casi la Corte costituzionale non si è invece preoccupata del
gravissimo pregiudizio economico che una decisione di accoglimento praticamente
ineseguibile avrebbe determinato a carico del gruppo imprenditoriale vittorioso
(e che, nel primo caso, ha in effetti determinato a danno del gruppo Cecchi Gori) e, conseguentemente, a danno del pluralismo
informativo.
6. La «politicità» come considerazione del rilievo ordinamentale o
istituzionale delle conseguenze della decisione. Tre esempi.
Un diverso ma non minore tasso di politicità presentavano tre importanti
conflitti di attribuzione da me discussi ormai parecchi anni fa: due conflitti interorganici sollevati dalla Corte dei conti e un
conflitto intersoggettivo sollevato dalla Regione Puglia: il primo proposto
contro la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e il Governo a
seguito della mancata sottoposizione a controllo preventivo di un decreto
legislativo, in applicazione dell’esclusione di tale controllo introdotta nel
nostro ordinamento dall’art. 16, comma 1, legge n. 400 del 1988 (giudizio
concluso con la sentenza
di rigetto n. 406 del 1989, red. Corasaniti);
il secondo proposto contro il solo Governo a seguito di atti e fatti impeditivi
dell’esercizio delle funzioni di controllo della Corte dei conti a carico
dell’IRI, dell’ENI, dell’INA e dell’ENEL, a seguito della loro trasformazione
in società per azioni (giudizio concluso con la sentenza
d’accoglimento n. 466 del 1993, red. Cheli); il
terzo proposto dalla Regione Puglia contro lo Stato, in persona del Presidente
del Consiglio pro tempore, per l’annullamento di un d.p.c.m.
che dichiarava lo stato di emergenza ambientale asseritamente
determinatasi nella Regione Puglia e di un’ordinanza emanata dallo stesso
Presidente del Consiglio che delegava il Prefetto di Bari a predisporre il
programma degli interventi (giudizio concluso con l’annullamento parziale degli
atti impugnati: sent.
n. 127 del 1995, red. Guizzi).
Diversamente dai giudizi ricordati al n. 5, la politicità, in tutti e tre
questi casi, risiedeva quindi esclusivamente nella rilevanza «istituzionale»
(nel primo e nel terzo caso) oppure «ordinamentale» (nel secondo) delle
questioni coinvolte, nel senso che l’accoglimento del primo ricorso avrebbe
implicato conseguenze sulla politica economica del Governo e forse addirittura
sulla forma di governo; l’accoglimento del secondo avrebbe spiegato - come in
effetti è accaduto - rilevanti conseguenze sull’intero sistema industriale;
l’accoglimento del terzo mirava infine a salvaguardare l’autonomia
costituzionale regionale nei confronti di provvedimenti governativi, in materia
di protezione civile, assunti in falsa applicazione della legge n. 225 del
1992, che conferivano ad organi amministrativi statali amplissimi poteri.
7. Illustrazione dei tre esempi.
Col primo ricorso, la Corte dei conti chiedeva infatti alla Corte
costituzionale di dichiarare la spettanza ad essa, «ai sensi dell’art. 100,
comma 2, Cost., (del) controllo preventivo di
legittimità sui decreti legislativi delegati ex art. 76 Cost. in quanto atti del Governo» (non invece sui decreti legge,
ancorché i dubbi di costituzionalità fossero praticamente gli stessi). Ciò
infatti avrebbe consentito alla Corte dei conti di effettuare il controllo
preventivo sull’attività normativa abitualmente delegata al Governo (discipline
codicistiche, attuazione delle direttive comunitarie,
riforma della p.a.) nonché sui decreti legislativi implicanti una nuova spesa,
i quali, per definizione, non hanno un controinteressato, con la conseguenza
che, una volta emanati, sfuggono a qualsivoglia sindacato giurisdizionale, con
grave nocumento per la finanza pubblica.
Di questo giudizio - nel quale io assistevo la Corte dei conti insieme al
collega ed amico prof. Federico Sorrentino - posso dire che esso è stato uno
dei più interessanti di quelli da me trattati sotto un profilo strettamente
costituzionalistico sia per la varietà delle questioni, anche d’ordine
processuale, sia per il valore dei colleghi avversari (i professori Paolo
Barile, Feliciano Benvenuti e Alberto Predieri e
l’Avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti) ([7]).
La Corte costituzionale dichiarò preliminarmente inammissibile il conflitto
nei confronti delle Camere in relazione all’approvazione dell’art. 16 della
legge n. 400 del 1988, così facendo propria la tesi, fino ad allora respinta
dalla dottrina prevalente, secondo la quale le leggi e gli atti con forza di
legge non potessero costituire oggetto di un conflitto tra poteri (questa tesi,
com’è noto, è stata poi in parte disattesa dalla stessa Corte costituzionale).
Quanto invece all’ulteriore profilo del conflitto, nei confronti del Governo,
avente ad oggetto la mancata sottoposizione alla Corte dei conti di un dato
decreto legislativo (incidentalmente al quale veniva chiesto alla Corte
costituzionale di sollevare la q.l.c. del cit. art. 16), la Corte
costituzionale respinse tale q.l.c. come «manifestamente infondata».
La Consulta dette infatti una lettura restrittiva dell’art. 100, comma 2,
Cost. («La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo») escludendo dal novero di tali atti quelli equiparati
alla legge, e ciò contro una prassi favorevole alla loro sottoposizione alla
Corte dei conti, che si fondava, prima della Costituzione, sull’art. 17 del t.u. n. 1214 del 1934 e, dopo di essa, sulla lettura
estensiva dell’art. 100, comma 2, Cost. (coonestata
dalla stessa Corte costituzionale) ([8])
che «costituzionalizzava», per l’appunto, quanto disposto dal cit. art. 17 (sent. n. 406 del
1989, cit.).
Col secondo ricorso, la Corte dei conti, difesa dal prof. Giorgio Oppo e da me, chiedeva invece alla Corte costituzionale di
«dichiarare che spetta alla Corte dei conti - nella composizione della sezione
del controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria -
l’esercizio del controllo, previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, sugli
enti pubblici economici trasformati in società per azioni con partecipazione
totalitaria o comunque prevalente dello Stato» ([9]).
In sostanza la Corte dei conti lamentava che il Governo si rifiutasse di
sottoporre al controllo ex art. 100, comma 2, seconda parte, Cost.,
l’IRI, l’ENI, l’INA e l’ENEL per il solo fatto che essi sarebbero stati
formalmente trasformati in società per azioni pur restando saldamente in mano
pubblica.
La Corte costituzionale accolse il ricorso sottolineando, tra l’altro, che
«(d)iversamente da quanto asserito dallo stesso
Governo, la semplice trasformazione degli enti pubblici economici di cui
all’art. 15 della legge n. 359 del 1992 non può essere (...) ritenuto motivo
sufficiente a determinare l’estinzione del controllo di cui all’art. 12 della
legge n. 259 del 1958 fino a quando rimanga inalterato nella sostanza l’apporto
finanziario dello Stato alla struttura economica dei nuovi soggetti, cioè fino
a quando lo Stato conservi nella propria disponibilità la gestione economica
delle nuove società mediante una partecipazione esclusiva o prevalente al
capitale azionario delle stesse» (sent. n. 466 del
1993, cit.).
Infine, con il terzo dei ricorsi qui ricordati, la Regione Puglia lamentava
la menomazione, da parte dello Stato, delle proprie attribuzioni costituzionali
prospettando che i problemi sanitario-ambientali erano stati solo il pretesto
per «commissariare» la Regione Puglia, retta da una maggioranza politica
diversa da quella di centro-destra allora al governo (c.d. Berlusconi I) del
Paese. La Regione non contestava quindi l’applicabilità alla specie della legge
n. 225 del 1992 (essa stessa aveva richiesto al Governo l’adozione dello stato
d’emergenza e l’adozione di provvedimenti straordinari ed indifferibili);
contestava invece la falsa applicazione di tale legge al fine di espropriare la
ricorrente, in violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.,
delle attribuzioni costituzionali spettatile ([10]).
Nella sua decisione la Corte riconobbe che quanto accaduto in Puglia non
realizzava né la previsione della calamità naturale, né quella della catastrofe.
Si trattava bensì di gravi carenze strutturali, da tempo segnalate dalla stessa
Regione, che riguardavano il ciclo idrico e lo smaltimento dei rifiuti, e che
presentavano un alto rischio per un bene fondamentale come la salute. La
Regione Puglia - con valutazione dei suoi organi tecnici, e con delibera della
Giunta - aveva del resto segnalato l’urgenza di provvedimenti straordinari ben
al di là dei pochi casi di colera registrati dagli uffici sanitari. Tale
situazione giustificava quindi, per la Corte, l’esercizio di poteri
straordinari per un arco di tempo ragionevolmente esteso, ma nel rispetto di
quel nesso di congruità e proporzione, che sarebbe valso a garantire
l’autonomia regionale.
In conclusione, la Corte, accogliendo il ricorso sia pure solo in parte,
dichiarava che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio
dei Ministri, di introdurre prescrizioni per fronteggiare uno stato di
emergenza che conferiscano ad organi amministrativi poteri d’ordinanza non
adeguatamente circoscritti nell’oggetto, e comunque tali da derogare a settori
di normazione primaria (oltre tutto richiamati in termini assolutamente
generici) e a leggi fondamentali per la salvaguardia dell’autonomia regionale,
senza nemmeno prevedere l’intesa per la programmazione generale degli
interventi. Conseguentemente la Corte annullava l’art. 1 dell’impugnata
ordinanza nella parte in cui non prevedeva l’intesa con la Regione per quanto
attiene alla predisposizione, da parte del commissario delegato, del programma degli
interventi, nei termini precisati in motivazione; e l’art. 2 della stessa
ordinanza, nella parte in cui venivano derogati, per intero, numerose leggi
statali in materia di valutazione dell’impatto ambientale, sul nuovo
ordinamento delle autonomie locali, sull’uso delle risorse idriche nonché
importanti leggi regionali in materia di programmazione regionale (sent. n. 127 del
1995, cit.).
La legge n. 225 del 1992 superava quindi l’esame di legittimità
costituzionale a cui la Regione Puglia incidentalmente l’aveva sottoposta, ma
al prezzo di una lettura riduttiva dei poteri che essa aveva originariamente
conferito al Governo centrale.
8. Il costituzionalismo «oppositivo» alla prova: a) la causa sul c.d. lodo
Maccanico (o Schifani).
Per chi ritenga che «il costituzionalismo implica un’impostazione
metodologica sempre tesa ad esaltare il limite del potere per evitarne gli
arbitri, quale che sia il problema in discussione: il contenuto dei diritti
costituzionali o i poteri dell’esecutivo, l’immunità del Capo dello Stato o dei
membri del Parlamento, le funzioni della Corte costituzionale e così via» ([11])
- e sia quindi essenzialmente «oppositivo» ([12])
o «polemico» ([13])
-, le controversie nelle quali l’avvocato «costituzionalista» può dar prova del
suo impegno civile sono soprattutto quelle nelle quali egli ha modo di
utilizzare le sue conoscenze professionali per combattere le manifestazioni
arbitrarie di potere.
In questo senso mi ritengo fortunato di aver potuto prestare la mia opera
professionale in talune delle cause in materia radiotelevisiva da me discusse,
da solo o con autorevoli colleghi - ad es. quelle ricordate supra al n. 5, alle quali vanno
però quanto meno aggiunte la causa conclusa con la famosa sent. n. 826 del
1988 (red. Spagnoli) ([14])
e quella conclusa «sotto tono» ([15])
con l’ord. n.
438 del 1990 (red. Spagnoli), la quale, al
momento della discussione dinanzi alla Corte, era politicamente non meno
importante delle altre ([16]).
In tale ottica, devo però soprattutto ricordare la mia partecipazione a due
altri giudizi: il primo concernente la legittimità costituzionale dell’art. 1
della legge n. 140 del 2003 (c.d. lodo Maccanico o Schifani) ([17])
e concluso con la sentenza
d’accoglimento n. 24 del 2004 (red. Amirante); il secondo relativo al conflitto di
attribuzioni tra poteri sollevato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Tempio Pausania contro il Presidente del Consiglio dei Ministri,
on. Berlusconi, occasionato dall’apposizione del segreto di Stato sulla villa
«La Certosa», residenza di villeggiatura del medesimo (ma di proprietà
privata). Questo secondo giudizio non superò la fase dell’ammissibilità in
quanto la Corte, con una discutibilissima decisione, ritenne che fosse cessata la
materia del contendere (ord. n. 404 del
2005, red. De Siervo).
L’oggetto del contendere nel primo giudizio è troppo noto per doverlo qui
ricordare ancorché sommariamente ([18]).
Basterà sottolineare la disciplina paradossale delle sospensioni penalprocessuali prevista dall’art. 1 della legge n. 140:
l’immunità processuale, ancorché temporanea, delle cinque Alte cariche valeva
per i fatti criminosi «extrafunzionali» addirittura antecedenti l’assunzione
della carica o della funzione ma non per i fatti criminosi «funzionali»
previsti dagli artt. 90 e 96 Cost. Il che chiariva, oltre ogni ragionevole
dubbio, che ciò che aveva preoccupato il legislatore della XIV legislatura non
era tanto di assicurare la funzionalità della carica (come ebbero a sostenere
dinanzi alla Corte i difensori dell’on. Berlusconi), quanto creare, in ragione
dell’alta carica ricoperta, «situazioni diverse da cittadino a cittadino», in
spregio di quanto disposto dall’art. 3 Cost. ([19]).
Né - come in un primo tempo si tentò di sostenere - era fondata la tesi
dell’esistenza di discipline analoghe, in favore del Presidente del Consiglio,
in altri ordinamenti contemporanei di democrazia liberale, e in particolare in
quello spagnolo ([20]).
È comunque significativo dell’essenza di privilegio insita nell’art. 1
cit., che l’allora Presidente Chieppa ebbe ad affermare pubblicamente, in mia
presenza, di ritenersi «profondamente offeso» che il Presidente della Corte
costituzionale fosse stato esplicitamente annoverato tra i beneficiari di tale
immunità ([21]).
Mette conto di ricordare che la q.l.c. era stata sollevata dal Tribunale di
Milano con ord. 30 giugno 2003 ([22])
nel corso di un processo penale a carico di Silvio Berlusconi, nel quale era
parte civile la CIR s.p.a. La causa fu chiamata
dinanzi alla Corte costituzionale il 9 dicembre 2003, e la discussione fu assai
ampia e approfondita. Difensori della CIR eravamo l’avv. Giuliano Pisapia, il prof. Roberto Mastroianni ed io. Per l’imputato
Berlusconi parlarono gli avvocati e parlamentari di Forza Italia prof. Gaetano
Pecorella e Nicolò Ghedini. Per il Presidente del
Consiglio intervenne l’allora vice Avvocato generale dello Stato (ora Avvocato
generale) Oscar Fiumara, mio collega di corso nella Facoltà giuridica romana
negli anni 1953-1957 ([23]).
La Corte decise la questione nella camera di consiglio del 13 gennaio 2004
e il Presidente fece diffondere lo stesso giorno un comunicato contenente il
dispositivo della sentenza ([24])
che pronunciava l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 2, della legge n. 140
e, in via conseguenziale, l’incostituzionalità dei commi 1 e 3 dello stesso
articolo.
Il 20 gennaio 2004 veniva depositata in cancelleria la sent. n. 24, a
prima vista un po’ deludente, in conseguenza delle perplessità che traspaiono
dall’impianto argomentativo ([25]).
Ci si sarebbe infatti aspettati che la Corte, ricollegandosi a precedenti sue
decisioni - nelle quali aveva collocato il disposto dell’art. 3 Cost. tra i principi supremi dell’ordinamento ([26])
(come tali immodificabili da parte dello stesso legislatore costituzionale) ([27])
-, affermasse, in maniera perentoria, che la sospensione prevista dall’art. 1,
comma 2, della legge n. 140, quand’anche fosse stata approvata con legge
costituzionale, sarebbe stata comunque annullata dalla Corte, appunto perché in
contrasto con un principio supremo.
Il fatto è che la motivazione risente - come fu autorevolmente sottolineato
- della «particolare difficoltà del contesto politico-istituzionale, di tipo
intimidatorio del tutto peculiare» nel quale la Corte si venne a trovare al
momento della decisione ([28]),
ed è quindi assai probabile che il discutibile impianto argomentativo
costituisse il prezzo del più elevato consenso tra i giudici ([29]).
Resta comunque agli atti (grazie a Dio!) l’annullamento «secco» della
disposizione impugnata - e questo era l’obiettivo davvero essenziale per cui in
quel giudizio la difesa della CIR si era battuta ([30])
-, con un dispositivo che ha pertanto un’indubbia eccedenza di valore «rispetto
agli stessi motivi sui quali si è retta la scelta della Corte» ([31]).
9. Segue: b) la causa sul segreto di Stato sulla residenza estiva del
Presidente del Consiglio.
La decisione che mi ha provocato, invece, una delle maggiori delusioni
della mia carriera professionale è senza dubbio l’ord. n. 404 del
2005, con la quale la Corte costituzionale dichiarò l’inammissibilità del
ricorso della Procura presso il Tribunale di Tempio Pausania, da me difesa,
contro l’allora Presidente del Consiglio dei Ministri on. Silvio Berlusconi, il
quale aveva negato l’accesso alla sua residenza estiva in località Punta Lada (Porto Rotondo) invocando a tal fine il segreto di
Stato, ufficialmente per preservare la conoscibilità dei luoghi, ma in effetti
per impedire la tempestiva contestazione di reati edilizi, paesaggistici ed
ambientali ivi posti in essere.
Le vicende che indussero la Procura di Tempio Pausania a sollevare il
conflitto di attribuzione tra poteri sono bene evidenziate nella motivazione
dell’ordinanza di inammissibilità e soprattutto sono riportate, con
completezza, in un’ottima cronaca costituzionalistica dell’intera vicenda ([32]).
Per quel che qui interessa, è sufficiente ricordare che su un quotidiano
sardo del 5 maggio 2004 veniva pubblicato un servizio fotografico dal quale
risultava che all’interno dell’area di circa 50 ettari denominata «Villa La
Certosa», di proprietà della soc. Idra, con sede in
Segrate, data in uso all’on. Silvio Berlusconi, erano in corso lavori edilizi
che avrebbero potuto configurare reati in materia edilizia, ambientale e
paesaggistica; che alla Procura di Tempio Pausania, la quale intendeva
verificare lo stato dei luoghi e la sussistenza di eventuali reati, il
difensore sia del rappresentante legale della soc.
Idra che dell’on. Berlusconi eccepì tanto l’immunità dalle perquisizioni in
quanto domicilio di un parlamentare, quanto la presenza di ragioni di sicurezza
imposte dal CESIS; che inoltre l’esecuzione dell’ispezione della Procura venne
ripetutamente procrastinata in attesa della produzione del più volte invocato
decreto di asserita apposizione del segreto di Stato.
Va altresì ricordato che solo con nota del 2 ottobre del Ministero
dell’Interno, veniva finalmente trasmesso alla Procura il decreto del Ministro
dell’Interno appositivo del segreto di Stato, datato 6 maggio 2004 (e cioè il
giorno successivo alle notizie di stampa!) al fine di «preservare la
conoscibilità dei luoghi» ([33]).
Essendo tale Ministro palesemente incompetente quanto all’apposizione del
segreto di Stato, il Procuratore della Repubblica, nello spirito di una leale collaborazione
tra i poteri dello Stato, ne chiedeva il 3 novembre 2004 la conferma al
Presidente del Consiglio in tempi brevi, altrimenti avrebbe senz’altro
proceduto all’ispezione.
Con nota del 23 dicembre 2004, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, dott. Gianni Letta, in nome e per conto del
Presidente del Consiglio (astenuto in considerazione di «delicati profili di
opportunità»!), confermava la «segretazione» delle residenze private, con le
relative pertinenze, dell’allora Presidente del Consiglio e, in particolare,
dell’area denominata «Villa La Certosa» «sede alternativa di massima sicurezza
per l’incolumità del Presidente del Consiglio, dei suoi familiari e dei suoi
collaboratori e per la continuità dell’azione di Governo».
La preservazione della conoscibilità dei luoghi era, a ben vedere, del
tutto pretestuosa, dato che le immagini interne ed esterne della villa erano
state oggetto di noti servizi fotografici e la villa era notoriamente
frequentata da Capi di governo straniero, politici, cantanti, giornalisti ecc.
Pertanto la Procura di Tempio Pausania, con ricorso del 15 gennaio 2005,
lamentava alla Corte costituzionale di essere stata illegittimamente menomata
nelle proprie attribuzioni costituzionali (art. 112 Cost.) in quanto, da un
lato, le limitazioni legittimamente ammissibili, a tutela del segreto di Stato,
concernono solo la testimonianza e il sequestro (artt. 202 e 256 c.p.p.) e,
dall’altro, la legge n. 801 del 1977 consente l’apposizione del segreto di Stato
solo su «atti, documenti, notizie, attività ed ogni altra cosa» e non su
«luoghi» ([34]).
Il 10 maggio, e cioè pochi giorni prima della camera di consiglio del 25
maggio nella quale la Corte (dopo alcuni rinvii) avrebbe finalmente dovuto
decidere dell’ammissibilità del ricorso, il Presidente del Consiglio,
avvalendosi delle «prerogative previste dal decreto del Ministro dell’interno
del 6 maggio 2004» (sic!), consentiva alla Procura di Tempio Pausania
l’effettuazione dell’ispezione, alla quale la Procura procedeva nei giorni 20 e
23 giugno 2005, pur con esplicita salvezza di ogni diritto in relazione al
ricorso pendente dinanzi alla Corte costituzionale. Ciò nonostante, la Corte,
affermando che il compimento dell’ispezione aveva «rimosso l’ostacolo frapposto
all’esercizio del potere d’indagine spettante alla stessa autorità
giudiziaria», riteneva venuta meno la materia del contendere e dichiarava
pertanto inammissibile il conflitto.
L’ord. n. 404
del 2005 si espone - e si è esposta - a severissime critiche ([35]).
In primo luogo, pur pendendo la fase dell’ammissibilità, la Corte ha dato modo
sia al Ministero dell’Interno che all’Avvocatura generale dello Stato di
interferire nel procedimento ([36]);
in secondo luogo, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del
contendere prima ancora che il contraddittorio si fosse instaurato; in terzo
luogo, la Corte ha ritenuto che il conflitto tra poteri fosse divenuto
«ipotetico» ancorché il Presidente del Consiglio non avesse affatto disposto la
revoca ex tunc
del decreto impugnato; in quarto luogo, la Corte ha ritenuto - disattendendo il
leading case che identifica i requisiti
necessari per la cessazione della materia del contendere (sent. n. 150 del
1981, rel. Paladin) ([37])
- che l’atto o il comportamento menomativo delle
altrui attribuzioni costituzionali debba (storicamente) sussistere al momento
del giudizio della Corte, perché il ricorso possa dirsi attuale (con il che
tutte le menomazioni uno actu finirebbero per esulare dai giudizi su conflitto
tra poteri!); infine, la Corte ha omesso di pronunciarsi sulla spettanza, alla
data del 6 maggio 2004, del potere in contestazione, nonostante sia proprio il
giudizio «sulla spettanza del potere» il contenuto essenziale delle decisioni
risolutive dei conflitti di attribuzione.
Anche se irrilevanti ai fini di causa, vanno per completezza segnalati tre
fatti che si connettono alle vicende processuali fin qui descritte e che, per
così dire, ne completano il quadro. Con legge 15 dicembre 2004, n. 308, il
Parlamento, per la prima volta nel nostro ordinamento, prevedeva il condono
anche per reati ambientali «commessi mediante lavori compiuti su beni
paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004» (art. 1, comma 37). Il 27
gennaio 2005 il rappresentante della soc. Idra
presentava la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi
del cit. art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 308, ai fini dell’ottenimento
del condono. Infine, con sent. n. 183 del
2006 (red. Finocchiaro) la Corte costituzionale
dichiarava l’infondatezza della q.l.c. del cit. art. 1, sollevata con ricorso
dalla Regione Toscana, basandosi sul rilievo che la potestà punitiva penale (e
quindi anche la disciplina delle cause estintive del reato) rientra nella
competenza legislativa esclusiva dello Stato. La Corte riteneva assorbiti in
questo profilo anche i motivi d’incostituzionalità più direttamente lesivi
dell’autonomia legislativa regionale.
10. Per una più completa indipendenza della Corte costituzionale:
riflessioni conclusive.
Gustavo Zagrebelsky, nelle pagine conclusive del
suo recente saggio "Principi e voti", si pone le seguenti domande:
«Possiamo essere sicuri che, in questi cinquanta anni di attività, la Corte
costituzionale del nostro Paese sia stata all’altezza del suo compito, un
compito di natura, prima che tecnico-giuridica, storico-culturale? Ha essa dato
un contributo alla formazione di una coscienza costituzionale nazionale, alla
formazione di un "partito della Costituzione" al di là dei partiti
ordinari, al quale ci si possa poter rivolgere con sicurezza e fiducia nei momenti
difficili? Quante sue pronunce, quanti suoi concetti, quante sue massime,
quante sue applicazioni della Costituzione sono entrati a far parte del
patrimonio spirituale vivente del nostro Paese, sono entrati nella circolazione
del flusso di energia vitale della nostra Repubblica? Peccherò forse di
pessimismo, ma temo non molti. Eppure, non è proprio questo il metro su cui si
dovrebbe misurare, in ultima e più profonda istanza, la vitalità della
Costituzione e l’efficacia della sua garanzia da parte di coloro che l’hanno
avuta in consegna, come loro compito specifico e precipuo?» ([38]).
Ho già avuto modo di esprimere il mio dissenso dalla pessimistica
conclusione dell’amico e collega, e l’ho fatto motivatamente, elencando, a solo
titolo di esempio, una quarantina di decisioni della Corte che, insieme a
moltissime altre (centinaia), hanno praticamente guidato il cambiamento del
nostro ordinamento adeguandolo ai principi e alle regole della nostra
Costituzione ([39]).
Ci sono però dei settori (o meglio, degli aspetti) della giurisprudenza
costituzionale che lasciano perplessi, e sui quali non si può non convenire con
Zagrebelsky. E sono appunto quelli - per così dire
trasversali alle c.d. materie formalisticamente intese - nei quali la Corte
viene a scontrarsi con gli esistenti assetti di potere.
Sia chiaro: non alludo alla sensibilità che tutte le Corti costituzionali e
tutte le Corti supreme manifestano sempre, sia pure implicitamente, per le
conseguenze «politiche» (ordinamentali o istituzionali) delle proprie decisioni
([40])
- per cui si potrebbe dire (rischiando di apparire impertinenti!) che gli
organi giudiziari di vertice sono sempre alquanto «strabici»: un occhio alla
Costituzione e l’altro alla politica (in senso alto, però).
Alludo piuttosto a quelle decisioni (come le ricordate sentenze nn.
420 del 1994, 466
del 2002 e l’ord.
n. 404 del 2005) che non hanno avuto la forza di incidere su situazioni di
vero e proprio privilegio: situazioni come tali già rifiutate sin dall’art. 1
della Déclaration
del 1789 e, quindi, in palmare contrasto con gli stessi diritti (prettamente
liberali) della c.d. prima generazione.
Mi si obietterà che la cit. sent. n. 24 del
2004, relativa all’art. 1 della legge n. 140 del 2003, costituisce
l’esempio del contrario. E l’obiezione è certamente calzante, se ci limitiamo a
leggerne il dispositivo; ma non lo è, come ho già avuto modo di dire, se
guardiamo alla motivazione alquanto perplessa.
Quale allora il rimedio per rafforzare l’indipendenza della Corte? Sembrerà
paradossale, ma a mio parere esso starebbe, innanzi tutto, nella riduzione, da
quindici a nove, del numero dei giudici costituzionali, così come da quindici a
nove è stato da tempo modificato il numero dei componenti delle Sezioni unite
della Corte di cassazione. Quindi solo nove giudici costituzionali (tre eletti
dalle Camere, tre di nomina presidenziale e tre eletti dalle supreme
legislature) come i giudici della Corte suprema statunitense, il cui Chief Justice
Hughes si ribellò contro l’aumento minacciato dal Presidente Roosevelt nel 1937
(il c.d. Court-Packing
Plan), sottolineando che nove giudici erano più che sufficienti per una
Corte di giustizia mentre quindici sarebbero stati davvero troppi ([41]1).
E sono troppi anche perché ritengo che un numero così alto di giudici ne
trasformi inevitabilmente alcuni in frontbenchers e altri in backbenchers, non sempre attenti,
quest’ultimi, ai delicati profili di talune questioni. Beninteso, una siffatta
riduzione del numero andrebbe compensata prevedendo la possibilità per il Presidente,
eventualmente coadiuvato da un ristretto numero di giudici, di effettuare una
scrematura delle questioni manifestamente inammissibili o infondate.
Sono certo, però, che un suggerimento del genere non sarà mai accolto, e
ciò per la semplice ragione che le forze politiche hanno un interesse contrario
a restringere i propri spazi di influenza.
Altri possibili rimedi di carattere tecnico - tutti, al contrario del
precedente, nella diretta disponibilità operativa della Corte - sono, in primo
luogo, l’auspicabile abrogazione, da parte della stessa Corte, dell’art. 16 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale relativo all’astensione
e alla ricusazione dei giudici (v. supra il n. 3) ([42])
e, in secondo luogo, l’altrettanto auspicabile rigore col quale la Corte
dovrebbe esercitare la verifica dei poteri dei giudici eletti o nominati.
Depone infatti assai male per l’indipendenza (e comunque per l’immagine) della
Corte che i partiti possano impunemente far eleggere dalle Camere alla suprema
magistratura costituzionale magistrati, avvocati o professori i cui requisiti ex art. 135, comma 2, Cost. non siano indiscutibili.
L’ultimo suggerimento sta nell’introduzione, tuttora controversa ([43]),
del «voto separato» (dissenting
o concurring)
nelle decisioni della Corte costituzionale. Tale introduzione - che a mio
avviso potrebbe avvenire anche in via di prassi (oltre tutto non essendovi né
una sede dove contestarla né alcuno legittimato a farlo) - avrebbe un duplice
merito: in primo luogo, quello di evitare quelle motivazioni che, avendo, per
così dire, più «anime» in contrasto tra loro, peccano quanto meno nella
linearità della ratio decidendi
([44])
e finiscono conseguentemente per contraddire proprio quel valore che il voto
segreto vorrebbe garantire: la «monolitica solidarietà» del collegio giudicante
([45])
(o, il che è lo stesso, «l’unitarietà della voce della Corte») ([46]);
in secondo luogo, quello di responsabilizzare i singoli giudici costituzionali
allo scopo di poter dimostrare erga omnes la loro indipendenza di giudizio ([47]),
con conseguente garanzia per l’effettiva indipendenza della Corte.
E’ bensì vero che il «dissenso dichiarato» potrebbe diventare uno strumento
intenzionale di indebolimento della decisione della maggioranza ([48]).
Ma il punto non è questo. Il punto è un altro e sta nella «qualità» degli
argomenti addotti dal dissenziente. Se gli argomenti sono deboli o
aprioristicamente partigiani, essi infatti squalificano il dissenter e non la Corte. Se
invece gli argomenti su cui il dissenso si basa sono fondati (o sono comunque
più convincenti di quelli della maggioranza), ben venga allora il dissenso,
perché la sua funzione sta proprio nel porre le premesse per un futuro overruling. Ma, a
ben vedere, le argomentazioni del dissenziente sono utili anche e soprattutto
se serie e ben motivate. In tale ipotesi, esse avranno infatti il merito - a
tutto vantaggio della linearità e della stringatezza della decisione - di
stimolare l’estensore ad eliminare dalla motivazione quei passaggi che potrebbe
esporre la decisione a critiche ([49]).
(16 aprile 2007)
* Articolo pubblicato anche sul Giornale
di storia costituzionale, 2006, fascicolo n. 11.
([2])
Sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale e dei giudici
comuni in materia radiotelevisiva dal 1960 al 2005, considerata nel contesto
politico, v. A. Pace e M. Manetti, Art. 21. La
libertà di manifestazione del proprio pensiero, in Gius.
Branca e A. Pizzorusso (a cura di), Commentario
della Costituzione, Bologna - Roma, Zanichelli - Foro it.,
2006, pp. 575 ss.
([4])
Per una critica alla tesi secondo la quale la retroattività delle sentenze
d'accoglimento della Corte costituzionale (art. 136, comma 1, Cost.)
costituirebbe la conseguenza di una scelta del legislatore ordinario (art. 30
della legge n. 87 del 1953) e non l'effetto congiunto dell'incidentalità del
giudizio (art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948) e dell'operatività dell'art.
24, commi 1 e 2, Cost., mi si consenta di rinviare al
mio Effetti temporali delle decisioni di
accoglimento e tutela costituzionale del diritto di agire nei rapporti pendenti,
in Aa.Vv., Effetti
temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle
esperienze straniere, Atti del seminario tenuto a Roma, Palazzo della
Consulta, il 23 e 24 novembre 1988, Milano, Giuffrè, pp. 54 ss.
In questa linea di pensiero, dice assai bene M. Cartabia, Nuovi
sviluppi nelle «competenze comunitarie» della Corte costituzionale, in Giur. cost.,
1989, parte I, p. 1021, quando rileva che «... ogni situazione in cui sia
esercitabile il diritto alla tutela giudiziaria richiede non solo che sia
accordato il diritto di prospettare la questione di legittimità
(costituzionale) delle norme, ma anche che essa sia definita sulla base di
norme non invalide».
([5])
R. Bin, L'applicazione diretta della
Costituzione, le sentenze interpretative, l'interpretazione conforme a
Costituzione della legge, relazione al Convegno dell'AIC su La circolazione dei modelli e delle tecniche
del giudizio di costituzionalità in Europa, Roma 27 e 28 ottobre 2006, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it
([6])
Le valutazioni politiche della Corte costituzionale sottese a tali decisioni si
fondavano su esigenze di bilancio posto che esse riguardavano le nomine, i
trasferimenti e i conferimenti di funzioni del personale della giustizia
militare; il trattamento pensionistico dei magistrati e degli avvocati dello
Stato; la pubblicità delle udienze per i procedimenti davanti alle Commissioni
tributarie. Si può quindi dire che esse, per quanto criticabili in quanto prive
di efficacia ex tunc
quanto meno nel giudizio a quo, si fondavano pur tuttavia su esigenze di funzionalità
(«ordinamentali») del sistema. Ben diverse, quindi, erano le valutazioni
politiche (né ordinamentali né istituzionali) sottese alle due decisioni di cui
si parla nel testo.
([7]) Il ricorso della Corte dei conti è
pubblicato in Giur. cost., 1989, parte II, 943 ss.; le
memorie delle parti sono invece pubblicate ivi
1989, parte I, p. 1842 ss
([8]) V. ad es. la sent. n. 143 del
1968, in Giur. cost.
1968, pp. 2363 ss., spec. p. 2366
([9]) Il
ricorso della Corte dei conti e le successive memorie delle parti sono
pubblicati in Giur. cost., 1993, pp. 3845 ss
([10]) Il ricorso della Regione Puglia può essere
letto in calce alla sent. n. 127 del
1995, in Giur. cost.
1995, 1009 ss
([14]) ... che è quella,
per intendersi, con la quale «annunciò» l'incostituzionalità dei c.d. decreti
Berlusconi, ma non la «dichiarò». In questa causa io difendevo la Rai con il
prof. Paolo Barile e l'avv. Attilio Zoccali. Per una
collocazione storica della decisione e per qualche ulteriore indicazione sul
punto, mi permetto di rinviare a quanto da me scritto in A. Pace e M. Manetti, Art. 21, cit., pp. 593 ss.
([15]) Così P.A. Capotosti,
Tanto tuonò..., ma non piovve, in Giur. cost., 1990, p. 2622, in nota
all'ordinanza citata nel testo.
([16]) ... perché
l'eventuale decisione (di accoglimento) di essa operò, in molteplici interviste
dell'allora Presidente della Corte costituzionale Francesco Saja,
come una spada di Damocle sul legislatore per indurlo ad approvare la legge di
riforma del sistema radiotelevisivo entro l'estate del 1990. Il che appunto
avvenne con la legge 6 agosto 1990, n. 223, parimenti deludente sotto il
profilo del pluralismo televisivo a livello nazionale. In tale causa io
difendevo l'ANTI. La causa fu discussa dinanzi alla Corte il 30 gennaio 1990;
relatore fu il compianto giudice Ugo Spagnoli che aveva già redatto la
motivazione della sent.
n. 826 del 1988 cit. nella nota precedente. Per una contestualizzazione
anche di questa vicenda v. ancora A. Pace e M. Manetti, Art. 21, cit., pp. 595 s.
([17]) Riporto, a futura memoria, il testo
dell'art. 1 della legge n. 140: «Non possono essere sottoposti a processo
penale, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione
della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il
Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'art. 90 della
Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della
Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto
previsto dall'art. 96 della Costituzione, il Presidente della Corte
costituzionale. // Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto
dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in ogni fase,
stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti
l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle
medesime. // Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le
disposizioni dell'art. 159 del codice penale»
([18]) Per critiche a tale disposizione, prima
ancora del giudizio davanti alla Corte costituzionale, v. in ordine cronologico
L. Carlassare, Responsabilità giuridica e
funzioni politico-costituzionali: considerazioni introduttive, in Aa.Vv., Diritti e
responsabilità dei soggetti investiti di potere, a cura di L. Carlassare,
Atti del Convegno di Padova del 4 aprile 2003, Padova, Cedam, 2003, p. 39; A.
Pace, Conclusioni, ivi, p. 187 ss.;
A. Pugiotto, «Lodo
Maccanico», una legge a rischio d'incostituzionalità, ivi, p. 195 ss.; S. Stammati, Le immunità
costituzionali: problemi attuali e tendenze di riforma, relazione
introduttiva al Seminario su «I diritti
fondamentali e le Corti in Europa» tenuto il 6 giugno 2003 presso la LUISS,
nell'ambito dell'Osservatorio Costituzionale curato dal compianto collega e
amico S.P. Panunzio (https://www.luiss.it/semcost/dirittifondamentali/newsletter.html);
A. Pace, Immunità politiche e principi
costituzionali, in Aa.Vv., Lo stato della Costituzione italiana e l'avvio della Costituzione
europea, Atti del Convegno del 14 e 15 luglio 2003, Roma, Accademia
Nazionale dei Lincei, 2003, p. 108 ss., nonché in Diritto pubblico, 2003, pp.
393 ss.; G. Azzariti e R. Romboli, Sospensione dei processi per le alte cariche
dello Stato e immunità per i parlamentari. Profili di costituzionalità, in Riv. dir. cost., 2003, p. 247 ss
([19]) Così, ante
litteram, C. Esposito, Eguaglianza e
giustizia nell'art. 3 della Costituzione, in Id., La Costituzione italiana. Saggi, Padova, Cedam, 1954, p. 31. Questo
importante passo del saggio di Esposito è stato ricordato, per primo, nel 2003,
da F. Sorrentino, Brevi riflessioni su
sovranità popolare e pubblica amministrazione, in Aa.Vv., La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli,
Paladin, a cura di L. Carlassare, Atti del
Convegno di Padova del 19-21 giugno 2003, Padova, Cedam, 2003, p. 221, e poi da
me in Immunità politiche e principi
costituzionali, locc. citt., rispettivamente
pp. 108 s. e pp. 394 s. Giustamente, in questa luce, è stato sottolineato che
la carica pubblica, nella specie, costituiva soltanto «il pretesto per
assicurare il privilegio». Così G. Giostra, Il
"lodo Berlusconi" alla prova dei giudici, in Questione giustizia, n. 4, 2003, p. 827
([20]) Mi permetto di rinviare ad A. Pace, La legge n. 140/2003 e i principi
costituzionali violati, in Studi in
onore di Gianni Ferrara, vol. III, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 35 ss
([21]) Il che contrasta frontalmente con quanto
riferito da B. Vespa, Storia d'Italia da
Mussolini a Berlusconi, Roma-Milano, Rai-Mondadori, 2004, pp. 510 s.
([22]) Si badi bene: la legge n. 140 era stata
promulgata il 20 giugno e prevedeva, all'art. 9, l'entrata in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione sulla G.U.,
avvenuta il 21 giugno, e ciò al fine specifico di «bloccare» la celebrazione
del processo di Milano a carico dell'on. Berlusconi
([23]) Fiumara ed io avevamo già discusso
insieme, esattamente due mesi prima, un altro importante giudizio per conflitto
di attribuzioni tra poteri che aveva visto il ricorrente CSM, difeso da me, contrapporsi
al Ministro pro tempore della Giustizia, on. Castelli, che si opponeva
pervicacemente alla nomina del Presidente del Tribunale di Bergamo nella
persona di un valente magistrato, il dott. Adriano Galizzi
(sent. n. 380
del 2003, di accoglimento). Faceva parte del collegio decidente, in
entrambi i giudizi, un altro ex collega di corso: il giudice costituzionale
Alfio Finocchiaro, già autorevole presidente di sezione della Corte di cassazione.
Di lì a poco il Presidente della Repubblica avrebbe
nominato giudice costituzionale la prof. Maria Rita Saulle, anch'ella mia
collega di corso, così come miei colleghi furono allora il prof. Lucio Valerio Moscarini e il prof. Franco Gaetano Scoca,
per citare solo quelli con i quali ho avuto modo di discutere dinanzi alla
Corte costituzionale.
([24]) Non è frequente, ma nemmeno rarissimo, che
la Corte diffonda la notizia dell'esito del giudizio prima del deposito in
cancelleria della sentenza. Si fa luogo a questa pubblicità parziale e
anticipata in caso di giudizi che rivestono grande importanza politica, il che
serve ad impedire interventi, da parte... degli dei dell'Olimpo, quando la
decisione è già stata raggiunta in camera di consiglio.
[25] Così S.
Stammati, Una
decisione condivisibile messa in forse da un impianto argomentativo perplesso e
non persuasivo, in Giur. cost. 2005, pp. 398 ss.; A. Pugiotto,
Sull'immunità delle "alte
cariche", una sentenza di "mezzi silenzi". Dichiarate
"assorbite" proprio le questioni più rilevanti, in D&G, n. 5, 2004, pp. 10 ss
([26])
V. le sentenze nn. 16 e 18 del 1982, 1146 del 1988, 388 del 1991, 62 del 1992 e 15 del 1996.
([27])
V. La notissima sent.
n. 1146 del 1988.
([28]) L. Elia, La Corte ha fatto vincere la Costituzione, in Giur. cost., 2004, p. 394; nello stesso senso
G. Giostra, Sospensione del processo a
tutela della carica costituzionale? Strumento costituzionalmente e tecnicamente
improprio, in D&G, n. 5,
2004, 26.
([30])
V. il mio articolo Confermata la
superiorità della Carta, apparso su Il
Messaggero del 14 gennaio 2004, p. 2, nell'immediatezza della diffusione
del comunicato della Corte costituzionale
([31])
L. Elia, La Corte ha fatto vincere la Costituzione,
cit., p. 394. In questo senso v. anche A. Pace, La legge n. 140/2003 e i principi costituzionali violati, cit., p.
33.
([32]) V. A. Masaracchia, Lo
strano caso del segreto di Stato sulla villa «La Certosa», in Giur. cost.
2005, pp. 4067 ss.
([33]) Merita incidentalmente di essere ricordato
che il contenuto del decreto del Ministro dell'Interno del 6 maggio 2004,
appositivo del segreto di Stato, veniva, a sua volta, classificato «segreto»
nella lettera del 2 ottobre 2004, con la quale il Ministro dell'Interno-Gabinetto
del Ministro-Segreteria speciale, lo trasmetteva alla Procura di Tempio
Pausania.
([34])
Il ricorso e le successive tre memorie prodotte dalla Procura di Tempio
Pausania sono riportate in Giur. cost., 2005, pp. 3962 ss.
([35])
V. le osservazioni, tutte fortemente critiche, di L. Elia, Villa «La Certosa»:
una inammissibilità che non convince, di R. Chieppa, Una discutibile cessazione
della materia del contendere su apposizione di segreto di Stato, di F.
Sorrentino, Inammissibilità del conflitto per cessazione della materia del contendere?, e di P. Pisa, Segreto di Stato: un caso
anomalo, in Giur. cost., 2005, pp. 3983 ss.
([36])
Ciò risulta, per quanto riguarda il Ministero, dalla I e dalla II memoria della
Procura, in Giur. cost., 2005, pp. 3974 ss., e per
quanto riguarda l'Avvocatura generale dello Stato, dalla stessa motivazione
dell'ord. n. 404.
([37]) Nella citata sent. n. 150 del
1981 (rel. Paladin) -
più volte richiamata nella successiva giurisprudenza - la Corte aveva
chiaramente impostato il problema della perpetuatio iurisdictionis, in un'ipotesi ben più controvertibile
del caso concluso prematuramente con l'ord. n. 404.
Sottolineò allora la Corte di aver già in precedenza chiarito che la pronuncia
di cessazione della materia del contendere s'impone solo «quando l'atto
denunciato risulti annullato ex tunc, facendo implicitamente venir meno le affermazioni
di competenza che avessero dato luogo al conflitto e privando in tal modo il
ricorrente dell'originario interesse ad ottenere una decisione
sull'appartenenza del potere contestato». E, nel respingere il ricorso del
Pretore di Genova, così la Corte concludeva la sua argomentazione: «Ne segue
che il Pretore non ha annullato ex tunc l'ordinanza del 25 febbraio 1977, la quale ha pur
sempre prodotto una serie di effetti quanto meno nell'ambito della competenza
territoriale di quel giudice. E non vi è stato nemmeno un riconoscimento - sia
pure implicito - che l'attribuzione contestata spettasse al potere esecutivo o
non potesse comunque venire esercitata dal Pretore (...). Malgrado la sorte dell'atto
impugnato, residua perciò l'interesse del ricorrente ad ottenere quella
decisione sulla spettanza delle attribuzioni in contestazione, che rappresenta
- specialmente nei conflitti tra i poteri dello Stato - l'oggetto principale
del giudizio di questa Corte, in base all'art. 38 della l. n. 87 del 1953».
([38])
G. Zagrebelsky, Principi
e voti. La Corte costituzionale e la politica, Torino, Einaudi, 2006, 130
s.
([39])
A. Pace, L'ultimo monito di Carlo
Esposito e le «lezioni» della Corte costituzionale, in Aa.Vv., Corte costituzionale e processo
costituzionale nell'esperienza della rivista «Giurisprudenza costituzionale»
per il cinquantesimo anniversario, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 711.
([40])
V. già, in questo senso, il mio Corte
costituzionale e «altri» giudici tra «garantismo» e «sensibilità» politica, in
Scritti in onore di Vezio Crisafulli, Padova, Cedam, 1985, pp. 593 ss
([41])
Le parole del Chief Justice
Hughes sono riportate da W.H. Rehnquist, The Supreme Court, New York, Knopf, 2001, p. 128: «Un aumento del numero dei giudici
della Corte suprema, a parte ogni questione di principio su cui non voglio
discutere, non aumenterebbe l'efficienza della Corte (...). Ci sarebbero più
giudici da ascoltare, più giudici con i quali conferire e discutere, più
giudici da convincere e con i quali decidere. Si è ritenuto che l'attuale
numero dei giudici sia ampio abbastanza perché la Corte possa affrontare
prontamente, adeguatamente e sufficientemente il lavoro che essa è chiamata a
svolgere...»..
Auspica la riduzione del numero dei giudici
costituzionali anche G. Zagrebelsky, Principi e voti, cit., p. 69.
([42])
V. le attente considerazioni sul punto di A. Pertici,
Astensione e ricusazione dei giudici costituzionali:ragioni e limiti
della loro esclusione ed ipotesi di una loro introduzione, in Giur. cost.,
2004, pp. 3105 ss.
([43])
Cfr. gli interventi, in vario senso, riportati in Aa.Vv., L'opinione dissenziente, a cura di A. Anzon,
Atti del seminario svoltosi a Roma, Palazzo della Consulta, il 5 e il 6
novembre 1993, Milano, Giuffrè, 1995. In particolare, v. A. Anzon,
Per l'introduzione dell'opinione
dissenziente dei giudici costituzionali, ivi, pp. 430 ss., spec. 435 e 437.
([44])
Nella mia esperienza di avvocato mi è raramente capitato di leggere una
sentenza di accoglimento della Corte costituzionale con tanti obiter dicta
di segno opposto, come la sent. n. 326 del
1998 (red. Onida),
sulla quale v. criticamente F. Modugno, La
posizione dei consorzi di bonifica nell'ordinamento vigente. (Un commento
critico alla sent. n. 326 del 1998 della Corte costituzionale), in Giur. it.,
1998, I, 2241 ss. e S. Bartole, E' possibile superare le ambiguità apparentemente presenti nella
posizione della Corte costituzionale in materia di consorzi di bonifica?, in Giur. cost.,
1998, p. 2390. Con la conseguenza, derivante appunto dalla perplessità della
motivazione della decisione della Corte (con la quale era stata pressocché interamente annullata una legge della Regione
Marche che trasferiva alle Province le funzioni dei consorzi di bonifica), che
il Consiglio di Stato, giudicando su un'ipotesi applicativa dei principi
contenuti nella sent.
n. 326 del 1998 della Corte, fece suoi gli ambigui obiter dicta e non l'effettiva ratio decidendi
della pronuncia. V. sul punto Cons. Stato, sez. VI, 25 luglio 2003, n. 4286, in
Foro amm.
CDS, 2003, p. 2316 (solo massima).
([45])
Così il noto giudice federale e autorevole giurista Learned
Hand, The Bill
of Rights, Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 1958, p. 72, citato criticamente, con buoni
argomenti, da A. Scalia, Remarks on Dissenting
Opinion, in Aa.Vv., L'opinione
dissenziente, cit., p. 413.
([47])
G. Zagrebelsky, Principi
e voti, p. 92, rileva giustamente, alla luce della sua esperienza, che «(q)uando tra i giudici si constatano irrigidimenti,
costituzionalmente immotivati o artificiosamente argomentati, è facile pensare
che ciò dipenda da fedeltà improprie. L'arrampicarsi sugli specchi in camera di
consiglio è sempre un brutto segno così come lo è, al contrario, il rinunciare
a motivare la propria posizione, per esprimere solo un voto bruto, come per
stendere un velo sulle vere ragioni che spingono ad agire». Ciò nonostante, Zagrebelsky (op. cit.,
pp. 70 s.), si esprime, sia pure problematicamente, contro l'introduzione del
voto separato. Il che lascia perplessi.