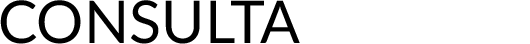Camilla
Bianchi
La definizione del principio di non
discriminazione di genere tra fonti del diritto internazionale e fonti interne:
spunti per una riflessione
Premessa
In una recente nota il Presidente
del Comitato delle Nazioni Unite, nell’esaminare lo stato di attuazione dei
principi contenuti nella Convenzione internazionale c.d. Cedaw, ha contestato
al Governo italiano la “mancanza di una definizione di discriminazione contro
le donne, nella Costituzione o nella legislazione”.
Il rilievo, per
l’autorevolezza della sua provenienza, offre lo spunto per una riflessione
volta a verificare se effettivamente nel nostro ordinamento non sia rinvenibile
una siffatta definizione, attesa peraltro l’assoluta rilevanza del principio
che ad essa si ricollega.
A tale fine, l’indagine
deve necessariamente prendere le mosse da una breve se pur puntuale analisi
dell’attuale stato dei rapporti intercorrenti tra l’ordinamento interno e
quello internazionale, con specifico riferimento al sistema delle fonti che da
sempre costituisce oggetto di dibattito dottrinario e giurisprudenziale con
interpretazioni spesso non univoche.
Considerato, infatti, che
nella richiamata Convenzione il concetto di discriminazione contro le donne
trova una sua specifica definizione, è di tutta evidenza che la questione si
incentra nel chiarire se tale definizione possa ritenersi giuridicamente
acquisita nel nostro ordinamento, in virtù dei meccanismi di adeguamento al
diritto internazionale disciplinati dalla Costituzione.
In oggi , peraltro, tale
indagine assume particolare rilievo, in considerazione della recente riforma
del Titolo V della Costituzione che ha ridefinito i limiti della funzione
legislativa esercitata dallo Stato e dalle Regioni .
Non v’è dubbio, infatti,
che nell’esaminare i rapporti intercorrenti tra le fonti interne e quelle
internazionali, si debba necessariamente rivisitare talune posizioni assunte al
riguardo dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale, prima
dell’anzidetta riforma.
1.
Le fonti del diritto internazionale
1.1 Tipologia ed ingresso nell’ordinamento interno
E’ noto come nell’ambito
delle fonti del diritto internazionale, si distingua tra le fonti di carattere
generale e le fonti di carattere particolare.
Le prime vengono
ricondotte alle norme consuetudinarie, ossia a quell’insieme di norme non
scritte che si sono venute consolidando nella loro applicazione per un periodo
di tempo ragionevolmente ampio e che sono, pertanto, ormai divenute patrimonio
riconosciuto ed irrinunciabile della Comunità internazionale.
Tale insieme di norme
costituisce quindi, nell’ambito del diritto internazionale, quello che
comunemente viene definito diritto
consuetudinario.
Le seconde, invece, si
sostanziano nel complesso di norme che regolano i rapporti tra i singoli Stati
in virtù di specifici patti ( trattati, convenzioni, ecc…) stipulati tra uno
Stato e l’altro.
In ragione di questa
particolarità, sempre nell’ambito del diritto internazionale, tale insieme di
norme viene ordinariamente definito come
diritto pattizio.
Alle sopracitate fonti di
diritto internazionale si affiancano poi quelle di diritto comunitario, a
seguito della adesione del nostro Paese ai Trattati Istitutivi delle Comunità Europee,
con una specificità di posizione che in questa sede non mette conto trattare,
attesa la sostanziale irrilevanza per i fini considerati.
Orbene, in relazione al
diritto consuetudinario l’art. 10, 1° comma, della nostra Costituzione dispone
espressamente che “l’ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute”.
Tale disposizione a
livello dottrinario e giurisprudenziale viene comunemente intesa come un rinvio
formale alle consuetudini internazionali, con un conseguente adattamento automatico dell’ordinamento
italiano al diritto internazionale consuetudinario (cfr Corte Costituzionale 32/1960, 68/1961, 48/1979, 323/1989).
Non v’è dubbio, infatti,
che il diritto internazionale consuetudinario sia l’unico “generalmente
riconosciuto”, ossia accettato dalla generalità degli Stati, e che a questo si
riferisca quindi il dettato costituzionale.
Solo una isolata anche se
autorevole dottrina, invero, ritiene che l’art.10 della Costituzione enunci un
principio implicante l’adattamento automatico del diritto italiano all’intero
diritto internazionale, ivi compresi tutti i trattati stipulati dal nostro
Paese; e ciò in quanto tra le norme cui rimanda la disposizione in parola,
rientrerebbe anzitutto la fondamentale regola pacta sunt servanda.
Sennonché, come già
precisato, la ricostruzione di gran lunga prevalente è invece nel senso che la
conformità prescritta dalla Costituzione non riguardi i Trattati, cui si
riferisce specificamente l’art. 80 della Costituzione, bensì le sole
consuetudini internazionali, e questa tesi è stata più volte condivisa dalla
Corte costituzionale, la quale ha espressamente contestato che l’art. 10 primo
comma ricomprenda i singoli impegni assunti in campo internazionale dallo Stato
italiano. (cfr. Corte Cost. 18 giugno 1979, n.
48, 6 giugno
1989, n. 323).
Per adattamento automatico, poi, si intende che le norme di diritto
internazionale consuetudinario entrano direttamente a far parte
dell’ordinamento nazionale, senza che occorrano specifici atti interni di
recepimento o di esecuzione.
In relazione al diritto
internazionale pattizio, invece, l’art. 80 della Costituzione dispone che “Le Camere autorizzano con legge la ratifica
dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati
o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi”.
Da ciò consegue, in primo
luogo, che i trattati che non rientrano nell’elencazione normativa possono
essere ratificati senza previa autorizzazione legislativa, o addirittura
conclusi e perfezionati mediante la semplice sottoscrizione di un
rappresentante del Governo.
In quest’ultimo senso,
infatti, la prassi internazionale ha visto crescere il numero dei Trattati
ratificati in forma c.d. semplificata, i quali non richiedono la ratifica del Capo
dello Stato rientrando nella sfera esclusiva di azione del Governo, che cura le
trattative preliminari e procede alla loro sottoscrizione, di regola attraverso
il ministro degli esteri.
In ambedue i casi,
comunque, resta fermo che l’ingresso nell’ordinamento interno della norma di
diritto internazionale pattizio non avviene in maniera automatica, ma solo in
virtù di uno specifico atto da parte dello Stato che il più delle volte si
sostanzia in una formula, la quale nel linguaggio tecnico prende il nome di ordine di esecuzione.
Il procedimento
disciplinato dall’art. 80 della Costituzione, poi, si articola nelle sue fasi
essenziali con la negoziazione tra gli Stati interessati, che si chiude con la
firma del rappresentante del Governo, seguita dalla presentazione del disegno
di legge e l’approvazione della legge di autorizzazione, in forza della quale
il Presidente della Repubblica può procedere alla ratifica del trattato.
La ratifica, peraltro, è
l’atto formale e solenne con cui il Presidente della Repubblica dichiara la
volontà dello Stato italiano di assumere gli obblighi ed i diritti derivanti
dal trattato, solo però all’interno dell’ordinamento internazionale.
Nell’ambito di
quest’ultimo ordinamento, infatti, il trattato entra in vigore con lo scambio delle
ratifiche, o con il loro deposito quando gli Stati contraenti sono molteplici.
Perché il trattato
produca effetti giuridici nell’ordinamento interno, poi, occorre ancora che si
disponga in tal senso con l’ordine di esecuzione.
E’ con tale atto che vengono
ordinariamente e conclusivamente recepite nell’ordinamento italiano le norme di
un trattato internazionale.
Con tale formula,
infatti, si ordina formalmente a tutti i soggetti tenuti all’applicazione del
diritto ( amministrazione pubblica, giudici, ecc..), di applicare le norme del
trattato come se fossero norme di
diritto interno.
In relazione a tale atto,
poi, va rilevato che la giurisprudenza costituzionale è intervenuta più volte
per assimilarne il regime a quello proprio della legge di autorizzazione.
Per un verso, infatti,
Per altro verso, la
medesima Corte ha escluso tale atto dal referendum abrogativo, sul rilievo che
la preclusione contenuta nell’art. 75 della Costituzione avrebbe ben poco senso
se riferita alle sole leggi di autorizzazione e non a qualsiasi legge che dia
esecuzione alle norme di un trattato .
Tanto chiarito in ordine
all’ingresso delle norme di diritto internazionale nell’ordinamento interno,
resta da affrontare la invero non facile questione del rango che le prime
vengono ad assumere nell’ambito del sistema delle nostre fonti del diritto.
1.2
Posizione nella gerarchia delle fonti
a.
Le norme consuetudinarie
Come già precisato, le norme
internazionali consuetudinarie entrano a far parte del nostro ordinamento in
virtù del meccanismo di adattamento automatico enunciato dall’art. 10, 1°
comma, della Costituzione.
Tuttavia detto articolo
non disciplina il rango delle norme in questione, con la conseguenza che la
dottrina ha formulato al riguardo le tesi più varie e talora stravaganti.
E’ stato, infatti,
addirittura sostenuto che questa tipologia normativa sia sovraordinata alla
stessa Costituzione.
Tesi questa, che secondo
l’opinione prevalente non risulta suffragata da seri argomenti risultando, al
di là di ogni ulteriore considerazione, incomprensibile come
All’estremità opposta,
invece, è stato sostenuto che l’art. 10, 1° comma, darebbe vita a norme di
adattamento al diritto internazionale dotate dell’efficacia propria delle fonti
primarie.
Anche nei confronti di
questa tesi, peraltro, è facile opporre che la norma costituzionale non colloca
le norme di adattamento ad un livello inferiore al proprio e che
conseguentemente tale declassamento non può essere ragionevolmente sostenibile
senza una specifica base testuale.
La tesi quindi
maggiormente sostenuta, e senz’altro preferibile, è quella intermedia che
attribuisce efficacia costituzionale alle norme consuetudinarie di diritto
internazionale.
Essendo, infatti, la
volontà di soggiacere a tali norme, contenuta in una disposizione
costituzionale, anche le prime acquistano conseguentemente pari rango
costituzionale.
Nell’ambito di tale tesi,
poi, un filone di pensiero ritiene che l’adattamento automatico debba
intendersi limitato alle sole norme consuetudinarie non contrastanti con norme
costituzionali, non potendo ammettersi l’ingresso di norme discordanti con
Secondo un’altra corrente
di pensiero, invece, il rapporto tra le norme di adattamento e le altre norme
costituzionali dovrebbe essere risolto in base alle comuni regole sui conflitti
di norme, ferma restando in ogni caso la subordinazione delle une e delle altre
ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato.
Tale opinione, in oggi,
risulta essere quella maggiormente condivisa e da preferire.
Deve perciò ritenersi che
le norme consuetudinarie di diritto internazionale, quando non siano in palese
contrasto con i principi supremi del nostro ordinamento, assumano la stessa
efficacia delle norme costituzionali e
che i conflitti che possano eventualmente insorgere debbano essere risolti,
stante l’equiparazione nella scala gerarchica, in base al principio di
specialità oppure, ove ciò non sia possibile, in base al principio cronologico.
Va da sé, infine, che
stante il rango costituzionale delle anzidette norme consuetudinarie, le leggi
interne che eventualmente si ponessero in contrasto con le stesse, si
profilerebbero viziate da illegittimità costituzionale, per violazione
dell’art. 10, 1° comma, della Costituzione.
b. Le norme pattizie
Per ciò che riguarda le
norme internazionali pattizie il loro ingresso nel nostro ordinamento, come già
precisato, è filtrato in via generale da una legge di autorizzazione delle
camere e da uno specifico ordine di esecuzione con cui viene stabilito di
dare attuazione alle stesse.
Conseguentemente secondo
il principio affermato in materia dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per
cui il rango assunto dalle norme internazionali è quello proprio della norma
nazionale che ne consente l’ingresso, le norme pattizie assumono rango
legislativo e si pongono in un rapporto di equiordinazione con le leggi
interne.
In tale contesto, quindi,
il rapporto tra la norma internazionale pattizia e quella interna viene ad
essere disciplinato secondo gli ordinari canoni vigenti tra fonti pariordinate,
ossia in base al criterio di specialità ed a quello cronologico.
Al riguardo, si è
tuttavia affermato da parte di taluna dottrina che le norme internazionali
pattizie sono caratterizzate da una loro specialità intrinseca derivata dal
fatto che il legislatore ha spontaneamente limitato la propria sovranità,
impegnandosi con un vincolo di fedeltà nei confronti dei patti internazionali e
delle norme che ne derivano.
In quest’ottica,
pertanto, si è sostenuto autorevolmente che nel contrasto tra norma interna ed
internazionale, debba essere privilegiata la soluzione interpretativa più
conforme a quest’ultima.
Sempre in tale ottica,
poi, si è ritenuto che il legislatore nazionale non possa procedere all’abrogazione
tacita della norma internazionale, potendo gli impegni assunti in sede pattizia
essere correttamente superati solo con l’ esplicitazione di un formale dissenso
sopravvenuto.
Conclusivamente, alla
stregua di quanto rilevato, è opinione consolidata in ambito dottrinario che la
specialità delle norme internazionali pattizie non si traduca in una valenza
formalmente superiore, ma si risolva in un vincolo di interpretazione
conservatrice ed in un tendenziale divieto di abrogazione tacita.
L’assunto, del resto,
corrisponde a quanto
Su tale assetto di
rapporti, peraltro, è di recente intervenuta la riforma del Titolo V della
Costituzione ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha
introdotto novità di assoluto rilievo per i fini considerati.
Nella sua attuale formulazione, infatti,
l’art. 117 della Costituzione dispone che “la
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali”.
La novella legislativa,
ha subito indotto parte della dottrina ad affermare la diretta applicabilità
anche dei trattati nell’ordinamento interno e la loro immodificabilità da parte
delle leggi nazionali, come peraltro già accade in altri Paesi.
A prescindere da questa
posizione, forse troppo assoluta, non sembra comunque che possano esserci dubbi
sul fatto che l’intervenuta costituzionalizzazione degli obblighi internazionali, comporti la necessaria incostituzionalità
delle disposizioni legislative interne contrastanti con tali obblighi.
In altri termini, la
riforma costituzionale ha determinato l’elevazione del rango occupato dalle
norme internazionali pattizie nell’ambito del sistema delle nostre fonti,
sottraendo le stesse alla possibilità di successivi interventi legislativi di
segno contrario.
Conclusivamente, in oggi
le norme internazionali pattizie possono essere superate a livello di normativa
interna, o con una retrocessione dal trattato di cui sono emanazione, ovvero
con una specifica norma di rango costituzionale.
Attenta dottrina, poi,
non ha mancato di rilevare che il riferimento agli obblighi internazionali, nella sua ampia formulazione, consente di
ricomprendere non solo gli obblighi derivanti dai trattati ratificati previa
autorizzazione legislativa, ma anche quelli derivanti dai trattati stipulati in
forma semplificata, che sono cioè conclusi, come già precisato, sulla base
della semplice sottoscrizione di un rappresentante del Governo dotato di pieni
poteri, senza necessità di successiva ratifica.
2.
L’affermazione del principio di non
discriminazione di genere nell’ordinamento internazionale
Il principio di non
discriminazione di genere ha da sempre costituito, nell’ambito dell’
ordinamento internazionale, uno dei principi cardine.
Sin dalla Carta di San Francisco del 1945,
infatti, le Nazioni Unite si sono prefisse, tra l’altro, lo scopo fondamentale
di “promuovere ed incoraggiare il
rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza
distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione…”.
Parimenti nella Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo del 1948, viene affermato all’art. 2 che “…ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati
nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza,
di colore, di sesso, di lingua, di religione….”.
Tale principio, poi, è
stato ripreso e riaffermato nei Patti
internazionali sui diritti dell’uomo, adottati dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite nel 1966, ed ulteriormente trasfuso in quel documento noto
come International Bill of Rigths,
Nel 1979, inoltre,
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha
adottato
A livello europeo, poi,
sin dalla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, viene
espressamente affermato il principio per cui
il godimento dei diritti e delle libertà “… deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare
quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua,…”(cfr.art. 14).
Da allora, attraverso l’Atto unico europeo, i Trattati di
Maastricht, Amsterdam e Nizza fino
alla recente Carta costituzionale europea,
ratificata nel nostro Paese con legge 7 aprile 2005, n. 57, il principio di non
discriminazione di genere è sempre stato enunciato e ricompreso tra quelli
fondanti l’ordinamento comunitario.
3.
La definizione del concetto di
discriminazione di genere nell’ambito dell’ ordinamento interno
Quanto sin qui esposto,
consente ora di poter compiutamente valutare la bontà del rilievo mosso dal
Comitato delle Nazioni Unite al Governo italiano, circa l’asserita mancanza di
una definizione di discriminazione contro le donne “nella Costituzione o nella
legislazione".
Detto rilievo nella sua
assolutezza non è esatto e, come tale, non appare condivisibile.
Se è vero, infatti, che
nella Costituzione manca una specifica definizione di “discriminazione contro
le donne”, sopperendo al riguardo sul piano sostanziale il principio di
eguaglianza enunciato all’art.3, non è altrettanto vero che “nella
legislazione” detta definizione non sia rinvenibile con una attenta operazione
di ermeneutica giuridica.
Ed invero,
Detta Convenzione è stata
adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 ed è
entrata in vigore, nell’ordinamento internazionale, nel 1981.
L’autorizzazione alla
ratifica e l’ordine di esecuzione in Italia, poi, sono stati dati con la legge
n. 132 del 14 marzo 1985 e le norme della Convenzione sono entrate in vigore
nel nostro ordinamento interno dal 10 luglio 1985.
Per quanto sin qui
precisato con riguardo al rapporto tra le fonti di diritto interno ed
internazionale, quindi, non v’è dubbio che dal 1985 la definizione di
discriminazione di genere abbia fatto il suo formale ingresso nel nostro
ordinamento giuridico, negli stessi esatti termini contenuti nell’art. 1 della
Convenzione.
Con l’ordine di
esecuzione contenuto nella sopra richiamata legge di autorizzazione, infatti, è
stata formalmente disposta l’applicazione di tutte le norme di quest’ultima
come se fossero norme di diritto interno, e quindi anche di quella che
definisce, giust’appunto, il concetto di discriminazione di genere,
Se si ha riguardo, poi, a
quanto più sopra rilevato in merito al rango che in oggi deve essere
riconosciuto alle norme internazionali pattizie, a seguito della riforma del
Titolo V della Costituzione, detta definizione normativa non solo è già
presente nel nostro ordinamento, ma non può neppure essere contraddetta o
comunque ridotta, nella sua ampia formulazione, da eventuali leggi nazionali.
Ove ciò avvenisse, infatti,
la relativa norma risulterebbe necessariamente incostituzionale per violazione
dell’art. 117 della Costituzione che in oggi, come già precisato, vincola la
potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi
internazionali.
A ciò aggiungasi, che con
legge 7 aprile 2005, n. 57 è stato ratificato con contestuale piena ed intera
esecuzione il Trattato che adotta
Tali specifiche
disposizioni, pertanto, sono parimenti entrate a far parte dell’ordinamento
interno con il nuovo rango assunto dalla normativa internazionale pattizia e
spiegheranno i loro effetti secondo quanto disposto dall’articolo IV-447 del
Trattato, con ciò concorrendo a corroborare ulteriormente la sopra richiamata
definizione di discriminazione di genere.
Conclusivamente, non v’e’
dubbio che alla stregua dell’attuale stato dei rapporti intercorrenti tra le
fonti del diritto internazionale e quelle interne, la definizione normativa del
concetto di discriminazione di genere sia presente nel nostro ordinamento
interno, con il rango proprio che in oggi deve essere riconosciuto alle norme
internazionali pattizie.
Certo, per riprendere la
contestazione avanzata dal Comitato delle Nazioni Unite, non può sottacersi
come la presenza di tale definizione non risulti immediatamente percepibile,
contrariamente a quanto sarebbe opportuno, considerata la rilevanza del principio
che ad essa si ricollega.
Ciò dipende,
verosimilmente, non solo dalla oggettiva complessità del sistema delle fonti
del diritto, ma anche, se non soprattutto, dalla persistenza di una visione
dualista degli ordinamenti ancora oggi largamente diffusa che si rivela, nella
sua accezione conservatrice, sempre più inadeguata ad affrontare e risolvere il
delicato problema dei rapporti intercorrenti tra l’ordinamento interno e quello
internazionale, nell’attuale momento storico di crescente globalizzazione.