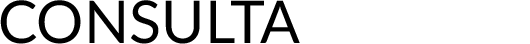SENTENZA N. 91
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 145 e 213 del Codice penale e degli artt. 124, primo comma, 125, secondo, quinto e sesto comma, 126, primo comma, e 327, secondo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 787, contenente il regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, promosso con ordinanza emessa il 26 luglio 1966 dal Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Fantin Alfonso, iscritta al n. 208 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1966.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1968 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Fantin Alfonso, ex detenuto nel carcere giudiziario di Lecco, con atto del 24 gennaio 1966 proponeva reclamo davanti al Tribunale di Varese ai sensi dell'art. 128 del R.D. 18 giugno 1931, n. 787, contenente il regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, e dell'art. 628 del Codice di procedura penale. Il reclamo era diretto contro un precetto di pagamento di lire 164.580 costituenti l'importo delle spese di mantenimento richiestegli dall'Amministrazione come da lui dovute per il periodo di detenzione.
Affermava il reclamante che l'ingiunzione era illegittima perché erano state effettuate a tal fine ritenute a suo carico ad opera dell'amministrazione del carcere dove esso Fantin aveva scontato la pena della reclusione dall'8 gennaio 1960 al 25 agosto 1961, pena inflittagli dal Tribunale di Varese. Dalle informazioni fornite al Tribunale dall'amministrazione stessa, risultava chiarito che a carico del Fantin erano state operate soltanto le ritenute a favore dell'erario previste dall'art. 125 del regolamento predetto sulla remunerazione del lavoro prestato in carcere e non anche quelle concernenti il mantenimento del condannato (vitto e medicinali) di cui agli artt. 145, n. 2, e 188 del Codice penale ed all'art. 2 del regolamento stesso.
Il Tribunale di Varese, ritenuto anzitutto che il detto reclamo rientrava in una delle ipotesi previste dall'art. 128 del regolamento, in quanto concernente l'applicazione delle norme che disciplinano la ripartizione della remunerazione spettante al detenuto, e che, quindi, esso Tribunale era competente quale giudice per gli incidenti di esecuzione, con ordinanza 26 luglio 1966 riconosceva pregiudiziale e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 124, primo comma, 125, secondo, quinto e sesto comma, 126, primo comma, e 327 del suddetto regolamento, nonché degli artt. 145 e 213 Codice penale per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 27 e 36 della Costituzione.
Il Tribunale ha osservato, anzitutto, che la disposizione dell'art. 124, primo comma, del regolamento stabilendo che i detenuti, prima di essere ammessi a qualsiasi lavoro retribuito, fanno un tirocinio gratuito, contrasterebbe con l'art. 36 della Costituzione, in base al quale ogni lavoro deve essere retribuito.
L'art. 125, secondo comma, e l'art. 126, primo comma, del regolamento, poi, parrebbero in contrasto con la libertà di scelta del lavoro, che sarebbe garantita dall'art. 4 della Costituzione, perché attribuiscono al direttore del carcere la facoltà discrezionale di assegnare i detenuti alle varie categorie di lavoratori senza possibilità di reclamo da parte dei detenuti stessi, mentre non potrebbe dubitarsi che l'invocato precetto costituzionale sia applicabile anche al lavoro carcerario, sia pure nei limiti delle esigenze particolari imposte da tale specifica qualità.
Il quinto e sesto comma dell'art. 125 con il limitare la remunerazione da corrispondere in concreto al detenuto ad una percentuale della mercede stabilita dal Ministero (variante a seconda della qualità della pena da espiare dai sei decimi agli otto decimi), e col riservare all'erario la differenza così risultante tra la mercede in astratto considerata e la remunerazione reale, contrasterebbe con il principio della proporzionalità tra lavoro effettivamente prestato e retribuzione fissata dall'art. 36 della Costituzione, e con l'art. 3 della Costituzione, riflettendo una differenziazione incompatibile con l'eguaglianza e la pari dignità sociale dei cittadini.
Eguali censure per eguali motivi vengono inoltre mosse all'art. 327 del citato regolamento, che limita per gli internati negli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva la retribuzione (chiamata gratificazione) ai nove decimi della mercede.
Il Tribunale passando quindi a trattare le questioni sollevate contro le ricordate norme del Codice penale (artt. 145 e 213) ha osservato che l'organizzazione del lavoro non sarebbe stata ancora uniformemente attuata in tutti gli stabilimenti carcerari, per cui i detenuti e gli internati, a carico dei quali i ricordati articoli porrebbero, rispettivamente, le spese di mantenimento, hanno la possibilità di pagarle durante l'espiazione della pena o l'applicazione della misura di sicurezza, solo se vengono ammessi al lavoro. Gli esclusi, invece, non potrebbero godere di questa possibilità e, per effetto di tale situazione, che l'ordinanza definisce "normativa", si concreterebbe una violazione dell'art. 1 della Costituzione, che, proclamando che l'Italia é una Repubblica fondata sul lavoro, garantirebbe la possibilità di lavoro a tutti i cittadini, e comporterebbe quindi, a favore del detenuto che non viene ammesso al lavoro, ed al quale non viene così offerta la possibilità di pagare il proprio mantenimento con la remunerazione, il diritto di essere mantenuto dallo Stato.
La descritta situazione, inoltre, costituirebbe un ostacolo di ordine economico-sociale che limiterebbe di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, e violerebbe quindi l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, mentre si porrebbe altresì in contrasto col principio per cui la pena deve tendere ad un fine educativo e non già meramente afflittivo, sancito dall'art. 27 della Costituzione.
L'ordinanza, notificata il 30 luglio 1966 al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Fantin il 17 ottobre 1966 ed al P. M. il 18 successivo, é stata comunicata come per legge ai Presidente dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 26 novembre 1966.
Avanti alla Corte costituzionale si é costituito il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato che ha depositato le proprie deduzioni il 21 ottobre 1966.
L'Avvocatura, pregiudizialmente, eccepisce l'inammissibilità della questione sollevata contro le norme del R.D. 18 giugno 1931, n. 87, in quanto, trattandosi di regolamento, emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, ed espressamente in forza dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sotto il profilo formale non potrebbe considerarsi atto avente forza di legge, e non sarebbe, pertanto, soggetto al controllo di legittimità costituzionale in questa sede.
Sempre pregiudizialmente, l'Avvocatura rileva altresì che nell'ordinanza di rinvio mancherebbe ogni accenno circa la rilevanza della questione, ed osserva al riguardo che le norme impugnate riguardano ipotesi diverse, come l'art. 145 del Codice penale, che concerne la remunerazione dei detenuti, e l'art. 213 del Codice penale, che concerne invece quella dei sottoposti a misura di sicurezza, mentre non risulterebbe precisato quale dei due articoli dovrebbe trovare applicazione per la soluzione del giudizio principale.
Aggiunge poi, sempre con riguardo alla rilevanza, che analoga carenza si verificherebbe specificamente in relazione alla questione sollevata contro l'art. 145 del Codice penale in quanto non solo non risulterebbe che il Fantin non poté pagare perché non gli era stata offerta la possibilità di lavorare e quindi di ottenere la remunerazione, ma dovrebbe ritenersi addirittura il contrario, essendogli state già praticate altre trattenute.
Nel merito, osserva che la questione sollevata relativamente all'art. 213 del Codice penale sarebbe mal posta perché i sottoposti a misura di sicurezza sarebbero tenuti a rimborsare le spese di mantenimento se ed in quanto lo consenta la remunerazione del lavoro prestato, e non risponderebbero quindi con tutti gli altri beni presenti e futuri, così come invece i detenuti condannati a pene detentive, in forza dell'art. 188 del Codice penale. Pertanto i sottoposti a misura di sicurezza che non lavorano sarebbero mantenuti a spese della collettività e quindi non si verificherebbe nei loro riguardi il vizio lamentato nell'ordinanza.
Afferma poi che mentre i dubbi di legittimità sollevati si fondano sul presupposto che l'obbligo in parola promani dall'art. 145 del Codice penale, invece, la norma che in realtà stabilisce l'onere del pagamento delle spese di mantenimento sarebbe l'art. 188 del Codice penale: l'art. 145 si limiterebbe soltanto ad affermare che il detenuto ha il diritto alla remunerazione e che su questa si prelevano le spese di mantenimento. Non avrebbero senso quindi, se riferite all'art. 145, tutte le argomentazioni dell'ordinanza di rinvio. L'art. 145, invero, dato il suo contenuto, non eluderebbe il supposto diritto al lavoro dei cittadini, e le diseguaglianze lamentate nell'ordinanza di rinvio non conseguirebbero all'art. 145 impugnato, ma, se mai, all'art. 188, che pone l'obbligo a carico di tutti i detenuti, abbiano o no lavorato, ed estende la garanzia relativa a tutti i beni diversi dalla remunerazione.
Egualmente sarebbero imputabili, in ipotesi, all'art. 188 e non all'art. 145 del Codice penale, le lamentate violazioni dell'art. 27 della Costituzione. Né l'oggetto del giudizio potrebbe estendersi in virtù dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riflettendo questo la ben circoscritta ipotesi della illegittimità conseguenziale, cioè, della illegittimità di norme che costituiscono conseguenze o derivazione di quella dichiarata incostituzionale, del tutto diversa da quella in esame.
Proseguendo nelle proprie deduzioni l'Avvocatura osserva che né l'art. 1, né l'art. 4 della Costituzione, i quali pongono soltanto affermazioni generalissime sulla importanza sociale del lavoro, attribuiscono al cittadino un "diritto" al posto di lavoro né, quindi, allo Stato l'obbligo di apprestarlo, il che escluderebbe anche la rilevanza costituzionale della diversità delle situazioni riservate rispettivamente ai detenuti che sono ammessi al lavoro ed a quelli che non lo sono. L'Avvocatura osserva altresì che la natura stessa del lavoro carcerario, da intendersi come modalità della pena, escluderebbe che ad esso possano applicarsi i principi costituzionali riferibili solo al lavoro del libero cittadino.
D'altra parte, osserva ancora l'Avvocatura, stabilendo l'obbligo del lavoro nei termini suddetti il legislatore penale non avrebbe violato alcuna norma della Costituzione e la mancata attuazione della legge attraverso una conveniente organizzazione del lavoro carcerario, su cui il giudice a quo fonda il dubbio di legittimità delle norme denunziate, evidenzierebbe, se mai, un difetto nell'esecuzione della legge, e non un vizio della stessa.
Evidente, infine, sarebbe l'infondatezza del richiamo all'art. 27 della Costituzione, non vedendosi come l'esistenza di un debito per il rimborso della spesa di mantenimento possa contrastare col principio della umanità della pena.
Considerato in diritto
1. - La questione di costituzionalità proposta dal Tribunale di Varese ha, anzitutto, per oggetto gli artt. 124, primo comma, 125, secondo, quinto e sesto comma, 126, primo comma, 327, secondo comma, del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 787.
Ma, come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato, la questione é inammissibile in quanto proposta, contrariamente al disposto dell'art. 134 della Costituzione, nei riguardi di un atto non avente veste e forza di legge.
Come già questa Corte ha affermato e ribadito, condizione dell'azione diretta a promuovere il giudizio costituzionale é che oggetto della denuncia sia una legge ovvero un decreto legislativo od un decreto legge: mai un regolamento che, per sua natura, é privo di quei caratteri intrinseci ed estrinseci, che possano conferirgli forza di legge.
Tale il regolamento sugli istituti di prevenzione e di pena, emanato, come é detto espressamente nel preambolo, in dipendenza e correlazione con l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, autorizzativo del potere regolamentare del Governo e preceduto, come prescritto per atti del genere, dal parere del Consiglio di Stato.
2. - Residua, dopo la dichiarazione di inammissibilità della questione come sopra proposta, l'esame della questione di costituzionalità sollevata con riferimento agli artt. 145 e 213 del Codice penale.
Di questi due articoli, il secondo riguarda il regime cui sono sottoposti gli internati negli stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive ed i ricoverati nei manicomi giudiziari: entrambe queste ipotesi sono estranee a quella che ha originato il sorgere della questione da parte dell'ordinanza di rinvio, consistente nel rimborso delle spese di mantenimento in carcere da parte del condannato a pena detentiva.
Di conseguenza, la questione in quanto posta in relazione all'art. 213 del Codice penale va dichiarata inammissibile per difetto dei requisiti di rilevanza, difetto tanto manifesto che l'ordinanza neppure motiva particolarmente sul punto, limitandosi ad un semplice richiamo dell'articolo predetto.
In relazione all'art. 145 del Codice penale l'ordinanza prospetta la questione di costituzionalità nel senso che, data l'incompleta attuazione dell'organizzazione del lavoro negli istituti di pena, non a tutti i detenuti sarebbe offerto il mezzo di poter contribuire, mercé la retribuzione del lavoro eseguito (lavoro che ha anche una finalità etica e rieducativa) alle spese di mantenimento in carcere; da ciò si trae l'ulteriore rilievo che l'insoddisfacente sistema vigente andrebbe corretto con l'attribuire soltanto allo Stato l'intero onere delle spese di mantenimento in carcere dei detenuti.
La questione di costituzionalità é proposta e motivata soltanto con richiamo all'art. 145 che, in applicazione del principio del rimborso allo Stato delle spese di mantenimento (n. 2 dell'articolo), regola i prelievi dalla remunerazione del lavoro prestato ai fini di detto rimborso nonché ad altri fini, ivi elencati.
Tale questione, nei limiti in cui risulta proposta, non é fondata nei confronti di alcuno degli indicati articoli della Costituzione. Non dell'art. 1 che dichiara il lavoro base della Repubblica; non dell'art. 3 che consacra il principio di eguaglianza; né dell'art. 4 che consacra il diritto al lavoro: e nemmeno degli artt. 27 e 36 che riguardano rispettivamente il carattere e la finalità delle pene e la retribuzione proporzionata del lavoro.
Il campo d'azione dell'art. 145 del Codice penale é ben più circoscritto nei confronti di quello su cui si riflettono i principi come sopra enunciati dalla Costituzione.
L'art. 145 riguarda soltanto l'ordine dei prelievi sulla retribuzione e la riserva del peculio. E quanto si osserva nell'ordinanza di rinvio circa l'attuazione, fin qui solo parziale, delle disposizioni concernenti l'organizzazione del lavoro negli stabilimenti di pena potrebbe bensì trovare qualche riscontro nella situazione reale cui sembra non corrispondano tuttora le aspettative di "graduale attuazione" preveduta fin dall'art. 327 dell'antico regolamento, ma non può, di per sé, avere alcuna influenza sulla costituzionalità della norma. Questa ha un contenuto che prescinde dal modo con cui in via generale é regolato l'ordinamento e s'innesta nel sistema, peraltro qui non sottoposto ad alcuna censura, secondo il quale le spese di mantenimento gravano sul condannato.
Di conseguenza, la questione così come proposta va dichiarata non fondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 124, primo comma, 125, secondo, quinto e sesto comma, 126, primo comma, 327, secondo comma, del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 787, proposta con ordinanza 26 luglio 1966 del Tribunale di Varese in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 27 e 36 della Costituzione;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213 del Codice penale sollevata con la stessa ordinanza dal Tribunale di Varese in riferimento agli articoli sopracitati della Costituzione;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 del Codice penale sollevata dallo stesso Tribunale di Varese con l'ordinanza di cui sopra in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 27 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1968.