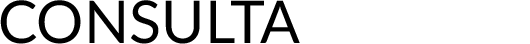ORDINANZA N. 485
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Cesare MIRABELLI, Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Annibale MARINI
- Dott. Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 8 e 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, promossi con due ordinanze emesse il 21 e il 17 settembre 1999 dal Tribunale di Bari sui ricorsi, riuniti, proposti da Ibrahimi Haziz e altri e da Rajendra Ramanah contro il Prefetto di Bari, rispettivamente iscritte ai nn. 658 e 693 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50 e 51, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che quattro cittadini extracomunitari, espulsi dal Prefetto in via amministrativa, proponevano opposizione al decreto di espulsione dinanzi al Tribunale di Bari;
che costoro allegavano che il provvedimento impugnato era stato emesso in violazione del divieto di espulsione stabilito dall’art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), essendo gli espulsi di etnia «Rom» e, quindi, se rimpatriati, sarebbero stati sottoposti a persecuzioni nel paese di provenienza, la Jugoslavia;
che due reclamanti sostenevano, inoltre, di non poter essere espulse, trovandosi in stato di gravidanza;
che il Tribunale adito, reputando che né l’appartenenza etnica né lo stato di gravidanza potessero essere accertati nel breve termine di dieci giorni fissato dalla legge per la conclusione del procedimento, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
che, stando alla prospettazione del rimettente, l’effettivo esercizio del diritto di difesa non può prescindere dall’effettivo riconoscimento del diritto alla prova;
che tale diritto non sarebbe adeguatamente tutelato dalla previsione di un termine di soli dieci giorni, anch’esso fissato dalla legge, poiché sarebbe impossibile o, comunque, estremamente difficile compiere, in un tempo così esiguo, qualsiasi attività istruttoria finalizzata all’accertamento della legittimità del decreto di espulsione;
che ulteriore vulnus al diritto alla prova (e, conseguentemente, al diritto di difesa) deriverebbe sia dalla impossibilità per il giudice di sospendere l’efficacia del decreto, sia dalla automatica esecutività di esso, decorsi quindici giorni dalla notifica;
che lo stesso Tribunale, con altra ordinanza, ha censurato il comma 8 della medesima norma, con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 10, 24, 41 e 113 della Costituzione;
che il rimettente, anche in questo caso chiamato a decidere il ricorso tardivamente proposto da un cittadino extracomunitario, ha ritenuto di individuare, nella norma in esame, i profili di illegittimità di seguito indicati;
che vi sarebbe contrasto con gli artt. 10, 24 e 113 della Costituzione, a causa della eccessiva brevità del termine di cinque giorni per la proposizione del ricorso, e vi sarebbe lesione degli artt. 2, 3, 10, 24 e 41 per l’irragionevole discriminazione degli extracomunitari che svolgono regolarmente un’attività lavorativa, dipendente o autonoma, e sono in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, ma non rinnovato, rispetto agli extracomunitari illegalmente entrati in Italia;
che, a questo riguardo, il giudice a quo osserva che il legislatore ha previsto, nel citato decreto legislativo n. 286, termini assai brevi sia per l’impugnativa sia per la decisione, al fine di garantire l’effettività dell’espulsione e tutelare, così, la sicurezza pubblica;
che, tuttavia, siffatta esigenza di tutela, oggettivamente ipotizzabile nei confronti di chi sia clandestinamente entrato nel nostro Paese, non sussisterebbe per colui che, già titolare d’un permesso di soggiorno, lo abbia lasciato scadere senza chiedere il rinnovo;
che, pertanto, coloro i quali avevano ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro possono vantare un interesse costituzionalmente protetto alla permanenza in Italia, sì che la previsione del breve termine per l’impugnazione, anche per queste categorie di soggetti, costituirebbe una «irrazionale compromissione» del diritto al lavoro e alla libera iniziativa economica;
che, inoltre, il lavoratore extracomunitario in possesso d’un permesso di soggiorno scaduto, e non rinnovato, sarebbe irragionevolmente discriminato rispetto all’extracomunitario (non lavoratore) immigrato clandestinamente, in quanto la condizione del lavoratore, maggiormente protetta, comporta un maggiore impegno «istruttorio e deduttivo» sia per la parte, sia per il difensore;
che, infine, il Tribunale di Bari invoca quale parametro l’art. 10 della Costituzione, sotto i seguenti profili:
- per violazione, data l’esiguità del termine di cinque giorni, del principio sancito dall’art. 6, lettera b), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, che impone agli Stati aderenti di concedere allo straniero il tempo e le facilitazioni necessarie per predisporre la propria difesa;
- per lesione del principio contenuto nell’art. 13 della suddetta Convenzione, ove si «prevede la possibilità di ricorsi effettivi»;
- per violazione del Protocollo addizionale n. 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963, ratificato e reso esecutivo con d.P.R. 14 aprile 1982, n. 217;
che, in ordine alla rilevanza, l’opposizione si presenterebbe fondata e che tuttavia, essendo il ricorso tardivamente proposto, soltanto qualora si fosse ritenuto costituzionalmente illegittimo il termine di cinque giorni per l’opposizione il Tribunale avrebbe potuto affrontare l’esame del merito;
che in entrambi i giudizi è intervenuta la Presidenza del Consiglio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, eccependo, con riferimento alla prima delle questioni indicate, che sia il termine di cinque giorni per l’impugnazione, sia quello di dieci giorni per la decisione non sarebbero termini perentori, ma ordinatori, sì che la loro inosservanza non comporterebbe «alcuna conseguenza»;
che, con riguardo alla seconda questione, l’Avvocatura dello Stato ne ha sostenuto l’infondatezza, perché la fissazione di termini per qualsiasi impugnazione rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore.
Considerato che le due questioni hanno a oggetto la medesima norma e debbono essere decise con unico provvedimento;
che si deve preliminarmente ribadire – contrariamente a quanto osserva l’Avvocatura dello Stato - che i termini previsti dall’art. 13, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 286 del 1998 sono perentori, come si desume, per il primo, dalla sua natura di termine processuale preordinato all’esercizio del diritto di impugnazione (sentenza n. 232 del 1985) e, per il secondo, dall’inciso «in ogni caso» contenuto nel comma 9;
che, con riferimento alla questione di cui all’ordinanza n. 658 del 1999, si deve ricordare come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la congruità di un termine debba essere valutata comparando l’interesse di chi sia gravato dall’onere di rispettarlo con quello, generale, al sollecito compimento dell’atto processuale per il quale esso è fissato dalla legge (sentenze nn. 161 del 2000; 138 del 1975; 10 del 1970; 93 del 1962);
che, alla luce di tali principi, il termine di dieci giorni stabilito dall’art. 13, comma 9, per la definizione del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione non è incongruo, poiché la necessità di una sollecita definizione del procedimento di impugnazione risponde all’interesse generale di un efficace controllo dell’immigrazione da Paesi extracomunitari (sentenza n. 161 del 2000);
che l’asserita impossibilità di assumere informazioni o disporre un accertamento medico legale nel termine di dieci giorni costituisce una difficoltà di mero fatto, inidonea a determinare un vulnus di costituzionalità e che, comunque, nel caso di sussistenza di oggettivi impedimenti non è inibito al giudice individuare gli strumenti di cui avvalersi, fra quelli previsti dall’ordinamento, per sospendere l’efficacia del decreto impugnato (ancora sentenza n. 161 del 2000);
che la questione sollevata con l’ordinanza n. 658 è, pertanto, manifestamente infondata;
che è del pari manifestamente infondato l’analogo dubbio di legittimità di cui all’ordinanza n. 693 del 1999;
che, con riferimento alla irrazionale disparità di trattamento fra i cittadini extracomunitari in possesso d’un permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato e quelli privi di esso, non è violato alcuno dei parametri costituzionali invocati (art. 2, 3, 24 e 41 della Costituzione), non essendo condivisibile l’assunto dal quale muove il rimettente, secondo cui l’espulsione sarebbe prevista dall’art. 13 del citato decreto legislativo n. 286 al solo fine di tutelare la sicurezza pubblica: esigenza, questa, che non sussisterebbe per i lavoratori extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno scaduto;
che, al contrario, soltanto l’espulsione disposta dal Ministro dell’interno, ai sensi dell’art. 13, comma 1, ha il precipuo fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, mentre negli altri casi l’espulsione amministrativa (art. 13, comma 2) è preordinata ad assicurare una razionale gestione dei flussi di immigrazione nel nostro Paese; e che pertanto, tale essendo la ratio della norma, non è implausibile l’equiparazione operata dal legislatore (art. 13 , comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 286) fra stranieri privi di permesso, per non averlo mai ottenuto, e stranieri il cui permesso sia scaduto senza essere rinnovato;
che non sussiste, altresì, il lamentato contrasto con l’art. 10 della Costituzione, giacché il procedimento di cui all’art. 13 ha a oggetto la legittimità del provvedimento di espulsione - che di norma non richiede lo svolgimento di indagini particolari – onde il termine di cinque giorni per il reclamo non è irrazionalmente breve, né si pone in contrasto con il disposto dell’art. 6, comma 3, lettera b), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
che è fuori luogo, infine, il richiamo al citato Protocollo addizionale, il cui art. 2, comma 1, riconosce il diritto di soggiorno e circolazione sul territorio dello Stato soltanto a chi vi si trovi «regolarmente».
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 8 e 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 10, 24, 41 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Bari con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 9 novembre 2000.