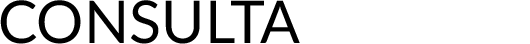SENTENZA N. 104
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1966 dal pretore di Iseo nel procedimento penale a carico di Bresciani Teresa, iscritta al n. 14 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1968 la relazione del Giudice Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Il pretore del mandamento di Iseo, con decreto penale 9 luglio 1966, riteneva la signora Teresa Bresciani responsabile della contravvenzione prevista negli artt. 9 e 36 del T.U. delle leggi sulla pesca (R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604) "per avere la stessa versato nel lago di Iseo i rifiuti del proprio stabilimento industriale senza la prescritta autorizzazione"' e la condannava all'ammenda di lire 120.000, pari al triplo del massimo edittale, perché riteneva che, a causa delle condizioni economiche di lei, dovesse farsi luogo nel caso all'applicazione dell'aumento di pena previsto dall'art. 26 del Codice penale.
La Bresciani si opponeva al decreto e, al dibattimento, dopo aver dedotto che la disposizione del citato art. 26, in base al quale era stata nei suoi confronti maggiorata la pena, dovesse ritenersi incostituzionale, perché contraria al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, chiedeva che, sospendendosi il giudizio, gli atti venissero rimessi a questa Corte, competente in materia a decidere sull'eccezione.
Il pretore, con ordinanza 8 novembre 1966, disponeva in conformità della richiesta, dopo avere, sul punto della rilevanza, osservato che, in caso di affermazione della responsabilità dell'imputata, stante le sue condizioni economiche, l'art. 26 del Codice penale doveva trovare applicazione, e sul punto della non manifesta infondatezza, ritenuto che il detto articolo appariva in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto legittima un aggravamento della sanzione in ragione delle sole condizioni economiche del reo, mentre, nel quadro del vigente ordinamento penale, i reati sono puniti proporzionalmente alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere del colpevole e solo nell'ordinamento tributario trova un giustificato e ragionevole ingresso un principio di progressività.
L'ordinanza del pretore, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25 febbraio 1967.
Nel presente giudizio si é costituita, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato depositando il 17 marzo 1967 l'atto di intervento.
L'Avvocatura ha dedotto che la questione di costituzionalità sollevata dal pretore di Iseo non sembra aver fondamento e ciò perché la ratio del sistema, che prevede la facoltà di aumentare fino al triplo la pena pecuniaria quando, per le condizioni economiche del reo, la pena stessa può presumersi inefficace, anche se applicata al massimo, non sarebbe da rinvenire nell'intento del legislatore di determinare una disuguaglianza dei cittadini in base ad una distinzione per diverse condizioni sociali (alle quali sono da rapportare quelle economiche), ma nell'intento dichiarato di garantire il carattere che si attenua nei confronti dei più economicamente dotati.
E, dopo aver richiamato principi espressi da questa Corte nella sentenza del 22 marzo 1962, n. 29 sulle linee fondamentali del nostro ordinamento penale e sul punto della legittimità delle norme che dispongono la commutazione della pena pecuniaria in quella detentiva, e dopo aver altresì fatto appello all'opinione più volte da essa espressa, e secondo la quale proprio il principio di eguaglianza richiede che a situazioni giuridiche differenziate sia applicato un parimenti differenziato trattamento, l'Avvocatura ha concluso che la disposizione denunciata dell'art. 26 del Codice penale, al contrario di quanto sembra al pretore di Iseo, deve ritenersi affermazione e non negazione di quel principio, come che intesa a correggere una diversità di incidenza della sanzione sul soggetto colpito, in relazione alle condizioni economiche di lui, diversità che é propria della pena pecuniaria.
Alla pubblica udienza dell'11 giugno 1968 il rappresentante dell'Avvocatura si riportava ai propri scritti difensivi.
Considerato in diritto
Come risulta dalla giurisprudenza costante di questa Corte, il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione postula non solo che a situazioni oggettivamente uguali debba corrispondere un eguale trattamento, ma anche che a situazioni oggettivamente diverse debba corrispondere un trattamento differenziato.
Accertare l'eguaglianza o la diversità delle situazioni, ai fini del trattamento da applicare, é compito del legislatore, il quale vi provvede nell'esercizio di una discrezionalità che trova limite soltanto nella ragionevolezza delle statuizioni.
Frequenti occasioni all'esercizio di tale discrezionalità offre al legislatore la disciplina dei reati e delle pene, ove, di fronte alla variabile complessità della condotta antigiuridica dei singoli, l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più che l'uniformità.
Risponde anzi alle esigenze del sistema penale che allo stesso giudice sia conferita una certa discrezionalità fra il minimo e il massimo previsto dalla legge nell'attribuzione della pena, al fine della sua determinazione in concreto (art. 133 del Codice penale).
Nell'esercizio di tale potere discrezionale il giudice deve tener conto, al fine di valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole, di elementi attinenti alla personalità del reo desunti dal suo carattere, dalla sua vita e dalla sua condotta, anche anteriore al commesso reato, e persino dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale di lui (art. 133 del Codice penale).
Non può dubitarsi che la ratio di tale sistema coincida con quella dell'art. 26, secondo comma, del Codice penale, ora portato all'esame di questa Corte, onde il problema della conformità al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione va posto, rispetto all'art. 133 e rispetto alla norma di che trattasi, in termini affatto paralleli.
Ciò premesso, é da ricordare che sulla legittimità costituzionale dell'art. 133, questa Corte ha avuto più volte occasione (v. sentenze n. 29 del 1962, 67 del 1963 e 111 del 1964), di pronunziarsi, in modo esplicito od implicito, in senso positivo, ravvisando nella norma la funzione di garantire, ai fini di una più efficiente ed equilibrata giustizia, il processo di individualizzazione della pena.
Alla stregua di analoghe considerazioni, la questione di costituzionalità dell'art. 26, comma secondo, del Codice penale prospettata dal pretore di Iseo, va pure risolta nel senso della sua infondatezza.
Il criterio ispiratore di questa norma, che autorizza il giudice ad aumentare sino al triplo l'ammenda quando, per le condizioni economiche del reo, può presumersi che quella stabilita dalla legge risulti per lui inefficace, é certo un criterio di discriminazione fondato sulle condizioni personali, ma non é affatto un criterio contrario alla logica e alla ragionevolezza. Infatti soddisfa anch'esso il principio della individualizzazione della pena.
Il legislatore ha inteso in tal modo, per le pene pecuniarie, sia della multa (art. 24) che dell'ammenda (art. 26), accogliere e superare - così come si legge nei lavori preparatori del Codice - proprio "le critiche che in genere si sogliono fare contro l'uso delle pene dirette a colpire il patrimonio del reo, siccome quelle che riescono diseguali e non personali".
Si é voluto cioè, con la facoltà concessa al giudice di aumentarle fino al triplo nei confronti dei più abbienti, conseguire l'effetto di adeguare quelle pene alla condizione del reo mettendole in grado di possedere, anche nei confronti degli anzidetti soggetti, quella necessaria efficacia afflittiva e intimidatrice, che rappresenta l'obbiettivo, se non unico, almeno precipuo, di ogni genere di pena, e che altrimenti le pene in questione rischierebbero - a cagione della maggiore capacità economica dei soggetti stessi - di non possedere.
Il che é proposito che non può qualificarsi contrario alla logica né alla ragionevolezza e che quindi non offende, ma tutela il principio di eguaglianza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma secondo, del Codice penale in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1968.